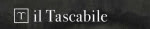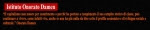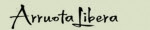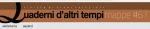Newsletter Sinistrainrete
tonino

Sergio Cesaratto: Italia: Una questione di tassi di interesse e fiducia
Italia: Una questione di tassi di interesse e fiducia
di Sergio Cesaratto
 Contrariamente all’immagine usualmente
trasmessa nei paesi
del nord d’Europa, l’Italia non è un paese fiscalmente
dissoluto. In verità, l’Italia ha un record di surplus fiscali
primari (i saldi del bilancio pubblico che escludono il
pagamento degli interessi) dal 1992; solo la Germania può
vantare qualcosa di simile
(figura 1). Purtroppo, questa serie ininterrotta di surplus di
bilancio è stata accompagnata dal 1995 dalla perdita della
competitività
esterna nella marcia di avvicinamento e poi con l’adozione
dell’euro. Questi due fattori combinati hanno costituito la
radice ultima della
stagnazione di lungo termine dell’economia italiana, in
particolare dell’appiattimento della sua produttività.
Contrariamente all’immagine usualmente
trasmessa nei paesi
del nord d’Europa, l’Italia non è un paese fiscalmente
dissoluto. In verità, l’Italia ha un record di surplus fiscali
primari (i saldi del bilancio pubblico che escludono il
pagamento degli interessi) dal 1992; solo la Germania può
vantare qualcosa di simile
(figura 1). Purtroppo, questa serie ininterrotta di surplus di
bilancio è stata accompagnata dal 1995 dalla perdita della
competitività
esterna nella marcia di avvicinamento e poi con l’adozione
dell’euro. Questi due fattori combinati hanno costituito la
radice ultima della
stagnazione di lungo termine dell’economia italiana, in
particolare dell’appiattimento della sua produttività.
Figura 1

Fonte:
Cesaratto, Iero (2018)
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Gli investimenti pubblici e il "Partito del Pil"
Gli investimenti pubblici e il "Partito del Pil"
di Leonardo Mazzei
 Dopo le buffonate di
Confindustria e soci, è possibile discutere seriamente del
piano
straordinario di investimenti pubblici di cui ha bisogno
l'Italia?
Dopo le buffonate di
Confindustria e soci, è possibile discutere seriamente del
piano
straordinario di investimenti pubblici di cui ha bisogno
l'Italia?
Per una strana congiunzione astrale, più esattamente per un'insolita congiuntura politica, sono tornati inopinatamente di moda gli investimenti pubblici. Peccato che tanti li vogliano solo su misura, ritagliati in base ai loro specifici interessi. Generalmente interessi economici, talvolta accompagnati da obiettivi strettamente politici.
Sta di fatto che, all'improvviso, tutti si son messi a parlare di investimenti. Bene, ma un po' d'ordine va fatto. Parla di investimenti il governo, anche se per ora ha messo in cantiere ben poco. Ma ne parlano pure le sfiatate opposizioni, tanto per dire che il governo non gli sta dando la giusta importanza. Parlano di investimenti gli eurofili d'ogni razza e tendenza, giusto per contrapporli a reddito di cittadinanza e "quota 100", sempre dimentichi però del fatto che gli investimenti pubblici son crollati proprio a causa dell'accettazione di quelle regole dell'ordoliberismo euro-germanico che tanto amano.
Nel nostro piccolo, vorremmo parlare di investimenti pure noi, ma per farlo in maniera adeguata dobbiamo prima mettere i puntini su parecchie "i".
Partiremo allora dal contesto politico, arrivando alle cose serie (il piano di investimenti da fare), solo dopo aver liquidato quelle non serie, rappresentate oggi dal pittoresco "Partito del Pil", una delle più disoneste congreghe messe in piedi dall'inizio del secolo, che pure di buffonate ne ha già proposte diverse.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: “Vendetta”, grida la piazza francese. Contro Macron e polizia
“Vendetta”, grida la piazza francese. Contro Macron e polizia
di Giacomo Marchetti – Potere Al Popolo Genova
Crisi politica, stato di polizia e movimento politico in Francia. Nel mentre scriviamo, dall’alba sono in corso i blocchi degli istituti superiori, per la terza giornata di mobilitazione promossa da l’UNL, che per alcune realtà territoriali non sono che la continuazione di una ininterrotta settimana di lotta, come a Marsiglia e a Tolosa.
L’hashtag delle mobilitazioni è – tradotto letteralmente – “vendetta studentesca”, una parola d’ordine azzeccata come non mai visto l’inedita, per tutta la storia della Quinta Repubblica, repressione esercitata sugli studenti medi che si sono mobilitati da venerdì scorso e la miglior risposta all’azione repressiva delle forze dell’ordine a Mants-La-Jolie, dove 151 sono stati “umiliati”, messi in fila sulle ginocchia e le mani dietro il capo, in massa.
Una immagine che ha suscitato sdegno e rabbia da ieri sera, dopo i ferimenti e le misure di limitazione della libertà viste tutta la settimana, nei confronti delle leve più giovani che dimostrano contro Macron: i 151 “interrogati” ieri in una modalità che ricorda direttamente le tragiche immagini delle dittature latino-americane sono tutti ragazzi nati tra il 1998 e il 2006.
Scene che si sommano a quelle dei “processi esemplari” celebratisi questa settimana a Parigi contro i dimostranti del manifestazione di sabato scorso, il primo dicembre, nella capitale. “Processi” in cui la vera imputazione era quella di aver partecipato alla mobilitazione, in una sorta di “concorso psichico” con le violenze senza che potessero essere formulate accuse per atti specifici.
Leggi tutto
Enzo Acerenza: Lotta di classe in Francia
Lotta di classe in Francia
di Enzo Acerenza
Ma non avevano detto che la lotta di classe era morta e sepolta, che il contrasto fra ricchi e poveri si era sciolto in percorsi individuali di ricollocazione sociale? La rivolta in Francia dice tutt’altra cosa
Ci dispiace per i teorici della nuova epoca, della fine delle classi e del contrasto di classe, si sono sbagliati. Il fuoco della rivolta ha lambito il monumento sacro della Repubblica Francese, l’Arco di Trionfo, l’hanno appiccato gli “immiseriti”. Guai a definirli proletari, o operai caduti in miseria, o piccola borghesia rovinata dalle misure economiche del governo, queste definizioni potrebbero richiamare vecchi schemi: la divisione sociale in operai e padroni, in borghesi e proletari e sollevare antichi quesiti di rivoluzione sociale. Verrà il tempo quando queste definizioni si riconquisteranno nella realtà dello scontro sociale la loro piena e innegabile legittimazione. Ora ne possiamo anche fare a meno, diventa noioso dibattere con qualche nuovo o vecchio trombone sulle “fallite” ideologie novecentesche. Intanto una massa imponente di individui inizia a manifestare contro le misure economiche del governo ed in particolare l’aumento dei carburanti. Una goccia che fa traboccare il vaso per centinaia di migliaia di cosiddetti cittadini. Cittadini particolare che si mettono in movimento per fermare il peggioramento costante ed inesorabile della loro condizione economica.
Leggi tutto
Nadia Garbellini: Formazione, lavoro ed emigrazione
Formazione, lavoro ed emigrazione
I giovani alle prese con i risultati della ristrutturazione neoliberista
di Nadia Garbellini*
Giovani a Sud della Crisi, lavoro collettaneo curato dai ragazzi di Noi Restiamo raccogliendo i contributi di vari collettivi universitari, è un volume importante non solo per i contenuti, ma anche – e in un certo senso soprattutto – per lo sforzo di elaborazione collettiva da cui ha avuto origine.
In una fase di grande povertà di pensiero e di frantumazione della classe lavoratrice – che inizia già durante il percorso universitario e, prima ancora, scolastico – è infatti vitale incoraggiare, sostenere e divulgare i risultati di elaborazioni collettive di questo tipo, di cui abbiamo più che mai bisogno.
In un ambiente universitario che dovrebbe incoraggiare ed alimentare – e invece ostacola e impoverisce – la capacità critica degli studenti, infatti, prendere in mano questo volume e scorrerne le pagine trasmette senza dubbio un sentimento di soddisfazione e speranza.
Sono tanti ed apparentemente eterogenei i temi trattati – dalle riforme dell’università alla modalità di finanziamento degli atenei, dal problema della disoccupazione giovanile all’analisi dei mutamenti del capitalismo europeo – ma gli autori sono stati a parere di chi scrive efficaci nel rendere un’idea: tutti questi aspetti, ben lungi dall’essere slegati gli uni dagli altri, sono parte integrante della cosiddetta ‘ristrutturazione neoliberista’, e come tali vanno analizzati e contrastati.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: In memoria di Preve
![]()
In memoria di Preve
di Salvatore Bravo
Il 23 novembre del 2013, cinque anni fa moriva Costanzo Preve, è il caso di ricordare un uomo, un filosofo che ha testimoniato la resistenza ai poteri e specialmente al capitalismo speculativo, come definiva l’attuale fase del capitalismo. Nei suoi innumerevoli scritti ha denunciato il nichilismo, l’alienazione della natura umana la quale da essere per sua natura di ordine simbolico è ridotta ad essere ad una funzione dell’immenso organismo cannibalico del capitalismo assoluto. La Bestimmung, la resistenza attiva e propositiva, come vocazione duratura, è stata la stella polare di un’esistenza che ha vissuto in pienezza la sua resistenza. La Filosofia è sempre Filosofia del presente, affermava, ovvero è risposta alle contingenze storiche nell’alveo della tradizione veritativa della Filosofia. La passione durevole per la Filosofia e per la politica sono state la sua catabasi, la discesa nell’agorà, sempre con l’intento di guardare in pieno viso il nichilismo del capitalismo speculativo/capitalismo assoluto da absolutus sciolto da ogni legame, curvato sull’illimitatezza, sul saccheggio ordinario non tanto delle finanze, ma della natura umana (Gattungswesen). Per C. Preve il mondo accademico della Filosofia aveva rinunciato alla Filosofia come al fondamento veritativo, i due elementi sono in relazione biunivoca.
Leggi tutto
Il Pedante: L'invasione degli ultratabù
L'invasione degli ultratabù
di Il Pedante
 Ogni
civiltà ha i suoi tabù, perché di ogni civiltà è il sacro.
Ciò che è sacro è intoccabile, inavvicinabile, perché in
origine maledetto. Scrive Pompeo Festo (De verborum
significatione) che l'homo sacer è «quem populus
iudicavit ob maleficium... quivis homo malus atque improbus».
Tra le
etimologie proposte, l'accadico sakāru rimanda appunto
all'atto del bloccare, interdire, ostruire l'accesso. In una
comunità di
persone il sacro postula l'indiscutibile, i riferimenti
invalicabili dell'identità e dei valori comuni di norma
rappresentati nella sintesi di
un simbolo o di una formula rituale. L'ambivalenza del sacro è
prospettica: nel tracciare un confine inviolabile discrimina
ciò che deve
restare fuori - il tabù - da ciò che sta dentro e
attorno a cui ci si deve raccogliere - il totem. Il
binomio freudiano
svela così i due volti del sacro: dove c'è un totem c'è un
tabù, e viceversa. Se la Repubblica Italiana si rispecchia nel
totem dell'antifascismo, il fascismo è un tabù. Se una chiesa
fissa il suo totem nel dogma, i tabù sono l'eresia e la
bestemmia
che lo negano.
Ogni
civiltà ha i suoi tabù, perché di ogni civiltà è il sacro.
Ciò che è sacro è intoccabile, inavvicinabile, perché in
origine maledetto. Scrive Pompeo Festo (De verborum
significatione) che l'homo sacer è «quem populus
iudicavit ob maleficium... quivis homo malus atque improbus».
Tra le
etimologie proposte, l'accadico sakāru rimanda appunto
all'atto del bloccare, interdire, ostruire l'accesso. In una
comunità di
persone il sacro postula l'indiscutibile, i riferimenti
invalicabili dell'identità e dei valori comuni di norma
rappresentati nella sintesi di
un simbolo o di una formula rituale. L'ambivalenza del sacro è
prospettica: nel tracciare un confine inviolabile discrimina
ciò che deve
restare fuori - il tabù - da ciò che sta dentro e
attorno a cui ci si deve raccogliere - il totem. Il
binomio freudiano
svela così i due volti del sacro: dove c'è un totem c'è un
tabù, e viceversa. Se la Repubblica Italiana si rispecchia nel
totem dell'antifascismo, il fascismo è un tabù. Se una chiesa
fissa il suo totem nel dogma, i tabù sono l'eresia e la
bestemmia
che lo negano.
Non si ha notizia di civiltà senza tabù, perché il sacro soddisfa un fabbisogno spirituale che si riscontra ovunque. Sarebbe perciò sciocco credere che i tempi laici in cui viviamo si siano emancipati dal sacro e quindi dai tabù. L'errore nasce dalla confusione di sacer e sanctus, dove il secondo rimanda in modo specifico alla sacralità religiosa. Sanctus è participio passato di sancīre, attestato anche nel significato di interdire, separare, dedicare (a una divinità), accomunato a sacer da una possibile radice comune sak-. La convergenza e quasi sovrapposizione nell'uso dei due termini sembra illustrare un processo che dall'era classica a quella cristiana ha progressivamente «relegato» il sacro nelle cose ultraterrene, con il vantaggio di trattare più pragmaticamente le cose umane e della terra, di schivare cioè il rischio di sacralizzarle rendendole così inconoscibili perché inaccessibili al λόγος. Un rischio che si sarebbe confermato e si sta più che mai confermando reale.
Leggi tutto
Marcello Minenna: Uno sguardo indietro
Uno sguardo indietro
Cosa ha significato realmente la “condivisione del rischio” nell’Eurozona
di Marcello Minenna
In questo post sul Financial Times Marcello Minenna, Responsabile dell’Ufficio Analisi Quantitativa e Innovazione Finanziaria della Consob, spiega, dati alla mano, che l’Italia ha sempre dato all’Unione Europea molto più di quanto ha ricevuto, e che i nostri soldi sono andati a vantaggio dei paesi “core” dell’UE, in primis Germania e Francia, anziché aiutare i paesi della periferia che versavano in difficoltà finanziarie. Ribadire in modo informato questi fatti diventa particolarmente importante oggi, mentre il nostro paese subisce attacchi quotidiani da chi ci accusa di avere “vissuto al di sopra delle nostre possibilità” e di aver approfittato indebitamente della generosità dell'”Europa”
 Uno dei dibattiti ricorrenti dopo l’eurocrisi è
stato
se gli strumenti di stabilità dovessero servire per
condividere il rischio tra gli Stati membri o, al contrario, a
isolare il rischio
all’interno dei singoli paesi. Mentre nella zona euro si
discute – rinviandole – su vere misure di condivisione del
rischio, come
l’assicurazione europea sui depositi, è importante ricordare
cosa è successo quando i rischi sono stati condivisi e chi ne
ha
effettivamente beneficiato.
Uno dei dibattiti ricorrenti dopo l’eurocrisi è
stato
se gli strumenti di stabilità dovessero servire per
condividere il rischio tra gli Stati membri o, al contrario, a
isolare il rischio
all’interno dei singoli paesi. Mentre nella zona euro si
discute – rinviandole – su vere misure di condivisione del
rischio, come
l’assicurazione europea sui depositi, è importante ricordare
cosa è successo quando i rischi sono stati condivisi e chi ne
ha
effettivamente beneficiato.
Condividere i rischi quando necessario
La narrazione comune è che i programmi di salvataggio avrebbero aiutato paesi in grave difficoltà ad evitare la bancarotta sovrana o fallimenti bancari diffusi. In realtà, nell’evitare tali esiti estremi, questi programmi proteggevano anche le banche dei paesi core – Germania e Francia, in particolare – che avevano accumulato enormi esposizioni verso la periferia prima della crisi. In quel momento, la condivisione del rischio (per quanto sgradevole) era la migliore opzione disponibile per i governi dei paesi core. Li ha salvati dall’intervenire direttamente (a spese dei loro contribuenti) per sostenere i propri sistemi bancari nazionali.
La “condivisione del rischio”, a partire dalla crisi, è sempre stata un “doppio salvataggio”. Un salvataggio per le banche della periferia, che a sua volta offriva un altro piano di salvataggio alle banche del centro.
Leggi tutto
Alessandro Robecchi: Altro che imprenditori: il partito del Pil sono gli italiani che lavorano
Altro che imprenditori: il partito del Pil sono gli italiani che lavorano
di Alessandro Robecchi
Prima di tutto una precisazione. I tremila imprenditori che l’altro giorno a Torino si sono riuniti per dire sì alla Tav e a tutto il resto (grandi opere, medie opere, tagli alla manovra) non sono, come si è scritto con toni eccitati e frementi “Il partito del Pil”. Non rappresentano, come si legge in titoli e sommari “due terzi del Pil italiano e l’80 per cento dell’export”. Il Pil italiano, e anche l’export, lo fanno milioni di lavoratori che in quelle imprese sono occupati. Gente che da anni vede assottigliarsi il suo potere d’acquisto, mentre aumentano profitti e rendite, che assiste all’erosione dei suoi propri diritti, che va a lavorare su treni affollati come gironi infernali, che sta in bilico sul baratro della proletarizzazione, che teme ogni giorno un disastro, una delocalizzazione, una vendita ai capitali stranieri, una riduzione degli organici, che combatte ogni giorno con servizi sempre più costosi, che fa la parte sfortunata della forbice che si allarga – da decenni – tra redditi da lavoro e profitti. Il Pil italiano – come il Pil di tutti i paesi del mondo – lo fanno loro, ed è piuttosto incredibile che una platea di tremila persone venga più o meno, con pochissime sfumature, identificata con l’economia italiana senza nemmeno una citazione di sfuggita, un inciso, una parentesi, che ricordi i lavoratori.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Francia: ed ora qualcosa di completamente diverso
Francia: ed ora qualcosa di completamente diverso
di Giacomo Marchetti
Il movimento politico-sociale in Francia sta mutando il suo segno. Così come il caro-benzina ha innescato il movimento dei Gilets Jaunes, così i GJ hanno fatto da “innesco” a loro volta ad un magma sociale in ebollizione che vomita tutte le contraddizioni dell’ultimo ciclo di sviluppo capitalista d’Oltralpe, la governance targata UE e l’impalcatura istituzionale pregressa della Quinta Repubblica.
Il giorno prima non è come il giorno dopo, e quello successivo non ricorda i precedenti.
Gli studenti delle medie-superiori dovevano, dopo la seconda tappa della mobilitazione, questo lunedì, ritornare a bloccare questo venerdì, ma hanno deciso di farlo anche oggi in numerosi istituti superiori, ed a Marsiglia ed a Tolosa la mobilitazione ha toccato la sua punta massima.
Sempre a Tolosa, in mattinata agricoltori e GJ hanno bloccato il deposito petrolifero di Lespinasse. Una studentessa delVictor Hugo, istituto che raccoglie studenti dei quartieri popolari ha dichiarato ad una giornalista di Le Monde: “è perché non cambiano le cose che c’è il caos“, riferendosi al montare della protesta innescata dai GJ.
Nella città fenicia 21 istituti sono stati chiusi, e i medi si sono riversati in strada cantando: “c’est la, c’est la, c’est la revolution“, scontrandosi con la polizia. Il servizio d’ordine della CGT – richiamato – è intervenuto per difendere gli studenti, che sono ripiegati dentro i locali dell’Università vicino alla stazione Saint Charles ed hanno votato all’unanimità per proseguire il blocco tutta la settimana.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3171
Emiliano Brancaccio: Contro le sinistre "codiste"
Hits 2597
Domenico Moro: L’esplosione del debito pubblico senza un prestatore di ultima istanza
Hits 2267
Domenico Moro: L’euro come governo politico dell’accumulazione capitalistica
Hits 2162
Sonia Savioli: "Ong, il cavallo di Troia del capitalismo globale"
Hits 2120
Elisabetta Teghil: Nodi irrisolti
Hits 1937
Sergio Cesaratto: L’Italia distruggerà l’eurozona?
Hits 1905
Alessandro Pascale: Marxisti cinesi e italiani a confronto
Hits 1903
Carlo Clericetti: La Patria è di destra o di sinistra?
Hits 1797
Andrea Fumagalli: Il grande business del debito italiano
Hits 1759
Clicca
qui se vuoi cancellarti
tonino

Alessandro Visalli: Fazi e Mitchell, “Sovranità o barbarie”
Fazi e Mitchell, “Sovranità o barbarie”
di Alessandro Visalli
 Un libro importante e coraggioso,
che affronta
alcuni dei nodi fondamentali oggi davanti ai nostri occhi e
che bloccano la nostra azione, costruito con un profondo
sguardo storico e capace di
ripercorrere in poche e dense pagine gli snodi che hanno
costituito il presente. Il presente come storia,
dunque.
Un libro importante e coraggioso,
che affronta
alcuni dei nodi fondamentali oggi davanti ai nostri occhi e
che bloccano la nostra azione, costruito con un profondo
sguardo storico e capace di
ripercorrere in poche e dense pagine gli snodi che hanno
costituito il presente. Il presente come storia,
dunque.
A me pare che una delle chiavi interpretative del testo sia da rintracciare nella dialettica delle durate, proposta da Braudel nel 1949[1], tra increspature superficiali, movimenti lenti dati dalle trasformazioni dei rapporti di produzione e mutamenti del sentire collettivo ed evoluzioni tecnologiche[2], e, al fondo, trasformazioni del sistema naturale, lentissime ma potenti. Quel che compiono gli autori, per gran parte del testo, è quel che Cervantes[3] chiama scrivere di storia, “madre della verità”. Storia, cioè, come verità narrata; non ciò che avvenne, ma ciò che giudichiamo essere avvenuto[4]. Una narrazione nella quale compare il problema del nesso tra la volontà dei singoli, nella loro interazione reciproca, e i fattori determinanti inerenti le ‘durate’ più lente, le strutture nella loro dialettica. Quanto valgono i piani dei capi nello svolgimento di una battaglia? Quanto conta che Kutuzov si addormenti mentre altri fanno complessi piani in “Guerra e pace”[5]?
Ancora più, la storia narrata da Fazi e Mitchell è storia militante; serve, la loro narrazione, a scopi evidenti nel testo. Ma il pathos narrativo che appare evidente in ogni pagina (con la loro partecipazione emotiva e la tensione morale) è esso stesso strettamente parte della storia narrata. Perché, come sostengono gli autori, questa storia, la sua verità, ci riguarda e ci contiene.
Si sta parlando dunque del nostro presente, incorporato nell’imperialismo dell’economico e nella onnipresenza di una dinamica di contrazione (e di espansione per pochi privilegiati) che origina nella ‘crisi’ degli anni settanta. O meglio, come scrivono, “almeno” degli anni settanta.
Leggi tutto
Il Pungolo Rosso: Il movimento dei “gilet gialli”
Il movimento dei “gilet gialli”
di Il Pungolo Rosso
 Abbiamo selezionato
dei materiali sul
movimento dei “gilet gialli” in Francia per i visitatori di
questo blog (che riprendiamo dal sito alencontre.org,
su cui è presente un’ampia e aggiornata documentazione).
Abbiamo selezionato
dei materiali sul
movimento dei “gilet gialli” in Francia per i visitatori di
questo blog (che riprendiamo dal sito alencontre.org,
su cui è presente un’ampia e aggiornata documentazione).
Il primo è un articolo di Alain Bihr, che consideriamo l’analisi più attendibile della composizione di classe del movimento e della sua essenziale spontaneità, e un’altrettanto attendibile presa d’atto della distanza da esso della sinistra liberal-democratica o riformista, ma anche di buona parte della sinistra sindacale e politica che si professa anti-capitalista (questo, a prescindere dal concordare o no con le sue indicazioni e raccomandazioni politiche). Il secondo è un elenco delle rivendicazioni emerse dai diversi comitati (che hanno differenti composizioni sociali).
Questo movimento è partito da una rivendicazione assai limitata (e certo inter-classista) riguardante l’aumento del prezzo del carburante, e ha poi espresso, nel corso del suo ampliamento e della sua radicalizzazione, una serie di rivendicazioni che rispecchiano in pieno il malessere, la rabbia, le aspettative e le istanze di strati sociali appartenenti a due distinte classi sociali (classe lavoratrice/proletariato, piccola borghesia).
E’ un movimento meno ampio di quello contro la Loi Travail, ma più arrabbiato, almeno finora più determinato, se è vero che non è arretrato davanti ad una repressione statale massiccia e non ha ceduto alle prime avances del governo e di Macron. Ma è certamente minato al suo interno da questa eterogeneità originaria, dato che non esistono le indistinte “moltitudini”, né gli indistinti “popoli” evocati dai “sovranisti”. Proprio su questa eterogeneità fa leva l’establishment per provocarne il rinculo e lo sfaldamento.
Leggi tutto
Francesco Coniglione: La scienza degli “ignoranti” e quella dei “sapienti”. Ovvero, dove sta la vera indigenza cognitiva
La scienza degli “ignoranti” e quella dei “sapienti”. Ovvero, dove sta la vera indigenza cognitiva
di Francesco Coniglione
 È
interessante fare un’analisi delle reazioni che si hanno su
Facebook [questo thread, per esempio]
quando si vengono
a toccare temi particolarmente impegnativi e che si
riferiscono a convinzioni profondamente radicate nei lettori.
È quanto accaduto –
dopo il mio primo articolo su “Scienza,
antiscienza e Barbara Lezzi” – al secondo articolo sull’ignoranza, la
scienza
e il burionismo: si leggono sulle pagine di FB e nei
commenti al post un certo numero di argomenti e atteggiamenti
ricorrenti che sarebbe
superficiale non prendere in considerazione. La prima cosa che
salta agli occhi è che una parte dei lettori esibisce il
comportamento del toro
cui si sventola davanti il drappo rosso: appena si toccano
certi capisaldi delle loro convinzioni gli scatta la
compulsione da tastiera e scrivono
commenti più o meno piccati, ma che spesso hanno in comune la
caratteristica di aver letto male o di aver poco capito (o a
volte di non aver
letto affatto) quanto è stato scritto. Questi rappresentano
quella che si potrebbe definire la “minoranza rumorosa”: la
gran parte
delle persone che ha letto l’articolo e lo ha condiviso non ha
bisogno di argomentare la propria condivisione (gli argomenti
sono contenuti
già in ciò che si condivide, li si fa propri) e così esprime
di solito il proprio apprezzamento che con un “like”.
Mentre chi invece non condivide, sente il bisogno di dirlo
(non esiste un “I don’t like”), e spesso di urlare la propria
disapprovazione. Così, se vogliamo fare i conti, i “critici
critici” sono molto più visibili ma in effetti sono spesso una
sparuta minoranza rispetto a coloro che hanno “likeizzato” e
condiviso, almeno in parte, un articolo.
È
interessante fare un’analisi delle reazioni che si hanno su
Facebook [questo thread, per esempio]
quando si vengono
a toccare temi particolarmente impegnativi e che si
riferiscono a convinzioni profondamente radicate nei lettori.
È quanto accaduto –
dopo il mio primo articolo su “Scienza,
antiscienza e Barbara Lezzi” – al secondo articolo sull’ignoranza, la
scienza
e il burionismo: si leggono sulle pagine di FB e nei
commenti al post un certo numero di argomenti e atteggiamenti
ricorrenti che sarebbe
superficiale non prendere in considerazione. La prima cosa che
salta agli occhi è che una parte dei lettori esibisce il
comportamento del toro
cui si sventola davanti il drappo rosso: appena si toccano
certi capisaldi delle loro convinzioni gli scatta la
compulsione da tastiera e scrivono
commenti più o meno piccati, ma che spesso hanno in comune la
caratteristica di aver letto male o di aver poco capito (o a
volte di non aver
letto affatto) quanto è stato scritto. Questi rappresentano
quella che si potrebbe definire la “minoranza rumorosa”: la
gran parte
delle persone che ha letto l’articolo e lo ha condiviso non ha
bisogno di argomentare la propria condivisione (gli argomenti
sono contenuti
già in ciò che si condivide, li si fa propri) e così esprime
di solito il proprio apprezzamento che con un “like”.
Mentre chi invece non condivide, sente il bisogno di dirlo
(non esiste un “I don’t like”), e spesso di urlare la propria
disapprovazione. Così, se vogliamo fare i conti, i “critici
critici” sono molto più visibili ma in effetti sono spesso una
sparuta minoranza rispetto a coloro che hanno “likeizzato” e
condiviso, almeno in parte, un articolo.
Inoltre risulta ovvio che ciascuno ha una sua posizione peculiare e che non si può essere d’accordo su tutto. Così nelle risposte io, come anche De Nicolao, abbiamo criticato chi ripete sempre le stesse obiezioni, dimostrando di non aver ben letto quanto scritto oppure scambiando il fuscello per la trave.
Leggi tutto
Daniel Blake: La controrivoluzione del capitale umano
La controrivoluzione del capitale umano
di Daniel Blake
La costruzione del capitalista umano è l’obiettivo delle politiche del workfare. A partire dal libro Capitale Disumano di Roberto Ciccarelli, una riflessione sulla radice teorica delle politiche attive e sulla loro funzione di disciplinamento della forza lavoro
 Quelle che seguono sono
brevi riflessioni a partire dall’ultimo libro di Roberto
Ciccarelli,
Capitale Disumano. La vita in alternanza scuola lavoro
(manifestolibri, 2018, pp. 222, € 16). Un testo che
propone
un’efficace critica della nozione beckeriana di capitale
umano, incardinata all’interno del paradigma neoliberale delle
politiche attive.
Sin dalle prime pagine si chiarisce che a sperimentare l’alternanza
scuola lavoro non sono solo 1,5 milioni di studenti
obbligati a
partecipare a questo programma (introdotto in Italia nel
2015), ma complessivamente l’intera forza lavoro sempre più
spesso incentivata,
o talvolta obbligata, a muoversi tra continui momenti di
accumulazione di competenze e occupazioni precarie.
Quelle che seguono sono
brevi riflessioni a partire dall’ultimo libro di Roberto
Ciccarelli,
Capitale Disumano. La vita in alternanza scuola lavoro
(manifestolibri, 2018, pp. 222, € 16). Un testo che
propone
un’efficace critica della nozione beckeriana di capitale
umano, incardinata all’interno del paradigma neoliberale delle
politiche attive.
Sin dalle prime pagine si chiarisce che a sperimentare l’alternanza
scuola lavoro non sono solo 1,5 milioni di studenti
obbligati a
partecipare a questo programma (introdotto in Italia nel
2015), ma complessivamente l’intera forza lavoro sempre più
spesso incentivata,
o talvolta obbligata, a muoversi tra continui momenti di
accumulazione di competenze e occupazioni precarie.
Affrontare la critica del capitale umano all’incrocio con le politiche attive ha una serie di vantaggi, tra cui quello di individuare le istituzioni del welfare che contribuiscono a fabbricare socialmente il «capitalista umano». Secondo questa prospettiva, il capitalista umano smette di essere il prodotto spontaneo di una serie di dispositivi economici, sociali, culturali, simbolici – come talvolta viene superficialmente presentato anche in una certa letteratura critica – per diventare il risultato di politiche di workfare che regolano il funzionamento del mercato del lavoro in tutte le economie avanzate.
Proviamo a interrogare il libro a partire da una specifica domanda: all’interno di questo ciclo reazionario globale come stanno cambiando i programmi di politica attiva e come vanno trasformandosi in particolare i dispositivi workfaristici di costruzione del capitale umano?
L’active labour market policy e le teorie del capitale umano
Quando in genere si parla di politiche attive ci si riferisce a un complesso sistema di politiche pubbliche che oltre a promuovere la formazione o altri interventi più rivolti al capitalista umano, hanno complessivamente lo scopo di aumentare i tassi di attivazione nel mercato del lavoro.
Leggi tutto
coniarerivolta: Europeisti e nazionalisti: le due facce del liberismo
Europeisti e nazionalisti: le due facce del liberismo
di coniarerivolta
Potere al Popolo! ha recentemente lanciato un invito al dibattito ed al confronto sull’Europa, in vista delle elezioni europee del 2019. Accogliamo l’invito e pubblichiamo il nostro primo contributo sul tema
Il dibattito politico è costruito sulla retorica, in particolare sulle figure retoriche. Una di queste è la cosiddetta “falsa dicotomia”: si riduce il discorso politico a due alternative, reciprocamente esclusive e, contemporaneamente, onnicomprensive. Per circa un ventennio, in Italia, le alternative del discorso politico sono state rappresentate dal centrosinistra e dal berlusconismo. I tempi, però, cambiano, e la falsa dicotomia più in voga di questi tempi è senz’altro quella che contrappone europeisti e nazionalisti.
Gli europeisti, siano essi uomini politici o semplici cittadini, di fronte alle critiche all’Unione Europea, ai Trattati e all’austerità, agitano lo spauracchio del ritorno al nazionalismo. Sì, certo, si può criticare l’intransigenza della Commissione Europea, si possono chiedere “margini di flessibilità”, ci si può mettere alla ricerca di un’Altra Europa (con Tsipras o con Varoufakis – più o meno), ma se non si considera il processo di integrazione economica europea come un luminoso esempio di progresso dell’umanità, si viene immediatamente relegati nel girone infernale dei nazionalisti, dei barbari feticisti dei confini, dei bacchettoni fustigatori dell’Erasmus. In una sola, terribile, parola: dei “sovranisti”.
Leggi tutto
Vanni Codeluppi: Digitale
Digitale
di Vanni Codeluppi
Gli scienziati sociali hanno spesso tentato negli ultimi decenni di coniare delle etichette allo scopo di definire sinteticamente le principali caratteristiche delle società contemporanee. Tali etichette però di solito hanno incontrato delle difficoltà, a causa della natura sfuggente dei sistemi sociali odierni. Pertanto, si è continuato a cercarne delle nuove. Tra queste, negli ultimi anni il concetto di “digitale” e la sua contrapposizione con quello di “analogico” hanno conosciuto un certo successo. Addirittura alcuni autori hanno parlato dell’esistenza di una “rivoluzione digitale”. L’universo digitale oggi è sicuramente importante socialmente, anche se non è possibile racchiudere in esso le multiformi dimensioni delle società contemporanee. Il concetto di digitale merita comunque di essere attentamente considerato.
Sulla natura del digitale si è interrogato, nel recente volume The Game (Einaudi), lo scrittore Alessandro Baricco, il quale spiega come il termine derivi dal latino digitus, cioè dito, e rimandi fondamentalmente al concetto di “numerico”, in conseguenza della capacità delle dita di consentire agli esseri umani di contare. Ma per Baricco il termine digitale corrisponde anche a un sistema estremamente efficace per tradurre in un dato numerico qualsiasi cosa esista nell’universo. Si tratta infatti di un geniale metodo grazie al quale è possibile trasformare, ad esempio, i suoni dell’universo oppure i dipinti della storia dell’arte in qualcosa che può essere facilmente stoccato, modificato e diffuso socialmente.
Leggi tutto
Geraldina Colotti: I falchi del Pentagono puntano a Caracas
I falchi del Pentagono puntano a Caracas
di Geraldina Colotti
Nella sala stampa del Palazzo Miraflores, l'entrata di tutti gli alti comandi militari e dei rappresentanti di governo annuncia l'importanza dell'incontro. Le parole del presidente Nicolas Maduro, precise e circostanziate, fanno tremare i polsi. Dice che John Bolton, assessore per la sicurezza di Trump, ha avuto l'incarico di incendiare di violenza il Venezuela, uccidere Maduro e provocare un intervento militare per formare un governo di transizione. Il piano – spiega il presidente – prevede l'attivazione di alcuni punti nei quali già sono presenti gruppi armati, pronti a entrare in azione con diverse strategie. Per questo, sono stati già disposti finanziamenti nell'ordine di 120 milioni di dollari.
Le riprese dall'alto, frutto di un capillare lavoro di intelligence e di contatti ben collocati all'interno stesso di quei paesi governati dal complesso militare-industriale, mostrano i campi di addestramento. Nel nord di Santander, in Colombia, si sta allenando un gruppo paramilitare denominato G8, composto da 730 mercenari. Hanno divise della Forza Armata Nazionale Bolivariana e della polizia, per creare false situazioni di conflitto armato alla frontiera e provocare l'intervento esterno. Un altro gruppo di mercenari è operativo nella “base aerea del Tolemaida, nel Megar, nella zona amazzonica, una delle sette basi aeree degli Usa in Colombia”.
Leggi tutto
Guido Viale: Tav. La dittatura dell’ignoranza
Tav. La dittatura dell’ignoranza
di Guido Viale
L’Italia deve ripartire, andiamo avanti. La retorica dei sostenitori politici e mediatici del Si Tav è disarmante. Nessuno entra ormai nel merito delle questioni di cui parla. Sarebbe sconveniente, d’altra parte, ammettere come le Grandi Opere inutili siano la quintessenza di quel capitalismo finanziario, estrattivo e predatorio – e parassitario nei confronti dello Stato – che si maschera dietro il termine neoliberismo. La dittatura dell’ignoranza è il titolo di un libro in versi di Giancarlo Majorino che Viale ha preso in prestito anni fa per designare il “liberismo” o “neoliberismo” del giorno d’oggi. Quel neoliberismo ha bisogno di una rappresentazione della realtà falsa, che impedisce di vedere e capire quello che ci sta intorno. Genera e prospera nell’ignoranza. Ed è una dittatura, perché questa visione viene imposta come “pensiero unico”, travalicando l’ambito delle discipline e delle attività economiche per imporre una “cultura” della competizione universale. Andiamo avanti e schiantiamoci!
La dittatura dell’ignoranza è il titolo di un libro in versi di Giancarlo Majorino che ho preso in prestito alcuni anni fa per designare il “liberismo” o “neoliberismo” del giorno d’oggi. Ignoranza, perché il neoliberismo è una rappresentazione della realtà falsa, che impedisce di vedere e capire quello che ci sta intorno, a partire dalla natura stessa del sistema in cui siamo immersi; che non è l’economia di un mercato concorrenziale, ma un regime estrattivo e predatorio in mano a un numero infimo di padroni della Terra, basato sull’accaparramento di risorse naturali, finanziarie e umane attraverso una competizione sempre sorretta dal sostegno finanziario e politico di uno Stato.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Sicure, ordinate e regolate
![]()
Sicure, ordinate e regolate
Le migrazioni dei figli di sabbia del Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, dicembre 2018. Il patto globale pensato per le migrazioni le vuole proprio così. Sicure, ordinate e soprattutto regolate. La dottrina dell’OIM è stata dunque fatta propria dalle Nazioni Unite e da buona parte dei Paesi che l’hanno assunta. Si presenta così la migrazione che si vuole imporre per i figli di sabbia del Sahel come altrove nel sud del mondo. La sicurezza che a noi interessa è quella alimentare, quella di curarsi quando malati e quella di pagare l’affitto a fine mese. Ci preme la sicurezza che i figli possano terminare l’anno scolastico e che le pioggie arrivino puntuali all’appuntamento desiderato. Ci affascina la sicurezza che dovrebbe accompagnare chi ha scelto di viaggiare. Per chi osa tradurre la mobilità in frontiere che si trasformano in passerelle strada facendo. La sicurezza che imponete è diventata appannaggio, qui come nel nord del mondo, dei militari e delle ditte che ne hanno fatto uno dei business tra i più lucrativi. Se migrazioni sicure significa per voi migrazioni scelte allora non è evitabile la domanda a chi appartenga il diritto di scegliere. Noi vorremmo essere sicuri di arrivare a destinazione e di essere trattati come soggetti di diritti umani. Vorremmo da voi la sicurezza di non essere detenuti e poi rispediti di forza alla sabbia da cui veniamo.
Quanto poi ad essere ordinate, le migrazioni che esigete, ciò suona come un’illusione di cattivo gusto. Fate di tutto per sregolare l’economia, la politica, il commercio, la cultura, la democrazia, i nascituri e il clima.
Leggi tutto
Lorenzo Battisti: Gilets Jaunes, Macron e i ritardi della sinistra
Gilets Jaunes, Macron e i ritardi della sinistra
di Lorenzo Battisti
Pubblichiamo come contributo alla discussione
 Il
movimento dei gillet gialli, che ha attraversato la Francia
nell’ultimo mese ha
avuto una grossa eco anche in Italia, accompagnata come sempre
da disinformazione e da superficialità. Il movimento è
espressione della
Francia socialmente periferica. E se rischia di cadere a
destra, è solo grazie ai ritardi della sinistra.
Il
movimento dei gillet gialli, che ha attraversato la Francia
nell’ultimo mese ha
avuto una grossa eco anche in Italia, accompagnata come sempre
da disinformazione e da superficialità. Il movimento è
espressione della
Francia socialmente periferica. E se rischia di cadere a
destra, è solo grazie ai ritardi della sinistra.
L’ecologismo di classe del presidente dei ricchi
Il movimento prende il via da una protesta contro la tassa ecologica sui diesel, volta a finanziare il passaggio ecologico verso automobili meno inquinanti. L’idea di Macron era quella di prelevare dai cittadini che utilizzano auto inquinanti (diesel in particolare) per finanziare il passaggio ad auto elettriche e ibride, con finanziamenti di 4 o 5000 euro per chi avesse acquistato una di queste automobili.
Il problema è che, sotto la patina ecologica, si celava l’ennesima manovra di classe. Chi utilizza queste vecchie auto inquinanti (un tempo peraltro ritenute meno inquinanti di quelle a benzina in termini di Co2) sono cittadini che si trovano in difficoltà economiche e che non possono quindi acquistare auto nuove. Neanche con gli aiuti promessi dal Presidente: anche con 5000 euro di finanziamenti, se ne hai meno di 1000 euro sul conto, non ci fai niente. E, al contrario di quelli che vivono nei centri urbani, non puoi sfoggiare il tuo lato ecologico andando in bici al lavoro e non ci sono metro o servizi pubblici adeguatamente flessibili e veloci da essere un’alternativa all’auto.
L’aumento delle accise si trasforma quindi semplicemente nell’ulteriore imposta sul consumo, che come tutte le imposte indirette (come l’Iva) pesa proporzionalmente di più sui redditi bassi, che hanno percentuali di risparmio più basse e che quindi ne portano il peso molto più dei ricchi. E in più, il gettito sarebbe stato usato per finanziare l’acquisto di auto da parte di chi di soldi li ha. Una vera e propria redistribuzione verso l’altro.
Leggi tutto
Daniela Palma: A lezione da Keynes, ripensando la macroeconomia
A lezione da Keynes, ripensando la macroeconomia
Recensione de “La scienza inutile” di F. Saraceno
di Daniela Palma
Francesco Saraceno: La scienza inutile: Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia,Luiss University Press (2018), https://www.luissuniversitypress.it/pubblicazioni/la-scienza-inutile
 Tra le
conseguenze della crisi che ormai da un decennio sta
attraversando l’economia
mondiale, non si contano solo fallimenti finanziari e una
diffusa stagnazione delle attività produttive. Lo stupore
con cui la regina
Elisabetta nel novembre del 2008 chiedeva ad autorevoli
professori della London School of Economics come mai
nessuno fosse stato in grado di
prevedere un evento di proporzioni così rilevanti, ci ha
avvisati infatti della crisi che stava per investire la
scienza economica corrente e
segnatamente la macroeconomia. Bene fa perciò Francesco
Saraceno con il saggio “La scienza inutile” a lanciare la
sua provocazione,
per poi subito precisare che si può imparare dall’economia
(e molto) purché la si legga con le lenti giuste.
Tra le
conseguenze della crisi che ormai da un decennio sta
attraversando l’economia
mondiale, non si contano solo fallimenti finanziari e una
diffusa stagnazione delle attività produttive. Lo stupore
con cui la regina
Elisabetta nel novembre del 2008 chiedeva ad autorevoli
professori della London School of Economics come mai
nessuno fosse stato in grado di
prevedere un evento di proporzioni così rilevanti, ci ha
avvisati infatti della crisi che stava per investire la
scienza economica corrente e
segnatamente la macroeconomia. Bene fa perciò Francesco
Saraceno con il saggio “La scienza inutile” a lanciare la
sua provocazione,
per poi subito precisare che si può imparare dall’economia
(e molto) purché la si legga con le lenti giuste.
Quella compiuta dall’autore è innanzitutto una scelta di metodo, che però va diritta al merito delle risposte che l’economia intesa come scienza è in grado di fornire. Ed è proprio questo il punto in cui si incardina tutto il ragionamento di Saraceno. Va ricordato infatti che i fenomeni economici non sono l’espressione di “leggi universali che regolano il comportamento umano”, ma si inquadrano in contesti storicamente determinati che condizionano nel tempo e nello spazio l’agire dei diversi soggetti. Respingendo l’approccio storico, la teoria economica tuttora dominante si rifà ai principi della cosiddetta scuola neoclassica, secondo la quale il sistema economico è l’espressione delle scelte ottimizzanti di individui razionali e tende a convergere verso uno stato di equilibrio di piena occupazione delle risorse.
Leggi tutto
Maurizio Gribaudi: I gilet gialli. Modernità “à la Macron”, democrazia diretta e ideologia
I gilet gialli. Modernità “à la Macron”, democrazia diretta e ideologia
di Maurizio Gribaudi
Rilanciamo un articolo uscito per storiamestre.it a proposito delle lotte dei cosiddetti “gilet jaunes”, di Maurizio Gribaudi, direttamente da Parigi, . Questo è il primo di una serie di interventi sul tema che Effimera ospiterà, quale occasione di approfondimento riguardo a delle proteste tanto discusse quanto facilmente liquidare e liquidabili nei dibattiti correnti
 1. Ecco che persino la Francia, a quanto
sembra, comincia a imboccare le
stesse strade percorse dai vari demagoghi che hanno occupato
la scena pubblica in molte democrazie occidentali. Con uno
slancio tanto forte quanto
inedito, i messaggi lanciati in rete da cittadini e cittadine
disperati hanno dato vita a un movimento nazionale che scuote
la maggioranza di governo
e preoccupa, a ragion veduta, la Francia umanista e
libertaria, inquieta per gli sviluppi che questo movimento
potrà avere. Infatti, dietro la
massa indistinta dei gilet gialli, alcuni credono di scorgere
i foschi contorni della destra conservatrice e reazionaria e
dei populismi.
1. Ecco che persino la Francia, a quanto
sembra, comincia a imboccare le
stesse strade percorse dai vari demagoghi che hanno occupato
la scena pubblica in molte democrazie occidentali. Con uno
slancio tanto forte quanto
inedito, i messaggi lanciati in rete da cittadini e cittadine
disperati hanno dato vita a un movimento nazionale che scuote
la maggioranza di governo
e preoccupa, a ragion veduta, la Francia umanista e
libertaria, inquieta per gli sviluppi che questo movimento
potrà avere. Infatti, dietro la
massa indistinta dei gilet gialli, alcuni credono di scorgere
i foschi contorni della destra conservatrice e reazionaria e
dei populismi.
In un contesto del genere, c’è davvero molto su cui interrogarsi. La Francia si sta forse accodando, inesorabilmente, a Orban, Putin, Trump, Salvini, agli inglesi della Brexit o ancora al sinistro Bolsonaro? Interpellato direttamente dai manifestanti, il presidente Emmanuel Macron ha risposto con un messaggio che voleva essere allo stesso tempo fermo e rassicurante. Fermo nell’ostentata certezza di non aver commesso né «errori strategici di governo» né «errori di fondo», e quindi di non dover fare alcun «cambiamento di rotta». Rassicurante nella promessa di impegnarsi, nei mesi a venire, a «riconciliare il popolo francese con i suoi dirigenti».
Eppure il suo messaggio contiene tutte le aporie insite nella visione del presidente, come del resto in quella della quasi totalità dei responsabili politici delle democrazie occidentali.
Leggi tutto
Aldo Zanchetta: Accendiamo una luce sul TAV Torino-Lione?
![]()
Accendiamo una luce sul TAV Torino-Lione?
di Aldo Zanchetta
 Cosa sanno
gli italiani del Treno Alta Velocità Torino-Lione? Ah no,
scusate,
del “treno trasporto ad alta intensità di merci” Torino–Lione?
Cosa sanno
gli italiani del Treno Alta Velocità Torino-Lione? Ah no,
scusate,
del “treno trasporto ad alta intensità di merci” Torino–Lione?
Come, non lo sapevate che è questa in realtà la natura del progetto. L’alta velocità (di trasporto passeggeri) è servita a eccitare la fantasia di quegli italiani, tanti sia destra che a sinistra, ammaliati dal mito del Progresso e dello Sviluppo. Alta intensità di trasporto merci che richiede binari diversi, atti a sopportare grandi carichi, rispetto a quelli per l’alta velocità dei treni passeggeri. Due cose fra loro incompatibili sullo stesso binario.
Ho scritto “progetto” e non “realizzazione in corso”. Anche qui l’informazione corrente ha confuso le idee. Sospendere un “progetto” è ben diverso, dal punto di vista finanziario, che sospendere dei lavori in corso, specie se già avanzati. A parte una serie di lavori accessori, fra i quali il tunnel geognostico di Chiomonte (6 mt di diametro e 7 km di lunghezza; sul significato di questa parola oscura tornerò), nessuna opera di scavo del tunnel è stata fino ad oggi appaltata (sta per esserlo, però) e quindi in caso di cancellazione non c’è nessuna penale da pagare, a nessuno, né alle imprese, né alla controparte francese, solo 500 milioni di euri all’Unione Europea, nulla rispetto ai tanti miliardi per la realizzazione di un progetto inutile, che verrebbero gettati al vento (o meglio, in conti correnti bancari ben precisi).
Inutile trasportare le merci? Ma lo sviluppo, il PIL? Allora iniziamo a vedere meglio le cose.
L’idea di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione nacque all’inizio degli anni ’90 del secolo passato nei salotti di casa Agnelli, i grandi patron di Torino. Cioè quasi trent’anni or sono. Coi tempi che corrono 30 anni sono un’eternità. Si prevedeva un ingente aumento di traffico merci con la Francia per cui la linea ferroviaria esistente sarebbe stata presto saturata (ma nessuno ha mai visto le carte su cui era basata la previsione: solo discorsi, non studi circostanziati).
Leggi tutto
Francesco Sisci: Vi spiego cosa cela lo scontro tra Stati Uniti e Huawei
Vi spiego cosa cela lo scontro tra Stati Uniti e Huawei
Michele Pierri intervista Francesco Sisci
Il sinologo Francesco Sisci, saggista, editorialista e ricercatore della China’s People’s University, commenta a Formiche.net l'arresto della numero due di Huawei Meng Wanzhou e le ragioni della contesa globale in atto (commerciale ma non solo) tra Washington e Pechino
L’arresto
in Canada del direttore finanziario del colosso cinese
Huawei Technologies,
Meng Wanzhou, non una “semplice” manager ma
figlia del fondatore del gruppo Ren Zhengfei,
lancia un
messaggio ben preciso degli Stati Uniti ai vertici politici
della Repubblica Popolare.
A crederlo è il sinologo Francesco Sisci – saggista, editorialista e ricercatore della China’s People’s University – che in una conversazione con Formiche.net spiega perché l’avvenimento “cela l’esplosione di una più ampia contesa globale, commerciale ma non solo, in atto tra Washington e Pechino”.
* * * *
Le autorità canadesi hanno arrestato a Vancouver su richiesta Usa il direttore finanziario del colosso cinese Huawei Technologies, Meng Wanzhou, non una “semplice” manager ma figlia del fondatore del gruppo Ren Zhengfei. Che cosa sta succedendo?
Il governo americano ha già da tempo una partita aperta con Huawei, accusata in questo caso specifico di aver violato le sanzioni all’Iran, ritenute da Washington un obiettivo strategico.
Leggi tutto
Andrea Muratore: La “trappola di Tucidide” rivela i perché della guerra tra Cina e Usa
La “trappola di Tucidide” rivela i perché della guerra tra Cina e Usa
di Andrea Muratore
La relazione tra Cina e Stati Uniti modella, oggigiorno, la linea di tendenza delle relazioni internazionali: le due principali potenze planetarie, infatti, sono inevitabilmente attratte l’una dall’altra, si vedono reciprocamente come partner imprescindibile e principale avversario potenziale.
Per la prima volta dopo il crollo dell’Unione Sovietica la Cina, non a caso definita “potenza revisionista” nella prima National Security Strategy firmata Donald J. Trump, si è consolidata nel rango di potenza capace di intaccare l’egemonia politica, economica e militare detenuta dagli Stati Uniti su scala globale. La rivalità sino-americana corre di pari passo all’attrazione fatale che avvolge i sistemi economici dei due Paesi e si manifesta in diversi scenari di crisi (dalla faglia indo-pakistana al Mar Cinese Meridionale), oltre che nelle reiterate schermaglie commerciali, rendendo necessaria una domanda: un conflitto militare diretto tra Pechino e Washington è da ritenersi possibile?
La trappola di Tucidide
A tale domanda ha provato a rispondere Graham T. Allison, professore alla John F. Kennedy School of Government di Harvard, nel suo testo fondamentale Destined for War, pubblicato nel 2017 e subito entrato nelle librerie personali di tutti gli alti decisori strategici statunitensi, primo fra tutti il National Security Advisor H. R. McMaster.
Leggi tutto
Benedetto Vecchi: Karl Marx impigliato nel futuro
Karl Marx impigliato nel futuro
di Benedetto Vecchi
Un sentiero di lettura, in cinque libri di recente pubblicazione, per orientarsi nel bicentenario del pensatore di Treviri. Un modo per rimettere al lavoro il Moro, evidenziandone i «punti di stress»
Due secoli separano il presente dall’anno di nascita di Karl Marx. In termini di anni (duecento), l’immagine evocata è quella di un uomo e di un’opera di altri tempi, ottocentesca. Eppure la sua critica all’economia politica, la sua antropologia filosofica, la sua militanza politica hanno condizionato gran parte del Novecento. Era quindi prevedibile che studiosi – marxisti e non solo – facessero i conti con la sua eredità teorica. Molte sono state le pubblicazioni dedicate al Moro. Difficile individuarne contorni netti, tuttavia. Ne esce semmai una costellazione tematica, talvolta sfuggente.
In primo luogo, emergono quelli che David Harvey ha chiamato i «punti di stress» dell’opera marxiana. La teoria del valore lavoro, la distinzione tra lavoro produttivo e improduttivo, la definizione della necessità di una organizzazione politica che valorizzasse l’autonomia della classe operaia. La polarità tra una tendenza globale del capitale (la formazione di un mercato mondiale, o per usare una espressione di Etienne Balibar di «capitalismo assoluto») e una «nazionalizzazione» della base economica del capitalismo stesso.
Leggi tutto
Stefano Fassina: Momento Tsipras per Salvini-Di Maio
Momento Tsipras per Salvini-Di Maio
Dovevano seguire il documento Savona
di Stefano Fassina
Erano partiti bene, coraggiosamente. La sera del 27 settembre scorso, Palazzo Chigi, a conclusione del Consiglio dei Ministri, si comunicava un ambizioso programma di finanza pubblica, in netta discontinuità con la lunga stagione dell’austerità: nella nota di aggiornamento al Def, il deficit obiettivo per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 sarebbe stato fissato al 2,4% del Pil. Attenzione: in linea con i dati dell’ultima legislatura, ma una significativa, “senza precedenti” secondo le parole dei Commissari europei, forzatura del Fiscal Compact per rivitalizzare l’economia italiana e affrontare le drammatiche condizioni sociali di larga parte del Paese.
Una forzatura coerente con il mandato elettorale, necessaria, avevo scritto qui a caldo e difficilissima da difendere dalle valutazioni politiche della Commissione e dei governi Ue, da un lato, e dalle reazioni dei cosiddetti mercati, dall’altro. Un radicale cambio di rotta, almeno sul piano macroeconomico: dalla linea mercantilista a quella keynesiana dall’affidamento esclusivo alle esportazioni, al primato della domanda interna dal martellamento autolesionista del deficit per provare a ridurre il peso del debito pubblico sul prodotto, al sostegno del denominatore, il prodotto.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Decreto Salvini, la legge che precarizza la sicurezza
Decreto Salvini, la legge che precarizza la sicurezza
di Ugo Boghetta
Si stanno moltiplicando le proteste, in particolare degli enti locali, in merito agli effetti prodotti dall’applicazione della Legge in/sicurezza voluta da Salvini.
L’aver circoscritto il diritto alla tutela per motivi umanitari dal resto degli immigrati (cosa in sè affatto scandalosa) comporta l’espulsione da questi centri dei non aventi più diritto. Ciò comporta l’irrompere sui territori di centinaia e migliaia di immigrati senza collocazione. Costoro inevitabilmente andranno ad ingrossare le periferie e le zone dove già la concentrazione di disagio è alta. Sul piano umano, una condizione davvero drammatica.
Questa situazione è la vera falla del provvedimento ed è un effetto voluto.
Una legge ed un Ministro non possono non prevedere la gestione di una situazione prodotta dall’applicazione del provvedimento.
I casi sono due. Il Ministro vuole gettare benzina sul fuoco, ma a questo punto sarebbe anche lui il colpevole, oppure prevede una mossa in un secondo tempo.
Questa non può che essere la caccia al clandestino e la sua reclusione nelle vecchie carceri previste per i migranti ed in nuove carceri da costruire.
Immaginiamo che queste carceri saranno costruite ed anche gestite da privati: diversi dai primi. Del resto non c’è altra soluzione visto che Salvini stesso ha affermato che ci vorrà molto tempo per rimpatriare le tante persone che non hanno diritto.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3183
Hits 2626
Hits 2290
Hits 2176
Hits 1935
Hits 1914
Hits 1806
Hits 1771
tonino

Massimo De Minicis: Perché dopo la crisi del 2008 l’agenda neoliberale è ancora dominante?
Perché dopo la crisi del 2008 l’agenda neoliberale è ancora dominante?
di Massimo De Minicis
La crisi del 2008 ha dimostrato che le politiche economiche mainstream sono dannose e fallimentari, ma la “retorica” neoliberale riesce ancora dominare il dibattito e le istituzioni e ad imporre pericolosamente la sua agenda
 Dalla metà
degli anni ’90, nel sistema a capitalismo avanzato, una
crescente
interdipendenza e accresciuta competizione tra le nazioni,
identificata nel concetto teorico della globalizzazione ha determinato le
basi
concettuali per identificare nello stato sociale del periodo
post-bellico europeo un lusso non più sostenibile: “nel
dibattito
svedese, è normale ritenere che l’egualitarismo degli anni
’70 non sia sostenibile e che l’uguaglianza debba, in una
certa
misura, essere sacrificata sull’altare dell’efficienza”
(Crouch, Streek 1996).
Dalla metà
degli anni ’90, nel sistema a capitalismo avanzato, una
crescente
interdipendenza e accresciuta competizione tra le nazioni,
identificata nel concetto teorico della globalizzazione ha determinato le
basi
concettuali per identificare nello stato sociale del periodo
post-bellico europeo un lusso non più sostenibile: “nel
dibattito
svedese, è normale ritenere che l’egualitarismo degli anni
’70 non sia sostenibile e che l’uguaglianza debba, in una
certa
misura, essere sacrificata sull’altare dell’efficienza”
(Crouch, Streek 1996).
Negli stessi anni gli ambienti politici dell’Unione europea hanno rappresentato un costante discorso teorico secondo cui la globalizzazione esponeva i paesi comunitari ad una serie di sfide di fronte alle quali dovevano essere riorganizzate le modalità di governance del welfare e del sistema delle relazioni industriali. Ciò sembra aver determinato una serie di vincoli esterni per le forme istituzionali prodotti attraverso un processo di persistente normalizzazione di tali presupposti teorici. Si è andata, così, consolidando una sorta di traiettoria neoliberale (Baccaro, Howell, 2011) che ha percorso anche i processi di integrazione europea per rispondere in maniera efficace agli imperativi dell’economia globale. Procedendo a rideterminare il peculiare “modello sociale europeo” emerso e consolidatosi nel primo dopoguerra (Hay, 2003). Una serie di posizioni ideali, che prefiguravano nella variante neoliberale di integrazione comunitaria la forma migliore per rispondere ai nuovi imperativi economici, hanno assunto effetti costrittivi e vincolanti per le società europee in assenza di manifeste conferme empiriche: “gli effetti reali dei discorsi economici sulla globalizzazione sono qualcosa di indipendente dalla veridicità delle analisi” (Hay, 2001).
Leggi tutto
Franco Romanò: I gilets jaunes e la soggettività al tempo della crisi
I gilets jaunes e la soggettività al tempo della crisi
di Franco Romanò
 Il documento presentato dai Gilet
jaunes alla stampa
merita una grande attenzione perché è la prima volta che un
movimento di tale ampiezza e consenso sociale arriva alla
formulazione di
un’agenda politica di rivendicazioni che vanno molto aldilà
della causa efficiente che ha dato vita al movimento e cioè le
accise
sui carburanti le tasse cosiddette ecologiche. L’interesse sta
proprio in questa relazione fra una lotta e una piazza reali e
non immaginarie,
virtuali o di pura opinione e un’agenda politica ampia che
nasce nel contesto di quella lotta. Nel merito dei 41 punti
presentati due giorni fa
in conferenza stampa e che pubblico alla fine di questa
riflessione, ognuno potrà farsi una propria idea. Credo sia
utile, invece, discutere
una questione preliminare e cioè quale tipo di soggetto s’è
affacciato improvvisamente nel cuore dell’Europa, con
un’azione politica di massa, diffusa e dirompente e circondata
dal consenso da parte di un popolo forse meno afflitto di
altri da cretinismo
legalitario, per ragioni storiche. La questione è prioritaria
perché di lotte ne esistono un po’ ovunque in Europa e nel
mondo e
anche in Italia: dalla nuova ondata mondiale dei movimenti
femministi, alle lotte territoriali, dalle fabbriche
recuperate e occupate agli scioperi
nel settore della logistica e dei riders o a forme più
tradizionali di conflitto operaio piuttosto che le
mobilitazioni di studenti e
insegnanti. In che cosa consiste la diversità del soggetto dei
gilet jaunes e anche del tipo di soggettività che si è
espresso in
Francia in queste quattro settimane? Senz’altro la difficoltà
di ricondurlo a categorie certe o almeno note, il che ha messo
in crisi un
po’ tutti. Lasciamo perdere chi me parla come di un movimento
delle classi medie impoverite o addirittura della piccola
borghesia e crede con
questo di avere chiuso il problema: sono gli stessi che hanno
preteso per decenni di sostenere che la lotta di classe era un
residuo del passato e poi
si scoprono a dare risposte sociologiche classiste del tutto
fuorvianti e ridicolmente superficiali.
Il documento presentato dai Gilet
jaunes alla stampa
merita una grande attenzione perché è la prima volta che un
movimento di tale ampiezza e consenso sociale arriva alla
formulazione di
un’agenda politica di rivendicazioni che vanno molto aldilà
della causa efficiente che ha dato vita al movimento e cioè le
accise
sui carburanti le tasse cosiddette ecologiche. L’interesse sta
proprio in questa relazione fra una lotta e una piazza reali e
non immaginarie,
virtuali o di pura opinione e un’agenda politica ampia che
nasce nel contesto di quella lotta. Nel merito dei 41 punti
presentati due giorni fa
in conferenza stampa e che pubblico alla fine di questa
riflessione, ognuno potrà farsi una propria idea. Credo sia
utile, invece, discutere
una questione preliminare e cioè quale tipo di soggetto s’è
affacciato improvvisamente nel cuore dell’Europa, con
un’azione politica di massa, diffusa e dirompente e circondata
dal consenso da parte di un popolo forse meno afflitto di
altri da cretinismo
legalitario, per ragioni storiche. La questione è prioritaria
perché di lotte ne esistono un po’ ovunque in Europa e nel
mondo e
anche in Italia: dalla nuova ondata mondiale dei movimenti
femministi, alle lotte territoriali, dalle fabbriche
recuperate e occupate agli scioperi
nel settore della logistica e dei riders o a forme più
tradizionali di conflitto operaio piuttosto che le
mobilitazioni di studenti e
insegnanti. In che cosa consiste la diversità del soggetto dei
gilet jaunes e anche del tipo di soggettività che si è
espresso in
Francia in queste quattro settimane? Senz’altro la difficoltà
di ricondurlo a categorie certe o almeno note, il che ha messo
in crisi un
po’ tutti. Lasciamo perdere chi me parla come di un movimento
delle classi medie impoverite o addirittura della piccola
borghesia e crede con
questo di avere chiuso il problema: sono gli stessi che hanno
preteso per decenni di sostenere che la lotta di classe era un
residuo del passato e poi
si scoprono a dare risposte sociologiche classiste del tutto
fuorvianti e ridicolmente superficiali.
Leggi tutto
Francesco Ciafaloni: La frammentazione del lavoro
La frammentazione del lavoro
di Francesco Ciafaloni
 Nel corso della sua esistenza
terrena, un’idea, sempre e dovunque, opera contro il suo
significato originario e perciò
si distrugge.
Nel corso della sua esistenza
terrena, un’idea, sempre e dovunque, opera contro il suo
significato originario e perciò
si distrugge.
Marianne Weber, Max Weber: A Biography
1. La situazione presente
La frammentazione del lavoro, la sua rarefazione, è sotto gli occhi di tutti. Non è svanita solo la fabbrica tayloristica; sono sparite le aziende come enti giuridici che tengono insieme progettazione, produzione, vendita, gestione del personale, contabilità, come era normale qualche decennio fa. Non solo le piccole aziende fanno gestire la contabilità all’esterno, ma ciò che resta delle aziende grandi è tenuto insieme solo dal marchio e dal controllo finanziario. I singoli stabilimenti possono essere entità autonome, con contratti diversi. Sotto lo stesso tetto, a contatto di gomito, ci sono lavoratori impegnati nella stessa attività produttiva che dipendono da aziende diverse, mentre lo stesso gruppo o conglomerato, lo stesso ente finanziario, può svolgere le attività più disparate.
Molti lavori non sono scomparsi, si sono solo spostati dove il lavoro viene pagato poco o nulla. Anche lavori in cui la lingua è fondamentale, come i call center, vengono trasferiti dove ci sono abbastanza lavoratori in grado di parlare la lingua del paese destinatario. Vale anche per lingue non veicolari, come l’italiano. Lo sappiamo dai giornali, per le vertenze, come quelle di Almaviva, e ce ne rendiamo conto dalle telefonate promozionali non richieste, con un forte accento, che riceviamo.
Si può dire che è il mercato, bellezza! Che è la globalizzazione. Che così va il mondo e a questo dobbiamo abituarci; che così le merci e i servizi vengono prodotti in modo più efficiente, che costano di meno; che se molti posti di lavoro si distruggono con l’automazione e l’informatica, molti altri, più qualificati, se ne creano. È il capitalismo, la distruzione creatrice!
Leggi tutto
Nicoletta Forcheri: Il paradosso del doppio legame UE
Il paradosso del doppio legame UE
di Nicoletta Forcheri
 Funziona così,
l’ingiunzione paradossale. Amami, detto con voce di odio.
Abbracciami, detto con le braccia
incrociate. Oppure: Aumenta il PIL! Detto con l’ordine di
ridurre il deficit/pil e la spesa pubblica netta!
Funziona così,
l’ingiunzione paradossale. Amami, detto con voce di odio.
Abbracciami, detto con le braccia
incrociate. Oppure: Aumenta il PIL! Detto con l’ordine di
ridurre il deficit/pil e la spesa pubblica netta!
L’Italia si trova sotto ingiunzione paradossale, in quello che gli psicologi chiamano il doppio legame. Io lo chiamerei doppio cappio. Doppiamente illegittimo: anticostituzionale e anti trattati UE. Per uscirne basta evidenziarne il paradosso e la contraddizione di chi, dall’UE, ingiunge ordini cinici e schizofrenici.
Premesso che dai Trattati firmati, come Maastricht in primis e MES, che prevedono un rapporto debito/PIL 60% e un deficit/PIL di massimo il 3%, niente si evince della legittimità dell’obbligo di rimanere sotto il 2% del rapporto deficit/PIL.
Non contenti, i nostri politicanti hanno firmato il Fiscal Compact nel 2012, in Italia con un governo NON eletto, Monti dopo il golpe a Berlusconi, anzi illegittimo e dichiarato tale dalla Corte costituzionale. Il Fiscal Compact, è un trattato aggiuntivo NON inserito nel corpo dei trattati UE e TFUE e a cui, ad esempio, la Repubblica ceca e la Gran Bretagna non hanno aderito. Così come è stato sottoscritto, può senza problemi essere rescisso, a differenza dei trattati UE, la cui revoca è più complessa, non per questo non auspicabile né impossibile, almeno da Maastricht in poi.
Noi abbiamo aderito in situazione di scacco, ricatto e golpe politico: il governo Monti che, ripeto, era illegittimo. Sempre con questo governo imposto dall’alto, è stato adottato dal Parlamento, lo sfregio alla Costituzione nell’articolo 81 con l’obbligo di pareggio di bilancio nei conti pubblici. Sempre il Fiscal Compact (1), introduceva l’obbligo, più severo ancora rispetto ai criteri di Maastricht e al Trattato di Stabilità che istituiva il MES nel 1997, di ridurre di 1/20 l’anno il rapporto debito/PIL.
Leggi tutto
Figure: Il lavoro subordinato
Il lavoro subordinato
di Figure
Le caratteristiche del lavoro autonomo di seconda generazione non sono cause, quanto sintomi di una diversa concezione dei rapporti fra venditore e compratore di lavoro nell’età contemporanea. Anche al lavoratore dipendente, nonostante le grandi differenze, è così proposto un modello nel quale le richieste di libertà e autonomia trovano spazio entro un modello orizzontale, responsabilizzante, compatto. Il management contemporaneo, la gestione delle risorse umane, si occupa appunto di questo.
Per capire di cosa si tratta, un esempio interessante è quello delle dichiarazioni di Marco Minghetti, che in Italia, nel 2005, ha fondato la prima cattedra di Humanistic management. Dall’omonimo Manifesto:
Un fantasma si aggira nel mondo aziendale: lo Humanistic Management. Un modo di fare impresa nuovo rispetto ai canoni tradizionali dello Scientific Management […]. Si traccia così il possibile percorso di un management che non teme di utilizzare tutte le risorse messe in campo dalle nuove ICT, ma per il quale la poesia, l’arte, la filosofia si traducono in catalizzatori […].
Un compito che può essere assolto grazie a un approccio incentrato sulla contaminazione, sulla diversità, sulla metadisciplinarità. Un umanesimo in cui si incontrano Dioniso e Apollo, il professionista e il manager, il tecnologo e il romanziere, tutti parte di una stessa molteplice unità.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Global hypocrisy compact for globalization
Global hypocrisy compact for globalization
di Ugo Boghetta
La proposta del Global Compact for Migration ha scatenato in Italia la solita discussione fra ultras: il rumore è tanto, il merito poco o nulla. Come sempre.
Proprio perchè il tema è sensibile ci rimettiamo al nostro approccio: nè buoni nè cattivi, ragioniamo.
Il documento è impostato su 10 principi guida: validità dei diritti umani per tutti i migranti, uguaglianza di genere, attenzione all’infanzia, approccio governativo multisettoriale e coerente, patnership multistakeholder.
Tali principi si devono realizzare attraverso 23 obiettivi:
1. Raccogliere e utilizzare dati accurati e disaggregati come base per le politiche basate su elementi concreti;
2. Ridurre al minimo i fattori negativi e i fattori strutturali che costringono le persone a lasciare il loro paese d’origine;
3. Fornire informazioni accurate e tempestive in tutte le fasi della migrazione;
4. Garantire che tutti i migranti abbiano la prova dell’identità legale e documentazione adeguata;
5. Migliorare la disponibilità e la flessibilità dei percorsi per la migrazione regolare;
Leggi tutto
Enzo Pennetta: Il “sovranismo psichico” e altre supercazzole del basso impero
Il “sovranismo psichico” e altre supercazzole del basso impero
di Enzo Pennetta
Dopo i gilet gialli infuriati perché non hanno capito la tassa ecologica, e contemporaneamente alla denuncia sulle ingerenze di Putin nelle sommosse francesi, ecco che il CENSIS supera tutti inventando una nuova patologia psicoillegale. Per consentire ai politici di riferimento di continuare a non vedere una realtà fatta di persone impoverite e tradite da una classe dirigente che li ha venduti alla finanza, che li ha sottomessi a regole fatte per trasferire ricchezza dal basso verso l’alto, che gli ha imposto obblighi ciechi e diritti surrogati da concedere senza se e senza ma sul verbo del politicamente corretto, ha trasformato le rivendicazioni in malattie mentali. Così il rapporto CENSIS riferito sul Sole 24Ore:
I nostri concittadini, spiega il capitolo chiave sulla “società italiana al 2018”, sono in preda a «una sorta di sovranismo psichico prima ancora che politico», che «talvolta assume i profili paranoici della caccia al capro espiatorio, quando la cattiveria – dopo e oltre il rancore ‒ diventa la leva cinica di un presunto riscatto e si dispiega in una conflittualità latente, individualizzata, pulviscolare».
Voi quindi non avete delle opinioni, siete malati mentali e la vostra malattia è il rancore, siete irriconoscenti verso persone che volevano solo fare il vostro bene, voi non individuate responsabilità e pericoli ma siete a “caccia del capro espiatorio”, non indicate soluzioni per tutelare i vostri legittimi interessi, siete alla ricerca di leve per un “cinico presunto riscatto”.
Leggi tutto
Francesco Galofaro: Il sequestro di Meng Wanzhou e la lotta per la sovranità algoritmica nelle reti cellulari
Il sequestro di Meng Wanzhou e la lotta per la sovranità algoritmica nelle reti cellulari
di Francesco Galofaro*
Fa notizia in queste ore il fermo di Meng Wanzhou. La donna, direttrice finanziaria di Huawei e figlia del fondatore, Ren Zhengfei, è stata fermata in Canada durante uno scalo aereo, su richiesta degli USA. Il fermo è una flagrante violazione del diritto internazionale, in quanto non sarebbe stato formulato uno specifico capo d'accusa [1]. Sono infatti i media americani ad aver fatto circolare la notizia per cui la causa dell'arresto sarebbe una presunta violazione dell'embargo nei confronti di Iran e Corea del Nord. Meng Wanzhou è stata trattenuta senza un motivo specifico: solo il sette dicembre, nel corso della prima udienza a Vancouver, le è stato comunicato il capo d'accusa [2].
Il fermo è avvenuto il primo dicembre: lo stesso giorno in cui Donald Trump e Xi Jinping avevano dichiarato una tregua nella guerra dei dazi al G20 di Buenos Aires. Inquadrare la questione entro la guerra commerciale degli USA contro la Cina per riequilibrare la bilancia commerciale è fuorviante; la vera posta in gioco è la supremazia sulle reti digitali, e in particolare la lotta per lo standard delle reti di telefonia mobile di quinta generazione (5G) che segnerà una nuova rivoluzione informatica a partire dal 2020.
Leggi tutto
Aldo Giannuli: Guerra commerciale Cina-Usa, Bolsonaro in Brasile,
Guerra commerciale Cina-Usa, Bolsonaro in Brasile, Vox in Andalusia, prossima recessione, gilet gialli: che succede?
di Aldo Giannuli
C’è un filo che lega cose distanti fra loro come lo scontro (ed il momentaneo armistizio) Trump-Xi Jinping, il caso Huawei, i gilet gialli, le vittorie elettorali della destra in Brasile ed Andalusia e i segnali di una prossima recessione?
Vediamo le cose più da vicino iniziando dal conflitto Cina Usa. Contrariamente alle attese, quindici anni fa, l’apertura mondiale dei mercati non giovò all’industria dell’auto americana, ma, al contrario, ne causò una crisi profonda.
Prodotti troppo costosi sia per l’acquisto che per l’uso, ed in presenza di un forte rialzo dei prezzi del petrolio e l’auto diesel europea, da un lato, e l’economica auto cinese, dall’altro, mordevano via via fette di mercato al dominio automobilistico americano già intaccato dai giapponesi. Il sopraggiungere della crisi rischiava di dare il colpo di grazia a marchi storici come la Ford e la Gm a malapena sorretti dall’intervento statale, in cambio della cessione di quote del capitale sociale (alla faccia dei dogmi neo liberisti).
Un primo contrattacco venne nel 2014 con il diesel-gate che azzoppava la Volkswagen, ma anche questo, come anche l’assorbimento della Fiat nell’orbita americana attraverso la Chisler, non risolveva i guai dell’auto americana e la run belt ormai sembrava avviata ad una irresistibile decadenza che lasciava sul campo schiere di disoccupati.
Leggi tutto
Militant: Gilet gialli, rossi e Negri
Gilet gialli, rossi e Negri
di Militant
 Dopo un
mese di mobilitazione, è ormai luogo comune entusiasmarsi per
le vicende
francesi. Se invece del sostegno politico ci spostassimo sulla
riflessione cosciente, la cosa meno improbabile è stata
scritta da Toni Negri
(L’insurrezione francese). Dal
punto
di vista politico, però, occorre sgomberare il terreno dalle
parodie deliro-marxistiche che, come quasi sempre, corrono in
soccorso del potere
costituito: “non è una rivolta di classe”, ammoniscono solerti
difensori di ogni status quo. Come se nelle rivolte di classe
fosse
mai apparsa, in qualche angolo della storia, quella purezza
alla quale tali pensatori rimandano: «si comincia, poi si
vede», diceva Lenin
riprendendo Napoleone. Ed è dentro questo spirito che tutte le
forze rivoluzionarie si sono sempre mosse: nell’occasione, che
non
è né predeterminata né socialmente definita. Fatta dunque la
premessa che in una rivolta politico-sociale ci si sta fino a
che la
finestra di possibilità rimane aperta, anche fosse un solo
spiraglio, se al contrario volessimo tentarne un’analisi
occorrerebbe frenare
i facili entusiasmi che circolano ormai in tutte le gradazioni
della politica, da Forza Italia all’estrema sinistra (esclusa,
come detto, la
parodia gendarme celata dietro prose marxiste).
Dopo un
mese di mobilitazione, è ormai luogo comune entusiasmarsi per
le vicende
francesi. Se invece del sostegno politico ci spostassimo sulla
riflessione cosciente, la cosa meno improbabile è stata
scritta da Toni Negri
(L’insurrezione francese). Dal
punto
di vista politico, però, occorre sgomberare il terreno dalle
parodie deliro-marxistiche che, come quasi sempre, corrono in
soccorso del potere
costituito: “non è una rivolta di classe”, ammoniscono solerti
difensori di ogni status quo. Come se nelle rivolte di classe
fosse
mai apparsa, in qualche angolo della storia, quella purezza
alla quale tali pensatori rimandano: «si comincia, poi si
vede», diceva Lenin
riprendendo Napoleone. Ed è dentro questo spirito che tutte le
forze rivoluzionarie si sono sempre mosse: nell’occasione, che
non
è né predeterminata né socialmente definita. Fatta dunque la
premessa che in una rivolta politico-sociale ci si sta fino a
che la
finestra di possibilità rimane aperta, anche fosse un solo
spiraglio, se al contrario volessimo tentarne un’analisi
occorrerebbe frenare
i facili entusiasmi che circolano ormai in tutte le gradazioni
della politica, da Forza Italia all’estrema sinistra (esclusa,
come detto, la
parodia gendarme celata dietro prose marxiste).
E qui Toni Negri coglie nel segno. Negri non ha l’entusiasmo del neofita, che si impressiona di ogni simulacro di rivolta sociale. Riconosce che lo spazio «dell’insurrezione», come lui la definisce, va lasciato aperto, va allargato e organizzato, più che richiuderlo attraverso scomuniche libresche. Eppure ci sono fattori particolari alla base di una rivolta simile che vanno tenuti in considerazione. Questa è una rivolta che ha ragioni generali, legate al processo di straordinario impoverimento determinato dalla fase neoliberale, ma ha anche ragioni specifiche, «francesi», che la rendono difficilmente replicabile altrove. Partiamo dalle ragioni generali.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico
![]()
C’è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d’antico
La République en marche ... jaune
di Fulvio Grimaldi
https://www.youtube.com/watch?v=AH0Fl09RG-E https://vimeo.com/305306130 (Torino No Tav)
https://www.zerohedge.com/news/2018-12-08/paris-lockdown-watch-live-hundreds-arrested-tear-gas-deployed-during-fourth-week?mc_cid=6e7bf29f37&mc_eid=741abab6a2 (Parigi, Gilet Jaunes, 4. Giornata)
 Terrorismo
di distrazione di massa
Terrorismo
di distrazione di massa
Sempre più grossolani, sempre più faciloni. Tanto c’è la rete mediatica sotto gli spericolati. In Francia è in atto un’insurrezione che, dopo aver bloccato e sconvolto il paese per un mese, non si ferma. Un’insurrezione approvata dai due terzi dei francesi, non di classe, ma di popolo che si è fatto, è stato fatto fare, proletariato. Un’insurrezione che si vuole limitata al rifiuto di un aumento dei prezzi, ma che si è rivelata contro il governo, l’Unione Europea, il neoliberismo, il colonialismo interno ed esterno. Tutti gli occhi, malevoli e benevoli, sono puntati su questo fenomeno di massa dai tratti epocali.
Tutti gli occhi, al quinto giro della lotta, si spostano, vengono diretti, verso Strasburgo, dove, naturalmente, il solito pregiudicato radicalizzato (ricostruito in carcere), naturalmente sotto osservazione per sospetto di terrorismo (!), con la casa piena di granate perquisita il giorno prima (!), assediato in un palazzo e, naturalmente, per miracolo fuggito, fa una nuova strage terroristica, naturalmente in pieno milieu natalizio, di pace e festa, e naturalmente qualcuno lo ha sentito urlare “Allah–U-Akbar”, talché nessuno pensasse che fosse un terrorista basco, o ceceno, o delle FARC, o laico. Naturalmente raccapricciante. Spazza via da occhi, orecchie, coscienza, riflessione, ogni altra cosa, anche la più grossa. Così, ratatatatà-clang!, è scesa la saracinesca su un mondo che, come per altri versi aveva cantato Ivan Della Mea mezzo secolo fa pensando a Mao, da rosso si era fatto giallo.
Repetita juvant
Macron era al 23% dei consensi. Hollande era messo anche peggio quando capitarono Bataclan e affini. In Belgio lo scazzo al vertice è tale che non si riesce più a mettere insieme un governo: ed ecco una bella raffica di attentati.
Leggi tutto
Eros Barone: Perché il ’68 è stato sconfitto
![]()
Perché il ’68 è stato sconfitto
di Eros Barone
 La borghesia
non riesce a educare i suoi giovani (lotta di
generazione): i giovani si lasciano attrarre culturalmente
dagli operai e addirittura se ne fanno o
cercano di farsene i capi («inconscio» desiderio di
realizzare essi l'egemonia della loro propria classe sul
popolo), ma nelle crisi
storiche ritornano all'ovile.
La borghesia
non riesce a educare i suoi giovani (lotta di
generazione): i giovani si lasciano attrarre culturalmente
dagli operai e addirittura se ne fanno o
cercano di farsene i capi («inconscio» desiderio di
realizzare essi l'egemonia della loro propria classe sul
popolo), ma nelle crisi
storiche ritornano all'ovile.
Antonio Gramsci
Non c’è eredità senza
eredi,
non si è eredi se non si sa di esserlo e se non ci si
situa in prospettiva fra un ieri e un domani, un
donde e un dove.
Franco Fortini
Un quesito che spesso mi viene posto dai giovani che conosco è quello concernente le ragioni della sconfitta del ’68. Proverò ad abbozzare una risposta nelle note che seguono.
In primo luogo, occorre tenere presente che, dopo il grande ciclo di lotte operaie, popolari e studentesche degli anni ’60 e ’70 del secolo scorso, durissima fu la reazione delle classi dominanti: la trama reazionaria (il ‘filo nero’ che percorre tutta la storia dello Stato italiano) si concretò in stragi (a partire da quella di piazza Fontana, che ebbe luogo a Milano il 12 dicembre 1969), attentati, tentativi golpisti, repressione e intimidazioni senza fine. La sanguinosa ‘strategia della tensione e del terrore’ fu l’arma con cui le classi dominanti cercarono di intimorire e disorientare il proletariato e le masse studentesche per fermarne il movimento di lotta. Il gruppo dirigente del Pci, intimorito dalla reazione borghese e dal colpo di Stato militare in Cile, che aveva dimostrato il fallimento delle teorizzazioni riformiste sulla ‘via pacifica al socialismo’, elaborò, a questo punto, per impulso e sotto la direzione di Enrico Berlinguer, la strategia del ‘compromesso storico’, cioè del patto di governo con la Dc.
Leggi tutto
Maria Morigi: Valori occidentali, valori cinesi e valori universali
Valori occidentali, valori cinesi e valori universali
di Maria Morigi
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
 Nel gennaio del 2015 il
Ministero dell’Istruzione cinese annunciava l’intenzione di
bandire dalle aule
universitarie i materiali d’insegnamento che “diffondevano
i valori occidentali”.
Nel gennaio del 2015 il
Ministero dell’Istruzione cinese annunciava l’intenzione di
bandire dalle aule
universitarie i materiali d’insegnamento che “diffondevano
i valori occidentali”.
Le autorità cinesi erano dunque ostili nei confronti dell’occidentalizzazione? Ci si chiede anche se in Cina è riconosciuta una sorta di equivalenza tra valori occidentali = valori liberali, ovvero princìpi di governo e ideali politico-sociali, quali libertà, uguaglianza, autonomia individuale e autogoverno repubblicano, con cui l’Occidente definisce la propria identità liberale e democratica. O forse i valori occidentali erano incompatibili con la “grande rinascita della nazione cinese” con cui erano stati promossi i “valori cinesi”?.
La stampa ufficiale intervenuta tempestivamente (Vedi Guangming online:
“Cosa c’è di sbagliato a non far circolare i valori occidentali nelle università socialiste”, 31-01-2015) chiariva: “I valori occidentali principalmente si riferiscono, nella Cina di oggi, alle idee errate provenienti dal mondo capitalista occidentale e in particolare a quelle idee e valori politici propagandati dai paesi capitalisti occidentali rappresentati in primis dall’America, come la democrazia costituzionale, i valori universali, la società civile, il neoliberalismo, il nichilismo storico…”.
Per capire le dimensioni del problema dobbiamo fare molti passi indietro, perché in Cina la storia contemporanea –a partire dalle Riforme dei 100 giorni (1898) dell'imperatore Guangxu- è segnata da un lato dalla promozione dell’occidentalizzazione, che chiedeva una costituzione e un parlamento per garantire ai cinesi uguali diritti e doveri e per partecipare alla costruzione della nazione; dall’altro lato è segnata dalla difesa dei valori autoctoni. Tale contesa culturale e ideologica era motivata dall’aspirazione a creare un moderno sistema democratico, pur assecondando l’esigenza di conservare un sistema autocratico che fosse espressione della tradizione cinese di Stato-civiltà.
Leggi tutto
Emiliano Brancaccio: Bitcoin a Napoli? L'ennesimo cavallo di Troia del liberismo
Bitcoin a Napoli? L'ennesimo cavallo di Troia del liberismo
Sergio Governale intervista Emiliano Brancaccio
Fare entrare le grandi criptovalute nei circuiti finanziari delle amministrazioni pubbliche è un azzardo. L’opinione del’economista Emiliano Brancaccio
“Fare entrare i bitcoin nei circuiti finanziari delle amministrazioni pubbliche può rivelarsi un errore”. L’economista Emiliano Brancaccio dell’Università del Sannio, esperto in tema di sviluppo e crisi dei regimi monetari internazionali, continua a mostrarsi scettico sull’apertura del Comune di Napoli alle cosiddette criptovalute. Lo raggiungiamo telefonicamente a Milano dove il prossimo 19 dicembre, presso la Fondazione Feltrinelli, si confronterà con l’ex capo economista del Fondo Monetario Internazionale Olivier Blanchard, in un dibattito sulle politiche necessarie per fronteggiare la disoccupazione e le disuguaglianze.
* * * *
Professor Brancaccio, a Milano lei discuterà con l’ex capo del FMI delle possibili “rivoluzioni” della politica economica del futuro, in Europa e nel mondo. In termini più circoscritti, potremmo dire che anche la scelta del sindaco De Magistris, di introdurre il bitcoin nei pagamenti del Comune di Napoli, può essere considerata una piccola “rivoluzione” della politica economica locale?
Leggi tutto
Miguel Martinez: Il Carnevale e la rivolta
Il Carnevale e la rivolta
di Miguel Martinez
Una riflessione su tre rivolte: Il Sessantotto, la Rivolta Araba del 2011, i Gilets Gialli
La mia idea è questa: le tre rivolte si somigliano, perché sono momenti liberatori e carnescialeschi. Ma sono radicalmente diversi, perché il Sessantotto avviene all’apice dell’illusione che “la pacchia è appena cominciata”. Mentre la rivolta araba prima e quella francese dopo, partono dalla constatazione che “la pacchia è finita”.
Il Sessantotto almeno Roma, mi raccontava chi c’era stato, fu una gran festa, cui parteciparono tutti i giovani vivi, a prescindere da considerazioni identitarie o astratte. Poi, mi spiegarono, divenne una faccenda ideologica.
Non so quanto questa ricostruzione corrispondesse ai fatti; ma sto guardando adesso una serie di foto e video delle manifestazioni dei Gilets Jaunes.
Gente che grida «Anti, Anti Anticapitalistes», i preti che benedicono i manifestanti, la bandiera di Casa Pound, gli Antifa mascherati che guidano il corteo, gli striscioni contro gli accordi di Marrakech, le bandiere dei NoTav italiani, i cori di Bella Ciao, una grande bandiera con il faccione di Apo Capo Curdo, le “A” cerchiate anarchiche sui muri, gente con i capelli bianchi e ragazzini, fricchettoni che suonano per strada, i pompieri schierati contro la polizia, le bande di motociclisti…
Leggi tutto
Carlo Clericetti: I dazi non ci sono, il dumping sì
I dazi non ci sono, il dumping sì
di Carlo Clericetti
Da quando il presidente americano Donald Trump ha cominciato a minacciare – e solo in qualche caso ad applicare – dazi sulle importazioni dai paesi con i quali è maggiore lo sbilancio commerciale degli Stati Uniti si è cominciato a parlare di fine della globalizzazione e ritorno del protezionismo.
Può darsi che ciò avvenga. Ma bisogna dire che la strada, se si vorrà proseguirla, è appena agli inizi. Se anche i dazi finora annunciati da Trump venissero effettivamente messi in atto, il livello globale resterebbe di pochissimo superiore ai minimi storici, come mostra un grafico sul loro andamento dal 1870 elaborato da Oxford Economics e presentato nel corso del convegno annuale organizzato dal centro studi Economia reale, fondato e presieduto da Mario Baldassarri. Ecco il grafico.
Leggi tutto
Palestina Rossa: Le campagne sioniste contro il BDS non intimidiscono
Le campagne sioniste contro il BDS non intimidiscono
di Palestina Rossa
Gli avvenimenti iniziati il 30 Marzo 2018 con la Grande Marcia del Ritorno in Palestina mostrano chiaramente che le minacce e l’uso della forza nonché la violenza indiscriminata, spesso mirata, dell’esercito sionista non servono ad ottenere concessioni dai palestinesi. Quello che è stato concepibile con l’ANP non si è mostrato possibile con la Resistenza.
Inoltre abbiamo visto crescere la solidarietà verso la Resistenza palestinese, che si è impegnata a rivedere la sua strategia per meglio valutare quale strada intraprendere nel futuro, per unire il fronte della Resistenza, per combattere l’occupazione e per valutare quali mezzi usare per far crescere la solidarietà ampliando il movimento per il Boicottaggio, Disinvestimento e Sanzioni (BDS) contro Israele.
Il governo israeliano ha investito molto sia nel combattere la Resistenza antisionista sia nell'impedire che il BDS si potesse espandere...inutilmente: grazie all’organizzazione dell’eroica Resistenza del popolo palestinese e delle sue organizzazioni, che agiscono con efficacia all’interno di un unico coordinamento, chi è andato in crisi è stato proprio il governo sionista.
Quello che si è dimostrato, ancora una volta, è che la cecità dei governi sionisti, che hanno come unico obiettivo la dissoluzione della Resistenza e la disgregazione della società palestinese (nonostante la collaborazione dell’Autorità Nazionale Palestinese, nata dopo il 1992, a seguito degli sciagurati Accordi di Oslo), li ha messi in crisi non ottenendo i risultati proposti e promessi.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Plebe e popolo: rivoluzione passiva e tecnologie
![]()
Plebe e popolo: rivoluzione passiva e tecnologie
di Salvatore Bravo
Vi è popolo dove vi è sovranità partecipata , dove le politiche sociali ed economiche non cadono come un destino ineluttabile, come catene fatali sul popolo. Oggi siamo oltre la “Rivoluzione passiva” descritta da Cuoco e da Gramsci. La Rivoluzione passiva presuppone una borghesia affetta da coscienza infelice, capace di sentire l’universalità dei valori fondanti della Rivoluzione francese e dell’Umanesimo. Il popolo, ancora plebe, deve ancorarsi alla classe motrice della coscienza nazionale per poter essere protagonista , defilato, perché agito. La condizione attuale ha sostituito alla rivoluzione delle coscienze, dell’idea che diventa Spirito (Geist) nel movimento della storia, la sola rivoluzione permanente delle tecnologie, del mercato della produzione e del lavoro, una nuova trinità senza salvezza.
La rivoluzione tecnologica appare scissa dalla storia dell’umanità, essa avviene… E’ un evento che plana nella storia e modifica le esistenze. Rivoluzione anonima, la scienza quale sostanza astratta dalla realtà contingenze detta i suoi ordini, riconfigura le comunità, le travia fino a fessurare il loro essere, la loro identità culturale per annientarle. Le comunità passivizzate perdono con la coesione, sincronicamente anche le parole. La rivoluzione passiva delle tecnologie senza finalismo, smantellano non solo lo stato sociale, ma con esso anche il linguaggio.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3196
Hits 2641
Hits 2312
Hits 2189
Hits 2170
Hits 1927
tonino

Dante Barontini: La crisi europea, lo scontro sociale che cresce
La crisi europea, lo scontro sociale che cresce
di Dante Barontini
 Quando i
dati – economici e politici – confermano un’analisi
sgradita, i cretini (e quelli che ci
guadagnano) voltanto la testa dall’altra parte, cominciando
a farneticare di “valori”. Il massimo dello sciacallaggio
poi avviene su
ragazzi uccisi, come il giovane giornalista italiano a
Strasburgo, le cui convinzioni e/o fraintendimenti vengono
ora spacciati per verità
rivelate che nessuno deve osare mettere in discussione. Un
po’ come fanno i generali in guerra, quando vanno in
difficoltà, che esaltano
il sacrificio dei ragazzi che loro stessi hanno mandato a
uccidere e morire.
Quando i
dati – economici e politici – confermano un’analisi
sgradita, i cretini (e quelli che ci
guadagnano) voltanto la testa dall’altra parte, cominciando
a farneticare di “valori”. Il massimo dello sciacallaggio
poi avviene su
ragazzi uccisi, come il giovane giornalista italiano a
Strasburgo, le cui convinzioni e/o fraintendimenti vengono
ora spacciati per verità
rivelate che nessuno deve osare mettere in discussione. Un
po’ come fanno i generali in guerra, quando vanno in
difficoltà, che esaltano
il sacrificio dei ragazzi che loro stessi hanno mandato a
uccidere e morire.
Il tutto mentre un “governo del cambiamento”, che doveva fare una “manovra del popolo”, sfidare l’Unione Europea e rivoltare la Ue come un calzino, si appresta a varare una legge di stabilità riscritta fino all’ultimo rigo sotto la supervisione della Commissione Europea, che intanto preparava – ad ogni buon conto – la “procedura di infrazione” per debito eccessivo.
Due cose possiamo rivendicare d’aver detto e scritto molto prima che anche nei giornali mainstream se ne accorgessero. La prima, seria e strategica, addirittura a metà maggio, è che Salvini e Di Maio erano i due nuovi Tsipras, sebbene uno fasciorazzista e l’altro neo-doroteo. La seconda, scherzosa ma altrettanto vera, è che a forza di ridurre la platea dei beneficiari di “quota 100” per le pensioni e del reddito di cittadinanza, pur di rientrare nei limiti dettati dalla Ue, alla fine daranno la “quota” all’autista di Salvini e e il reddito a un vicino di casa di Di Maio…
Per i dati, e quel comportano in termini di insorgenza sociale e fratture tra establisment e popoli, ci soccorre – ormai spesso – un editoriale di Guido Salerno Aletta, pubblicato su Milano Finanza (non sull’organo dei soviet!).
Il quale spiega con grande sintesi, dunque con la massima efficacia, come l’ordoliberismo economico sottostante a tutti i meccanismi di regolazione Ue abbiano nel corso degli ultimi venti anni prima logorato e poi distrutto le leadership politiche dell’Europa intera (ricordiamo sempre che l’Europa è il continente in cui viviamo, la Ue una schifosa forma di governo di questo territorio; confonderle è un’infamian o un suicidio).
Leggi tutto
Fernanda Mazzoli: Leggendo«Elogio sì, ma di quale democrazia?» di Giancarlo Paciello
Leggendo«Elogio sì, ma di quale democrazia?» di Giancarlo Paciello
di Fernanda Mazzoli
 Leggendo l’ultimo libro
di Giancarlo Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia?
La rivolta o forse la
rivincita del demos, non ho potuto fare a meno di
pensare ad una considerazione di Antonio Gramsci sul contesto
in cui era andata maturando la
crisi moderna che aveva trasformato i ceti dirigenti in ceti
semplicemente dominanti. Le sbarre del carcere non gli
impedivano di affacciarsi curioso
sulla realtà contemporanea e di osservare che «il vecchio
muore e il nuovo non nasce»,[1] ad indicare
la
possibilità di sviluppi incerti, contraddittori e anche
morbosi nella vita sociale e a suggerire il rischio di una impasse.
Posto che
non intendo stabilire alcun parallelismo fra gli anni vissuti
da Gramsci e i nostri, mi preme cogliere di tale osservazione
la capacità di
fotografare in modo incisivo un momento storico che le
consolidate categorie interpretative faticano a cogliere,
perché dalle macerie di un
certo sistema di rappresentanza politica stenta a crescere e
ad imporsi un cambiamento sostanziale, capace di andare oltre
la manifestazione di un
netto rifiuto dell’Ancien Régime.
Leggendo l’ultimo libro
di Giancarlo Paciello, Elogio sì, ma di quale democrazia?
La rivolta o forse la
rivincita del demos, non ho potuto fare a meno di
pensare ad una considerazione di Antonio Gramsci sul contesto
in cui era andata maturando la
crisi moderna che aveva trasformato i ceti dirigenti in ceti
semplicemente dominanti. Le sbarre del carcere non gli
impedivano di affacciarsi curioso
sulla realtà contemporanea e di osservare che «il vecchio
muore e il nuovo non nasce»,[1] ad indicare
la
possibilità di sviluppi incerti, contraddittori e anche
morbosi nella vita sociale e a suggerire il rischio di una impasse.
Posto che
non intendo stabilire alcun parallelismo fra gli anni vissuti
da Gramsci e i nostri, mi preme cogliere di tale osservazione
la capacità di
fotografare in modo incisivo un momento storico che le
consolidate categorie interpretative faticano a cogliere,
perché dalle macerie di un
certo sistema di rappresentanza politica stenta a crescere e
ad imporsi un cambiamento sostanziale, capace di andare oltre
la manifestazione di un
netto rifiuto dell’Ancien Régime.
È quanto l’autore sottolinea già a partire dalla premessa, mettendo in guardia da troppo facili entusiasmi per il voto del 4 marzo che, se ha segnato il «redde rationem di una classe politica improvvida»,[2] non rappresenta certamente la fine dell’oligarchia che ci governa da troppo tempo, ma, sicuramente, è da leggersi come un segnale importante, l’espressione di un desiderio autentico, anche quando soggetto a pulsioni contraddittorie, di farla finita con una classe politica corrotta che ha saccheggiato il Paese, finendo, poi, per consegnarlo nelle mani di organismi sovranazionali dominati dalla finanza.
Il libro si sviluppa su due binari: da un lato, la focalizzazione sull’attualità che si sostanzia nell’analisi precisa dei sistemi elettorali dal dopoguerra ad oggi e del voto degli ultimi anni, dall’altro una ricerca intorno al significato della democrazia che si avvale del contributo fornito da eminenti studiosi, quali Vernant, Preve, Canfora, Giacché. Il percorso si snoda dalla nascita della polis, decisivo punto di partenza per una nuova modalità di vita associata, e dalle considerazioni di Aristotele sulla differenza fra oligarchia e democrazia, nonché sulla natura dell’uomo come animale politico, fino al moderno concetto di democrazia.
Leggi tutto
Alessandro Ferrari: Prove tecniche di convergenza gialla
Prove tecniche di convergenza gialla
di Alessandro Ferrari
Dopo l’articolo di Maurizio Gribaudi e i contributi “francesi” di Edwy Plenel e del Comitato Adama, continuano le riflessioni Effimere sui cosiddetti “gilet gialli” con Alessandro Ferrari
 Una
domanda provocatoria
Una
domanda provocatoria
La mobilitazione dei gilets jaunes si é ormai da alcune settimane imposta al centro del dibattito politico in Francia per la sua crescita ed ampiezza e nonostante gli appelli e gli auspici del governo il movimento non accenna a sgonfiarsi e l’atto III di questa mobilitazione che ha messo a ferro e fuoco Parigi sta qui a dimostrarlo; in questo testo non ci limiteremo né ad una semplice descrizione dei fatti e sintesi della mobilitazione né ad un’analisi esterna che tiri le somme cercando di costruire esternamente una posizione politica di fronte alla variabile rappresentata dai gilets gialli quanto piuttosto un tentativo di articolare il reale con una sua sovrainterpretazione che cerca di leggere gli aspetti tendenziali del movimento dei gilets jaunes non per provare a sovradeterminarlo politicamente quanto per azzardare una bozza di una delle sue possibili evoluzioni e del ruolo da giocare in questa evoluzione. Faremo questo attraverso una sintesi degli avvenimenti che hanno caratterizzato la mobilitazione dei gilets gialli ed insieme una radiografia progressiva delle sue evoluzioni ed obbiettivi per provare in seguito a vedere nella giornata del primo dicembre a Lyon più che a Parigi un’esemplificazione della nostra lettura tendenziale, una scelta che deriva da un lato della participazione e dalla conoscenza diretta e dall’altro lato come primo esempio di quell’azzardo interpretativo appena descritto che lega i fatti alla torsione politica della tendenza. Una lettura che piuttosto che localizzare gli ennesimi nuovi e definitivi soggetti rivoluzionari o predeterminare il progetto politico di una mobilitazione in divenire pone una semplice domanda al dibattito collettivo, non tanto una domanda voyeuristica delle lotte altrui quanto un sasso lanciato nello stagno del conflitto e del nostro lavoro politico, una domanda che sopravanza provocatoriamente e paurosamente la durezza dei fatti chiedendosi se l’esigenza smaniosa e il seme di una convergence des luttes che aleggiava nei cortei e nelle piazze attraversate dalle lotte degli cheminots e degli studenti stia finalmente vedendo la luce nella mobilitazione dei gilets gialli.
Leggi tutto
J. A. Kregel: Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale
Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale
Allegato alla “Politeia” di Savona
di J. A. Kregel
 Una
esauriente e approfondita scheda esplicativa sullo studio
intitolato “Crescita e moneta unica: il paradosso
della politica fiscale” elaborato dall’economista
J. A.
Kregel e allegato al documento “Una politeia per
un’Europa diversa, più forte e più equa” che
il Ministro Paolo Savona ha proposto come base di
discussione al Consiglio europeo al fine di verificare la
reale rispondenza della
architettura europea agli obiettivi di crescita di piena
occupazione e di stabilità che sarebbero alla base dei
trattati.
Il documento di Kregel, estremamente
significativo, dimostra su base scientifica la natura
paradossale dell’impianto della moneta
unica, che con le sue regole di rigore fiscale nel lungo
periodo non può che portare o a condizioni di stagnazione
permanente o ad
un’intrinseca fragilità finanziaria tipica di uno schema
Ponzi, che si scaricherebbe sul resto del mondo. Una follia
economica.
Una
esauriente e approfondita scheda esplicativa sullo studio
intitolato “Crescita e moneta unica: il paradosso
della politica fiscale” elaborato dall’economista
J. A.
Kregel e allegato al documento “Una politeia per
un’Europa diversa, più forte e più equa” che
il Ministro Paolo Savona ha proposto come base di
discussione al Consiglio europeo al fine di verificare la
reale rispondenza della
architettura europea agli obiettivi di crescita di piena
occupazione e di stabilità che sarebbero alla base dei
trattati.
Il documento di Kregel, estremamente
significativo, dimostra su base scientifica la natura
paradossale dell’impianto della moneta
unica, che con le sue regole di rigore fiscale nel lungo
periodo non può che portare o a condizioni di stagnazione
permanente o ad
un’intrinseca fragilità finanziaria tipica di uno schema
Ponzi, che si scaricherebbe sul resto del mondo. Una follia
economica.
Ringraziamo il curatore della scheda Beppe Vandai, che ha spesso collaborato con Vocidallestero traducendo articoli di particolare rilevanza. Beppe, di formazione filosofica, vive da 32 anni in Germania e ha fondato ad Heidelberg il circolo di discussione politico-culturale Volta la Carta!! e a Treviso il circolo Risorse, sui temi dell’economia.
Scheda a cura di Beppe Vandai sul documento di Jan A. Kregel* “Crescita e moneta unica: il paradosso della politica fiscale”
*Jan A. Kregel è un importante economista post-Keynesiano, direttore del programma «Politica monetaria» presso il Levy Economic Institute of Bard College e professore di Development Finance presso la Tallinn University of Technology. Ex professore di Economia Politica presso l’Università degli Studi di Bologna ed ex professore di Economia Internazionale presso il Johns Hopkins University’s Paul Nitze School of Advanced International Studies, dove è stato anche direttore associato del Bologna Center dal 1987 al 1990.
Leggi tutto
Paolo Mottana: Le grandi distrazioni di massa
Le grandi distrazioni di massa
di Paolo Mottana*
Possibile che, nonostante tutto quello che accade, dai nostri vocabolari non siano state bandite parole come competitività, profitto e crescita? Possibile che l’ossessione della sicurezza riguardi i profughi in un paese dove ci sono ‘ndrangheta, camorra, mafia e sacra corona unita? Possibile che si ha paura di ragionare di reddito di cittadinanza e di patrimoniale? Siamo destinati a restare perdine di un gioco altrui oppure possiamo scoprire che quel gioco dipende anche da noi e dalla nostra capacità di mettere in discussione vocaboli e ossessioni? “Vogliamo guardare in avanti, oltre questo schifo, oltre al cancro che ci assedia, oltre alla retorica padronale della crescita ad ogni costo – scrive Paolo Mottana -, oltre alla professionalizzazione anche dei bambini e delle bambine per renderli da subito soggetti imprenditoriali?…”
Possibile che nessuno sollevi il sopracciglio? Che nessuno invochi un minimo di attenzione? Che la sensibilità sia totalmente sepolta? Che non vi sia uno straccio di idea di futuro da contrapporre alla terapia funesta del tempo presente?
Dove sono finite le voci accorte? Gli sguardi profetici, le visioni radicali e prospettiche?
Possibile che dal vocabolario di chi vorrebbe un mondo diverso e possibile non siano state bandite le parole competitività, concorrenza, profitto e crescita? Tutta la sinistra cosiddetta ne parla.
Leggi tutto
Marco Pondrelli: Sovranità o barbarie, il ritorno della questione nazionale
Sovranità o barbarie, il ritorno della questione nazionale
di Marco Pondrelli
Pubblichiamo un recensione al libro di Thomas Fazi e William Mitchell, Sovranità o barbarie (edito da Meltemi) che verrà presentato a Bologna venerdì 14 dicembre presso il bar La Linea
Il libro di Fazi – Mitchell andrebbe letto partendo dalle conclusioni, laddove si legge che le forze di destra oggi sono egemoni “perché [...] in grado di tessere nuove narrazioni identitarie in cui la sovranità nazionale viene declinata in chiave etnica, razziale o religiosa”, la sinistra quindi deve sviluppare una nuova visione socioeconomica ed istituzionale della società se vuole tornare a vincere.
I mali della sinistra hanno radici profonde. Gli autori scardinano alcuni luoghi comuni che, anche fra la sinistra radicale, trovano grande eco. Per capire le difficoltà attuali bisogna partire dalla fine dei 30 gloriosi quando il patto keynesiano entrò in crisi. L'economia mista, centrale nella Costituzione Italiana, non era solo una concessione dei padroni al mondo del lavoro, era un sistema basato sul mercato interno e su un ruolo attivo dello Stato. Un sistema che diede all'Italia un importante sviluppo.
La fine di questo patto aprì la strada al neoliberismo. Questa rottura non avvenne con l'opposizione della sinistra (socialista e, in Italia, comunista) ma con la sua complicità. Nel libro è ricostruito il dibattito che attraversò il PCI, i socialisti francesi ed il Labour Party inglese.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Antifascismo o ignorantismo?
Antifascismo o ignorantismo?
di Ugo Boghetta
Un sedicente nodo antifascista di Bologna ha emanato una fatwa contro la presentazione del libro di Thomas Fazi: “Sovranità o barbarie, il ritorno della questione nazionale“. Presentazione che si terrà venerdì prossimo presso il bar La Linea in Piazza Maggiore. L’accusa è quella di rossobrunismo e, addirittura, di nazionalsocialismo. La fatwa è corredata da capi di imputazione che, come sempre, ignorano la storia e la teoria a cui invece credono di richiamarsi.
Si legge, ad esempio, che: “Storicamente, l’ideologia del Fascismo è nata proprio da una rete di scambi e ibridazioni fra «destra» e «sinistra», combinando lotta di classe e nazionalismo, dittatura del proletariato e stirpe eletta, socialismo e razzismo.”
Storicamente, invece, furono fascismo e nazismo che usarono esperienze e terminologie del movimento operaio come: fasci o socialismo, facendo delle operazioni egemoniche. Non ci fu nessuno scambio ma un’appropriazione. Non ci fu nessun rossobrunismo.
Per quanto riguarda la nazione invece, fallita la rivoluzione mondiale, i bolsevichi appoggiarono per decenni le rivoluzioni e lotte di liberazioni nazionali cercando di inseririvi la prospettiva socialista. Questione già presente da prima.
Del resto, Marx ed Engels nel Manifesto indicarono come compito del proletariato lo sviluppo politico a livello nazionale. Se ti vuoi sviluppare a quel livello devi fare i conti con la situazione sociale, culturale e storica di quel paese. E l’internazionalismo era fra proletariati.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Gli Usa si preparano allo scontro con Russia e Cina
Gli Usa si preparano allo scontro con Russia e Cina
di Manlio Dinucci
Dal rapporto ufficiale 2018 dalla Commissione incaricata dal Congresso degli Stati uniti di vagliare la strategia di difesa nazionale, emerge come Washington sia disposta a tutto pur di conservare la «ineguagliata potenza militare» su cui gli Usa basano il loro impero, che si sta sgretolando con l’emergere di un mondo multipolare
A prima vista sembra la sceneggiatura di un film catastrofico di Hollywood. È invece uno degli scenari prospettati nel rapporto ufficiale 2018 dalla Commissione incaricata dal Congresso degli Stati uniti di vagliare la strategia di difesa nazionale: «Nel 2019, in base a false notizie su atrocità contro le popolazioni russe in Lettonia, Lituania ed Estonia, la Russia invade questi paesi. Mentre le forze Usa e Nato si preparano a rispondere, la Russia dichiara che un attacco alle sue forze in questi paesi sarà considerato un attacco alla Russia stessa, prospettando una risposta nucleare. Sottomarini russi attaccano i cavi transatlantici in fibra ottica e hackers russi interrompono le reti elettriche negli Usa, mentre le forze militari russe distruggono i satelliti militari e commerciali Usa. Le maggiori città statunitensi vengono paralizzate, mettendo fuori uso Internet e cellulari».
Leggi tutto
Andrea Zhok: Sovranisti psichici di tutti i paesi unitevi
Sovranisti psichici di tutti i paesi unitevi
di Andrea Zhok
Ci sono analisi che sono il segno dei tempi e che, almeno per questa ragione, meritano di essere menzionate.
Quella recente del Censis verrà ricordata dai posteri per l'introduzione della nozione di "sovranismo psichico". (Non c'è che dire, ci sono dei mancati poeti da quelle parti).
Questa formulazione verbale non va sottovalutata perché opera scientemente secondo un modello interpretativo classico. Essa mette insieme un'idea politica e una condizione psicologica, in modo di ridurre la prima alla seconda.
Si tratta di una mossa frequentemente usata.
È la stessa mossa che, per dire, di fronte alla richiesta di 'giustizia sociale' la riconduce a 'invidia sociale'. La richiesta di giustizia è un'idea politica, con una pretesa di universalità; al contrario l'invidia è un sentimento privato, una turbativa dell'animo individuale, che come tale può essere sottoposto a 'terapia' o 'correzione', ma mai generalizzato. Riportando la domanda di giustizia sociale alla psicologia dell'invidia la si sottrae alla dimensione delle ragioni universalizzabili e la si sposta in quella delle cause contingenti. Una volta effettuato questo spostamento, la dimensione politica è delegittimata una volta per tutte.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Il discorso di Macron, la risposta di Mélenchon, il futuro del movimento
Il discorso di Macron, la risposta di Mélenchon, il futuro del movimento
di Giacomo Marchetti
 Alle otto di lunedì
sera, Emmanuel Macron ha pronunciato il suo atteso discorso
alla nazione;
dopo poco Jean-Luc Mélenchon, deputato e leader della France
Insoumise, ha “risposto” per punti alle affermazioni del
messaggio del
Presidente.
Alle otto di lunedì
sera, Emmanuel Macron ha pronunciato il suo atteso discorso
alla nazione;
dopo poco Jean-Luc Mélenchon, deputato e leader della France
Insoumise, ha “risposto” per punti alle affermazioni del
messaggio del
Presidente.
Dopo avere considerato il “botta e risposta” tra il Macron e Mélenchon, dobbiamo approfondire l’analisi su questo movimento per comprendere come i pochi palliativi macroniani non avranno probabilmente gli esiti sperati.
L’aumento del salario minimo intercategoriale di 100 euro (in realtà 64 in più rispetto all’aumento automatico previsto in conseguenza all’indicizzazione), la defiscalizzazione per il lavoratore e per l’impresa delle ore straordinarie, un premio delle imprese ai lavoratori per la fine dell’anno – comunque facoltativo e comunque defiscalizzato – e per ultimo l’innalzamento della CSG per le pensioni inferiori a 2.000 euro, sono le uniche misure concrete di cui ha parlato Macron nel suo discorso, e si inseriscono nel solco della sua filosofia di governo, tesa a sposare la tesi dello “sgocciolamento” e a legittimare il rapporto plebiscitario che esacerba i tratti più autoritari della Quinta Repubblica in un rapporto Presidente – o meglio monarca repubblicano – e cittadini, riportati a sudditi, al di là di un generico ascolto di facciata dei corpi democratici.
La risposta a Macron del leader della France Insoumise, in un intervento di poco più di cinque minuti, si articola in 5 punti.
Come premessa viene fatto rilevare che nel discorso del presidente non compare alcuna scusa per le violenze delle forze dell’ordine, mentre è netta la condanna delle violenze dei manifestanti.
Macron si illude che “la distribuzione di soldi possa calmare l’insurrezione dei cittadini che è scoppiata”, afferma Mélenchon, che comunque lascia che sulle parole del Presidente si esprimano direttamente i GJ.
Leggi tutto
Giovanni De Matteo: Comunismi paralleli e altri viaggi nell’utopia
Comunismi paralleli e altri viaggi nell’utopia
di Giovanni De Matteo
 Siamo nel 1927 e in
tutta l’Unione Sovietica fervono i preparativi per i
festeggiamenti del
decennale della Rivoluzione d’Ottobre. Denni è una ragazza dal
passato misterioso che arriva a Mosca dalle sperdute regioni
del sud. Sta
seguendo le tracce di un padre scomparso e, quando si presenta
alla porta dell’Istituto Trasfusionale, per il direttore
Aleksandr Bogdanov
(figura storica realmente esistita), che già si sta misurando
con gli esiti frustranti della rivoluzione, comincia la sfida
più
incredibile della sua carriera che lo porterà a fare i conti
sia con il suo ruolo personale nella Storia che con un caso
medico che da subito
rivela caratteri straordinari.
Siamo nel 1927 e in
tutta l’Unione Sovietica fervono i preparativi per i
festeggiamenti del
decennale della Rivoluzione d’Ottobre. Denni è una ragazza dal
passato misterioso che arriva a Mosca dalle sperdute regioni
del sud. Sta
seguendo le tracce di un padre scomparso e, quando si presenta
alla porta dell’Istituto Trasfusionale, per il direttore
Aleksandr Bogdanov
(figura storica realmente esistita), che già si sta misurando
con gli esiti frustranti della rivoluzione, comincia la sfida
più
incredibile della sua carriera che lo porterà a fare i conti
sia con il suo ruolo personale nella Storia che con un caso
medico che da subito
rivela caratteri straordinari.
Il personaggio immaginario di Leonid Voloch, il padre che Denni non ha mai conosciuto, è stato delegato al soviet di San Pietroburgo, militante irriducibile e compagno di lotta di Bogdanov: scomparso nel 1907 dopo una rapina a Tbilisi a cui prendeva parte lo stesso Stalin, sarebbe riapparso solo a distanza di diversi mesi, sottoposto a giudizio dai compagni in esilio a Capri per sospetto tradimento e graziato da Bogdanov, che aveva riconosciuto nel suo comportamento i segni di un disturbo post-traumatico riconducibile alla conclusione violenta proprio di quella rapina. La ragazza versa in condizioni di salute precarie e, dagli accertamenti condotti all’istituto, risulta portatrice di un batterio apparentemente legato a una forma sconosciuta di tubercolosi. Trovare Voloch diventa così una corsa contro il tempo, non solo per permetterle di ricongiungersi con quello che resta della sua famiglia, ma anche per salvarle la vita.
“Bogdanov resta in silenzio. Quella sfida lo affascina. Un elemento sconosciuto è giunto a turbare le loro certezze. Ora li attende un periodo eccitante, fatto di disordini e divergenze, di contraddizioni e aggiustamenti, finché il sistema non troverà una nuova stabilità. Crisi, differenziazione, equilibrio. La dialettica in versione tectologica, che muove ogni progresso”
(Wu Ming, 2018).
Leggi tutto
Emanuela Fornari: Sul concetto di valore
Sul concetto di valore
di Emanuela Fornari
 Prendiamo le mosse da una premessa autoevidente
del linguaggio
comune. «Valore» è un termine polisemico in duplice senso. La
sua polisemia è manifesta in ragione del diverso significato
che il concetto di valore assume nei due ambiti in cui
indiscutibilmente regna: l’ambito dell’economia e quello della
morale. Si tratta di
due ambiti distinti, ma per altro verso interconnessi: Adam
Smith, il fondatore dell’economia politica moderna – la nuova
scienza fondata
sulla saldatura di due dimensioni che la cultura classica
aveva tenuto ben distinte (l’oikos e la polis,
lo spazio della
produzione-riproduzione di beni di sussistenza e quello della
praxis intesa come attività di governo della Città) per porre
come fine e
fonte di legittimazione di uno Stato non più la «vita buona»
ma il benessere e the wealth of nations – teneva
insieme i due insegnamenti della Political Economy e della
Moral Philosophy. Ma la polisemia, in secondo luogo, è
presente anche
all’interno dello stesso ambito economico propriamente inteso:
dove il concetto di valore assume significati diversi nella
macroeconomia (o
politica economica), nella microeconomia (o economia
aziendale) e nella finanza.
Prendiamo le mosse da una premessa autoevidente
del linguaggio
comune. «Valore» è un termine polisemico in duplice senso. La
sua polisemia è manifesta in ragione del diverso significato
che il concetto di valore assume nei due ambiti in cui
indiscutibilmente regna: l’ambito dell’economia e quello della
morale. Si tratta di
due ambiti distinti, ma per altro verso interconnessi: Adam
Smith, il fondatore dell’economia politica moderna – la nuova
scienza fondata
sulla saldatura di due dimensioni che la cultura classica
aveva tenuto ben distinte (l’oikos e la polis,
lo spazio della
produzione-riproduzione di beni di sussistenza e quello della
praxis intesa come attività di governo della Città) per porre
come fine e
fonte di legittimazione di uno Stato non più la «vita buona»
ma il benessere e the wealth of nations – teneva
insieme i due insegnamenti della Political Economy e della
Moral Philosophy. Ma la polisemia, in secondo luogo, è
presente anche
all’interno dello stesso ambito economico propriamente inteso:
dove il concetto di valore assume significati diversi nella
macroeconomia (o
politica economica), nella microeconomia (o economia
aziendale) e nella finanza.
Una volta fissati questi presupposti di partenza, occorre però adesso porre la questione della genealogia. In che modo, attraverso quali passaggi complessi, si è giunti a definire tramite il ricorso al concetto di valore quello che nel mondo classico era invece rappresentato, in autori quali Platone e Aristotele, dall’idea di arché: di un principio inteso al contempo come criterio-guida e «principato», come principio ordinatore oggettivo, indiscutibilmente superiore e universalmente riconosciuto? La tesi che intendo prospettare in questa rapida sintesi è che il passaggio dalla logica del Principio a quella del Valore ha innescato, a partire dall’età moderna, un’irreversibile tendenza dissolutiva e deoggettivante, rappresentata da una dinamica di progressiva soggettivazione della logica del valore. Vediamo allora di procedere con ordine, prendendo avvio dall’etimologia del termine.
Leggi tutto
Francesco Maimone: Global Compact for safe, orderly and regular Migration
Global Compact for safe, orderly and regular Migration
La grande pianificazione e il diritto internazionale privatizzato
di Francesco Maimone
 “Dobbiamo consentire ai
migranti di diventare membri a pieno titolo delle
nostre società evidenziando il
loro
contributo positivo”
“Dobbiamo consentire ai
migranti di diventare membri a pieno titolo delle
nostre società evidenziando il
loro
contributo positivo”
(Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration)
1 In questi giorni sta tenendo banco sui Social e nei media il tema riguardante l’approvazione del Global Compact for Safe, Orderly and Regular migration (per brevità, GCSORM), ovvero l’accordo promosso in sede ONU e che sarebbe finalizzato a dare una risposta globale al fenomeno della migrazione. Tra le voci che si sovrappongono a favore e contro detto accordo, sembra soprattutto passare inosservato il fatto che il GCSORM non è una misura estemporanea partorita improvvisamente dal nulla, ma costituisce un documento inserito in una logica e ben congegnata “sequenza procedimentale” per dare specifica attuazione ad un disegno molto più vasto che l’Ordine sopranazionale dei M€rcati ha tracciato già da tempo.
2 In questa sequenza, ed evitando di risalire troppo nel tempo (per esempio, alla International Conference on Population and Development tenutasi nel lontano 1994 al Cairo), bisogna innanzi tutto prendere le mosse dalla distopica volontà di “trasformare il nostro mondo” contenuto in quel capolavoro cosmetico chiamato “Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile” adottata all’unanimità (quindi anche con il contributo del rappresentante italiano pro tempore) dall’Assemblea Generale dell’ONU con Risoluzione del 25 settembre 2015, entrata in vigore il 1° gennaio 2016 e che ha il compito di orientare i successivi sviluppi per i prossimi 15 anni. Come risulta da documenti parlamentari, l’Agenda “ha sostituito i precedenti Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals) che avevano orientato l’azione internazionale di supporto nel periodo 2000-2015”. La nuova Agenda globale si propone, in particolare, di raggiungere i seguenti 17 obiettivi pubblicizzati alla stregua di un nuovo e meraviglioso paese di Bengodi, obiettivi ai quali sono associati “169 traguardi … che sono interconnessi e indivisibili” (così al punto 18, pag. 6, dell’Agenda):
Leggi tutto
Carlo Formenti: Cittadini vs. élite: i No Tav come i gilet gialli
Cittadini vs. élite: i No Tav come i gilet gialli
di Carlo Formenti
Il clima di terrore che politici e media francesi hanno tentato di alimentare in previsione della manifestazione dei gilet gialli di sabato 8 dicembre ha raggiunto punte di vera e propria isteria, come la dichiarazione del ministro dell’Interno Castaner che ha evocato le “migliaia di violenti pronti a riversarsi a Parigi per uccidere”, come gli accostamenti fra i sanculotti assetati di sangue e questi loro emuli postmoderni pronti a chiedere la testa di Macron, o come il vecchio ritornello (chi ha vissuto gli anni Settanta in Italia se lo ricorda bene) degli “opposti estremismi”, alleati per creare il caos e distruggere l’ordine sociale.
Una repressione preventiva simile a quella che fu messa in atto a Genova nel 2001, con la differenza che, da noi, ciò non impedì di portare centinaia di migliaia di manifestanti nel capoluogo ligure, per cui si rese necessario passare dalle minacce ai fatti, cioè ai crimini commessi dalle “forze dell’ordine” alla caserma Diaz e altrove (che l’immagine dei giovani studenti francesi inginocchiati contro un muro ci ha richiamato alla memoria ), viceversa in Francia ha funzionato, con grande sollievo della stampa di regime: il deterrente di ottomila poliziotti ha fatto sì che i manifestanti convenuti nella capitale fossero più o meno altrettanti (assai di più quelli nel resto del Paese, ma comunque meno che nelle precedenti mobilitazioni).
Leggi tutto
Branko Milanovic: Prime riflessioni sugli “événements de décembre” in Francia
Prime riflessioni sugli “événements de décembre” in Francia
di Branko Milanovic
Un breve post sul blog Global Inequality sottolinea due lezioni che possiamo trarre dalla rivolta dei Gilet Jaunes: in primo luogo, l’ipocrisia insita in alcuni aspetti della retorica della “decrescita” (più o meno felice) e dell’ambientalismo, che spesso nasconde un programma di impoverimento generale e di inasprimento delle diseguaglianze; in secondo luogo l’elitismo e la distanza dalla popolazione dei leader incensati dai media in quanto progressisti e vincenti, come Macron e la Clinton. Ora è però necessario vigilare perché il legittimo risentimento popolare non venga dirottato in senso radicale e violento, poiché ciò potrebbe sfociare in un risultato diametralmente opposto
I recenti fatti accaduti in Francia, eventi che visti da fuori appaiono meno drammatici che dall’interno, sollevano due questioni importanti: una nuova, l’altra “storica”. È infatti un caso che la goccia che ha fatto traboccare il vaso sia stata una tassa sul carburante che colpiva soprattutto le aree rurali e suburbane, le popolazioni con redditi relativamente modesti. Apparentemente il punto non era tanto l’entità dell’aumento, ma il fatto che esso ha contribuito a intensificare un sentimento molto diffuso: che oggi, dopo aver già pagato i costi della globalizzazione, delle politiche neoliberiste, della delocalizzazione, della concorrenza con la manodopera straniera più economica e del deterioramento dei servizi sociali, a tutto questo si aggiunga quella che è considerata, probabilmente non in modo del tutto infondato, una tassa elitaria sul cambiamento climatico.
Leggi tutto
comidad: La fittizia dicotomia tra Stato e Capitalismo
La fittizia dicotomia tra Stato e Capitalismo
di comidad
Mentre viene annunciata prossimamente una nuova ondata recessiva, la Commissione Europea riesce a tenere inchiodato il governo Conte alla questione di un ridicolo 0,5 in più o meno di deficit. Il paradosso della artificiosa scarsità di denaro (il “non ci sono i soldi”) a fronte di una capacità produttiva diventata invece praticamente illimitata, costituisce il capolavoro mistificatorio della lobby della deflazione.
La lobby della deflazione è un tipico caso di “troppo evidente per essere visto”. Le grandi multinazionali bancarie ed i grandi fondi di investimento hanno un chiaro interesse a tenere l’economia reale in condizione di stagnazione: lo scopo è quello di evitare ogni fiammata inflazionistica che possa incrinare il valore dei crediti ed ogni incremento del PIL che, aumentando il gettito fiscale, renda i governi meno dipendenti dai prestiti dei grandi investitori.
I componenti di una lobby non hanno bisogno di riunirsi o di scambiarsi gli auguri di natale per riconoscersi come una coalizione di interessi. Nelle multinazionali bancarie e nei fondi di investimento si alleva un personale che gestisce con pieno automatismo quegli interessi. Questo personale possiede (per dirla alla Foucault) i “saperi”, ma anche gli agganci, che gli consentono di accedere alle gerarchie delle organizzazioni sovranazionali come il FMI, l’OCSE, la Banca Mondiale, il WTO e la Commissione Europea.
Leggi tutto
Angelo d'Orsi: Parigi: la rivoluzione in marcia?
Parigi: la rivoluzione in marcia?
di Angelo d'Orsi*
PARIGI - La giornata dell’8 dicembre 2018, è stata epocale? Forse sì.
Mentre in Italia, un’altra Torino, diversa e opposta a quella delle “madamine” del 10 novembre, ha risposto con forza straordinaria a quanti hanno fatto credere che la realizzazione del Tav sarebbe stata la svolta per l’economia e la vita stessa della città, mentre dal profondo Nord calavano su Roma, le truppe cammellate (pagate?) di Matteo Salvini (un ministro, per di più dell’Interno, che organizza una manifestazione non s’era mai visto, tanto più che il suo scopo era una dimostrazione di forza); a Parigi, da dove scrivo, si teneva il sequel del sabato precedente, 1 dicembre quando la capitale francese fu centro di scontri violentissimi, devastazioni, repressioni.
Questo sabato 8, la situazione si è riproposta sia pure con minore violenza, ma con maggiore forza, maggiore determinazione e, mi è parso, anche con maggiore consapevolezza. Nei giorni precedenti una campagna terroristica dei media governativi e para-governativi ha indotto buona parte dei parigini a tapparsi in casa, mentre i negozianti chiudevano fin dalla sera di venerdì le loro botteghe, ricorrendo, molti, a coprire di truciolato le vetrine: Parigi la mattina dell’8 dicembre offriva un ben strano spettacolo, assolutamente inedito, nella uniformità lignea dei negozi, nel silenzio delle strade, nel deserto dei grandi viali.
Leggi tutto
Alessandro Pascale: Il programma "rivoluzionario" dei "Gilets gialli" e l'Italia
Il programma "rivoluzionario" dei "Gilets gialli" e l'Italia
di Alessandro Pascale
Lorenzo Battisti ha già fatto per Marx21 una completa e dettagliata analisi del movimento dei “gilets gialli”. Alcune considerazioni sul suo pezzo e più in generale sulla situazione francese, oltre che sulle sue possibili implicazioni per l'Italia:
1) Non è ancora chiara la genesi delle proteste francesi. La storia del movimento operaio e della lotta di classe spinge a ritenere difficile, seppur non impossibile, che esse siano totalmente spontanee. Finché non si dispongono di nuovi elementi si può esprimere il dubbio che lo scoppio di quella che in altri contesti avremmo chiamato “una rivoluzione colorata” non sia totalmente casuale.
Ci si può e deve domandare se tale esplosione sociale sia da mettere in collegamento con la fase di particolare debolezza delle relazioni internazionali tra UE (cioè asse franco-tedesco) e USA. Gli sviluppi recenti del conflitto tra USA e Cina, specie sulla “questione Huawei”, sembrerebbero escludere tale possibilità, dato che sia la Francia che la Germania hanno finora tenuto una certa ostilità nei confronti alla Belt and Road Initiative. Ciononostante i motivi ulteriori di tensione tra USA e Francia non mancano e non è totalmente da escludere un intervento politico “esterno”, una cabina di regia finora rimasta occulta, capace di contribuire ad accendere la scintilla che ha fatto esplodere il malessere sociale del popolo francese.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3203
Hits 2659
Hits 2326
Hits 2202
Hits 2188
Hits 1941
Hits 1802
Hits 1775
tonino

Stefano G. Azzarà: Domenico Losurdo 1941-2018, in memoriam
Domenico Losurdo 1941-2018, in memoriam
di Stefano G. Azzarà*
 A chi, per lusingarlo o con sincera
ammirazione, gli faceva notare
quanto originale e personale fosse il suo modo di pensare,
Hegel rispondeva che se mai fosse stato presente qualcosa di
esclusivamente personale nel
suo sistema, questa cosa sarebbe stata senz’altro sbagliata. È
un episodio che Domenico Losurdo era solito raccontare spesso
ai propri
allievi, per spiegare quale fosse il giusto atteggiamento
conoscitivo degli studiosi e in particolare degli storici
della filosofia. Ma è anche
una citazione che sintetizza in maniera assai efficace il modo
di praticare il lavoro filosofico al quale Losurdo stesso ha
sempre cercato di
attenersi. A differenza di molti altri intellettuali, i quali
anche quando parlano del mondo finiscono in realtà per parlare
in primo luogo di
se stessi e della propria distinzione nei suoi confronti, in
Losurdo era infatti assolutamente preminente il rigore
dell’oggettività. La
volontà pervicace, cioè – radicata in una scelta argomentata
sul piano teoretico in favore della “via hegeliana”
rispetto alla “via fichtiana” – di concepire tale lavoro come
uno sviluppo il più possibile coerente delle determinazioni
inscritte nell’oggetto, ovvero nella cosa stessa. L’idea che
il movimento storico, la cui comprensione era ciò che gli
stava
più a cuore, scaturisse non dall’attività produttiva della
coscienza che incontra il reale e se ne appropria o lo risolve
in se
stessa, oppure se ne tiene a distanza e lo deplora per
specchiarsi nella propria superiore immacolatezza, ma da una
contraddizione che è
inscritta già nell’oggettività. In un tessuto ontologico,
cioè, che è intrinsecamente lacerato, scisso. Agitato da
una conflittualità immanente che con la sua trama tragica
costituisce il presupposto del dolore del negativo e che,
trasmettendosi semmai al
soggetto che se ne fa carico nella relazione, chiama sempre di
nuovo all’appello la fatica del concetto.
A chi, per lusingarlo o con sincera
ammirazione, gli faceva notare
quanto originale e personale fosse il suo modo di pensare,
Hegel rispondeva che se mai fosse stato presente qualcosa di
esclusivamente personale nel
suo sistema, questa cosa sarebbe stata senz’altro sbagliata. È
un episodio che Domenico Losurdo era solito raccontare spesso
ai propri
allievi, per spiegare quale fosse il giusto atteggiamento
conoscitivo degli studiosi e in particolare degli storici
della filosofia. Ma è anche
una citazione che sintetizza in maniera assai efficace il modo
di praticare il lavoro filosofico al quale Losurdo stesso ha
sempre cercato di
attenersi. A differenza di molti altri intellettuali, i quali
anche quando parlano del mondo finiscono in realtà per parlare
in primo luogo di
se stessi e della propria distinzione nei suoi confronti, in
Losurdo era infatti assolutamente preminente il rigore
dell’oggettività. La
volontà pervicace, cioè – radicata in una scelta argomentata
sul piano teoretico in favore della “via hegeliana”
rispetto alla “via fichtiana” – di concepire tale lavoro come
uno sviluppo il più possibile coerente delle determinazioni
inscritte nell’oggetto, ovvero nella cosa stessa. L’idea che
il movimento storico, la cui comprensione era ciò che gli
stava
più a cuore, scaturisse non dall’attività produttiva della
coscienza che incontra il reale e se ne appropria o lo risolve
in se
stessa, oppure se ne tiene a distanza e lo deplora per
specchiarsi nella propria superiore immacolatezza, ma da una
contraddizione che è
inscritta già nell’oggettività. In un tessuto ontologico,
cioè, che è intrinsecamente lacerato, scisso. Agitato da
una conflittualità immanente che con la sua trama tragica
costituisce il presupposto del dolore del negativo e che,
trasmettendosi semmai al
soggetto che se ne fa carico nella relazione, chiama sempre di
nuovo all’appello la fatica del concetto.
Leggi tutto
Andrea Inglese: Pensare l’originalità dei gilet gialli: territorio, rappresentanza, salario
Pensare l’originalità dei gilet gialli: territorio, rappresentanza, salario
di Andrea Inglese
 Questo articolo non si propone di fare la
cronaca del movimento dei gilet
gialli francesi, ma di provare a pensare la sua originalità,
riconoscendolo come una creazione collettiva, e non come la
semplice replica di
modelli d’organizzazione e lotta già codificati storicamente
in seno a istituzioni, partiti, organizzazioni sindacali. Il
primo segno
evidente d’originalità politica è riscontrabile proprio
nella difficoltà che testimoni e commentatori esterni hanno
nel
situarlo “politicamente”. Non si tratta di prendere qui per
buone le ripetute affermazioni di apoliticità
degli
sparpagliati portavoce del movimento. Sappiamo come la giurata
apoliticità sia quasi sempre maschera, nei fatti, di mentalità
e
rivendicazioni reazionarie. Il punto è che questa presunta
apoliticità del movimento ha prodotto nell’arco di un mese di
mobilitazione collettiva uno stravolgimento del dibattito
mediatico e politico in Francia. Dove da noi le destre
populiste e identitarie campano
principalmente su due argomenti – le auto blu e i migranti –,
i gilet gialli hanno posto in maniera fulminante al centro del
dibattito
pubblico tre questioni cruciali che non sono certo appannaggio
di partiti di destra o di estrema destra: territorio,
rappresentanza, salario.
Questo articolo non si propone di fare la
cronaca del movimento dei gilet
gialli francesi, ma di provare a pensare la sua originalità,
riconoscendolo come una creazione collettiva, e non come la
semplice replica di
modelli d’organizzazione e lotta già codificati storicamente
in seno a istituzioni, partiti, organizzazioni sindacali. Il
primo segno
evidente d’originalità politica è riscontrabile proprio
nella difficoltà che testimoni e commentatori esterni hanno
nel
situarlo “politicamente”. Non si tratta di prendere qui per
buone le ripetute affermazioni di apoliticità
degli
sparpagliati portavoce del movimento. Sappiamo come la giurata
apoliticità sia quasi sempre maschera, nei fatti, di mentalità
e
rivendicazioni reazionarie. Il punto è che questa presunta
apoliticità del movimento ha prodotto nell’arco di un mese di
mobilitazione collettiva uno stravolgimento del dibattito
mediatico e politico in Francia. Dove da noi le destre
populiste e identitarie campano
principalmente su due argomenti – le auto blu e i migranti –,
i gilet gialli hanno posto in maniera fulminante al centro del
dibattito
pubblico tre questioni cruciali che non sono certo appannaggio
di partiti di destra o di estrema destra: territorio,
rappresentanza, salario.
Salario
Dal 17 novembre, prima data di manifestazioni non autorizzate e di blocchi del traffico su scala nazionale, non solo i dibattiti, animati dai soliti giornalisti e personalità politiche, si sono moltiplicati in TV e sulla stampa, ma si sono dovuti concentrare sulle rivendicazioni del movimento, che nel frattempo si erano ampliate e radicalizzate. Questo ha comportato anche la comparsa, negli studi televisivi, di persone che ne erano state fino ad allora escluse: uomini e donne dai profili sociali differenti – ma senza legami con il mondo politico, giornalistico o della ricerca universitaria – che si presentavano come portavoce più o meno riconosciuti del movimento.
Leggi tutto
Felix Boggio Ewanje-Epee: Cosa significano i gilet gialli?
Cosa significano i gilet gialli?
di Felix Boggio Ewanje-Epee
Questo testo è un intervento a caldo nella congiuntura politica. Cronologicamente si colloca fra due momenti caldi della mobilitazione detta dei Gilet Gialli, la giornata del 17 novembre 2018, che ha mobilitato su più di 2000 barricate in tutta la Francia più di 280mila persone, e il 24 novembre seguente, un secondo atto di azione di movimento, incentrata su Parigi.
Fra queste due tappe, iniziative a singhiozzo hanno ritmato le tempistiche politiche, alcune mostrando i lati migliori (tentativi di blocco delle raffinerie), altre i peggiori (espressioni razziste agli sbarramenti, denuncia dei migranti alla dogana). Le note seguenti cercano di comprendere il senso e la portata di tale movimento in un periodo di riflusso del movimento operaio e di debolezza generale delle capacità di mobilitazione delle forze militanti
 1. Il
movimento dei gilets gialli e la loro eco mediatica e
politica indicano una profonda crisi di
regime. Tale crisi era in vista da questa estate,
quando è scoppiato il caso Benalla, dal quale l’esecutivo ha
dovuto affrontare
una serie di dimissioni. Evidentemente l’emergere e la
diffusione delle attuali mobilitazioni hanno delle ragioni
autonome, ma non è un
caso fortuito che scoppino dopo una forte
delegittimazione del blocco di potere al governo. Il
carattere sociale e politico dei gilets gialli che si
possono descrivere (in modo neutro) come “populismo dal
basso” corrisponde ad un
elemento fondamentale di questo periodo: da una parte
l’emergere di vari scandali, della evidenza della corruzione
del blocco di potere,
dall’altro l’impunità delle classi politiche e la diffusione
in tutta Europa di un “degagismo” [neologismo che indica
le pressioni per chiedere le dimissioni dei vertici
politici, n.d.t] derivante da tale delegittimazione del
corpo politico tradizionale. Si tratta di
un movimento le cui caratteristiche sono fluide per
definizione, il cui carattere inquietante è stato già
sottolineato (talvolta a
ragione) dalla sinistra sociale e politica. Queste
esplosioni popolari con parole d’ordine ambivalenti
e prive di una strutturazione politica o sindacale
non potrebbero essere isolate da una crisi generale delle
organizzazioni tradizionali del
movimento operaio. Tanto dal punto di vista della capacità
di mobilitazione, che delle rivendicazioni raggiunte a
favore delle lotte, le
organizzazioni sindacali, collettive ed i partiti che si
richiamano all’emancipazione sono in un impasse.
1. Il
movimento dei gilets gialli e la loro eco mediatica e
politica indicano una profonda crisi di
regime. Tale crisi era in vista da questa estate,
quando è scoppiato il caso Benalla, dal quale l’esecutivo ha
dovuto affrontare
una serie di dimissioni. Evidentemente l’emergere e la
diffusione delle attuali mobilitazioni hanno delle ragioni
autonome, ma non è un
caso fortuito che scoppino dopo una forte
delegittimazione del blocco di potere al governo. Il
carattere sociale e politico dei gilets gialli che si
possono descrivere (in modo neutro) come “populismo dal
basso” corrisponde ad un
elemento fondamentale di questo periodo: da una parte
l’emergere di vari scandali, della evidenza della corruzione
del blocco di potere,
dall’altro l’impunità delle classi politiche e la diffusione
in tutta Europa di un “degagismo” [neologismo che indica
le pressioni per chiedere le dimissioni dei vertici
politici, n.d.t] derivante da tale delegittimazione del
corpo politico tradizionale. Si tratta di
un movimento le cui caratteristiche sono fluide per
definizione, il cui carattere inquietante è stato già
sottolineato (talvolta a
ragione) dalla sinistra sociale e politica. Queste
esplosioni popolari con parole d’ordine ambivalenti
e prive di una strutturazione politica o sindacale
non potrebbero essere isolate da una crisi generale delle
organizzazioni tradizionali del
movimento operaio. Tanto dal punto di vista della capacità
di mobilitazione, che delle rivendicazioni raggiunte a
favore delle lotte, le
organizzazioni sindacali, collettive ed i partiti che si
richiamano all’emancipazione sono in un impasse.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: Conflitto di classe e femminismo: una contraddizione insanabile
Conflitto di classe e femminismo: una contraddizione insanabile
di Fabrizio Marchi
 Ho letto
questo
articolo di Lenny Benbara di Lenny Benbara (un
intellettuale della sinistra francese vicino a France
Insoumise) pubblicato sul blog di
Senso Comune che è un gruppo politico che orbita nei paraggi
di “Patria e Costituzione”, l’associazione recentemente
fondata
da Stefano Fassina.
Ho letto
questo
articolo di Lenny Benbara di Lenny Benbara (un
intellettuale della sinistra francese vicino a France
Insoumise) pubblicato sul blog di
Senso Comune che è un gruppo politico che orbita nei paraggi
di “Patria e Costituzione”, l’associazione recentemente
fondata
da Stefano Fassina.
L’articolo, per chi lo condivide (il sottoscritto, al contrario, per nulla…) ha un pregio, quello di fare uno sforzo sia teorico che politico per superare le divisioni e trovare una credibile sintesi fra le varie anime della sinistra, in particolare fra quella “sovranista”, quella marxista (quel poco che ne rimane) e quella cosiddetta “movimentista” (l’autore fa particolare ed esplicito riferimento ai movimenti femministi ed LGBT).
Benbara (ma mi pare di capire che gli amici e i compagni di Senso Comune sposino le sue posizioni, anche dalla lettura di precedenti articoli pubblicati sul loro blog) ritiene che la contrapposizione fra sinistra marxista ortodossa e quella “movimentista” (femminista, radical, ecologista, Lgbt ecc.) sia ormai destinata ad essere superata, così come ancor più deve essere superata quella fra la “sinistra “sovranista e populista” e quella “movimentista”. E questo non per ragioni meramente tattiche – spiega – ma di merito. Porre la “questione sociale” (cioè di classe) prima e sopra alle altre è sbagliato – soggiunge – così come sarebbe altrettanto sbagliato porre per prima e sopra all’altra quella del femminismo, dei diritti LGBT (che costituiscono il cuore e il mattone fondamentale dell’ideologia politicamente corretta, cioè l’attuale ideologia capitalista dominante, ma di questo Benbara non se ne avvede neanche…). Quindi si tratterebbe di superare quella che lui stesso definisce appunto una sorta di “gerarchizzazione” delle diverse istanze (diritti sociali, sostenuti dai “sovranisti-populisti” e anche dai marxisti, e diritti civili, sostenuti dai “movimentisti”), evitando però la mera sommatoria che sortirebbe solo l’effetto di impoverirle tutte, per lavorare a quella che lui definisce una sorta di “articolazione”.
Leggi tutto
S.C.: I poteri forti tirano la volata a Milano, la Capitale “vicino all’Europa”
I poteri forti tirano la volata a Milano, la Capitale “vicino all’Europa”
di S.C.
Alla fine il cerchio si è quadrato. La classifica del Sole 24 Ore, quotidiano della Confindustria, ci fa sapere che finalmente Milano è la prima città italiana per benessere, spodestando così la vivibile ma marginale Bolzano che deteneva il primato.
“Smog, traffico e scarsa sicurezza potrebbero far pensare che la prima classificata non si meriti il podio. Ma i dati, messi in graduatoria su base provinciale, dicono il contrario. Il capoluogo lombardo festeggia il suo primato, inedito nell’indagine annuale del Sole 24 Ore, piazzandosi ben sette volte su 42 nei primi tre posti per le performance conseguite negli indicatori del benessere. E conquista così lo scettro di provincia più vivibile d’Italia, dopo averlo sfiorato per quattro volte, fermandosi al secondo posto nel 2003 e 2004 e poi nel 2015 e nel 2016”. Sprizza soddisfazione da tutti i pori il giornale della Confindustria andando a confermare un processo di “Capitalizzazione” di Milano che i grandi gruppi economici del Nord stanno perseguendo negli ultimi anni. Un processo che il nostro giornale ha individuato e denunciato per tempo (il primo ad avercelo riconosciuto è stato lo scomparso urbanista Antonello Sotgia).
Queste classifiche sulla qualità della vita in realtà servono sempre più a sancire il luogo ideale per fare affari e riaffermare la logica delle “città competitive”, alimentando fantasmi che è bene conoscere e smascherare.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: I libri secondo l’economista Keynes
![]()
I libri secondo l’economista Keynes
di Salvatore Bravo
I borghesi dalla coscienza infelice, presi dall’universale ma nel contempo assorbiti dalla pratica del particolare, ci hanno lasciato testimonianza della grandezza della dialettica, della forza motivazionale dell’universale. I loro interessi personali, la loro temporalità vissuta non era completamente funzionale all’accumulazione del plusvalore, ma in essi vi abitava un’eccedenza, l’universale, capace di mettere le ali alla loro creatività emotiva che si traduceva nel senso civico, nella disposizione a guardare per pensare oltre l’angusto orizzonte del privato. La scissione pubblico-privato era una faglia, una soglia di vitalità intellettuale ed impegno da colmare.
John Maynard Keynes è stato un grande economista, ma non solo. La formazione classica gli ha consentito di trascendere il bieco scientismo degli economisti che credono nelle loro previsioni guidati da schemi ed algoritmi. Keynes è stato un innovatore poiché la formazione classica come la frequentazione di grandi scrittori e scrittrici come Virginia Woolf , gli ha insegnato che i mezzi scientifici di indagine sono utilissimi, ma non sono una totalità che conclude il sapere, anzi l’abitudine al pensiero, alla pratica dei libri, gli ha insegnato che ogni previsione scientifica che crede ciecamente in se stessa è astratta, scissa dal concreto. L’economia, come ogni scienza non può non confrontarsi con la variabile umana, che può dissolvere le previsioni profetiche degli economisti.
Leggi tutto
Mauro Poggi: Marchette
Marchette
di Mauro Poggi
Nella puntata del 12 dicembre di “Quante Storie”, Corrado Augias ha esordito in un modo da lui stesso definito “un po’ anomalo”.
Prima di presentare l’oggetto della marchetta quotidiana (il libro di turno da reclamizzare sotto il pretesto della critica culturale), Augias ha voluto mandare in onda il videoclip del lungo applauso che gli spettatori della Scala, all’apertura dell’anno lirico, hanno tributato al Presidente Mattarella.
A dire il vero, l’immagine della sontuosa platea scaligera in piedi ad applaudire, alternata a quella del Presidente in piedi a ricevere l’ovazione, se pensata in relazione a più numerose e meno confortanti realtà italiane sembrava appartenere ad un mondo parallelo. Ma per l’anziano conduttore è stata una scena “bella”, meritevole di chiosa appropriata:
“Un applauso insistito, significativo, non rituale, non solamente istituzionale, nei confronti del Presidente della Repubblica Mattarella. Un applauso che ha avuto, ha acquisito un connotato politico, chiaramente, tale la sua intensità e il tempo prolungato. Chi dicesse ‘ma era una platea fatta di signori in smoking e di signore in abito da sera, dunque borghesia e alta borghesia’ – sì, coglierebbe un aspetto della cosa ma non tutto, perché poi il Presidente Mattarella è stato applaudito anche fuori dal teatro, mentre attraversava un tratto della piazza – applausi accompagnati dalle grida ‘bravo! bravo!’.Ora tutto questo ha un senso politico, che cogliamo con facilità. Se avrà anche delle conseguenze prima o poi altrettanto politiche resta da vedere“.
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: I guardiani dell’austerità
I guardiani dell’austerità
di Tommaso Nencioni
Vi è in Italia un quarto Partito, che può non avere molti elettori, ma che è capace di paralizzare e di rendere vano ogni nostro sforzo, organizzando il sabotaggio del prestito e la fuga dei capitali, l’aumento dei prezzi o le campagne scandalistiche. L’esperienza mi ha convinto che non si governa oggi l’Italia senza attrarre nella nuova formazione di Governo, in una forma o nell’altra, i rappresentanti di questo quarto Partito, del partito di coloro che dispongono del denaro e della forza economica.
Alcide De Gasperi, aprile 1947
Le teorie del complotto non avevano ancora sostituito l’analisi politica, in quell’Italia del ’47 in cui i partiti appena rinati iniziavano a riappropriarsi delle loro funzioni democratiche e del loro ruolo di nesso forte tra il popolo e lo Stato repubblicano. Il quarto partito, il partito degli investitori, dei risparmiatori anche medio-piccoli, temeva la forza che comunisti e socialisti stavano acquisendo tramite la loro partecipazione ai governi di unità nazionale. Andava quindi, quel quarto partito, rassicurato. Di qui, oltre che dalle spinte geopolitiche provenienti da oltre-atlantico, l’esclusione delle sinistre dal governo e l’avvio della stagione del “centrismo”, poi sanzionata dai risultati delle elezioni del 18 aprile dell’anno successivo. Dal punto di vista economico, all’appello alla benevolenza del “quarto partito” e all’estromissione dei ministri social-comunisti, seguì una stretta creditizia ad opera del super ministro dell’economia Luigi Einaudi (poi assurto al Quirinale) che gettò il paese nella recessione e fece scoppiare la disoccupazione. Un impianto austeritario che fece da prodromo alla ricostruzione del Paese in senso liberista.
Leggi tutto
Kit Knightly: La UE e i segnali premonitori di fascismo
La UE e i segnali premonitori di fascismo
di Kit Knightly
Un articolo del sito off-Guardian descrive con grande lucidità l’evidente deriva della Ue verso un regime totalitario. I tentativi – maldestramente nascosti – di stabilire una “verità ufficiale” e di reprimere ogni pensiero alternativo o di dissenso sono sempre più numerosi ed espliciti. È in questa fase che i pericoli per il popolo sono maggiori, visto che gli eurocrati si rendono conto che stanno perdendo presa sul potere, e potrebbero ricorrere ad azioni estreme per tentare di rimanere in sella
In Europa la situazione sta sfuggendo di mano più velocemente di quanto molti avessero previsto. Oltre alla Brexit, esiste un forte clima anti-Ue in Ungheria, Spagna, Italia, Grecia e Francia. La Ue rischia di crollare, e le persone che temono di perdere il potere tendono a gesti estremi di controllo dittatoriale.
Quanto ci vorrà prima che la Ue diventi effettivamente quella forza autoritaria che entrambi gli estremi dello schieramento politico hanno sempre temuto?
La forza militare europea
All’inizio dell’anno, la Ue ha votato per “punire” un proprio membro, l’Ungheria, per le politiche interne adottate dal suo governo. Chiariamo una cosa – qualsiasi cosa si pensi di Viktor Orban, si tratta di un primo ministro eletto dal popolo ungherese. È il loro leader democratico legalmente riconosciuto. L’Ungheria lo ha votato – al contrario, l’Ungheria NON ha votato alcuno dei 448 parlamentari europei che hanno sostenuto la mozione, posta dal parlamentare olandese Judith Sargentini, che afferma:
Leggi tutto
Paolo Favilli: “Fascismo”: il nome e la cosa
“Fascismo”: il nome e la cosa
di Paolo Favilli
 1) L’uso del termine
«fascismo» per indicare aspetti tutt’altro che marginali
dell’attuale governo a trazione Salvini è al centro di un
dibattito fortemente controversistico sul rapporto tra il
«nome» e
la «cosa». Una discussione che si svolge a diversi livelli:
quello degli studiosi di professione, quello degli ex
studiosi (personaggi che
non fanno più ricerca reale da qualche decennio), quello dei
giornalisti «colti» (si sono a suo tempo laureati in storia,
ma non
hanno mai praticato davvero il mestiere e ignorano del tutto
le logiche dell’indagine analitico-epistemologica) e
giornalisti-propagandisti
tout court. Inevitabilmente questi diversi livelli
finiscono per incrociarsi nelle necessità di scelta inerenti
all’odierna
temperie politica.
1) L’uso del termine
«fascismo» per indicare aspetti tutt’altro che marginali
dell’attuale governo a trazione Salvini è al centro di un
dibattito fortemente controversistico sul rapporto tra il
«nome» e
la «cosa». Una discussione che si svolge a diversi livelli:
quello degli studiosi di professione, quello degli ex
studiosi (personaggi che
non fanno più ricerca reale da qualche decennio), quello dei
giornalisti «colti» (si sono a suo tempo laureati in storia,
ma non
hanno mai praticato davvero il mestiere e ignorano del tutto
le logiche dell’indagine analitico-epistemologica) e
giornalisti-propagandisti
tout court. Inevitabilmente questi diversi livelli
finiscono per incrociarsi nelle necessità di scelta inerenti
all’odierna
temperie politica.
Uno dei filoni di questo intreccio, nel negare le possibilità di un’analogia tra il fascismo storico ed elementi caratterizzanti il momento attuale definiti tramite il termine «fascismo», appare interessato, soprattutto, alla banalizzazione di tali fenomeni. E la banalizzazione è un modo particolarmente efficace per immetterci in una «notte in cui tutte le vacche sono nere» e le parole perdono il senso profondo del loro significato, nella storia e soprattutto nella memoria. È ora di sconfiggere «l’egemonia delle parole (il corsivo è mio) della sinistra»[1], ebbe a dire Gianfranco Fini nel momento in cui il «neofascismo», parola certo più adeguata nel contesto di esaurimento del «fascismo storico», cominciava la sua, finora, irresistibile ascesa. Un’ascesa che lo avrebbe portato da una presenza ai margini del sistema politico italiano al centro delle istituzioni, in particolare al centro dell’esecutivo, ed a diventare un aspetto rilevantissimo di tanta parte del «senso comune» degli italiani.
Il nostro presente italiano deve confrontarsi con fantasmi che non si sono dissolti nella dissoluzione del Novecento, ma che anzi, nei modi di quella dissoluzione hanno trovato nuove forme di apparizione, nuove forme di corposa presenza.
Leggi tutto
Sergio Bologna: Il “mancato approdo” del confronto tra operaie/i e capitale
Il “mancato approdo” del confronto tra operaie/i e capitale
Nuove e impervie sfide per il mondo del lavoro
di Sergio Bologna
Presentiamo l’ultima versione dell’intervento di Sergio Bologna al convegno di presentazione del numero speciale di «Primo maggio» a Torino, 1 dicembre 2018. Riteniamo le questioni poste di grande rilevanza e per questo sarebbe interessante e utile che su questi temi si potesse sviluppare un dibattito fruttuoso. Una versione precedente del testo è stata pubblicata sul sito di Commonware
 Quando inizia la
letteratura sul “declino” in Italia?
Quando inizia la
letteratura sul “declino” in Italia?
Sarebbe interessante fare una ricerca ad hoc, perché – se non ricordo male – non è stata una qualche corrente “riformista” ad iniziare questo percorso, sono stati ambienti culturali contigui a Confindustria. Un percorso che poi si è incamminato su un terreno dove il tema del “declino” è diventato quasi mainstream al punto da condizionare lo sguardo all’indietro (come dimostra l’Annale Feltrinelli dello scorso anno intitolato l’Approdo mancato). Senza riuscire a temperare tuttavia lo slancio cieco dell’onda mediatica che esaltava le magnifiche sorti e progressive del modello neoliberale e pretendeva piena, incondizionata fiducia in esse.
La classe capitalistica, la cui inettitudine viene continuamente messa in luce dalla letteratura sul “declino”, persevera nella sua autoreferenziale esaltazione della propria missione di classe dirigente, scaricando tutte la responsabilità del “declino” sulla politica.
Ma né gli uni né gli altri, né gli storici o gli analisti del “declino” né il padronato nel suo complesso s’interrogano se sia o meno il caso di rivedere il giudizio dato sui comportamenti antagonistici di classe degli Anni 70, anni di emancipazione e di produzione d’intelligenza operaia. Su quel ciclo di lotte continua invece a pendere il giudizio di condanna come un momento di follìa collettiva, d’insensatezza. Io credo che la lettura di quegli anni dovrebbe rivalutare come chiave interpretativa quella battuta di Mario Tronti, che tanto fece sorridere allora quando fu pronunciata, e cioé che “la lotta operaia impone lo sviluppo capitalistico”. La vicenda Fiat dal 1980 al 2002 è la controprova della giustezza di quella affermazione: là dove la lotta operaia tace, là dove il suo silenzio si fa prolungato, il capitalismo s’infogna in una crisi mortale. Sconfitti gli operai nell’ottobre 1980 e dopo ventidue anni di pace sociale, la Fiat e con essa l’industria italiana dell’auto, erano a terra.
Leggi tutto
Mario Giambelli: La pericolosa illusione della moneta fiscale (e complementare)
La pericolosa illusione della moneta fiscale (e complementare)
di Mario Giambelli
 Da qualche tempo
alcuni economisti e/o professionisti che si qualificano
esperti in economia, finanza, fiscalità,
sovranità e moneta propongono, per correggere le disfunzioni
dell’Eurosistema, l’introduzione, in forma gratuita ed
aggiuntiva,
della c.d. “moneta fiscale” [qualunque titolo che lo Stato
si impegna ad accettare per l’adempimento di obbligazioni
fiscali (tasse,
imposte, contributi ai sistemi sanitari e pensionistici
pubblici, eccetera), cioè di titoli finanziari che diano
diritto a conseguire, dopo un
certo numero di anni dalla loro introduzione, sconti
fiscali].
Da qualche tempo
alcuni economisti e/o professionisti che si qualificano
esperti in economia, finanza, fiscalità,
sovranità e moneta propongono, per correggere le disfunzioni
dell’Eurosistema, l’introduzione, in forma gratuita ed
aggiuntiva,
della c.d. “moneta fiscale” [qualunque titolo che lo Stato
si impegna ad accettare per l’adempimento di obbligazioni
fiscali (tasse,
imposte, contributi ai sistemi sanitari e pensionistici
pubblici, eccetera), cioè di titoli finanziari che diano
diritto a conseguire, dopo un
certo numero di anni dalla loro introduzione, sconti
fiscali].
Un diritto di riduzione degli importi dovuti a titolo di imposte (quindi un diritto a beneficiare di uno sconto fiscale) metterebbe in atto un’azione di stimolo della domanda aggregata, intervenendo sulle sue varie componenti e rilanciando contemporaneamente consumi privati, spesa sociale e investimenti. Tanto più la manovra venisse indirizzata verso soggetti con alta propensione e necessità di spesa, tanto più elevato sarebbe l’impatto sulla domanda aggregata.
Chi ricevesse Moneta Fiscale beneficerebbe di un immediato incremento della sua capacità di spesa, la rivolgerebbe all’acquisto di beni e servizi, e riavvierebbe produzione e occupazione. L’introduzione della Moneta Fiscale restituirebbe alle economie nazionali le leve d’azione perse con il passaggio alla moneta unica, senza peraltro compromettere (anzi, consentendo di raggiungere) l’obiettivo di stabilizzare in valore le passività statali da rimborsare in euro, e di ridurle costantemente rispetto al PIL.
La Moneta Fiscale sarebbe quindi la soluzione per dare stabilità ed efficienza all’Eurosistema e per risolvere il problema degli altissimi, inaccettabili, livelli di disoccupazione nell’Europa mediterranea. E tutto questo senza chiedere agli stati dell’ex area marco (Germania ma anche Austria e Olanda) neanche un centesimo di trasferimenti fiscali (soluzione alternativa che costerebbe a questi ultimi paesi il 5% del PIL indefinitamente).
Leggi tutto
nucleo comunista internazionalista: Gilet gialli di Francia
Gilet gialli di Francia
Una prima sommaria cronaca politica
di nucleo comunista internazionalista
La nostra gente ne ha piene le balle. Via il governo Macron, via il "governo dei ricchi"
 Nel
movimento di autentica rivolta popolare che come goccia che
ha fatto traboccare il vaso
è stato innescato dall’imposizione della tassa “ecologica”
sul diesel (ennesima tassa: “per il governo siamo come
delle vacche da mungere” si dice fra chi fatica ad
arrivare a fine mese e ne ha davvero piene le scatole e
dunque, vivaddio, si ribella
all’insopportabile stato delle cose) c’è, per il
momento, una prima data “spartiacque” che marchiamo nella
nostra
cronaca politica: il 17 di novembre 2018.
Nel
movimento di autentica rivolta popolare che come goccia che
ha fatto traboccare il vaso
è stato innescato dall’imposizione della tassa “ecologica”
sul diesel (ennesima tassa: “per il governo siamo come
delle vacche da mungere” si dice fra chi fatica ad
arrivare a fine mese e ne ha davvero piene le scatole e
dunque, vivaddio, si ribella
all’insopportabile stato delle cose) c’è, per il
momento, una prima data “spartiacque” che marchiamo nella
nostra
cronaca politica: il 17 di novembre 2018.
Prima di tale data, il movimento partito dall’iniziativa di alcune donne (fra cui una di colore, capirete subito più oltre il senso della puntualizzazione) che si sono messe a spulciare fra la gragnola di bollette e di relativi aumenti constatando e denunciando che “c’è qualcosa che non va” nell’andazzo delle cose “governato dai ricchi” e personificato dall’odiosa figura del presidente Macron che si tratta di cacciare via, prima di tale data dicevamo, il movimento è stato osservato e marchiato con un misto di supponenza e disprezzo dalla borghesia (dai maitre-à-penser al suo servizio). Un movimento che non è, e non può essere altro, dice la borghesia “illuminata” e “progressista”, che brodo di coltura di massa per la demagogia social-nazionale della Le Pen e delle altre correnti dell’estrema destra. Come il signorotto sapiente, civile, lungimirante che dall’alto guarda in basso lo spregevole e puzzolente popolaccio, rozzo e ignorante al punto di fregarsene dei destini ecologici del mondo ma di badare solo, volgarmente, ai destini delle sue tasche sempre più vuote e ai bassi istinti dettati dal suo stomaco.
(L’iniziativa-innesco primordiale della protesta di queste donne, in qualche modo ci richiama alla mente il ruolo della famosa “cuoca di Lenin”. Cioè la donna di casa che con il suo scrupolo, con il suo semplice criterio razionale è chiamata a far quadrare i conti della famiglia proletaria e che nella nostra prospettiva deve potere verificare, controllare e governare i conti dello Stato!
Leggi tutto
Luca Cangianti: Il Necronomicon di Karl Marx
Il Necronomicon di Karl Marx
di Luca Cangianti
Marcello Musto, Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883, Einaudi, 2018, pp. 344, € 30,00
È impossibile non notare alcuni elementi tragici e a tratti orrifici nella vita di Karl Marx. La biografia di questo filosofo è una lunga lotta prometeica per completare Il capitale, il «più terribile proiettile che sia mai stato scagliato contro i borghesi», il libro magico che a detta del suo autore avrebbe inflitto «alla borghesia, sul piano teorico, un colpo dal quale non si riprenderà più». Il rapporto tra Marx e Il capitale è paragonabile a quello tra l’«arabo pazzo» Abdul Alhazred e il Necronomicon, lo pseudobiblion inventato dallo scrittore statunitense Howard Phillips Lovecraft. L’autore di quel grimorio immaginario muore divorato in pieno giorno da una creatura invisibile, così come tutta la vita del filosofo di Treviri è fagocitata da un progetto incompletabile: «il mio tempo di lavoro appartiene interamente alla mia opera» confessa Marx, evidenziando il paradossale processo di alienazione nei confronti del suo libro.
La scrittura del Capitale è un viaggio eroico, portato avanti con passione cristologica tra i tormenti di un corpo mutante afflitto da insonnia, da emicrania, da un fegato duro e ingrossato, dal continuo insorgere di dolorosissimi favi e di lesioni pustolose sui genitali. Marx è un immigrato apolide, senza mai un soldo in tasca, inseguito da droghieri, macellai e lancinanti sensi di colpa nei confronti della famiglia.
Leggi tutto
È l’euro, argomento tabù, la causa principale dei “gilet gialli”
È l’euro, argomento tabù, la causa principale dei “gilet gialli”
Un gruppo di economisti, tra cui Jacques Sapir, pubblica un articolo sul blog francese “Les Crises” in cui cerca di riassumere in pochi paragrafi il grande argomento “tabù” di cui in Francia (come e forse più che in Italia) nessuno parla: l’euro. Con la conseguenza del tasso di cambio fisso, l’euro impone di aggiustare gli squilibri tramite svalutazione interna, causando disoccupazione e riduzione del potere d’acquisto. La rivolta, in Francia, è cominciata, sebbene la consapevolezza sulle sue ragioni profonde sia ancora limitata
A quasi vent’anni dal lancio dell’euro, avvenuto il primo gennaio 1999, la situazione della moneta unica è paradossale. Da un lato, il fallimento di questo progetto è palese, ed è stato riconosciuto dalla maggior parte degli economisti competenti, tra cui molti premi Nobel. Dall’altro lato, questo argomento continua a restare un tabù in Francia, tanto che nessun politico di rilievo osa affrontarlo a testa alta. Come si spiega una situazione del genere?
Nessuno sembra ricollegare l’attuale movimento dei “gilet gialli” al fallimento dell’euro. Eppure, l’impoverimento della maggior parte della popolazione, di cui esso è il segno più manifesto, è la conseguenza diretta delle politiche messe in atto per tentare di salvare a qualsiasi costo la moneta unica europea. Non si sta parlando, qui, dell’allentamento della politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea col suo quantitative easing, peraltro inefficace nel rilanciare la produzione.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Mattarella il Presidente dei ricchi e il sovranismo psichico
Mattarella il Presidente dei ricchi e il sovranismo psichico
Viva la cattiveria!
di Ugo Boghetta
Raccontano che alla prima della Scala il Presidente Mattarella ha ricevuto un’ovazione: un applauso fragoroso lungo più di cinque minuti. E’ un evento significativo. Le élite di questo paese vedono in Mattarella il loro difensore. Qualche giornalista motiva quell’applauso per il comportamento rigoroso e neutrale. Qualcuno lo ha paragonato a Pertini!?!
Ma le cose non stanno così. Mattarella si è dimostrato
assolutamente di parte scaricando Savona in quanto antieuro
e inviso ai
mercati. Un presidente del liberismo piuttosto che della
Costituzione del ’48. Di questa infatti cita solo l’articolo
81 (il pareggio di
bilancio).
Pertini invece stava dalla parte del popolo non certo dei
Mercati, dei mercanti, degli speculatori.
Quell’applauso dimostra ancora una volta la secessione delle élite dal popolo e dai valori costituzionali. La loro ideologia politicamente corretta è il liberismo, l’europeismo con una mano di vernice di antifascismo di maniera e antirazzismo da salotto (tanto i migranti vanno nelle periferie...).
A parlare dell’altra parte è l’ultimo rapporto del Censis che testimonia il passaggio di quote consistenti di italiani dall’indolenza alla cattiveria. Questo cambiamento è stato chiamato: “sovranismo psichico“: è tutta colpa della mancanza di sovranità nazionale. E’ un qualcosa che si è radicato nelle mente come qualsiasi idea, ma quel psichico sta per malato, inquietante, disturbante.
Leggi tutto
Vittorio Morfino: La temporalità plurale
La temporalità plurale
La storia e le storie nel pensiero marxiano
di Vittorio Morfino
Pubblichiamo un estratto della
relazione che verrà
presentata al convegno 200 Marx. Il futuro di Karl, al
Museo Macro di Roma, dal 13 al 16 dicembre. Qui
il sito
dell’iniziativa
Per affrontare la questione della storia al singolare o al plurale nel pensiero marxiano, vorrei servirmi di una duplice tradizione: la prima è quella che ho chiamato, con un gesto arbitrario e con un colpo di forza teorico, tradizione marxista della temporalità plurale: Bloch, Gramsci, Althusser e – perché no? – Chakrabarty. In essa la temporalità plurale viene fatta emergere dai testi marxiani, spesso con sviluppi originali rispetto ad analisi di congiunture differenti. Tuttavia per dare consistenza teorica a quelli che sono di fatto abbozzi di una teoria, è stato necessario costruire una sorta di preistoria, quella che potremmo chiamare, mimando un’espessione althusseriana, corrente sotterranea della temporalità plurale: Lucrezio, Machiavelli, Spinoza, Herder, Darwin, Freud. Con tutti i limiti che la metafora della corrente porta con sé, è possibile rintracciare una comune opposizione in questi autori alla temporalità unilineare, sia essa pensata nella forma del circolo o della linea. La metafora del sottosuolo indica invece tanto la posizione subalterna rispetto al pensiero dominante, quanto i fraintendimenti di cui questi pensatori sono stati fatti oggetto dal pensiero dominante stesso, rendendo invisibile questa tradizione sulla superficie. Questo è il circolo, vizioso o virtuoso che sia, che ho messo in campo per leggere a contropelo alcuni testi di Marx.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: La ministra Trenta in mimetica per la «pace» in Afghanistan
La ministra Trenta in mimetica per la «pace» in Afghanistan
di Manlio Dinucci
La ministra della Difesa Elisabetta Trenta (M5S), ai microfoni di una radio musicale, ha intonato «C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones», dicendo «Questa canzone mi fa venire in mente il valore della pace, un valore inestimabile che dobbiamo preservare sempre». Una decina di giorni dopo, in divisa mimetica in Afghanistan, la ministra esaltava «la nostra presenza in armi fuori dai confini dell’Italia, guidata dai valori della nostra Costituzione, in una missione fondamentale per la pace».
La missione è la Resolute Support (Appoggio Risoluto), iniziata dalla Nato in Afghanistan nel 2015 in prosecuzione dell’Isaf, missione Onu di cui la Nato aveva preso il comando con un colpo di mano nel 2003. Prosegue così la guerra Usa/Nato in Afghanistan, entrata nel 18° anno.
Fu lanciata dagli Usa il 7 ottobre 2001 con la motivazione ufficiale di dare la caccia a Osama bin Laden, accusato degli attacchi dell’11 settembre, nascosto in una caverna afghana sotto protezione dei talebani. Quali fossero i reali obiettivi lo rivelava il Pentagono in un rapporto diffuso una settimana prima dell’inizio della guerra: «Esiste la possibilità che emerga in Asia un rivale militare con una formidabile base di risorse.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3225
Hits 2722
Hits 2355
Hits 2230
Hits 1967
Hits 1837
tonino

coniarerivolta: Ce lo chiede l’Europa: disoccupazione, disuguaglianza e precarietà
Ce lo chiede l’Europa: disoccupazione, disuguaglianza e precarietà
di coniarerivolta
Potere al Popolo! ha recentemente lanciato un invito al dibattito ed al confronto sull’Europa, in vista delle elezioni europee del 2019. Accogliamo l’invito e pubblichiamo il nostro secondo contributo sul tema
 Cosa ci chiede l’Europa
lo sappiamo fin troppo bene: con la sua disciplina fiscale ci
chiede di tagliare la
spesa pubblica in sanità, istruzione, cultura, sicurezza,
infrastrutture e di ridurre le pensioni; con il suo modello di
economia di mercato ci
chiede di competere con i salari di paesi dove lo stipendio
mensile lordo non supera 400 euro, di accettare una crescente
precarietà del lavoro
e dei tempi di vita attraverso le liberalizzazioni, di
rinunciare a qualsiasi forma di controllo pubblico
sull’economia, dalle grandi reti
infrastrutturali ai servizi pubblici locali. Ci chiede,
insomma, tutto quello che i Governi degli ultimi 30 anni hanno
scrupolosamente realizzato: che
partissero da centrosinistra, da centrodestra, oggi
addirittura da una piattaforma populista, tutti hanno seguito
la stessa direzione,
quell’austerità che ha portato in Europa una crisi che in
tempi di pace non si vedeva da quasi un secolo. Ma
perché
l’Europa ci chiede questo?
Cosa ci chiede l’Europa
lo sappiamo fin troppo bene: con la sua disciplina fiscale ci
chiede di tagliare la
spesa pubblica in sanità, istruzione, cultura, sicurezza,
infrastrutture e di ridurre le pensioni; con il suo modello di
economia di mercato ci
chiede di competere con i salari di paesi dove lo stipendio
mensile lordo non supera 400 euro, di accettare una crescente
precarietà del lavoro
e dei tempi di vita attraverso le liberalizzazioni, di
rinunciare a qualsiasi forma di controllo pubblico
sull’economia, dalle grandi reti
infrastrutturali ai servizi pubblici locali. Ci chiede,
insomma, tutto quello che i Governi degli ultimi 30 anni hanno
scrupolosamente realizzato: che
partissero da centrosinistra, da centrodestra, oggi
addirittura da una piattaforma populista, tutti hanno seguito
la stessa direzione,
quell’austerità che ha portato in Europa una crisi che in
tempi di pace non si vedeva da quasi un secolo. Ma
perché
l’Europa ci chiede questo?
Le risposte più comuni a questa domanda, affatto banale, sono due. La risposta dell’Europa e degli europeisti è la seguente: in Italia, così come in tutta la periferia europea, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, con un modello di sviluppo incompatibile con la dimensione globale che il progresso tecnico impone ai sistemi produttivi moderni; i sacrifici derivanti dall’abbandono di questa organizzazione sociale obsoleta e insostenibile sarebbero più che compensati dal futuro radioso che l’affermazione di una moderna economia di mercato spontaneamente realizzerà. La risposta di molti euroscettici non mette in discussione gli obiettivi dichiarati dalle istituzioni europee, che sarebbero sempre quelli di garantirci un futuro migliore nel turbinio della globalizzazione, ma critica piuttosto la messa in pratica di questo progetto: secondo alcuni l’Europa sarebbe un grande errore, un’istituzione mal congegnata, un’unione economica incompleta condannata al fallimento dalle teorie economiche sbagliate su cui è disegnata.
Leggi tutto
Matteo Bortolon: Lo spettro della UE
Lo spettro della UE
di Matteo Bortolon
 1. La blindatura
1. La blindatura
Uno spettro si aggira per l’Italia: lo spettro della Unione Europea. A pochi mesi dalle elezioni europee di maggio 2019 pare sempre più probabile che le forze anti-UE facciano il pieno di voti, arrivando forse persino ad insidiare il dominio che le famiglie politiche tradizionali (conservatori del Partito popolare europeo e progressisti) hanno sempre mantenuto sulle istituzioni comunitarie.
A fronte di questo scenario quello che colpisce in Italia è il contrasto fra un lavorio febbrile di riposizionamenti, scissioni e iniziative per costruire liste e un dibattito sui temi assai modesto, quasi inesistente. In pratica le elezioni europee sono considerate come un prolungamento della competizione politica che si svolge a livello nazionale. Persino il contrasto fra le istituzioni comunitarie e la maggioranza di governo non spinge ad una riflessione più approfondita sulla natura degli assetti europei. Nel migliore dei casi si dibatte sulla idea di “Europa”, non su quella reale. La realtà della UE diventa – appunto – spettrale e impalpabile. Un fantasma.
La cosa appare tanto più preoccupante se si considera che solo pochi anni fa, a ridosso della crisi economica del 2007-2008, si sviluppò un certo dibattito circa la forza degli assetti finanziari sulla società e sulla economia reale. Quando dal 2009 il focus si spostò sullo scacchiere europeo, rendendo popolari termini quali spread, rating e simili, fu come se si sollevasse un velo di menzogne che oscurava la realtà di una UE dominata dalle banche e dalla Germania.
Gli anni chiave per l’Italia sono stati 2011-2012 col passaggio dal traballante esecutivo di Berlusconi a quello di Monti, forte della più ampia maggioranza del periodo storico recente, col definitivo, esplicito allineamento del PD alle forze dominanti.
Leggi tutto
Judith Balso: Di che colore è il tempo che viene con i "gilet gialli"?
![]()
Di che colore è il tempo che viene con i "gilet gialli"?
di Judith Balso
Ciò che il movimento dei gilet gialli ci insegna sullo stato della Francia, sullo stato dello Stato e sullo stato delle attuali questioni politiche
 Nell'attuale deserto di ogni condivisione di
una vera
intellettualità politica, i "movimenti" sono attesi come la
salvezza, coccolati come il possibile segno di un
sollevamento generale, da parte
di tutti coloro che sono rivoltati dallo stato di questo
mondo. Perché quelli e quelle in Francia che non hanno
conosciuto nessuna grande lotta
si vivono attualmente come una sorta di "generazione
sacrificata", che la storia avrebbe privato di qualsiasi
evento politico – il che acuisce
in loro il desiderio di trovare una positività in situazioni
in cui le persone dichiarano di muoversi e agire contro
un'oppressione.
Nell'attuale deserto di ogni condivisione di
una vera
intellettualità politica, i "movimenti" sono attesi come la
salvezza, coccolati come il possibile segno di un
sollevamento generale, da parte
di tutti coloro che sono rivoltati dallo stato di questo
mondo. Perché quelli e quelle in Francia che non hanno
conosciuto nessuna grande lotta
si vivono attualmente come una sorta di "generazione
sacrificata", che la storia avrebbe privato di qualsiasi
evento politico – il che acuisce
in loro il desiderio di trovare una positività in situazioni
in cui le persone dichiarano di muoversi e agire contro
un'oppressione.
Questa soggettività richiede una prima discussione.
Da un lato, di questi tempi, non sono gli eventi politici che mancano, è il pensiero politico che manca. O meglio, se i movimenti che sorgono sono alla fine così deboli, è perché il pensiero della politica è debole. I più grandi movimenti recenti lo hanno dimostrato: l'Egitto, la Tunisia, le cui forti insurrezioni sono ricadute sotto il controllo dei “partiti dell'ordine”, o persino dell'esercito; la Grecia è stata ammanettata dall'Europa e condotta alla rinuncia da quelli stessi (Syriza) che fingevano di mantenerla in piedi; anche qui in Francia, il movimento contro la legge sul lavoro è stato cieco sullo stato delle questioni al punto da rivendicare ... la legge delle 35 ore, che era stato il cavallo di Troia della flessibilità generalizzata e della distruzione dei diritti del lavoro.
D'altra parte, nessun movimento è in grado da solo di creare una nuova politica. Un movimento rivela lo stato delle politiche esistenti ed è da esse attraversato. Può quindi aprire una nuova congiuntura per tutte queste politiche, ma di per sé non crea una nuova politica. Questo è vero anche per movimenti molto grandi, come quello del maggio 68 in Francia, o come quelli della Primavera araba.
In queste condizioni, la domanda diventa non più a favore o contro i gilet gialli, ma quale congiuntura si apre con questo movimento? Secondo me, quella che si apre è una congiuntura pericolosa e non ci si deve accontentare di parole vuote. Proverò ad elencare alcuni per dire come la vedo.
Leggi tutto
Francesco Galofaro: Recensione del libro di Carlo Galli "Marx eretico"
Recensione del libro di Carlo Galli "Marx eretico"
di Francesco Galofaro
Carlo Galli, Marx eretico, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 164, 13,00 euro
 Perché scrivere l'ennesimo libro su Marx? Forse
perché di
moda: 43 i titoli dedicati a Marx nel 2018, tra inediti e
ristampe. A giudicare dal numero di opere, si direbbe che il
marxismo sia vivo, avanzi e
conquisti il mondo. Non è stato detto già tutto su Marx? A
quanto pare la risposta è no: nella fase politica nuova che si
è aperta in Europa e nei Paesi occidentali, alcune
caratteristiche del pensiero marxiano mostrano un rinnovato
interesse. La nuova situazione
spinge a verificare la tenuta della filosofia politica
contemporanea. Inoltre, è evidente a tutti l’estinzione della
sinistra europea:
tanto di quella socialdemocratica, il portiere di notte del
condominio liberista europeo, quando di quella radicale,
subalterna alla prima e privata
del suo spazio politico dal successo di movimenti populisti e
della nuova destra sociale.
Perché scrivere l'ennesimo libro su Marx? Forse
perché di
moda: 43 i titoli dedicati a Marx nel 2018, tra inediti e
ristampe. A giudicare dal numero di opere, si direbbe che il
marxismo sia vivo, avanzi e
conquisti il mondo. Non è stato detto già tutto su Marx? A
quanto pare la risposta è no: nella fase politica nuova che si
è aperta in Europa e nei Paesi occidentali, alcune
caratteristiche del pensiero marxiano mostrano un rinnovato
interesse. La nuova situazione
spinge a verificare la tenuta della filosofia politica
contemporanea. Inoltre, è evidente a tutti l’estinzione della
sinistra europea:
tanto di quella socialdemocratica, il portiere di notte del
condominio liberista europeo, quando di quella radicale,
subalterna alla prima e privata
del suo spazio politico dal successo di movimenti populisti e
della nuova destra sociale.
Se la situazione è questa, il libro di Galli mostra senz’altro un proprio interesse e una fisionomia specifica. Non solo non si tratta di una esposizione introduttiva al pensiero del filosofo di Treviri, ma richiede al contrario la conoscenza di filosofi della politica molto distanti da Marx, come Schmitt e Popper, Derrida e Arendt. E’ un libro difficile. E si pone programmaticamente al di fuori del marxismo: la tesi di Galli è che il marxismo è un effetto della filosofia marxiana, la cui strutturale incompiutezza ha generato una molteplicità di interpretazioni e tentativi di rinchiudere in un sistema un pensiero che ha fatto dell’apertura asistematica il proprio stesso fondamento. Tutto questo non può che rendere questa lettura interessante a paragone dei 'ritorni a Marx' professati da ogni nuovo leader di ogni piccolo movimento pseudomarxista dagli anni '70 ad oggi (tutta gente che ha scritto molto, ha letto poco, e ha compreso ancora meno).
Questa recensione non riassumerà il libro, ma si concentrerà programmaticamente attorno ad alcune parole-chiave: popolo, win-win society, nichilismo, ultimi, decrescita felice, questione nazionale, diritti, incompiutezza. Non che Galli dedichi loro paragrafi o capitoli appositi, ma esse fanno capolino qua e là, a caratterizzare il modo in cui - a parere di chi scrive - attraverso Marx Galli legge il reale contemporaneo.
Leggi tutto
Sergio Cappello: Media e gilets gialli: come il nuovo fascismo si serve del vecchio
Media e gilets gialli: come il nuovo fascismo si serve del vecchio
di Sergio Cappello*
Mai come in queste cinque – sei settimane di “crisi” dei Gilet gialli, i media dominanti francesi hanno esercitato il loro ruolo di guardiani dell’ordine stabilito.
L’associazione Acrimed (Azione – Critica – Media) denuncia un trattamento mediatico fondato sull’appiattimento senza riserve dell’informazione sulla comunicazione del governo, sull’intimazione incessante a non manifestare, sulla sovraesposizione delle violenze (ma solo quelle dei manifestanti), sulle ingiunzioni unanimi e unilaterali a condannarle, sulla delegittimazione delle rivendicazioni e di certi rappresentanti della mobilitazione. È la copertura, ormai abbastanza classica dei movimenti sociali di massa, ma con qualcosa di nuovo.
In queste settimane di crisi governativa, in effetti, il panico è subentrato nelle redazioni, dove i soliti noti delle testate giornalistiche e radiotelevisive hanno creduto opportuno assumere tutti i ruoli, da quello di consiglieri in comunicazione del presidente a quello di arbitri della legittimità delle rivendicazioni o addirittura di organizzatori del dialogo sociale. Una tale agitazione nasce probabilmente dal dubbio che sembra aleggiare nelle loro menti: il popolo ignorante, manipolabile a volontà, sarebbe dunque capace di pensare, analizzare e comprendere da solo?
Leggi tutto
Carlo Clericetti: Anche i Draghi sbagliano
Anche i Draghi sbagliano
di Carlo Clericetti
“Mario, quali dati stai guardando?” Lucio Baccaro, direttore dell’autorevole centro di ricerche tedesco Max Planck, è rimasto un po’ sconcertato dalla lettura del discorso che il presidente della Bce ha tenuto il 15 dicembre alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, che gli ha conferito la laurea honoris causa.
Il passaggio che ha colpito Baccaro è questo:
“La flessibilità dei tassi di cambio avrebbe indebolito il mercato unico in due modi. In primo luogo avrebbe ridotto l’incentivo delle imprese residenti nel paese che svalutava ad accrescere la produttività, perché avrebbero potuto – sia pur temporaneamente – elevare la competitività senza aumentare il prodotto per addetto. L’Europa sperimentò ripetutamente come questa via fosse tutt’altro che efficace. Dal varo dello SME nel 1979 alla crisi del 1992 la lira venne svalutata 7 volte rispetto al DM (marco tedesco), perdendo cumulativamente circa la metà del suo valore rispetto a questa valuta. Eppure, la crescita media annua della produttività in Italia fu inferiore a quella dei futuri paesi dell’area dell’euro a 12 nello stesso periodo”.
I dati, però, non sembrano andare d’accordo con queste affermazioni. Ecco un grafico sulla produttività (Pil reale per ora lavorata)dell’Italia a confronto con quella europea, di fonte Ocse. Le due linee rosse segnano l’ingresso e l’uscita dallo Sme (1979 e 1992).
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Habermas dinanzi all’integralismo dell’economia
![]()
Habermas dinanzi all’integralismo dell’economia
di Salvatore Bravo
Gli integralismi dell’epoca attuale non sono semplicemente eventi senza nessuna ragione, fenomeni naturali che in quanto tali devono essere accettati con una semplice constatazione. Gli integralismi hanno la loro genesi in una serie di cause, la Filosofia in tal senso ha le sue responsabilità. J. Habermas nel testo “Tra scienza e fede”, constata l’avvento dell’era postmetafisica ed il trionfo della cultura democratica pur minacciata da integralismi che le mordono il fianco. Dinanzi allo svuotamento di senso della democrazia, all’attacco degli integralismi oppone la ragione con i suoi nessi comunicativi. La ragione ha la funzione attraverso la sua capacità di traduzione comunicativa di fare da collante tra le diverse situazioni degli interlocutori, essa diviene il debole universale delle prospettive che si affrontano. Debole universale in quanto Habermas giudica ogni fondazione metafisica tramontata, la ragione è il residuo restante della Filosofia dopo che la sua fondazione veritativa è stata praticamente cancellata dagli eventi storici. Si consegna la Filosofia al nichilismo storicistico sottraendole l’eterno. Dunque ragione senza fondamento, spogliata di ogni fondamento veritativo diviene il residuo filosofico dell’occidente, del pianeta globalizzato su cui fondare la comunicazione tra prospettive differenti. Essa è il punto archimedico di incontro di una realtà sociale sempre sul punto di frammentarsi in un pulviscolo di conflitti.
Leggi tutto
Loris Caruso: Full Metal Masterchef e lo sfruttamento postfordista
Full Metal Masterchef e lo sfruttamento postfordista
di Loris Caruso
Oggi ricomincia il talent show culinario di maggiore successo. Analisi di uno spettacolo e della sua funzione ideologica: trasmettere l'etica del lavoro contemporaneo
Perché i media fanno quello che fanno e dicono quello che dicono? Per vendere e conquistare ascolti o per diffondere ideologie? I mezzi di comunicazione sono imprese che vendono prodotti e cercano di massimizzare i profitti, o sono soprattutto organizzazioni ideologiche? E se sono tutte e due, in che relazione stanno queste due cose tra loro? Da molto tempo la sociologia della comunicazione accademica ha propeso per la prima ipotesi: i media sarebbero semplicemente aziende che vendono prodotti. L’ideologia non c’entra. Basta parlare di ideologia. L’ideologico è chi ci vede dell’ideologia. Così, si è spesso rinunciato a capire in che modo i prodotti della comunicazione di massa contengano ideologia. Eppure molto del senso comune nasce nei luoghi meno sospetti. L’ideologia è al suo massimo quando non sembra ideologia. Come accade nei prodotti di puro entertainment.
Ad esempio Masterchef, una delle trasmissioni più popolari, viste, cliccate e replicate degli ultimi anni. Per i pochi che non ne hanno mai visto nemmeno uno stralcio, spieghiamo velocemente in cosa consiste. Si tratta di una gara di cucina tra cuochi dilettanti.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Crisi Europa: non si salvi chi può
Crisi Europa: non si salvi chi può
di ilsimplicissimus
Tra le cose più imbarazzanti della resa senza condizioni del governo Conte a Bruxelles c’è il fatto che la bandiera bianca è stata sollevata in un momento in cui la Ue è in profondissima crisi e di certo non ha bisogno di altri scossoni, anche se ha ancora la forza di ringhiare: la rivolta francese contro la dottrina dell’austerità non si arresta, mentre prosegue il disordinato divorzio della Gran Bretagna e la grande stilista dell’europa contemporanea, la signora Merkel, ha già annunciato il suo ritiro e con esso anche quello della classe politica che ha gestito l’unificazione tedesca e la trasformazione del marco in euro. Ma che si fosse messa in moto una faglia continentale lo si poteva avvertire già da qualche tempo e la prima forte scossa si è manifestata nel 2016 prima con il referendum sull’unione in Gran Bretagna e poi con l’elezione di Trump in Usa che hanno messo in crisi le elite anglosassoni che avevano disegnato l’Europa a loro immagine e somiglianza e in vista dei propri interessi.
Questa cosa non sembra ancora abbastanza chiara agli europeisti che non la vogliono vedere dal momento che tale prospettiva contraddirebbe tutto ciò che essi portano all’attivo, ma non di meno essa è reale: l’Europa è stata una costruzione americana e non certo un’ Unione per proteggersi dallo strapotere americano come generalmente è stata interpretata dalla socialdemocrazia occidentale.
Leggi tutto
Riccardo Realfonzo: Su austerità e precarietà
Su austerità e precarietà
Documento della consulta economica per il Congresso FIOM-CGIL 2018
di Riccardo Realfonzo
Sottoinvestimenti, deindustrializzazione e bassa competitività del Mezzogiorno e del Paese. Una vertenza per una nuova stagione di politiche industriali. Riccardo Realfonzo interviene come coordinatore della consulta economica della FIOM al Congresso della FIOM-CGIL tenutosi a Riccione dal 12 al 15 dicembre 2018. L’analisi mostra quale sia stato il drammatico sottofinanziamento delle politiche industriali nel decennio successivo alla crisi scoppiata nel 2008 ed anche gli effetti negativi delle politiche di deflazione salariale. Occorrerebbe una svolta di politiche industriali e del lavoro che è assente nella nuova manovra del governo in carica
 1.
Premessa
1.
Premessa
Questo documento è stato realizzato dalla Consulta economica della FIOM-CGIL (coordinata da Riccardo Realfonzo), a seguito di numerosi momenti di confronto con le segreterie regionali e i lavoratori organizzati dalla FIOM nel corso del 2018 e nel dialogo continuo con la Segreteria Nazionale che ne ha condiviso i contenuti. Emerge la necessità di una nuova stagione di politiche industriali che, a partire dal Mezzogiorno, ponga le basi per un rilancio dell’industria e dell’intero sistema produttivo del Paese, al fine di arrestare i processi di declino in atto e garantire le condizioni per una crescita occupazionale e una più equa distribuzione dei redditi. Le politiche industriali dovrebbero sostanziarsi in una strategia unitaria, sovraregionale, dotata di finanziamenti ben maggiori rispetto a quelli messi in campo negli ultimi anni e dal governo in carica. Una strategia da attuare mediante nuovi investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, un articolato sistema di incentivi e aiuti alle imprese che permetta loro di compiere un salto tecnologico-dimensionale e che le spinga a investire sulla qualità del lavoro, un adeguato sistema di ammortizzatori sociali che sostenga le imprese e i lavoratori nelle fasi di rallentamento della produzione e nelle crisi industriali. Questa nuova stagione di politiche industriali dovrebbe prendere le mosse dalla consapevolezza del drammatico sottoinvestimento pubblico e privato realizzato dal Paese negli scorsi anni, almeno a partire dalla crisi del 2007-2008. Un sottoinvestimento che ha favorito la deindustrializzazione, ha impoverito drammaticamente l’Italia e ha assecondato i processi di distruzione di capacità produttiva innescatisi dopo la crisi, e che a fine 2017 vede il Paese, e in misura ancora più radicale il Mezzogiorno, ancora molto lontano dai livelli di produzione di dieci anni prima.
Leggi tutto
Robert Kurz: Tutto sotto controllo sulla nave che affonda
Tutto sotto controllo sulla nave che affonda
di Robert Kurz
 Sovraccumulazione,
crisi da indebitamento e «politica»
Sovraccumulazione,
crisi da indebitamento e «politica»
A partire dagli anni Settanta sono sempre più numerosi i sintomi di una grave crisi per la riproduzione del sistema globale della merce. Tassi di crescita declinanti o stagnanti, disoccupazione «strutturale» di massa largamente svincolata dal ciclo congiunturale, sia nei paesi sviluppati dell’OCSE che alla periferia del mercato mondiale, la crescita del protezionismo con le avvisaglie ben visibili di una «guerra commerciale» tra gli USA, il Giappone e l’Europa e, non da ultimo, la «crisi del debito» strisciante del Terzo mondo, sono tutte manifestazioni di una crisi ormai impossibile da trascurare, su cui incombe, come se non bastasse, una crisi ecologica su scala planetaria sempre più minacciosa: dal «buco dell’ozono» nell’atmosfera terrestre fino alla distruzione delle foreste equatoriali africane e amazzoniche, dall’espansione delle distese desertiche fino alla contaminazione delle catene alimentari, dalla devastazione dei sistemi ecologici come il Mare del Nord, le Alpi e il Mediterraneo fino all’inquinamento irreversibile del terreno e delle acque potabili etc.
Allo stesso tempo però anche il sedicente «socialismo reale», ex- e pseudo-alternativa dell’ormai devastante sistema della merce – di cui è, in realtà, carne della stessa carne – si dibatte in una crisi ancora più grave, almeno per il momento. Stagnazione e paralisi culturale, una produttività sempre più declinante rispetto all’Occidente, disordini nazionali e separatismi ne sono altrettanti indizi, così come la rapidità della distruzione ecologica, forse l’unico terreno in cui lo «standard occidentale» sia stato non solo raggiunto ma addirittura superato.
Si ha però l’impressione che, «in un modo o nell’altro», ci si debba rassegnare a questi due sistemi in disarmo; l’uomo finisce con l’assuefarsi a tutto, persino alla propria fine.
Leggi tutto
Mario Lupoli: La manipolazione genetica tra barbarie e possibilità
La manipolazione genetica tra barbarie e possibilità
di Mario Lupoli
 Le tecnoscienze contemporanee da una parte
producono possibilità
straordinarie per l’umanità intera, dall’altra rispondono a
interessi economici, sociali e politici della società
capitalistica, e ne esprimono e riproducono una razionalità
cieca e costitutivamente incapace di autoriflessione. La
facoltà di porre un
argine contro i rischi e le minacce che comportano gli
interventi sulla genetica umana, e di cogliere al contempo
le opportunità che le scienze
possono offrire, rimanda necessariamente a un consapevole
controllo di un’umanità socializzata, capace non solo di
un’amministrazione generale coerente con gli interessi umani
e con gli equilibri del pianeta, ma di assumere un punto di
vista e una prospettiva
radicalmente altri da quello della razionalità del dominio,
troppo spesso assunta come in sé neutra, come se fosse
sufficiente liberarla
dalle mani borghesi. Una prospettiva riduzionistica e
metafisica che compromette uno statuto della teoria
comunista all’altezza delle questioni
che pone la società contemporanea.
Le tecnoscienze contemporanee da una parte
producono possibilità
straordinarie per l’umanità intera, dall’altra rispondono a
interessi economici, sociali e politici della società
capitalistica, e ne esprimono e riproducono una razionalità
cieca e costitutivamente incapace di autoriflessione. La
facoltà di porre un
argine contro i rischi e le minacce che comportano gli
interventi sulla genetica umana, e di cogliere al contempo
le opportunità che le scienze
possono offrire, rimanda necessariamente a un consapevole
controllo di un’umanità socializzata, capace non solo di
un’amministrazione generale coerente con gli interessi umani
e con gli equilibri del pianeta, ma di assumere un punto di
vista e una prospettiva
radicalmente altri da quello della razionalità del dominio,
troppo spesso assunta come in sé neutra, come se fosse
sufficiente liberarla
dalle mani borghesi. Una prospettiva riduzionistica e
metafisica che compromette uno statuto della teoria
comunista all’altezza delle questioni
che pone la società contemporanea.
* * * *
L’annuncio della nascita in Cina di due gemelle «con il Dna modificato con la tecnica del taglia-incolla del Dna, la Crispr, in modo da renderlo resistente al virus Hiv»[1], è in attesa di conferme da fonti terze. La notizia sta comunque sollevando dibattiti di portata globale, per le speranze sulle ricadute sanitarie che potrebbe avere e per le preoccupazioni che implicano gli interventi di ingegneria genetica sull’uomo e i possibili programmi di eugenetica.
D’altronde anche le ricerche che si stanno sviluppando nella Silicon Valley sull’immortalità, attraverso la combinazione di robotico, digitale e biologico, rientrano in una tendenza prepotente a oltrepassare in modo visibile i confini di ciò che appare tacitamente lecito alla coscienza comune.
Leggi tutto
Ivan Mikhajlovič Syroežin: Pianificabilità, pianificazione, piano
![]()
Pianificabilità, pianificazione, piano
di Ivan Mikhajlovič Syroežin
Capitolo 3 - Condizioni strutturali e informative di realizzazione della pianificabilità (parte I)
 Introduzione di Paolo
Selmi
Introduzione di Paolo
Selmi
L’uomo celebrato in questa foto, probabilmente rubata perché non in posa, visibilmente preoccupato, attaccato a due telefoni per qualcosa che non va come deve (con il personaggio che cerca di smarcarsi dietro ancor più preoccupato per quello che accadrà nel momento in cui appoggerà entrambe le cornette...), è un mito, una leggenda per un intero popolo, orgoglio di un’intera generazione e finanche visione del mondo: oggi, probabilmente, non dirà niente a nessuno il nome del “progettista capo” (главный конструктор) Sergej Pavlovič Korolëv (pronuncia italiana “karaliòv”, 1907-1966). A lui si deve la fase epica dell’epopea spaziale sovietica, dallo Sputnik (1957) alla prima passeggiata nello spazio (1965), passando per la cagnetta Lajka (1957), il primo cosmonauta nello spazio, Jurij Alekseevič Gagarin (1961), la prima cosmonauta, prima civile, nonché prima operaia nello spazio, Valentina Vladimirovna Tereškova (1963), insieme a una serie di altri record che in questo emisfero difficilmente si ricordano. Non è, ovviamente, un caso (anche se dovrebbe stupire il fatto che così si comportino anche “a sinistra”), così come non sono i record stessi frutto del caso: un Paese che poco più di dieci prima era appena emerso da un conflitto a cui aveva pagato un enorme tributo di sangue (quei venti milioni di morti che nessuno, guarda caso, ricorda) e distruzione, grazie al proprio sistema economico, al proprio modo di produzione, al proprio popolo, al proprio partito, e a un geniale glavnyj konstruktor, aveva compiuto ciò che nessuno avrebbe MAI immaginato potesse compiere.
Questo, ovviamente, dava fastidio: dovevano continuare a mangiare bambini. E dà fastidio ancora oggi: tre film sono usciti recentemente e sempre, guarda caso, con la solita distribuzione ridicola (se mai vi è stata), tipica da repubblica delle banane qual’è la nostra; anzi, già tanto che siano stati doppiati e non censurati nelle scene con troppo rosso, sia pur – ormai – solo coreografico. Stiamo parlando di: Gagarin, primo nello spazio (Гагарин, первый в космосе, Russia, 2013), Il tempo dei primi (Времия первых, Russia, 2017) e Saljut-7 (Салют-7, Russia, 2017).
Leggi tutto
Militant: Il governo del cedimento
Il governo del cedimento
di Militant
Avrebbe dovuto essere la manovra del cambiamento e invece quello a cui abbiamo assistito è stato il cambiamento della manovra, per giunta sotto dettatura dell’Unione Europea che, almeno fino a febbraio, continuerà comunque a vigilare sui nostri conti non fidandosi affatto delle rassicurazioni del governo italiano. Qualche settimana fa Mario Monti, in un’intervista divertita al Corriere della Sera, e cogliendo purtroppo nel segno, aveva descritto questo particolare frangente del rapporto tra un governo “ribelle” e Bruxelles come “il momento Tsipras”: ovvero quell’esatto istante in cui il populista di turno (di destra o di sinistra poco importa) non regge più il bluff del tiro alla corda e dunque è costretto a calare le braghe, accettando tutte le richieste della Commissione. Tanto per ribadire il concetto l’ex idolo delle sinistre europee aveva anche ammonito il governo italiano: arrendetevi subito, perché dopo sarà peggio. Ieri Antonio Polito ha esposto il concetto in maniera forse meno sarcastica, ma ugualmente puntuale.
Dopo 4 mesi di “me ne frego” e di “non ci sposteremo di una virgola” Salvini e Di Maio hanno quindi dimostrato di essere più che ligi ai diktat della UE, e la virgola l’hanno spostata eccome.
Leggi tutto
Alberto Pantaloni: Quando l’operaismo si fece progetto politico: la storia di Potere Operaio
Quando l’operaismo si fece progetto politico: la storia di Potere Operaio
di Alberto Pantaloni
Alberto Pantaloni recensisce per Effimera Potere operaio. La storia. La teoria (volume I), di Marco Scavino, DeriveApprodi, Roma 2018, pp. 185
Fra le differenti aree della Sinistra extraparlamentare o rivoluzionaria che agirono nel conflitto politico e sociale dell’Italia degli anni Settanta, quella operaista è forse la più studiata finora e di ciò dobbiamo ringraziare sostanzialmente i tipi di DeriveApprodi. È impossibile qui citare tutta la vastissima produzione di ristampe, nuove ricerche, memorialistica, della casa editrice di Roma sul tema. Mi limiterò qui a ricordare il mastodontico tomo curato da Fabio Milana e Marco Trotta (L’operaismo degli anni sessanta. Da «Quaderni Rossi» a classe operaia, 2008), quello curato da Francesca Pozzi e Guido Borio (Gli operaisti, 2005) e i quattro volumi sull’Autonomia (Gli autonomi, Le storie, le lotte, le teorie, voll. I-II-III, 2007-2008, curati da Sergio Bianchi e Lanfranco Caminiti, e Gli autonomi. L’autonomia operaia romana, vol, IV, 2017, curato da Giorgio Ferrarie G. Marco D’Ubaldo). Tuttavia, mancava ancora una ricerca approfondita e sistematizzata sull’organizzazione che più di tutte ha rivendicato l’eredità teorica dell’operaismo italiano, ossia Potere Operaio. Finora la letteratura secondaria a disposizione si concentrava nei due libri scritti dal giornalista Aldo Grandi (La generazione degli anni perduti. Storie di Potere Operaio, Einaudi, 2003; Insurrezione armata, Rizzoli, 2005) basati su fonti poliziesco-giudiziarie e su interviste ai protagonisti, e più recentemente sulla memorialistica (come i due volumi autobiografici di Toni Negri, curati da Girolamo De Michele, Storia di un comunistae Galera ed esilio, Ponte alle Grazie, 2015 e 2018).
Leggi tutto
comidad: È un governo Conte o un governo Gentiloni bis?
È un governo Conte o un governo Gentiloni bis?
di comidad
In base alle incongruenze della narrazione giornalistica, il Presidente del Consiglio Conte avrebbe finalmente dimostrato una statura di leader politico proprio nella circostanza in cui è riuscito ad imporre a Salvini e Di Maio il cedimento ai diktat della Commissione Europea. Da questa narrazione deriverebbe il curioso ossimoro secondo cui si rivela una statura di leader allorché ci si calano le brache. Un tortuoso percorso ideologico dal sovranismo al calabrachesimo.
Quando Conte aveva dichiarato di voler essere “l’avvocato degli Italiani”, in molti avevano commentato ricordando che durante le cause le peggiori fregature le si prendono di solito dal proprio avvocato. Forse però anche questo richiamo realistico nel caso di Conte può costituire una forzatura. Probabilmente Conte riteneva sinceramente che fosse il caso di prendere tempo, poiché l’esito delle prossime elezioni europee potrebbe portare alla formazione di una Commissione meno ostile. Conte deve anche aver considerato che incappare in una procedura di infrazione in questo momento, avrebbe fornito al Presidente Mattarella un pretesto per qualche colpo di mano istituzionale, mettendo in evidenza la debolezza di un governo che non ha dietro di sé né le burocrazie ministeriali, né le forze armate, né la Banca d’Italia.
Il problema è che il fattore tempo non gioca necessariamente a favore dei “sovranisti”. Lo stesso cedimento dell’Italia potrebbe sortire un effetto depressivo sulla attuale ondata nazionalistica e far riprendere fiato ai partiti “mondialisti”.
Leggi tutto
Piemme: Il pasticciaccio
Il pasticciaccio
di Piemme
E' fatta dunque. Dopo uno psicodramma durato tre mesi governo giallo-verde e Commissione europea hanno trovato l'accordo.
Grazie al passo indietro del governo — 10 miliardi in meno di spesa in deficit, col che si accetta di procedere nella diminuizione del debito pubblico — la Commissione evita di avviare la famigerata "procedura d'infrazione".
Entrambi i duellanti possono così cantare vittoria: il governo per aver difeso le due misure totemiche (reddito di cittadinanza e riforma della Fornero), la Commissione per aver ottenuto da Roma una maldestra accettazione delle "regole".
E' vero quel che Conte ha ribadito oggi in Parlamento, che il governo, avendo difeso le due misure totemiche del cosiddetto Reddito di cittadinanza e della riforma della Fornero "non ha ceduto sui contenuti", ma è altrettanto vero che al momento esse restano promesse in quanto non ci sono le relative leggi e, più importante ancora, i suoi decreti attuativi. Per questo Bruxelles ha legato il suo lasciapassare ad una serie pesante di "condizionalità", come a voler dire, "la pistola ce l'avete sempre puntata alla tempia e come sgarrate partirà il colpo delle sanzioni".
Quale giudizio dare dunque? La risposta è duplice, va data sui due piani, quello del contenuto e quello del metodo.
Leggi tutto
È pronto il bavaglio UE per l'informazione libera
È pronto il bavaglio UE per l'informazione libera
#LightBlu 12
Una bufera si abbatterà presto sull’informazione libera. La Ue vuole blindare le prossime elezioni europee, ed è pronta a tutto. Firmato (anche dall’Italia di Conte) un documento al Consiglio Europeo che pone le basi per una censura a tappeto di ogni opinione scomoda e che, in sinergia con la direttiva sul Copyright di prossima emanazione, potrebbe falcidiare la rete. Anche colossi come Youtube sono scesi in campo per contrastare questo crimine contro la libertà di espressione, che potrebbe portare in tempi brevi alla chiusura di centinaia di migliaia di profili.
L’Unione Europea, non Putin, vuole fare piazza pulita di chi pensa al di fuori degli schemi dominanti, di chi sfugge alle maglie dei media mainstream. Se non si attiva una risposta immediata, adesso, potrebbe non esserci una seconda possibilità per farlo. Qualche dettaglio in più in apertura del Mini-Tg di Byoblu di oggi. Guardate il video, dove si parla anche di Global Compact, di una sorpresa dei pro-Brexit, di novità inquietanti sui vaccini, del cibo immondo che hanno dati ai nostri bambini a scuola, dello spettro dei generali in Francia e di molto altro. Ecco la nuova edizione light della Controrassegna di Byoblu: le notizie che a qualcuno piacerebbe fossero false!
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3234
Hits 2385
Hits 2235
Hits 1979
Hits 1848
Hits 1833
tonino

Marco Palazzotto: Conflitto, crisi, incertezza
Conflitto, crisi, incertezza
La teoria economica dominante e le teorie alternative
di Marco Palazzotto
Lo scorso 22 dicembre è scomparso l’economista Giorgio Lunghini. Per ricordarlo pubblichiamo una recensione del suo ultimo libro in italiano Conflitto crisi incertezza, 2012, apparso su Kom-pa alcuni anni fa
 Nell’ultimo
trentennio, dopo l’abbandono delle politiche economiche di
stampo
keynesiano soprattutto in Europa, le scuole accademiche che si
rifanno alla teoria neoclassica hanno preso il sopravvento su
tutte quelle cosiddette
critiche fino ad assurgere a pensiero unico. Autori
considerati eretici come Marx o Sraffa sono stati
completamente dimenticati, mentre Keynes
è stato relegato in quell’ibrido teorico rappresentato dalla
sintesi neoclassica.
Nell’ultimo
trentennio, dopo l’abbandono delle politiche economiche di
stampo
keynesiano soprattutto in Europa, le scuole accademiche che si
rifanno alla teoria neoclassica hanno preso il sopravvento su
tutte quelle cosiddette
critiche fino ad assurgere a pensiero unico. Autori
considerati eretici come Marx o Sraffa sono stati
completamente dimenticati, mentre Keynes
è stato relegato in quell’ibrido teorico rappresentato dalla
sintesi neoclassica.
Giorgio Lunghini con il libretto Conflitto crisi incertezza (Bollati Boringhieri – 2012) mette in luce, in maniera sintetica ed efficace, le contraddizioni della teoria neoclassica attraverso l’analisi dei più importanti protagonisti del pensiero critico.
Conflitto, crisi e incertezza rappresentano tre elementi caratteristici del sistema capitalistico e tre termini che contraddistinguono la produzione teorica di pensatori come Ricardo, Marx, Keynes e Sraffa. Attraverso lo studio del pensiero di questi quattro autori Lunghini fornisce al lettore delle chiavi di lettura alternative e abbastanza complete del quadro delle dottrine “eretiche”. Queste sono state superate da un pensiero mainstream oggi palesemente inadeguato nel condurre il sistema economico fuori dalle crisi e dai conflitti sociali.
Lo sforzo dell’autore del libro è quello di comparare studiosi molto diversi tra loro, ma che hanno in comune l’aver interpretato, con il sostengo di teorie forse non molto inattuali, le falle della teoria economica classica (con Ricardo e Marx) e neoclassica (con Keynes e Sraffa).
Questi quattro intellettuali ci descrivono il sistema economico non come un sistema circolare, in cui la scarsità dei fattori di produzione e la loro produttività lasciata sviluppare secondo le regole della mano invisibile fanno tendere verso l’equilibrio, ma come un sistema storicamente determinato in cui la distribuzione del prodotto sociale è oggetto di conflitto tra le classi, la crisi è la normalità e non l’eccezione, gli operatori economici prendono le loro decisioni senza conoscere il futuro, nell’incertezza, e in presenza di aspettative poco razionali.
Leggi tutto
Il Lato Cattivo: Il demos, il Duce e la crisi
Il demos, il Duce e la crisi
ovvero
Del «pericolo fascista» come diversivo per un golpe annunciato
di Il Lato Cattivo
 «Non siamo mai
completamente contemporanei
del nostro presente. La storia avanza coperta da una
maschera: entra in scena con la maschera della scena
precedente e già non capiamo
più niente del dramma. Ogni volta che il sipario si alza
bisogna riannodare i fili della trama. La colpa,
naturalmente, non è della
storia, ma del nostro sguardo, carico di ricordi e di
immagini apprese.» (Régis Debray)
«Non siamo mai
completamente contemporanei
del nostro presente. La storia avanza coperta da una
maschera: entra in scena con la maschera della scena
precedente e già non capiamo
più niente del dramma. Ogni volta che il sipario si alza
bisogna riannodare i fili della trama. La colpa,
naturalmente, non è della
storia, ma del nostro sguardo, carico di ricordi e di
immagini apprese.» (Régis Debray)
Pietà! Non se ne può più di tutto questo blaterare di fascismo e di fantomatici come-back del fascismo. A vedere tutti questi leccaculo vecchi e nuovi – gli Scalfari e i Mughini, le Murgia e le Fornero – agitarsi come isterici su giornali e televisioni, viene quasi voglia di difenderlo, questo dannato governo gialloverde! Ma questi sinceri democratici dove hanno vissuto, di grazia, negli ultimi vent'anni? Si sono forse scandalizzati quando la Troika otteneva la resa incondizionata di Syriza, stracciando contestualmente il risultato del referendum contro il piano di salvataggio? Hanno forse detto «bao» quando il generale Sisi e i suoi compari mettevano fine, con l'implicito benestare del FMI, all'unico governo democraticamente eletto nella storia dell'Egitto? Si sono forse indispettiti quando il duetto fra Unione Europea e spread faceva cadere l'ultimo governo Berlusconi, uscito comunque dalle urne, per sostituirlo con quello dei tecnici capitanati dal signor Monti, che non era stato eletto da nessuno? Tre autentici putsch che, come si vede, si fanno sempre più sovente in guanti di velluto, e quand'anche siano accompagnati da spargimenti di sangue (vedi in Egitto) sono attuati con le migliori intenzioni democratiche. Dopo la «guerra umanitaria» e altri ossimori dal retrogusto orwelliano, dovremo prendere atto dell'esistenza di un altro sorprendente ibrido: il golpe democratico. Così va il mondo: i governi si mantengono o cadono a seconda della solerzia con cui onorano i diktat del capitale mondiale. Diceva un tale che ci sono molti modi per uccidere un uomo. Lo stesso vale per i governi.
Leggi tutto
Giovanna Cracco: Europa, squilibri macroeconomici
Europa, squilibri macroeconomici
Il balletto tra Commissione e Germania
di Giovanna Cracco
 Rapporto debito/Pil al 60% e
deficit entro il 3%:
sono questi i numeri che il cittadino associa all'Unione
europea - accanto alla parola spread, tanto spesso
pronunciata da essere divenuta
quasi un intercalare - perché l'informazione mainstream li ha
ossessivamente ripetuti fino a farli entrare nel linguaggio
comune. Eppure ci
sono numeri ben più importanti che circolano nelle stanze
europee, che la grande stampa generalista -meno quella
economica - lascia lì
chiusi indisturbati, condannando il cittadino all'ignoranza -
e non è un'esagerazione: è strutturale nell'architettura della
normativa
europea una complicazione che rende fortemente difficoltoso
raccapezzarsi per chi voglia conoscerla e ne sfida il grado di
ostinazione: le
informazioni sono pubbliche e il più delle volte online nei
siti ufficiali, ma tra loro scollegate e prive di uno 'schema'
che possa dare una
visione d'insieme; Pollicino insomma, nella Ue non lascia
briciole da seguire. Sono numeri che portano a un diverso
ragionamento su che cosa
significhi equilibrio all'interno del sistema
europeo.
Rapporto debito/Pil al 60% e
deficit entro il 3%:
sono questi i numeri che il cittadino associa all'Unione
europea - accanto alla parola spread, tanto spesso
pronunciata da essere divenuta
quasi un intercalare - perché l'informazione mainstream li ha
ossessivamente ripetuti fino a farli entrare nel linguaggio
comune. Eppure ci
sono numeri ben più importanti che circolano nelle stanze
europee, che la grande stampa generalista -meno quella
economica - lascia lì
chiusi indisturbati, condannando il cittadino all'ignoranza -
e non è un'esagerazione: è strutturale nell'architettura della
normativa
europea una complicazione che rende fortemente difficoltoso
raccapezzarsi per chi voglia conoscerla e ne sfida il grado di
ostinazione: le
informazioni sono pubbliche e il più delle volte online nei
siti ufficiali, ma tra loro scollegate e prive di uno 'schema'
che possa dare una
visione d'insieme; Pollicino insomma, nella Ue non lascia
briciole da seguire. Sono numeri che portano a un diverso
ragionamento su che cosa
significhi equilibrio all'interno del sistema
europeo.
Nel 2010 esplode la crisi sui debiti sovrani dei cosiddetti PIIGS europei: Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Sappiamo com'è andata (1). L'anno successivo la Commissione europea istituisce la "Procedura per gli squilibri macroeconomici" (Macroeconomic imbalance procedure, MIP), che nasce proprio in conseguenza di quanto accaduto: "La crisi finanziaria ha mostrato che gli squilibri macroeconomici - come un ampio deficit delle partite correnti o una bolla immobiliare - in un Paese possono influenzare gli altri" si legge sul sito della stessa Commissione, e la MIP "mira a identificare, prevenire e affrontare l'emergere di squilibri potenzialmente dannosi che potrebbero influire negativamente sulla stabilità economica in un particolare Paese della Ue".
Leggi tutto
Fabio Ciabatti: Marx l’incompiuto
Marx l’incompiuto
di Fabio Ciabatti
Carlo Galli, Marx eretico, il Mulino 2018, pp. 168, € 13.
La socialdemocrazia occidentale e l’economia di comando sovietica sono state sconfitte dal neoliberismo. Quest’ultimo, benché in crisi strutturale, ha ancora oggi, rispetto al pensiero che a vario titolo si ispira a Marx, una superiore capacità di agire sui bisogni e sui desideri dei singoli enfatizzando non tanto la loro identità di produttori membri di un insieme collettivo (di una classe) quanto quella di consumatori e fruitori di godimento individuale. Il suo potere si nutre della capacità di produrre un immaginario più espansivo, una narrazione più pervasiva, una speranza più immediatamente comunicabile, nonostante la rapidità con cui gli sviluppi storici hanno smentito le sue promesse. Se questo è il panorama che ci presenta Carlo Galli nel suo ultimo libro Marx eretico, cosa mai ci potrà rimanere del pensiero del filosofo di Terviri e delle differenti tradizioni teorico-politiche che a lui si sono è ispirate? L’autore non aggiunge la sua firma a quella dei tanti sedicenti curatori fallimentari del lascito marxiano, ma sceglie una via più articolata: Marx è “un autore sul quale non tramonta il sole, e sul quale è tuttavia passata la storia”.1 E questa storia ci ha mostrato la “strutturale incompiutezza” del suo pensiero che “va di pari passo con la sua volontà di Verità e di Totalità”.2 Tutto sta a capire se questa incompiutezza sia il sintomo di un fatale errore che mina inevitabilmente l’edificio teorico marxiano o se, al contrario, possa rappresentare un segno della sua ricchezza, della sua possibile fecondità.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Sul pericolo atomico l’Italia delle «Tre Scimmiette»
Sul pericolo atomico l’Italia delle «Tre Scimmiette»
di Manlio Dinucci
Eloquente il silenzio praticamente assoluto dell’intero arco parlamentare nostrano rispetto all'intervento del presidente russo Putin che ha sottolineato come il mondo sottovaluti il pericolo di guerra nucleare. Come se l’Italia non avesse niente a che fare con la corsa agli armamenti nucleari che potrebbe portare alla «distruzione dell’intera civiltà o forse dell’intero pianeta»
Quale reazione ha suscitato in Italia l’avvertimento del presidente russo Putin che il mondo sottovaluta il pericolo di guerra nucleare e che tale tendenza si sta accentuando? Significativo il commento de La Repubblica che parla di «toni molto allarmistici».
Eloquente il silenzio praticamente assoluto dell’intero arco parlamentare. Come se l’Italia non avesse niente a che fare con la corsa agli armamenti nucleari che, ha avvertito Putin nella conferenza stampa di fine anno, potrebbe portare alla «distruzione dell’intera civiltà o forse dell’intero pianeta».
Scenario non allarmistico, ma previsto dagli scienziati che studiano gli effetti delle armi nucleari. Un particolare pericolo – sottolinea Putin – è rappresentato dalla «tendenza ad abbassare la soglia per l’uso di armi nucleari, creando cariche nucleari tattiche a basso impatto che possono portare a un disastro nucleare globale».
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Paradossi
Paradossi
di Leonardo Mazzei
Paradossi. Paradossi interessanti. A lorsignori la manovra prima versione proprio non piaceva: conti a loro avviso disastrati, scontro con l'Europa, procedura d'infrazione, spread, spread, spread a volontà. Ma non gli piace neppure la seconda, di versioni. Eppure lo scontro con l'Europa è rinviato, la procedura d'infrazione non ci sarà, sui conti c'è il compromesso e lo spread si è calmato.
Dovrebbero esser felici, e invece no. Ora, neppure noi siam
contenti, ma perlomeno spieghiamo il perché.
E lo facciamo in coerenza con la nostra visione sull'Unione
europea (da cui liberarsi) e sugli interessi del popolo
lavoratore (da rimettere al centro
della scena). Lorsignori invece strepitano. Più precisamente,
continuano a strepitare, esattamente come fanno da sette mesi.
Formalmente Pd e Forza Italia hanno ragione a denunciare
l'umiliazione del parlamento. Sostanzialmente hanno però torto
marcio. Chi è
infatti il primo colpevole di quanto accaduto, se non la canea
reazionaria che hanno scatenato insieme ai loro pari di ogni
ordine e grado?
Vogliamo far l'elenco? Confindustria, potentati economici
all'unisono, media sistemici h24, partiti di opposizione e
sindacati di regime, senza
dimenticarci alcuni battitori "liberi" alla Boeri, alla Visco,
alla Cottarelli.
Leggi tutto
Giovanni Di Fronzo: Siria , il destino dei curdi tra Usa, Russia e Turchia
Siria , il destino dei curdi tra Usa, Russia e Turchia
di Giovanni Di Fronzo
Continuano ad essere agitatissimi questi ultimi giorni del 2018 per le aree del nord-est della Siria, controllate dalle Forze Democratiche Siriane, costituite a maggioranza dalle milizie curde Ypg-Ypj, di “derivazione” Pkk.
Dopo l’improvviso, annunciato, ritiro del contingente USA, che garantisce protezione a tali milizie, avvenuto attraverso l’ormai famosissimo tweet del Presidente Trump (“Abbiamo sconfitto l’Isis in Siria, la mia unica unica ragione per rimanere lì durante la presidenza Trump”), sia il Capo del Pentagono Mattis, sia il responsabile della cosiddetta coalizione anti-Isis, McGurk, hanno lasciato il rispettivo incarico.
Ciò è indice del fatto che questa decisione presidenziale è molto contrastata negli apparati politico-militari yankee; i principali organi d’informazione mainstream d’oltreoceano, infatti, assieme ai principali esponenti di entrambi i “partiti” (se così possiamo definirli), stanno riempendo lo spazio mediatico con articoli e dichiarazioni che segnalano con preoccupazione come tale decisioni significhino fare un passo indietro nelle politiche imperialiste d’intervento in Medio-Oriente, lasciando spazio alle potenze nemiche Russia e Iran.
Leggi tutto
Ascanio Bernardeschi: Gramsci e la lotta per l’egemonia
Gramsci e la lotta per l’egemonia
di Ascanio Bernardeschi
Un libro di Salvatore Schinello sul concetto di egemonia in Gramsci utile anche per la battaglia delle idee di oggi
Abbiamo ricevuto dall’Autore un agile saggio sul concetto di egemonia in Gramsci [1] e lo abbiamo trovato di interesse sia per la ricostruzione di un concetto gramsciano complesso, sia soprattutto per l’uso che anche qui e ora possiamo farne nello scontro in atto fra le ideologie imperialiste e il movimento che aspira a “cambiare lo stato di cose presenti”.
Antonio Gramsci, uno dei fondatori del Pci, grande uomo politico e straordinario intellettuale, che il regime fascista volle far marcire in carcere nell’illusione di poter “impedire a questo cervello di pensare” (parole di Mussolini), ha dato un contributo non sufficientemente apprezzato allo sviluppo del marxismo e del leninismo. E, per ironia della sorte, è letto e studiato maggiormente all’estero che in Italia.
Superando una lettura dogmatica delle pagine marxiane sul materialismo storico, Gramsci cercò di approfondire i nessi non sempre lineari fra struttura e sovrastruttura e pose in rilievo il ruolo che anche il sapere, la cultura e le ideologie possono svolgere negli assetti materiali delle società.
L’elaborazione del concetto di egemonia è uno dei frutti più significativi della sua ricerca e Schinello, nella prima parte del suo saggio, ricostruisce in maniera organica questo pensiero, attingendo ai frammentari spunti presenti sia nei Quaderni del carcere sia in articoli di Gramsci pubblicati nell’Avanti!, l’Ordine Nuovo, La Città Futura, Il Grido del Popolo e altri periodici.
Leggi tutto
Marco Paciotti: Critica dell’imperialismo e lotta per la pace
Critica dell’imperialismo e lotta per la pace
Un mondo senza guerre
di Marco Paciotti*
 Lo sbocco imperialista del modo di produzione
capitalistico in crisi, cui è
connaturato un latente stato di tensione nei rapporti
internazionali tra Stati in competizione tra loro per la
conquista di sempre più vaste
fette di mercato, è parte integrante del patrimonio teorico
del comunismo sin dal celebre scritto di Lenin Imperialismo
fase suprema del
capitalismo, pubblicato nel 1917. Ebbene l’analisi e la
critica dell’imperialismo e la lotta per la pace risultano di
scottante
attualità per chi intenda osservare con sguardo attento la
politica internazionale.
Lo sbocco imperialista del modo di produzione
capitalistico in crisi, cui è
connaturato un latente stato di tensione nei rapporti
internazionali tra Stati in competizione tra loro per la
conquista di sempre più vaste
fette di mercato, è parte integrante del patrimonio teorico
del comunismo sin dal celebre scritto di Lenin Imperialismo
fase suprema del
capitalismo, pubblicato nel 1917. Ebbene l’analisi e la
critica dell’imperialismo e la lotta per la pace risultano di
scottante
attualità per chi intenda osservare con sguardo attento la
politica internazionale.
Fondamentale allo sviluppo e all’aggiornamento di questi concetti risulta l’analisi dei vari progetti di pace perpetua, che Domenico Losurdo ha delineato in Un mondo senza guerre. Dalle promesse del passato alle tragedie del presente, pubblicato da Carocci nel 2016, testo che ci restituisce un saggio del metodo di Losurdo, sempre volto a calare le elaborazioni teorico-concettuali nel contesto storico-politico che in ultima istanza le determina.
Nel tracciare la storia del tema l’autore non ravvisa una logica binaria e manichea che vede contrapporsi ideali di guerra contro ideali di pace; il conflitto è bensì tra diversi ideali di pace che si confrontano in una dialettica complessa. Essi non vanno posti tutti sullo stesso piano: il principale discrimine riguarda il rapporto con il concetto di universalità, dobbiamo chiederci: essi puntano a una sua estensione oppure a un rimpicciolimento e in definitiva una negazione dell’universalismo?
Punto iniziale della trattazione è il Kant che invoca la “ewiger Friede”, la pace perpetua; ma non è tanto questo il merito del pensatore tedesco quanto quello di essere stato appunto il primo a intendere l’instaurazione della pace definitiva in senso universalistico.
Leggi tutto
Jacques Sapir: Gilet gialli, il virus che può contagiare l'Europa
Gilet gialli, il virus che può contagiare l'Europa
Nico Spuntoni intervista Jacques Sapir
Parla l'economista francese Jacques Sapir: "Macron smascherato dalla mobilitazione"
 Da settimane la Francia
sta conoscendo una mobilitazione di carattere generale che
ha catturato l'attenzione del mondo
ed ha costretto il presidente Macron a
mettere da parte la consueta sicumera per scendere a patti
con la piazza. La protesta dei
gilet gialli, nonostante le cronache non
particolarmente benevole che ne hanno fatto i media
occidentali, è riuscita
però a conquistare la simpatia di buona parte dell'opinione
pubblica internazionale. In Italia, ad esempio,
molti hanno
solidarizzato con la causa dei manifestanti; alcuni lo hanno
fatto dopo aver visto le immagini della dura repressione
governativa, altri per antipatia
nei confronti di Macron. Ma quali sono le motivazioni di
questa mobilitazione apparentemente spontanea e apartitica?
Davvero si riduce tutto - come ci
ha raccontato la maggior parte dei media nostrani -
all'opposizione all'aumento dell'ecotassa imposto da 'monsieur
le
Président'? Lo abbiamo chiesto al professor
Jacques Sapir, noto economista già direttore
della Scuola
superiore di scienze sociali di Parigi, oltre che membro
dell'Accademia Russa delle Scienze. Voce autorevole e
controcorrente nel panorama economico
internazionale, Sapir ha offerto ai nostri lettori
un'analisi lucida e dettagliata sul fenomeno che sta
scuotendo il Paese d'Oltralpe, non
risparmiando però anche un'attenta riflessione sul sovranismo.
Da settimane la Francia
sta conoscendo una mobilitazione di carattere generale che
ha catturato l'attenzione del mondo
ed ha costretto il presidente Macron a
mettere da parte la consueta sicumera per scendere a patti
con la piazza. La protesta dei
gilet gialli, nonostante le cronache non
particolarmente benevole che ne hanno fatto i media
occidentali, è riuscita
però a conquistare la simpatia di buona parte dell'opinione
pubblica internazionale. In Italia, ad esempio,
molti hanno
solidarizzato con la causa dei manifestanti; alcuni lo hanno
fatto dopo aver visto le immagini della dura repressione
governativa, altri per antipatia
nei confronti di Macron. Ma quali sono le motivazioni di
questa mobilitazione apparentemente spontanea e apartitica?
Davvero si riduce tutto - come ci
ha raccontato la maggior parte dei media nostrani -
all'opposizione all'aumento dell'ecotassa imposto da 'monsieur
le
Président'? Lo abbiamo chiesto al professor
Jacques Sapir, noto economista già direttore
della Scuola
superiore di scienze sociali di Parigi, oltre che membro
dell'Accademia Russa delle Scienze. Voce autorevole e
controcorrente nel panorama economico
internazionale, Sapir ha offerto ai nostri lettori
un'analisi lucida e dettagliata sul fenomeno che sta
scuotendo il Paese d'Oltralpe, non
risparmiando però anche un'attenta riflessione sul sovranismo.
* * * *
La rivolta dei gilet gialli ha origine soltanto dal malumore per l'aumento del prezzo del carburante?
“Questo movimento è stato effettivamente innescato dall'annuncio di un aumento dei prezzi del carburante, cosa che sembra abbastanza sorprendente in vista del suo ulteriore sviluppo. Tuttavia, riflette una rabbia molto più profonda e cause molto più complesse. La questione dei prezzi del carburante si riferisce al cosiddetto ‘consumo vincolato’ delle famiglie delle classi inferiori.
Leggi tutto
Silvia Bencivelli: La rivoluzione del servizio sanitario nazionale
La rivoluzione del servizio sanitario nazionale
di Silvia Bencivelli*
Quarant’anni fa, nel dicembre 1978, diventava legge in Italia un’idea importante e preziosa
 Sono solo quarant’anni che abbiamo il
Servizio
sanitario nazionale. Quarant’anni significa che quattro
italiani su dieci sono nati quando la salute non era un
diritto definito per legge.
C’era, sì, la Costituzione del 1948, che con l’articolo 32
diceva che la Repubblica tutela la salute come diritto
fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività, ma non
c’era una legge che dicesse esattamente come. Quella legge
arrivò
nel dicembre del 1978.
Sono solo quarant’anni che abbiamo il
Servizio
sanitario nazionale. Quarant’anni significa che quattro
italiani su dieci sono nati quando la salute non era un
diritto definito per legge.
C’era, sì, la Costituzione del 1948, che con l’articolo 32
diceva che la Repubblica tutela la salute come diritto
fondamentale
dell’individuo e interesse della collettività, ma non
c’era una legge che dicesse esattamente come. Quella legge
arrivò
nel dicembre del 1978.
Prima di ripercorrere questa storia, vale la pena ricordare che di fondo c’è un’idea che forse diamo per scontata e che invece scontata non è. La salute è un diritto dell’individuo: non un privilegio né una merce, ma un diritto umano di cui la società deve farsi carico e da cui la società non ha che da trarre vantaggi. Un diritto del singolo e insieme un bene della collettività: un’idea enorme.
La salute come diritto venne messa nero su bianco, per la prima volta nella storia dell’umanità, nel preambolo della Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità firmata a New York il 22 luglio del 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile del 1948. È la carta che definisce la salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e non solo assenza di malattia, e che dice che la sanità dei popoli è “condizione fondamentale per la pace del mondo”. È lì che si legge che “il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano”.
Sempre nel 1948, il 10 dicembre, lo ribadì la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. E nel 1966 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, scrisse che la realizzazione di questo diritto è compito degli Stati.
Leggi tutto
Ubu Re: 1977. Il conflitto, la musica
1977. Il conflitto, la musica
di Ubu Re
 Quando lo
straordinario è vissuto come
ordinario allora vuol dire che la rivoluzione è in atto.
Quando lo
straordinario è vissuto come
ordinario allora vuol dire che la rivoluzione è in atto.
Massima del "Che" che bene si addice allo "stato d'animo" dei protagonisti del movimento del ‘77, l'anno della grande rivolta. Ma il '77 è anche l'anno più occultato, più rimosso. Sul versante del potere istituzionale la rimozione ormai decennale esprime il timore di riaffrontare i contenuti di un movimento con caratteristiche irriducibilmente rivoluzionarie.
Il ‘77 non fu come il '68. Il '68 fu contestativo, il '77 fu radicalmente alternativo. Per questo motivo la versione ufficiale definisce il ‘68 come buono e il ‘77 come cattivo, infatti il '68è stato recuperato, mentre il ‘77 è stato annientato. Per questo motivo il '77, a differenza del '68 non potrà mai essere un anno di facile celebrazione.
Eppure la rimozione del movimento del '77 è stata operata anche dai suoi stessi protagonisti. Migliaia di persone hanno interiorizzato gli effetti catastrofici del terrorismo repressivo dello stato, annullando insieme alla memoria di quel vissuto anche la loro identità antagonista.
Al di sopra di queste due rimozioni "volontarie", l’effetto azzeratore della memoria sociale prodotto dal gigantesco mutamento delle tecnologie comunicative. Ma nonostante tutto questo, le domande poste dall'ultimo movimento di massa antistituzionale in Italia restano attuali perchè irrisolte. “Quale sviluppo per quale futuro?”fu la domanda principale, semplice e terribile nel sintetizzare “l’intuizione” del vivere quel momento come il crinale di un passaggio di trasformazione epocale, reso esplicito dalla crisi e dall'esaurirsi delle regole di relazione e organizzazione e sociale basate sul sistema industriale.
Leggi tutto
Joseph Halevi: Giorgio Lunghini 1938-2018
Giorgio Lunghini 1938-2018
di Joseph Halevi
La scomparsa di Giorgio Lunghini mi ha rattristato moltissimo, come è già successo pochissimo tempo fa con il decesso di Aris Accornero. Sono figure centrali del pensiero progressista italiano nel campo delle discipline sociali. Nell’ambito economico tale pensiero, sviluppatosi dopo la Liberazione, si è rivelato essere decisamente il più avanzato d’Europa e tra i più innovatori nel mondo intero. Mi riferisco a persone come Paolo Sylos Labini (1920-2005), Luigi Pasinetti (1930-) Claudio Napoleoni (1924-1988), Federico Caffè (1914-1987 anno della sua misteriosa sparizione), Augusto Graziani (1933-2014), Marcello De Cecco (1939-2016), Pierangelo Garegnani (1930-2011), Sergio Steve (2015-2006), Pasquale Saraceno (1903-1991), Siro Lombardini (1924-2013). Prese nel loro insieme queste persone hanno prodotto dei pensieri non dogmatici, rigorosi, poliedrici, articolati, differenti ma non necessariamente incompatibili tra di loro. Il conformismo dilagante dalla fine degli anni 80 del secolo scorso e la normalizzazione accelerata del pensiero economico accademico ha comportato una rapida marginalizzazione delle idee di questi grandi intellettuali man mano che raggiungevano l’età pensionabile.
Giorgio Lunghini, che con mio grande dispiacere si aggiunge all’elenco degli scomparsi, è stato un intellettuale che le suddette idee ha coltivato e contribuito ad arricchire con le proprie elaborazioni.
Leggi tutto
redazione - Guido Salerno Aletta: La partita tra governo italiano ed Unione Europea, più politica che economica
La partita tra governo italiano ed Unione Europea, più politica che economica
di redazione - Guido Salerno Aletta
“Il governo doveva assolutamente evitare che l’Italia diventasse il detonatore di una crisi finanziaria: non siamo noi a dover fare da fusibile, visto che tra le banche tedesche con prospettive fallimentari, la Brexit e le guerre commerciali ci sono focolai assai più pericolosi di un miserrimo aumento del deficit pubblico italiano”.
Sta in questo passaggio una chiave di lettura estremamente interessante su quella che è stata (e che rimane) la partita in corso tra il governo gialloverde italiano e la Commissione Europea. Una partita che si è rivelata più politica che economica. A conferma che l’Unione Europea, diversamente da quanto lamentano gli europeisti di sinistra e di destra, la politica la fa eccome e non si occupa solo di economia. E la fa anche sulla base di valutazioni strettamente politiche, ragione per cui alla Francia di Macron, alle prese con una vasto conflitto sociale, viene consentito di sforare il deficit per farvi fronte, mentre lo si nega all’Italia di Conte, Salvini, Di Maio. Una analisi interessante, anche perché l’autore è Guido Salerno Aletta, editorialista di Milano Finanza, giornale della borghesia finanziaria del Nord.
* * * *
Qui di seguito il testo dell’articolo pubblicato su Milano Finanza del 22/12/2018.
Si sta avviando a conclusione l’approvazione parlamentare della manovra di bilancio per il 2019, il cui iter è stato assai contrastato per via delle due lettere di censura con cui la Commissione Europea aveva preannunciato l’apertura di una procedura di infrazione anche per debito eccessivo.
Leggi tutto
Andrea Fumagalli: In ricordo di Giorgio Lunghini
In ricordo di Giorgio Lunghini
di Andrea Fumagalli
La scomparsa di Giorgio Lunghini è un segno dell’inaridirsi del presente. Con lui se ne va un protagonista finissimo della critica economica di questo Paese. Nato nella libertaria Ferrara, laureatosi in Bocconi con Di Finizio, Giorgio Lunghini aveva cominciato la sua lunga carriera da docente di economia politica all’Università Statale di Milano negli anni della contestazione studentesca. Ottenuta la cattedra in giovane età, ha poi insegnato alla neo-nata Facoltà di Economia di Pavia per poi approdare allo Iuss pavese e all’Accademia dei Lincei.
Negli anni Settanta, grazie soprattutto al suo ruolo di traino, la facoltà di Economa di Pavia è stata uno dei principali centri del pensiero economico non allineato (insieme a Modena). Ne è testimonianza il convegno Scelte politiche e teorie economiche in Italia (1945-1978), da lui organizzato alla fine del decennio, che ha raccolto il gotha del pensiero economico critico dell’epoca, i cui atti sono stati pubblicati nel 1981 da Einaudi.
Studioso della storia del pensiero economico, Giorgio Lunghini è stato uno dei pochi pensatori (insieme ad Augusto Graziani) che ha saputo coniugare il pensiero di Sraffa con quello di Marx, di Keynes e Schumpeter. Al punto da scrivere importanti saggi su tutti e quattro gli autori, che rappresentano i cardini, pur nella diversità, della critica al pensiero neoclassico dominante del libero mercato.
Leggi tutto
Marinella Correggia: Africa, smettiamola di rapinarli a casa loro
Africa, smettiamola di rapinarli a casa loro
di Marinella Correggia
Secondo il rapporto «Honest Accounts», a conti fatti il continente africano risulta essere creditore climatico e finanziario. E gli stessi africani nemmeno lo sanno
Nel 1989 la Campagna Nord-Sud (Biosfera, sopravvivenza dei popoli, debito) organizzò a Verona il convegno «Il Sud del mondo, nostro creditore». Trent’anni dopo, i politici occidentali amano invece lo slogan «aiutiamoli a casa loro» (sottotitolo: così non ci invadono).
Ma prendiamo il continente africano. Come diceva Leopold Senghor: «L’Africa ha dato tanto, ma gli stessi africani non lo sanno». Li informa e ci informa il rapporto Honest Accounts. How the world profits from Africa’s Wealth, preparato da una serie di organizzazioni britanniche e africane, fra le quali Global Justice Now e People’s Health Movement Kenya, Health Poverty Action, Uganda Debt Network: «I 48 paesi dell’Africa sub-sahariana sono ricchi di risorse minerarie, lavoratori specializzati, nuove attività economiche e biodiversità. Ma sono a tutti gli effetti derubati da un sistema globale che avvantaggia una piccola minoranza consentendo alla ricchezza di uscire dall’Africa; così, secondo la Banca africana di sviluppo, 800 milioni vivono con meno di 4 dollari al giorno».
Nel 2015 il continente ha ricevuto 161,6 miliardi di dollari fra rimesse, prestiti e donazioni. Però di miliardi ne ha dati – diciamo persi – ben 202,9, sia direttamente sia indirettamente. Il suo credito è dunque pari a 41,3 miliardi di dollari.
Leggi tutto
Frédéric Lordon: Perchè i francesi manifestano con violenza?
Perchè i francesi manifestano con violenza?
di Frédéric Lordon (*)
Un ordine decadente è riconoscibile dallo stupore stampato sulle facce dei suoi sommi sacerdoti.
Questo sabato lo spettacolo non si svolgeva solo nelle strade. Era anche sulle facce sconcertate della CNN, di France 2 e di quasi tutti i media audiovisivi.
Stupidità e stupore hanno la stessa radice etimologica. I trombettieri del “macronismo rivoluzionario” sono tornati alle loro vecchie categorie, le categorie del vecchio mondo. Ora tentennano tra il definire di estrema destra o di estrema sinistra i gilet gialli.
Il vecchio regime sta cercando ansiosamente “rappresentanti” o “portavoce” presentabili. A loro piacerebbe un “direttorio” con cui “negoziare”. Disperati cercano freneticamente accordi con i leaders di partito, i parlamentari e i sindacati.
La loro speranza è una “uscita dalla crisi”. Una moratoria alla tassa sul diesel o forse qualcosa di più? Cioè, stanno montando un’altra pantomima. E tutto questo mentre il sistema sembra andare in rovina.
Le élites stanno qui. Non vogliono vedere che lo spostamento delle tasse non è una soluzione. Che non c’è più tempo, che un intero mondo sta crollando, che le istituzioni sono intrappolate in un collasso perché i gilet gialli non sono un “movimento sociale”: sono una sollevazione popolare.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3266
Hits 2435
Hits 2015
Hits 1878
Hits 1807
Hits 1730
tonino

Thomas Meyer: I Big Data e il nuovo mondo intelligente visto come palcoscenico supremo del positivismo
I Big Data e il nuovo mondo intelligente visto come palcoscenico supremo del positivismo
di Thomas Meyer
 «Nel suo
articolo, "I Big Data e il nuovo mondo intelligente visto
come palcoscenico supremo del positivismo",
Thomas Meyer affronta quella che nel panorama scientifico
appare come una tendenza recente nei confronti dei Big Data,
che vengono ormai applicati
quasi ovunque. Gli apologeti delle "Scienze dei Big Data" e
delle loro applicazioni si attendono da tali Big Data la
soluzione di ogni tipo di
problema. In ciò, questi apologeti mostrano un forte slancio
tecnocratico, e una completa mancanza di comprensione di che
cosa sia la
società e la storia. Meyer, pertanto, mostra quali sono le
pretese della Fisica Sociale, così come essa viene formulata
dallo scienziato
informatico Alex Pentland. Vediamo inventariate anche le
diverse possibilità di applicazione dei Big Data, così come
vengono
implementate in diversi algoritmi. Ad esempio, nella lotta
(preventiva) contro il crimine, e nel prevedere i
"recidivi". Nella conclusione vengono
riportate le diverse critiche di sinistra (liberali) nei
confronti dei Big Data, come quella di Cathy O'Neil, che
possiamo sentire ripetutamente
citata nel dibattito pubblico. Grazie all'enorme
abbassamento dei costi che hanno avuto i sensori, le
videocamere, ecc., ora tutte le apparecchiature
possono essere equipaggiate con questo genere di dispositivi
ed essere collegati ad Internet. Ed ecco che così si può
formare la
"Internet delle cose". In questo modo, il mondo digitale
arriva, per così dire, con innumerevoli promesse di
salvezza: per esempio, con i
"dispositivi intelligenti", si può economizzare elettricità
e aiutare le persone a consumare in maniera "verde" e
"sostenibile". Anche
per ciò che riguarda l'Internet delle Cose, "del nuovo mondo
intelligente", vengono riferite le critiche di sinistra
(liberali), soprattutto
quelle di Evgeny Morozov, e vengono mostrate quali sono le
loro preoccupazioni. Di regola, l'individuo borghese si
sente sotto pressione e minacciato,
per quel che attiene alla sua maturità e alla sua libertà di
scelta, dai Big Data e da un'infrastruttura sempre più
"intelligente". Tuttavia, da queste critiche, la
digitalizzazione non viene vista nel contesto della crisi,
della repressione sociale e della dinamica
della valorizzazione capitalista in generale.
«Nel suo
articolo, "I Big Data e il nuovo mondo intelligente visto
come palcoscenico supremo del positivismo",
Thomas Meyer affronta quella che nel panorama scientifico
appare come una tendenza recente nei confronti dei Big Data,
che vengono ormai applicati
quasi ovunque. Gli apologeti delle "Scienze dei Big Data" e
delle loro applicazioni si attendono da tali Big Data la
soluzione di ogni tipo di
problema. In ciò, questi apologeti mostrano un forte slancio
tecnocratico, e una completa mancanza di comprensione di che
cosa sia la
società e la storia. Meyer, pertanto, mostra quali sono le
pretese della Fisica Sociale, così come essa viene formulata
dallo scienziato
informatico Alex Pentland. Vediamo inventariate anche le
diverse possibilità di applicazione dei Big Data, così come
vengono
implementate in diversi algoritmi. Ad esempio, nella lotta
(preventiva) contro il crimine, e nel prevedere i
"recidivi". Nella conclusione vengono
riportate le diverse critiche di sinistra (liberali) nei
confronti dei Big Data, come quella di Cathy O'Neil, che
possiamo sentire ripetutamente
citata nel dibattito pubblico. Grazie all'enorme
abbassamento dei costi che hanno avuto i sensori, le
videocamere, ecc., ora tutte le apparecchiature
possono essere equipaggiate con questo genere di dispositivi
ed essere collegati ad Internet. Ed ecco che così si può
formare la
"Internet delle cose". In questo modo, il mondo digitale
arriva, per così dire, con innumerevoli promesse di
salvezza: per esempio, con i
"dispositivi intelligenti", si può economizzare elettricità
e aiutare le persone a consumare in maniera "verde" e
"sostenibile". Anche
per ciò che riguarda l'Internet delle Cose, "del nuovo mondo
intelligente", vengono riferite le critiche di sinistra
(liberali), soprattutto
quelle di Evgeny Morozov, e vengono mostrate quali sono le
loro preoccupazioni. Di regola, l'individuo borghese si
sente sotto pressione e minacciato,
per quel che attiene alla sua maturità e alla sua libertà di
scelta, dai Big Data e da un'infrastruttura sempre più
"intelligente". Tuttavia, da queste critiche, la
digitalizzazione non viene vista nel contesto della crisi,
della repressione sociale e della dinamica
della valorizzazione capitalista in generale.
Leggi tutto
Cristina Morini: Marx, tra di noi. Dentro e contro l’antropomorfosi del capitale
Marx, tra di noi. Dentro e contro l’antropomorfosi del capitale
di Cristina Morini
 Lui accarezza lo sguardo tuo,
Lui accarezza lo sguardo tuo,
tu ti abbandoni al gioco suo.
E io, tra di voi, se non parlo mai,
ho visto
già tutto quanto.
Ed io tra di voi, Charles Aznavour
Ci sono alcuni aspetti di Marx che costituiscono, per me, una fonte di ispirazione e di discussione, nel presente, tra noi, ora e qui. Ci ritroviamo sempre più numerose e numerosi a ragionare su come l’analisi delle forme assunte dal capitale necessiti di essere più strettamente congiunta a un’analisi delle forme delle interiorità o delle sfumature soggettive che il capitale va affermando (o meglio: prova ad affermare) come progresso della sua propria riproduzione.
“Vite, parole e corpi”: effettivamente è esattamente su questo crinale che interseco da un lato una lettura di Marx meno economicista e più attenta all’umano e ai corpi; dall’altro una radice che spinge ad approfondire la nuova/antica, eterna eppure cangiante, materia del lavoro, le sue forme (astratte e concrete) e le differenti prospettive da cui guardarle.
La mia lettura è debitrice al retroterra femminista e alle interpretazioni neo-operaiste del lavoro come fatto sociale. Incrocia inoltre il pensiero di alcuni autori marxisti “eretici”, come Luciano Parinetto in Corpo e rivoluzione (1976) e Giorgio Cesarano in Critica dell’utopia capitale (1979). Molti ulteriori preziosi spunti derivano dai due libri di Roberto Ciccarelli usciti quest’anno (Forza Lavoro. Il lato oscuro della rivoluzione digitale, 2018 e Capitale Umano. La vita in alternanza scuola lavoro, 2018).
I nuovi paradigmi socio-economici hanno oggi più esplicite incidenze sugli esseri umani, al punto che essi introiettano modelli tipici dell’impresa (competizione intesa sempre più esplicitamente come concorrenza; efficienza intesa come produttività dell’uomo-donna impresa; reputazione intesa qui come brandizzazione dell’individuo medesimo, attraverso la sua vetrinizzazione).
Leggi tutto
Michele Nobile: La RPC nel mar cinese meridionale II
La RPC nel mar cinese meridionale II
Dalle battaglie tra Cina e Vietnam al 2008
di Michele Nobile
L'articolo di Michele Nobile continua la serie sulla politica estera della Repubblica popolare cinese, centrata sull’analisi della situazione nel Mar cinese meridionale. Di Nobile si veda anche «Sul “socialismo con caratteristiche cinesi”, ovvero del capitalismo realmente esistente in Cina», 10 settembre 2018, http://utopiarossa.blogspot.com/2018/09/sul-socialismo-con-caratteristiche.html e «La Cina e la questione dell’egemonia. Il Mar cinese meridionale come banco di prova: attori e scenario (Prima parte)», 10 dicembre 2018, http://utopiarossa.blogspot.com/2018/12/la-cina-e-la-questione-dellegemonia.html e https://sinistrainrete.info/geopolitica/13951-michele-nobile-la-cina-e-la-questione-dell-egemonia.html
 1. Locale
e globale: le battaglie tra Cina e Vietnam nel Mar cinese
meridionale
1. Locale
e globale: le battaglie tra Cina e Vietnam nel Mar cinese
meridionale
La Repubblica popolare cinese (Rpc), Taiwan e il Vietnam rivendicano la sovranità sull’intero Mar cinese meridionale fin dal termine della Seconda guerra mondiale ma, per un lungo periodo, non furono in grado di concretizzare queste pretese, sia a causa delle loro limitate capacità operative locali che del contesto globale. Durante la conferenza di San Francisco del 1951 - che produsse il trattato di pace col Giappone - la delegazione vietnamita (allora non ancora diviso) rivendicò la sovranità sia sull’arcipelago delle Isole Paracelso che su quello delle Spratly.
Né la Rpc né la repubblica stabilita in Taiwan dalle sconfitte forze del Kuomintang vennero invitate alla Conferenza, ma la delegazione sovietica espresse per conto della Rpc le stesse rivendicazioni del Vietnam, con l’aggiunta delle isole Pratas - amministrate da Taiwan, in realtà si tratta di una piccola isola senza abitanti permanenti che è parte di un atollo corallino solo in parte è sopra il livello dell’alta marea - e di Macclesfield Bank, un grande atollo sommerso tra le Paracelso e le Pratas1.
Leggi tutto
Militant: Visioni Militant(i): Santiago, Italia, di Nanni Moretti
Visioni Militant(i): Santiago, Italia, di Nanni Moretti
di Militant
Il golpe contro Allende è notoriamente una delle mitologie degli anni Settanta, vicenda entro cui trovano spazio tutte le narrazioni edificanti della sinistra popolare dell’epoca. Dopo essersi allontanato dalle dispute politiche – ritagliandosi e poi rifiutando il ruolo di grillo parlante dell’incontro tra Dc e Magistratura (i girotondi, Micromega, in seguito il Pd) – Moretti decide di tornare a parlare di politica senza rischiare nulla. Riparte dunque dal golpe cileno, sicuro dell’unanimità di vedute che avvolge l’evento. Per essere sicuro di essere ecumenicamente accettato e osannato nei circoli intellettuali più navigati, decide di parlare del Cile senza mai parlare degli Usa, senza intervistare i politici cileni più compromessi, senza indagare il ruolo della Chiesa o della borghesia stracciona e dipendente. Una merda insomma? Non proprio. Perché l’asciutto resoconto delle testimonianze dei sopravvissuti, delle vittime del golpe, e della solidarietà che questi ricevettero dal mondo e in particolare dall’Italia, hanno oggi – oggi, alle soglie del 2019 – ancora la forza di colpire al cuore tanto il militante politico “abituato” al racconto della dura storia di classe, quanto il sincero democratico lontano dalla bagarre degli eventi ma ancora “umano”. Fino a qualche anno fa un’operazione di questo tipo sarebbe stata molto più compromettente. Il silenzio sulle responsabilità, certo, ma anche la struttura di un racconto che si regge sulle emozioni dei rifugiati, degli espatriati.
Leggi tutto
Lorenzo Procopio: Marcello Musto: Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883
Marcello Musto: Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883
di Lorenzo Procopio
Marcello Musto: Karl Marx. Biografia intellettuale e politica 1857-1883, Einaudi Editore. Un libro che nel ricostruire il pensiero del Moro non scivola mai nella retorica delle commemorazioni del bicentenario della nascita di Marx
Il bicentenario della nascita di Karl Marx è stato ricordato in tutto il mondo con numerose iniziative. Molte di queste si sono tradotte in deprimenti commemorazioni di rito, così come è accaduto in occasione del centenario della Rivoluzione russa nel corso del 2017, tanto da rappresentare quanto di più lontano possa essere immaginato dai presupposti teorici del marxismo stesso.
Anche tra le fila delle cosiddette avanguardie rivoluzionarie, il bicentenario ha offerto loro l’occasione per ripetere vecchie giaculatorie così stantie da non essere più in grado, ovviamente, di cogliere nella loro pienezza le moderne contraddizioni in cui si contorce il capitalismo del XXI secolo. Per siffatti “rivoluzionari” rimanere fedeli al pensiero di Marx significa perpetuare fideisticamente vecchie formule non più funzionali alla comprensione delle dinamiche del moderno capitalismo. Così facendo, quella che in apparenza sembra come una difesa ad oltranza del marxismo rivoluzionario, si trasforma in realtà nell’abbandono del materialismo storico, la cui applicazione richiede incessantemente una valutazione critica dei dati derivanti dal mondo reale.
Leggi tutto
Vincenzo Maddaloni: Tanti Auguri da Santiago del Cile
Tanti Auguri da Santiago del Cile
di Vincenzo Maddaloni
Sono stati sufficienti tre nomi - Santiago, Italia, Nanni Moretti – per scatenare gli zombie della politica, delle frasi ad effetto del tipo: “Un inno sobrio, emozionante e rigoroso al valore della memoria”, come ha commentato Walter Veltroni il nuovo film (Santiago, Italia) di Nanni Moretti. Beninteso non è proprio un film , piuttosto è un documentario di un viaggio nel Cile di 45 anni fa; un calzante pretesto per segnalare l’involuzione politica, sociale e culturale dell’Italia di oggi; per esprimere la speranza che gli italiani essendo stati altro, potrebbero domani tornare ad essere generosi, appassionati, solidali, come lo erano negli anni Settanta. A quel tempo essi furono i protagonisti di una storia di solidarietà internazionale della quale gli attori principali erano allende2quegli uomini uniti dalla comunanza di un ideale e dalla passione per il bene comune che la Sinistra rappresentava all'epoca. Infatti, c'era una volta la Sinistra impegnata con zelo a sublimare la gente comune con una condizione di vita migliore, sovente in modo radicale. Essa si era dedicata a cambiare realmente, significativamente, genuinamente il mondo, la società, le sue strutture, le sue istituzioni.
Sicché la domanda è d'obbligo: dov'è quella Sinistra che ha costruito un nuovo stile di vita, affrontando per la prima volta nella storia dell'umanità, necessità ineludibili come l' assistenza sanitaria, le cure all'infanzia, il diritto alla pensione, il reddito da lavoro e via dicendo.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Natale di polvere nel Sahel
![]()
Natale di polvere nel Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, Natale 2018. Puntuale come un orologio svizzero. L’harmattan arriva secondo la stagione prefissata dalle consuetudini. Si invita a dicembre proprio sotto Natale, più vicino qui che altrove. L’harmattan è un vento caldo e secco che soffia sul Sahara e l’Africa occidentale. Si raffredda la notte provocando l’ abbassamento della temperatura. Il suo lavoro consiste nel trasporto gratuito di polvere per tutti. Una polvere democratica, che non risparmia o esclude nessuno. Facilita la trasmissione di epidemie di meningite e di malgoverni che, grazie alle polvere attecchiscono, prosperano e si mantengono. Anche il primo Natale è stato così. Pieno di polvere più che di stelle. Gli stessi imperi di sempre, i censimenti per tassare meglio i poveri e i re fantoccio che temono concorrenti e rivali. Nulla di nuovo sotto la polvere del Sahel che comincia a dicembre e si estende fino a febbraio quando va bene. ‘Natale coi tuoi e Pasqua con chi vuoi’, sentenziavano gli antichi. Qui intanto ci prendiamo la polvere di Natale e per la Pasqua vedremo. Il nome Harmattan deriva, sembra, dalla lingua Fanti del Ghana.
L’harmattan è un vento aliseo regolare delle regioni intertropicali e soffia dall’est all’ovest, dalle alte pressioni subtropicali alle basse pressioni equatoriali. Aliseo è un nome forse derivato dal provenzale ‘liscio, dolce’ o dal latino ‘lisciare’.
Leggi tutto
Domenico Losurdo: Cento anni dalla Rivoluzione d’ottobre
Cento anni dalla Rivoluzione d’ottobre*
Rivoluzione sociale e rivoluzione anticoloniale
di Domenico Losurdo
One hundred years after the October Revolution, we can try to make an assessment of its outcomes and heritage. But if we just focus on the construction of a post-capitalistic society, of socialism, our evaluation will be partial, incomplete and unable to allow an understanding of the past and the current times. So, we have to tackle this issue from a double perspective: looking to the construction of socialism but looking also to the struggle against colonial domination, against imperialism. The result of a reflection on these two levels is on one side that the movement started from the October Revolution led to the vanishing of the colonial classic system, and on the other side that the construction of socialism is a troubled process of political, economical and intellectual apprehension that is unavoidably full of contradictions. This process is still in progress – in China, for instance. On the other hand, today neocolonialism carries on the tradition of exploitation and domination, generating the premises of a new large-scale war. The construction of a post-capitalistic society is once again strictly connected with the cause of peace
 Nell’anno del
centenario le iniziative di discussione sulla Rivoluzione
d’ottobre sono molto più
numerose di quelle che, fino a qualche tempo fa, ci si poteva
attendere. C’è stato un tempo in cui l’ideologia dominante
parlava
della Rivoluzione d’ottobre come qualcosa di insignificante
che non interessava più a nessuno e non aveva avuto alcuna
influenza reale
sulla storia. Invece, negli ultimi tempi, il tono è un po’
cambiato: certo, si cerca di dipingere un quadro a tinte
fosche della
Rivoluzione d’ottobre e della sua influenza, ma in qualche
modo se ne riconosce l’importanza storica. Non c’è dubbio –
questo è il mio punto di partenza – che la Rivoluzione
d’Ottobre sia stato il momento decisivo della storia del
Novecento, di un
secolo di straordinaria importanza. Perché?
Nell’anno del
centenario le iniziative di discussione sulla Rivoluzione
d’ottobre sono molto più
numerose di quelle che, fino a qualche tempo fa, ci si poteva
attendere. C’è stato un tempo in cui l’ideologia dominante
parlava
della Rivoluzione d’ottobre come qualcosa di insignificante
che non interessava più a nessuno e non aveva avuto alcuna
influenza reale
sulla storia. Invece, negli ultimi tempi, il tono è un po’
cambiato: certo, si cerca di dipingere un quadro a tinte
fosche della
Rivoluzione d’ottobre e della sua influenza, ma in qualche
modo se ne riconosce l’importanza storica. Non c’è dubbio –
questo è il mio punto di partenza – che la Rivoluzione
d’Ottobre sia stato il momento decisivo della storia del
Novecento, di un
secolo di straordinaria importanza. Perché?
Prima di esprimere giudizi di valore, vediamo: la Rivoluzione d’ottobre ha cambiato qualcosa, ha cambiato qualcosa in modo radicale nel mondo? Direi di sì. E, per accorgersene, basta fare una riflessione sul mondo prima e dopo di essa. Prima della rivoluzione, il mondo era assimilabile a una sorta di proprietà privata detenuta, su larga parte del pianeta, da un piccolo gruppo di potenze capitaliste e colonialiste.
Leggi tutto
Renato Caputo: Per l’unità delle forze che considerano irriformabile l’Unione europea
Per l’unità delle forze che considerano irriformabile l’Unione europea
di Renato Caputo
Solo partendo dall’unità fra le forze sinceramente antimperialiste diverrà possibile trovare un compromesso con le forze che mirano alla riformabilità dell’Ue, ma hanno come piano B la rottura anche unilaterale con essa
 Nonostante che il “governo del cambiamento”,
del
“sovranismo” e dei “mene frego” ai diktat dell’Unione europea
abbia fatto una figura barbina, capitolando
vergognosamente dinanzi alle minacciate sanzioni,
purtroppo quasi certamente le forze della sinistra non se ne
avvantaggeranno più di
tanto.
Nonostante che il “governo del cambiamento”,
del
“sovranismo” e dei “mene frego” ai diktat dell’Unione europea
abbia fatto una figura barbina, capitolando
vergognosamente dinanzi alle minacciate sanzioni,
purtroppo quasi certamente le forze della sinistra non se ne
avvantaggeranno più di
tanto.
In primo luogo perché da troppi anni il collaborazionismo della sinistra radicale con la sinistra neoliberista ha portato i proletari – privi di coscienza di classe e di una visione del mondo autonoma da quella dominante, ossia la netta maggioranza – a non distinguere in modo chiaro la sinistra reale, ossia quella schierata con i ceti subalterni contro le classi dominanti, da quella che da diversi anni si è posta al servizio di queste ultime.
In tal modo, alla componente del proletariato più vittima dell’egemonia dell’ideologia dominante continuano ad apparire come reali forze alternative ai governi apertamente antipopolari dei Monti, Letta, Renzi e Gentiloni le forze populiste grilline o, addirittura, leghiste. Mentre la componente del proletariato che, per quanto priva di coscienza di classe, non cede completamente all’ideologia delle classi dominanti – ma mantiene un sano scetticismo, espressione di buon senso – continua a ritenere che fra i precedenti governi apertamente antipopolari e l’attuale governo, che lo è in modo solo meno sfacciato, non ci sia poi una differenza tale per cui valga la pena schierarsi da una parte piuttosto che l’altra. Tanto più che la stessa maggioranza della sinistra radicale si è così sovente alleata in funzione subalterna alla sinistra neoliberista che le differenze appaiono persino alla componente proletaria ancora dotata di sano buon senso delle differenze indifferenti.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: La neuroeconomia
La neuroeconomia
di Salvatore Bravo
 Pensare e avere pensieri sono
due cose diverse.
Pensare e avere pensieri sono
due cose diverse.
L’oggetto della nostra disciplina consiste nel sapere il pensare; sapere ciò che siamo.
L’uomo è spirito, e sapere ciò che questo comporta è il compito più grande. L’uomo è davvero soltanto ciò che sa di essere.
G.W.F. Hegel
La neuroeconomia
L’economicismo integralista negli ultimi decenni sta compiendo un salto qualitativo. Dalla propaganda mediatica continua ed ossessiva, ma ancora debolmente controllabile dagli utenti e dai popoli, si sta gradualmente strutturando una nuova strategia di mercato: entrare nella mente, controllare il cervello, per disporlo al baratto.
Si tratta di un intervento radicale e discreto, l’economia trasforma gli esseri umani, i popoli, in stabili consumatori per il mercato, ambisce a forgiare la natura umana. Il mercato – novello Demiurgo – vuole plasmare i circuiti cerebrali per rendere la persona non solo consumatore, ma specialmente, dipendente in modo assoluto dal mercato, anzi ad esso organico. Si tratta di una forma di totalitarismo, assolutamente nuova, che non trova precedenti nella storia umana.
Il mercato ipostatizza se stesso, mediante l’asservimento globale all’economia con una strategia assolutamente nuova: entrare nella mente, fessurare la mente ed incidere in essa la logica del mercato. Le neuroscienze, la psichiatria e la psicologia divengono lo sgabello dell’economia, mettono a disposizione le loro ricerche per rafforzare l’espansione del mercato e contribuire alla trasformazione dei popoli in pubblici dipendenti del valore di scambio, inconsapevoli e nel contempo complici.
Gli strumenti
La neuroeconomia si avvale delle neuroscienze, queste ultime portano a compimento un processo iniziato con David Hume ed Adam Smith.
Leggi tutto
Gustavo Piga: La manovra che c’è e quella che non c’è
La manovra che c’è e quella che non c’è
Conversazione con Start Magazine
di Gustavo Piga
Prof, ha letto un breve passaggio dell’analisi del Corriere della Sera firmata da Federico Fubini ieri? Ha scritto Fubini: “L’area euro continua ad essere dominata dal totem del debito lordo iscritto nel Fiscal compact. Non importa quanto vale e quanto rende ciò che si produce con quel debito: conta solo ridurlo — si dice — «per non lasciarlo ai nostri figli». Poco importa se un debito investito bene a costo zero lascia un’economia con più conoscenza, migliori infrastrutture, scuole e università moderne, più edilizia sociale, più capacità di sostenere gli oneri in futuro”. Mi verrebbe da dire: alla buon’ora caro Corriere della Sera, perché non accorgersene prima? Perché non sostenere il referendum anti Fiscal Compact? O mi sbaglio?
Dice quel referendum con cui con Paolo De Ioanna ed altri cercammo di mobilitare l’Italia e che nell’estate del 2014 sfiorò le 500.000 firme necessarie per arrivare alla Corte Costituzionale? Guardi, più che dal Corriere, del quale mi avrebbe stupito all’epoca anche un solo articolo contro a fronte del silenzio più totale che adottò, ancora non riesco a digerire l’assurda mancanza di sostegno al referendum da parte del Pd di Renzi, un harakiri, l’ennesimo certo ma forse il più grave, di un partito che aveva l’opportunità di salvare l’Europa dell’euro dai sovranismi e guidare per i prossimi 20 anni il Paese. Comunque sia, felice che un corsivista come Fubini arrivi a Canossa, ma se devo dirgliela tutta…
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Potere al popolo e il "Piano B" (che non c'è)
Potere al popolo e il "Piano B" (che non c'è)
di Leonardo Mazzei
A sinistra si discute delle elezioni europee, ed è normale. Meno "normale", anche se assolutamente abituale, è il come se ne discute. Quel che pensiamo dell'operazione De Magistris, della sua lista della sinistra europeista, l'abbiamo già scritto. Mentre un'idea su chi la sostiene, ogni lettore può farsela leggendo questo documento della Direzione del Prc, dove il passaggio più qualificante è la richiesta di "ricandidatura della compagna Eleonora Forenza"... Niente di male, ognuno ha le sue priorità.
Qui vogliamo invece occuparci di un'altra parte della sinistra, quella che si è appena separata da Rifondazione: Potere al popolo (Pap).
Parlando della riunione del Coordinamento nazionale di Pap, ne scrive su Contropiano Sergio Cararo. Riferendosi alle recenti vicende della Legge di bilancio, il suo editoriale sottolinea giustamente la necessità di un "Piano B" nel confronto con l'Ue, ma la formula utilizzata per descriverlo - la previsione della «rottura, anche unilaterale, con i Trattati europei» - è come sempre fumosa. Se si rompono i Trattati si esce dall'Ue ed a maggior ragione dall'euro. La verità è che un Piano B o include espressamente questa scelta o non è un vero Piano B.
Fin qui, comunque, nulla di nuovo. Il punto è che al solito pasticciaccio di chi vede il problema ma ha paura ad affrontarlo per l'irrisolto tabù della questione nazionale, si aggiunge un'analisi della fase irrealistica assai.
Leggi tutto
Federico Pieraccini: Trump si ritira dalla Siria
Trump si ritira dalla Siria
di Federico Pieraccini
Nel disperato tentativo di salvare la sua presidenza, causa un terremoto geopolitico
Il 19 dicembre, Donald Trump aveva annunciato in un messaggio su Twitter: “I nostri ragazzi, le nostre giovani donne, i nostri uomini, stanno tornando tutti e stanno tornando adesso. Abbiamo vinto.” Poco dopo, la portavoce del Pentagono, Dana White, aveva dichiarato: “Abbiamo avviato il processo di rimpatrio dalla Siria delle truppe statunitensi e passiamo alla fase successiva della campagna.”
Le ragioni della mossa di Donald Trump sono molte, ma derivano tutte principalmente dalle tensioni interne degli Stati Uniti. Dopo le elezioni di medio termine, l’atmosfera politica per Trump si sta riscaldando, mentre i Democratici si preparano ad assumere il controllo della Camera dei Rappresentanti a gennaio, una cosa che Trump aveva sempre sperato di poter evitare. Si era circondato di generali, nella vana speranza che ciò lo avrebbe, in qualche modo, protetto. Se gli ultimi due anni della sua presidenza sono stati costantemente sotto l’ombra delle indagini di Mueller, o delle insinuazioni di essere un agente di Putin, dal gennaio 2019 la situazione sarà molto più complicata. La base elettorale democratica reclama l’impeachment del Presidente, il partito è già in completa modalità pre-primarie, con più di 20 candidati in competizione tra loro, e il titolare della Casa Bianca fa sentire il suo il grido di guerra.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Le mani pulite del colonialismo
Le mani pulite del colonialismo
di ilsimplicissimus
Non siate affamati, come diceva un mitico ragazzo del garage noto per non aver scritto in vita sua nemmeno una riga di codice, ma abbastanza levantino da riuscire a vendere a prezzo doppio rispetto alla concorrenza strumenti basati su un sistema operativo libero e gratuito. No, non siate affamati per affamare gli altri, siate invece curiosi, non vi fermate alle apparenze, alle blandizie e alle persuasione di un sistema feroce ed elusivo. Questa storia comincia con un sapone, uno di quei saponi neri africani di cui si dicono meraviglie: uno di questi distribuito in esclusiva e con un proprio marchio da un’azienda inglese e prodotto in Ghana, presenta tutta la panoplia dell’acchiappacitrullismo contemporaneo: naturale, vegano, con un aspetto grezzo appositamente ricercato per asseverare la sua lontananza dall’ industria, cosa che tanto piace alle cattive coscienze dei desideranti benestanti e nascondendo il fatto di essere un potente esfoliante che per certe situazioni dermatologiche piuttosto diffuse può essere gravemente controindicato.
Ma una scritta su tutte le altre mi ha colpito e cioè il fatto che sia anche ethically sourced: la cosa non può che rafforzare ulteriormente la propensione all’acquisto sebbene non significhi proprio nulla, sia perché l’espressione può avere almeno una decina di accezioni differenti ed è facilmente usato come specchietto per le allodole dalle multinazionali, sia perché quasi sempre significa sfruttamento delle persone.
Leggi tutto
comidad: Calenda e l'epica darwiniana dell'assistenzialismo per ricchi
Calenda e l'epica darwiniana dell'assistenzialismo per ricchi
di comidad
L’opposizione parlamentare del PD cerca di trasformare le brutte figure del governo Conte in proprie fortune, rischiando soltanto di essere percepita dall’opinione pubblica come sicario dell’Unione Europea. Intanto il dibattito precongressuale del PD langue e molti esponenti di spicco ne prendono persino le distanze. Uno degli interventi più apprezzati continua ad essere il “manifesto” dell’ex ministro dello Sviluppo Economico, Carlo Calenda, che risale a vari mesi fa. Un manifesto apprezzato non per le proposte, ma per le sue premesse che sembrano mettere finalmente in discussione il quadro rassicurante sinora offerto sulle sorti della cosiddetta “globalizzazione”.
Le posizioni di Calenda sono state considerate di “sinistra” per il fatto che assumono il punto di vista dei “vinti”, degli “sconfitti” della globalizzazione. In effetti Calenda sembra parafrasare l’introduzione de “I Malavoglia”, nella quale Giovanni Verga dichiarava di voler narrare le vicende dei “vinti” nella lotta per la vita. Verga proponeva un darwinismo visto dall’ottica dei perdenti, ma ciò non faceva di lui un rivoluzionario e neppure un uomo di sinistra. Verga rivendicava anzi il suo conservatorismo politico in una famosa lettera a Cesare Lombroso. Verga è stato spesso adottato come riferimento dalla narrativa di sinistra, ma si è trattato appunto di un malinteso poiché è stata percepita come potenzialmente di sinistra quella che era soltanto una posizione di “destra umanitaria”.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3283
Hits 2475
Hits 2103
Hits 1913
Hits 1826
Hits 1740
Hits 1739
Hits 1728
tonino

Alessandro Cardinale: Sulla più recente traduzione italiana del Libro primo de Il capitale
Sulla più recente traduzione italiana del Libro primo de Il capitale
di Alessandro Cardinale
Con un approfondimento sul termine “Arbeiter” e con la segnalazione di sviste e alternative di traduzione
 Il lettore
italiano che oggi avverta il bisogno di misurarsi con la
lettura del testo principale di Karl
Marx ha a disposizione, e già da molti anni, tre traduzioni
integrali del Libro primo de Il capitale,
in ordine cronologico,
secondo la prima edizione di ciascuna, quelle di Delio
Cantimori (Editori Riuniti, 1951), Ruth Meyer (Avanzini e
Torraca, 1965), Bruno Maffi (UTET,
1974). A queste si è aggiunta nel 2011 una nuova traduzione,
curata da Roberto Fineschi, pubblicata da La Città del
Sole come
volume XXXI delle Opere complete di Marx ed Engels.
Questo volume, in due tomi, contiene oltre al testo
principale, alle varianti e
all’apparato, ulteriori materiali che rappresentano alcune
tappe della storia editoriale del Libro primo: una
porzione del
Manoscritto 1863-1865 la quale consiste in gran parte
nel cosiddetto Capitolo VI inedito; due porzioni di
testo tratte dalla prima
edizione (1867) del Libro primo, e cioè il primo
capitolo e l’appendice su La forma di valore; un
manoscritto
preparatorio, utilizzato da Marx per approntare sia la seconda
edizione tedesca che la traduzione francese, tradotto qui per
la prima volta in
italiano con il nome di Manoscritto 1871-1872.
Questi materiali, che occupano metà del secondo tomo, non
saranno oggetto delle
considerazioni che seguono, nelle quali prendo in esame solo
il testo principale, comprese le varianti e l’apparato.
Il lettore
italiano che oggi avverta il bisogno di misurarsi con la
lettura del testo principale di Karl
Marx ha a disposizione, e già da molti anni, tre traduzioni
integrali del Libro primo de Il capitale,
in ordine cronologico,
secondo la prima edizione di ciascuna, quelle di Delio
Cantimori (Editori Riuniti, 1951), Ruth Meyer (Avanzini e
Torraca, 1965), Bruno Maffi (UTET,
1974). A queste si è aggiunta nel 2011 una nuova traduzione,
curata da Roberto Fineschi, pubblicata da La Città del
Sole come
volume XXXI delle Opere complete di Marx ed Engels.
Questo volume, in due tomi, contiene oltre al testo
principale, alle varianti e
all’apparato, ulteriori materiali che rappresentano alcune
tappe della storia editoriale del Libro primo: una
porzione del
Manoscritto 1863-1865 la quale consiste in gran parte
nel cosiddetto Capitolo VI inedito; due porzioni di
testo tratte dalla prima
edizione (1867) del Libro primo, e cioè il primo
capitolo e l’appendice su La forma di valore; un
manoscritto
preparatorio, utilizzato da Marx per approntare sia la seconda
edizione tedesca che la traduzione francese, tradotto qui per
la prima volta in
italiano con il nome di Manoscritto 1871-1872.
Questi materiali, che occupano metà del secondo tomo, non
saranno oggetto delle
considerazioni che seguono, nelle quali prendo in esame solo
il testo principale, comprese le varianti e l’apparato.
Cominciamo con il testo principale e con il problema di partenza che si pone al traduttore del Libro primo de Il capitale, cioè quello di scegliere il testo su cui condurre la traduzione: la II edizione tedesca (1873), la III (1883), la IV (1890), o l’edizione francese (1875). Come due dei precedenti traduttori italiani la scelta del curatore e traduttore Roberto Fineschi è ricaduta sulla IV edizione tedesca (1890)1, vale a dire sul testo di Marx revisionato da Engels in base a indicazioni di Marx2.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: La funzione del pensiero complesso nell'era della complessità
La funzione del pensiero complesso nell'era della complessità
di Pierluigi Fagan
 Credo che il prossimo sarà il secolo
della complessità.
Credo che il prossimo sarà il secolo
della complessità.
S. Hawking,
2000
L’intero è qualcosa di
più
delle parti.
Aristotele, Metafisica, IV secolo
a.e.v.
Il semplice è sempre
falso, ciò che
non lo è, è inutilizzabile.
P.
Valery
La cultura della complessità si è sviluppata in Occidente a più ondate a partire dal dopoguerra e piano piano, si è ampliata a praticamente tutti i campi di studio nei quali di declina la nostra conoscenza, dalla fisica alla metafisica, passando invariabilmente, seppur con adattamenti specifici, dalle scienze dure a quelle umane ai saperi umanistici. Per questo la chiamiamo “cultura”, perché non è un paradigma specifico di una disciplina che vuole colonizzare le altre, ma una impostazione generale del pensiero umano qualsiasi sia l’oggetto che si dà. Ovviamente se il pensiero ha sentito questa esigenza riformista è perché i suoi oggetti hanno reclamato analisi e comprensioni adeguate alla loro natura, natura che si è disvelata nel tempo. Gli stessi oggetti (atomi, molecole, cellule, organi ed organismi, individui e loro relazioni sociali, economiche, culturali e politiche, financo stati o forme di civilizzazione, ecologie, linguaggio, storie e narrazioni e molto altro), dopo esser stati trattati per molto tempo secondo certe forme standard del pensiero moderno, ci hanno mostrato lati del loro essere statico e viepiù dinamico, che chiamavano forme più ampie di analisi ed interpretazione.
Ad esempio, non sempre è possibile o utile ridurre una cosa o un fenomeno al sottostante, le cose o i fenomeni sono il risultato di tutte le parti tra loro in relazione che le compongono così che, come già aveva intuito Aristotele “L’intero è qualcosa di più delle parti”.
Leggi tutto
John Bellamy Foster: Un movimento di resistenza per il pianeta
Un movimento di resistenza per il pianeta
Juan Cruz Ferre intervista John Bellamy Foster
 Il
cambiamento climatico è fuori controllo. È già troppo tardi
per evitare le alte
temperature, la scarsità d'acqua e le condizioni climatiche
estreme. Ma la struttura finanziaria del capitalismo è
legata ai
combustibili fossili. Le soluzioni basate sul mercato sono
inefficaci.
Il
cambiamento climatico è fuori controllo. È già troppo tardi
per evitare le alte
temperature, la scarsità d'acqua e le condizioni climatiche
estreme. Ma la struttura finanziaria del capitalismo è
legata ai
combustibili fossili. Le soluzioni basate sul mercato sono
inefficaci.
John Bellamy Foster, professore di sociologia presso l'Università dell'Oregon e direttore di Monthly Review, parla circa il tipo di programma necessario per fermare questa catastrofe. È stato intervistato da Juan Cruz Ferre per Left Voice dove il testo fu pubblicato per primo.
* * * *
Juan Cruz Ferre (JCF): C'è una schiacciante evidenza che dimostra come il clima antropico è fuori controllo e porterà alla catastrofe ambientale globale – senza un radicale miglioramento della produzione di energia. Nel numero di febbraio 2017 della Monthly Review, vi segnalo che, sebbene ci sia stata presentata con valutazioni precise e indiscutibili, la scienza e le istituzioni di scienze sociali non sono riuscite a venire con soluzioni efficaci. Perché pensi che questo è il caso?
John Bellamy Foster (JBF): Siamo in una situazione di emergenza nell' epoca Antropocene in cui la rottura del sistema terra, particolarmente il clima, sta minacciando il pianeta come luogo di abitazione umana. E tuttavia, il nostro sistema politico-economico, il capitalismo, è orientato principalmente all'accumulo di capitale, che ci impedisce di affrontare questa enorme sfida e accelera la distruzione. Gli scienziati naturalisti hanno fatto un lavoro eccellente e coraggioso nel lanciare l'allarme sui pericoli enormi della continuazione di affari come al solito per quanto riguarda le emissioni di carbonio e altri limiti del pianeta. Ma il mainstream delle scienze sociali come esiste oggi ha interiorizzato quasi completamente l’ideologia capitalista; tanto che gli scienziati sociali convenzionali sono completamente incapaci di affrontare il problema alla scala e nei termini storici che sono necessari. Sono abituati alla visione che la società molto tempo fa "conquistò" la natura e che la scienza sociale riguarda solo persone – relazioni personali, mai persone-natura.
Leggi tutto
Militant: Il sovranismo populista di Marcos
Il sovranismo populista di Marcos
di Militant
[Più di vent'anni dopo, un testo che sembra scritto oggi. Che però verrebbe scambiato per il report dell'ultimo consiglio dei ministri giallo-blu, o forse per la lezione inaugurale del think tank di Steve Bannon. Cambiano i tempi, non le mitologie che si costruiscono attorno alle diverse posizioni politiche].
“Noi stiamo dicendo che nella nuova fase del capitalismo, il neoliberismo, si verifica una distruzione dello Stato nazionale. Noi diciamo che la patria non c’è più. Si sta distruggendo il concetto di nazione, di patria, e non soltanto nella borghesia, ma anche nelle classi governanti. È molto difficile pensare che vi siano settori del governo che difendano il concetto di nazione. Coloro che difendono il concetto di nazione sono assassinati o espulsi. Il progetto neoliberista esige questa internazionalizzazione della storia; pretende di cancellare la storia nazionale e farla diventare internazionale; pretende di cancellare le frontiere culturali. Il costo maggiore per l’umanità è che per il capitalismo finanziario non c’è niente. Il capitale finanziario possiede solo dei numeri di conti bancari. E in tutto questo gioco viene cancellato il concetto di nazione. Un processo rivoluzionario deve cominciare a recuperare i concetti di nazione e patria”.
Leggi tutto
Marco Veronese Passarella: La Teoria del Circuito Monetario: Tutto Quello che So (o Quasi)
La Teoria del Circuito Monetario: Tutto Quello che So (o Quasi)
di Marco Veronese Passarella
Ricorre oggi l’anniversario della morte di Augusto Graziani, uno dei più eminenti economisti italiani del novecento e padre del filone teorico eterodosso noto come teoria del circuito monetario (TMC). Benché apparentemente semplice ed intuitiva, la TCM nasconde alcune insidie interpretative che nel tempo hanno dato adito a fraintendimenti e ne hanno depotenziato il messaggio originario. Le brevi note che seguono hanno lo scopo di contribuire a fare chiarezza su alcuni punti chiave della TCM. Con l’avvertenza che si tratta di considerazioni personali sparse, senza alcuna pretesa di esaustività.
Che cosa la TCM di Augusto Graziani mi ha insegnato
Che un’economia monetaria di produzione, o economia capitalistica, è composta necessariamente da tre macro-classi sociali: imprese (o capitalisti industriali), lavoratori salariati e banche (o capitalisti finanziari).
Che in tale sistema la moneta è un rapporto sociale triangolare in cui le passività di un soggetto terzo, la banca, vengono accettate come mezzo di regolamento degli scambi tra due contraenti (impresa vs salariati o imprese vs imprese).
Leggi tutto
Paolo Baldeschi: Mercati, riforme, sviluppo: le fake word del neoliberismo
Mercati, riforme, sviluppo: le fake word del neoliberismo
di Paolo Baldeschi
“I mercati ci chiedono le riforme per rilanciare lo sviluppo”. Quante volte abbiamo letto o sentito queste parole, ripetute ossessivamente nei giornali e nei programmi televisivi; si noti bene che non si chiedono “riforme”, ma “le riforme” per antonomasia, cioè quelle riforme che sono gradite all’establishment. Proviamo a tradurre queste parole magiche nel loro autentico significato, un esercizio non di parte, ma puramente ermeneutico.
La prima parola magica sono “i mercati”. Di quali “mercati” si tratta? Il mercato azionario, quello delle obbligazioni, dei futures, dei mutui sub-prime, delle materie prime, o cosa altro? Tutti riassunti nel termine “sistema dei mercati”, una parola neutra che, come ha scritto Luciano Gallino [1], ha sostituito il molto più esplicito, veridico, ma ormai impopolare, “capitalismo”. Cui deve essere aggiunta la qualifica di “finanziario”, ciò che lo rende radicalmente diverso da quello industriale e manifatturiero, i cui profitti non sono neanche lontanamente paragonabili a quanti ottenuti con strumenti speculativi.
La seconda parola magica sono “le riforme”, quelle che ci vengono chieste sia dai “mercati”, sia dall’ Unione Europea, a sua volta prona ai voleri dei “mercati” ben rappresentati al suo interno dall’immenso apparato burocratico e tecnocratico della Commissione e all’esterno dalle lobby delle multinazionali, potenti e aggressive. Le riforme, nell’accezione neoliberista, sono quelle che comprimono i salari e i diritti dei lavoratori.
Leggi tutto
Lelio Demichelis: Come uscire dal labirinto della paura
Come uscire dal labirinto della paura
di Lelio Demichelis
Il labirinto di Cnosso (oggi, per analogia, il labirinto prodotto da neoliberalismo e tecnica e rete, da cui sembra altrettanto impossibile uscire, convinti come siamo che non ci sono alternative e che l’innovazione non si può fermare) era una costruzione leggendaria (oggi, invece, è realissima e concretissima) che, secondo la mitologia fu fatto costruire da Minosse a Creta (oggi, è il mondo intero) per rinchiudervi il Minotauro – mentre oggi, ma rinchiusi insieme al Minotauro-capitalismo-rete siamo tutti noi (con la gabbia d’acciaio weberiana o la società amministrata secondo i francofortesi come nuovo labirinto), sue vittime sacrificali come allora le giovani e i giovani ateniesi destinati a essere divorati dal mostro.
Se Arianna diede a Teseo un filo per permettergli di uscire dal labirinto dopo avere ucciso il Minotauro, oggi il tecno-capitalismo ha rimosso la figura di Arianna (cioè ha cancellato speranza e utopia, la rivoluzione e il riformismo, presentandosi esso stesso come speranza e utopia e democrazia e rivoluzione), per non farci uscire da sé. Le pareti che delimitano l’intrico di strade, piazze e gallerie sono così alte che ci impediscono persino di vedere il cielo (metafora di una consapevolezza superiore), la tecnica però consolandoci con una realtà virtuale che ci illude di uno spazio infinito e di una società della conoscenza o della consapevolezza.
Leggi tutto
Riccardo Bellofiore: C’è vita su Marx? Il Capitale nel bicentenario
C’è vita su Marx? Il Capitale nel bicentenario
di Riccardo Bellofiore*
Abstract: The article suggests a reconstruction of Marx’s Critique of Political Economy as a macro-monetary theory of capitalist production. The first part of what follows will provide a sort of methodological introduction to Das Kapital. I am questioning the meaning of critique versus criticism, the distinction between fetish-character and fetishism, the role of dialectics, and the difference between reading, interpretation and reconstruction. I will focus especially on Volume I. At the centre of the discussion are: the multiple meanings of abstract labour and socialization, the role of money as a commodity for the labour theory of value, the “method of comparison” in grounding valorisation (the emergence of gross profits) as the constitution of capital from class struggle in production, the unity of absolute and relative surplus value extraction, the key notion of «Technologie» in the real subsumption of labour to capital, the law of the tendential fall in relative wage, Marx’s two notions of «competition», and the macro-monetary class perspective in capitalist reproduction crucial to Capital, Volume I. Some considerations are devoted to the transformation problem, the so-called New Interpretation, and crisis theory
 Marx pubblicò la prima edizione del Capitale
nel 1867, circa
150 anni fa, e quest’anno cade il bicentenario della sua
nascita[1]. Sembra
dunque essere
questo un momento opportuno per tracciare un bilancio di
quanto vi è di vitale e illuminante nell’eredità marxiana.
Propongo qui
una ricostruzione della critica dell’economia politica di Marx
come teoria macro-monetaria della produzione capitalistica. La
prima parte di
quanto segue fornirà una sorta di introduzione
metodologica al Capitale. In seguito, mi
concentrerò soprattutto sul primo
libro, toccando tuttavia anche alcuni temi trattati nel
secondo e nel terzo: in particolare, discuterò alcuni punti
rilevanti per il
problema della trasformazione ed esporrò la mia
prospettiva riguardo la teoria della crisi.
Marx pubblicò la prima edizione del Capitale
nel 1867, circa
150 anni fa, e quest’anno cade il bicentenario della sua
nascita[1]. Sembra
dunque essere
questo un momento opportuno per tracciare un bilancio di
quanto vi è di vitale e illuminante nell’eredità marxiana.
Propongo qui
una ricostruzione della critica dell’economia politica di Marx
come teoria macro-monetaria della produzione capitalistica. La
prima parte di
quanto segue fornirà una sorta di introduzione
metodologica al Capitale. In seguito, mi
concentrerò soprattutto sul primo
libro, toccando tuttavia anche alcuni temi trattati nel
secondo e nel terzo: in particolare, discuterò alcuni punti
rilevanti per il
problema della trasformazione ed esporrò la mia
prospettiva riguardo la teoria della crisi.
La mia generazione – ho iniziato il mio studio delle teorie economiche nel 1973, ma avevo in qualche maniera familiarizzato con la teoria marxiana già sul finire degli anni ’60 – si è formata sulla grande tradizione di Maurice Dobb e Paul M. Sweezy.
Leggi tutto
Renato Curcio: L’algoritmo sovrano
L’algoritmo sovrano
Identità digitale, sorveglianza totale, sistema politico
di Renato Curcio
Incontro-dibattito sul libro L’algoritmo sovrano. Metamorfosi identita- rie e rischi totalitari nella società artificiale, di Renato Curcio (Sensibili alle foglie, 2018), presso il Csa Vittoria, Milano, 27 settembre 2018
 Questo ultimo libro, L’algoritmo
sovrano, riflette sui cambiamenti delle relazioni di
potere che stiamo vivendo, in quella che è una grande
trasformazione antropologica che riguarda non solo la rete, in
quanto dimensione
tecnologica, ma anche la formazione del sociale in cui siamo
inseriti. Ci hanno abituati a immaginare le relazioni di
potere, almeno nella loro forma
più organizzata, con le analisi di Weber o Foucault, per non
fare citazioni classiche del marxismo; questo significa che in
epoca moderna
abbiamo guardato il potere all’interno di un mondo che non c’è
più, perché negli ultimi trent’anni, dal
1990/91, in questo mondo è entrato un nuovo continente:
internet. È questo il primo punto su cui voglio suggerirvi uno
sguardo. Dobbiamo
cominciare a guardare internet in questo modo perché è un
territorio che prima non c’era, e all’interno del quale si
giocano
ormai i destini dell’economia, della comunicazione, della
politica, di fatto tutti i destini della vita delle persone
che vivono nei continenti
storici. Le relazioni faccia a faccia sono diventate
paradossalmente secondarie rispetto alle relazioni alias-alias
che caratterizzano la presenza nel
continente di internet.
Questo ultimo libro, L’algoritmo
sovrano, riflette sui cambiamenti delle relazioni di
potere che stiamo vivendo, in quella che è una grande
trasformazione antropologica che riguarda non solo la rete, in
quanto dimensione
tecnologica, ma anche la formazione del sociale in cui siamo
inseriti. Ci hanno abituati a immaginare le relazioni di
potere, almeno nella loro forma
più organizzata, con le analisi di Weber o Foucault, per non
fare citazioni classiche del marxismo; questo significa che in
epoca moderna
abbiamo guardato il potere all’interno di un mondo che non c’è
più, perché negli ultimi trent’anni, dal
1990/91, in questo mondo è entrato un nuovo continente:
internet. È questo il primo punto su cui voglio suggerirvi uno
sguardo. Dobbiamo
cominciare a guardare internet in questo modo perché è un
territorio che prima non c’era, e all’interno del quale si
giocano
ormai i destini dell’economia, della comunicazione, della
politica, di fatto tutti i destini della vita delle persone
che vivono nei continenti
storici. Le relazioni faccia a faccia sono diventate
paradossalmente secondarie rispetto alle relazioni alias-alias
che caratterizzano la presenza nel
continente di internet.
***
Internet nasce negli Stati Uniti per concorso di due forze, quella militare e quella scientifica, studi legati a università americane che avevano iniziato a immaginare una comunicazione tra computer, quindi la costruzione di una rete. Quando parliamo di ‘rete’ stiamo entrando progressivamente in un territorio molto materiale, perché la rete è una cosa materiale, che esiste, dentro la quale succedono delle cose, ma è un territorio molto diverso dalla rete delle relazioni: è una rete di connessioni, sono computer, macchine, che entrano in relazione.
Leggi tutto
Samir Amin: Il capitalismo entra nella sua fase senile
Il capitalismo entra nella sua fase senile
 L’inizio
d’anno distrae sempre un po’, anche sul piano delle
“percezioni”. La visione si distorce nella comunque
fiduciosa attesa che “il nuovo” porti novità, sperabilmente
positive. E’ un momento che, paradossalmente, accorcia la
capacità di visione, facendo passare in secondo piano sia la
durezza delle cose
che, soprattutto, “il lungo periodo”. Quello che determina
entità e direzione dei processi storici, anche economici, e
che ben poco
risente di quanto avviene nel breve arco di 365 giorni.
L’inizio
d’anno distrae sempre un po’, anche sul piano delle
“percezioni”. La visione si distorce nella comunque
fiduciosa attesa che “il nuovo” porti novità, sperabilmente
positive. E’ un momento che, paradossalmente, accorcia la
capacità di visione, facendo passare in secondo piano sia la
durezza delle cose
che, soprattutto, “il lungo periodo”. Quello che determina
entità e direzione dei processi storici, anche economici, e
che ben poco
risente di quanto avviene nel breve arco di 365 giorni.
Pensiamo perciò sia utile riproporvi questa intervista a Samir Amin, rilasciata a Ruben Ramboer nel 2012, che non ha perso un grammo della sua attualità. Del resto, il vecchio saggio ricorda lui stesso che – in fondo – la crisi attuale (segnalata da tutti a partire dal 2007-2008) si colloca al di qua di un crinale storico ben più fondamentale. Visto da lui e pochi altri già nella svolta degli anni ‘70.
Dedicato a chi ha sempre così fretta di “vedere i risultati” da rinunciare per sempre a capire in che direzione stiamo andando. Sono tanti, se ci pensate un attimo… Sicuramente quanti quelli che, con la scusante dei “tempi lunghi”, non muovono mai un passo perché non è mai “il momento giusto”.
* * * *
“Il pensiero economico neoclassico è una maledizione per il mondo attuale”. Samir Amin, 81 anni, non è tenero con molti dei suoi colleghi economisti. E lo è ancor meno con la politica dei governi. “Economizzare per ridurre il debito? Menzogne deliberate”; “Regolazione del settore finanziario? Frasi vuote”. Egli ci consegna la sua analisi al bisturi della crisi economica.
Dimenticate Nouriel Roubini, alias dott. Doom, l’economista americano diventato famoso per avere predetto nel 2005 lo tsunami del sistema finanziario. Ecco Samir Amin, che aveva già annunciato la crisi all’inizio degli anni 1970.
Leggi tutto
Gisella Ruccia: DL Sicurezza, Rizzo (Pc): “Protesta sindaci su porti? Fuffa di pseudosinistra”. E a Roggiani (Pd): “Il popolo vi odia”
DL Sicurezza, Rizzo (Pc): “Protesta sindaci su porti? Fuffa di pseudosinistra”. E a Roggiani (Pd): “Il popolo vi odia”
di Gisella Ruccia
“Questa vicenda dei porti, dei sindaci e di Salvini è paradigmatica del perché la sinistra sia scomparsa o stia scomparendo in questo Paese. Questi sindaci, che ormai si muovono in campagna elettorale, intanto non hanno le prerogative, perché l’apertura dei porti è competenza del ministero delle Infrastrutture“. Esordisce così, a Coffee Break (La7), il duro intervento di Marco Rizzo, segretario generale del Partito Comunista, che critica con toni caustici il dissenso di alcuni sindaci contro il decreto Sicurezza.
E aggiunge: ” Ma avete visto qualche sindaco di pseudosinistra rompere il patto di stabilità e i vincoli del pareggio di bilancio voluti dalla Ue o, ad esempio, aumentare il numero dei dipendenti comunali in modo da risolvere problemi concreti di lavoro e di utenza nel proprio Comune? No. Avete mai visto questi sindaci di pseudosinistra fare una battaglia durissima per le case, visto che mancano specie nelle grandi città? Avete mai visto questi sindaci fare delle battaglie contro i grandi gruppi immobiliari che hanno decine di migliaia di alloggi sfitti, che consentono l’oscillazione del mercato degli affitti e delle case? No”.
Poi rincara: “Questi sarebbero stati veri sindaci di sinistra, che, secondo le loro prerogative, avrebbero potuto fare delle scelte politiche ammissibili anche dal punto di vista legale e non fare solo della fuffa.
Leggi tutto
coniarerivolta: Elezioni europee: mentre il Governo arretra, noi dobbiamo avanzare
Elezioni europee: mentre il Governo arretra, noi dobbiamo avanzare
di coniarerivolta
Potere al Popolo! ha recentemente lanciato un invito al dibattito ed al confronto sull’Europa, in vista delle elezioni europee del 2019. Accogliamo l’invito e pubblichiamo il nostro terzo contributo sul tema. A questo link è invece possibile scaricare un unico file PDF che riporta i nostri tre contributi
Sono passati meno di dieci mesi dalle elezioni politiche del 4 marzo. Apparentemente, questo breve lasso di tempo dovrebbe essere stato più che sufficiente per chiarire una serie di equivoci che, per diverse ragioni, avevano fatto breccia anche in una certa sinistra, o presunta tale: il governo gialloverde non ha – e non ha mai avuto, come si sarebbe potuto desumere dalla lettura del contratto di governo – alcuna intenzione di rompere con la gabbia dell’austerità né di invertire la rotta di politica economica seguita incessantemente dai governi degli ultimi venticinque anni. La capitolazione definitiva sulla legge di bilancio, con la perla di situazionismo rappresentata dal passaggio da un austero deficit al 2,4% del PIL ad un austerissimo 2,04%, è stata solamente l’atto finale della farsa iniziata a fine settembre, quando si prometteva e si celebrava l’abolizione della povertà e al contempo si delineava già una bozza di legge di bilancio che sottraeva risorse all’economia.
Leggi tutto
Piccole Note: Trump: l'Iran è cambiato
Trump: l'Iran è cambiato
di Piccole Note
Per Trump la presenza dell’Iran in Siria non è più un problema. Una dichiarazione, resa ieri in una conferenza stampa, che ha mandato in fibrillazione mezzo mondo.
Siria: l’Iran si ritira?
Per Trump, infatti, Teheran sta ritirando le forze che ha inviato in Siria a supporto di Assad. Ciò perché lo smantellamento dell’accordo sul nucleare iraniano e la riproposizione delle sanzioni la stanno mettendo in difficoltà.
Insomma, gli iraniani hanno gravi problemi interni da affrontare e ciò non gli consente di alimentare la propria influenza nella regione.
Le parole di Trump hanno scosso Israele, preso già alla sprovvista dalla sua decisione di ritirare le truppe americane dalla Siria.
I giornali israeliani hanno messo in risalto un passaggio del suo discorso: “Francamente penso che l’Iran possa fare quel che vuole” in Siria.
Estrapolate dalle altre considerazioni, queste parole hanno fatto scattare l’allarme a Tel Aviv, perché sembrano sottendere un’impossibile disinteresse di Washington riguardo Israele, che percepisce l’influenza iraniana come una minaccia esistenziale.
Leggi tutto
Andrea Muratore: La Democrazia svuotata
La Democrazia svuotata
di Andrea Muratore
Il blog ufficiale dei Cinque Stelle ha titolato: “la democrazia è sotto attacco“, e con esso il governo. Emma Bonino piange il calpestamento della democrazia e delle istituzioni da parte del governo e Giorgio Napolitano sottolinea come le mosse dell’attuale esecutivo siano senza precedenti, inaudite. Sbagliano tutti quanti.
Sbaglia il Blog delle Stelle perché certe parole andrebbero pesate bene, prima di scavare trincee di odio destinate a rimarginarsi con enorme difficoltà. Tutti in Italia ricordiamo come l’imbarbarimento del dibattito politico abbia avuto un’accelerazione nel contesto della campagna referendaria del 2016.
Non perdonerò mai a Matteo Renzi di aver tentato una forzatura di tale livello, che ha spaccato il Paese e ne ha spaccato la retorica politica. Tra i pronostici catastrofistici dei fautori del Sì in caso di bocciatura della riforma (crollo del Pil, blocco degli investimenti, default) e gli attacchi contro la “deriva autoritaria” si è avviata una spirale discendente in cui siamo tutt’ora intrappolati. Renzi ha pagato giustamente il fio con l’annichilimento politico, ma chi gli è succeduto, di fatto, è figlio dello stesso sistema.
La democrazia rappresentativa ha difficoltà enormi a relazionarsi con i vincoli di natura finanziaria, economica e burocratica che troppo spesso rappresentano un freno indebito all’azione politica. Ma la strada per superare questi vincoli non può essere esclusivamente retorica.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
mesi
Hits 3332
Hits 1939
Hits 1867
Hits 1775
Hits 1762
Carlo Galli: A sinistra: da dove ripartire?
Hits 1741
Elisabetta Teghil: “…di luce intellettual piena d’amore”
Hits 1727
Daniele Benzi: Chiuso per fallimento (e lutto)
Hits 1610
tonino

Tommaso Redolfi Riva: A partire dal sottotitolo del Capitale: Critica e metodo della critica dell’economia politica
A partire dal sottotitolo del Capitale: Critica e metodo della critica dell’economia politica
di Tommaso Redolfi Riva*
redolf...@yahoo.it
Abstract: The aim of the paper is to explain the concept of «critique of political economy» (CPE) in Marx’s mature work. Starting from the different meanings CPE assumes, I will try to explain the peculiarities of such a critical project. In particular, I will focus the attention on CPE as a critique of capital as objective-subjective totality: on the one side, as a system of social production whose aim is the valorisation of capital, based on the appropriation of unpaid labour and generating a system of socialisation of production increasingly becoming autonomous from the social agents which establish it; on the other side, as the place of constitution of the categories of political economy, whose defect cannot only be brought back to the methodological lack of the economists because such categories, as a part of the capitalistic reality itself, are products of capitalistic social relationships. What emerges from this perspective is that CPE, as the presentation of the system of capitalistic relationships, is the critique of a specific science put forth by means of the critique of its own specific object
 «Il metodo
della dialettica,
«Il metodo
della dialettica,
che cerca di andare al di là della
prospettiva specialistica
e circoscritta della logica e
dell’epistemologia,
consisterebbe nel non accontentarsi della
semplice individuazione
del punto che richiede di essere criticato e
poi affermare:
‘Guarda, qui c’è un errore nel
ragionamento, sei caduto in contraddizione –
quindi tutta la
cosa non vale nulla’, bensì […]
nell’indicare perché, nella
costellazione di questo pensiero,
certi errori e certe
contraddizioni sono inevitabili,
che cosa li ha generati nel movimento
di tale pensiero e
in che
senso quindi essi si mostrano significativi,
nella loro
falsità e contraddittorietà, nella totalità del pensiero».
(Adorno 2010, 222-3)
1. Introduzione
Le categorie dell’economia politica rappresentano per Marx il luogo di accesso privilegiato alla realtà del modo di produzione capitalistico, non soltanto in quanto momenti di una teoria che rappresenta «il tentativo di penetrare nell’intima fisiologia della società borghese», ma anche in quanto esse sono una prima «nomenclatura» dei fenomeni «economici» che sono così riprodotti nel «processo di pensiero» (Marx 1993b, 168-169). Se è vero che l’oggetto della teoria di Marx è il modo di produzione capitalistico, l’accesso a tale oggetto passa necessariamente attraverso la mediazione concettuale (cfr. Schmidt 2017 e Fineschi 2006, in particolare 131-136).
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Siria: élite mondialista e pacifisti sinistri contro Trump. Vaticano-Quirinale: Benedictio urbi et orbi atque PD
Siria: élite mondialista e pacifisti sinistri contro Trump. Vaticano-Quirinale: Benedictio urbi et orbi atque PD
di Fulvio Grimaldi
(E’ lungo, forse prolisso, ma tratta due temi grossi, si può digerire in due puntate e, giuro, per un po’ non mi farò vedere. Per combinare il testo con le immagini andate su www.fulviogrimaldicontroblog.info. Almeno da lì nessuno può rimuovere)
 Palloncino
bucato
Palloncino
bucato
Una cosa si è confermata chiara e ha bucato il pallone gonfiato delle fake news dei grandi media e la loro forsennata passione per la globalizzazione di guerre, neoliberismo, totalitarismo. Una cosa ha definitivamente sancito la scomparsa, da noi, ma anche da molte altre parti, di quel settore della società politica che si definiva di sinistra e coltivava il paradosso di chiamare destra l’altro settore. Per la sedicente sinistra vale ormai al massimo il corrispettivo linguistico al maschile.
Questa cosa ha l’aspetto di Giano Bifronte: da un lato fulmina con occhiate di sdegno e riprovazione il trucidone della Casa Bianca che, sfidando una tradizione di guerre d’aggressione che risale alla fondazione del suo paese e ne costituisce l’essenza ontologica e, ahinoi, anche escatologica, annuncia il ritiro di truppe da Siria e Afghanistan (vedremo poi i perché e percome); dall’altro inneggia con passione smodata ai Supremi di casa nostra che, in occasione delle festività, ci hanno fatto volare sul capo aerostati gonfi di pace. Nella fattispecie aria calda.
Siamo il paese dei fessi che fanno i furbi, che tuffano il diavolo nell’acqua santa e se la cavano scegliendo la sudditanza a discapito della cittadinanza. Arlecchino servitore di due padroni. Don Abbondio, se di fronte c’è don Rodrigo, don Rodrigo, se si ha a che fare con don Abbondio. Dunque, don Abbondio prima con i tedeschi, poi con gli americani. Con tutti quelli che ci menano. E dunque con l’UE. Don Rodrigo con quelli che possiamo menare. Di solito noi stessi. E da questa caratteristica nazionale che nasce il prodigio di un paese, escluso il 32,7 % degli elettori che restano in stato d’attesa, che si diverte come un bambino sull’altalena nel parco giochi costruitogli dai potenti.
Leggi tutto
Marta Fana e Simone Fana: Jeff Bezos mette le mani nella tua posta
Jeff Bezos mette le mani nella tua posta
di Marta Fana e Simone Fana
Amazon si rafforza nel nostro paese grazie all'accordo con Poste Italiane: un'intesa che non serve a lavoratori e consumatori. E che consolida due monopoli privati, uno globale l'altro nazionale
 Il servizio postale
nazionale nasce insieme allo stato unitario, nel 1862, quando
fu istituito il monopolio delle
Regie poste seguito vent’anni più tardi, nel 1889, dal
Ministero per le poste e i telegrafi. La storia è quella
dell’espansione del servizio pubblico e universale di accesso
alla corrispondenza, ma anche al diritto all’inviolabilità
delle
lettere, e della tariffa unica, con l’istituzione del
francobollo. Obiettivi diametralmente opposti alle regole che
vigono oggi nel sistema
privatizzato in cui la velocità delle spedizioni e la garanzia
del servizio universale sono subordinati al potere d’acquisto:
al censo,
si sarebbe detto in quel lontano inizio del ventesimo secolo.
Dall’interesse di garantire il servizio di corrispondenza a
tutti i cittadini
mediante il controllo della rete e dei prezzi si è giunti a
porre l’interesse degli azionisti e del capitale privato come
prioritari;
fino a rendersi servizio non dei cittadini ma del capitale
stesso, come mette in luce l’ingresso di Amazon nei servizi
postali e l’accordo
siglato con Poste Italiane.
Il servizio postale
nazionale nasce insieme allo stato unitario, nel 1862, quando
fu istituito il monopolio delle
Regie poste seguito vent’anni più tardi, nel 1889, dal
Ministero per le poste e i telegrafi. La storia è quella
dell’espansione del servizio pubblico e universale di accesso
alla corrispondenza, ma anche al diritto all’inviolabilità
delle
lettere, e della tariffa unica, con l’istituzione del
francobollo. Obiettivi diametralmente opposti alle regole che
vigono oggi nel sistema
privatizzato in cui la velocità delle spedizioni e la garanzia
del servizio universale sono subordinati al potere d’acquisto:
al censo,
si sarebbe detto in quel lontano inizio del ventesimo secolo.
Dall’interesse di garantire il servizio di corrispondenza a
tutti i cittadini
mediante il controllo della rete e dei prezzi si è giunti a
porre l’interesse degli azionisti e del capitale privato come
prioritari;
fino a rendersi servizio non dei cittadini ma del capitale
stesso, come mette in luce l’ingresso di Amazon nei servizi
postali e l’accordo
siglato con Poste Italiane.
Tra la fase del monopolio pubblico e la totale liberalizzazione, Poste Italiane ha vissuto da protagonista l’intera storia del capitalismo misto italiano, cadendo sotto i colpi del mantra della redditività e della libera concorrenza. A partire da fine anni Novanta le esigenze sovranazionali di completare la creazione del mercato unico investono il settore postale con quello dei trasporti e della logistica più in generale. In principio si provava a armonizzare il servizio postale e soprattutto a imporre i limiti ai diritti riservati ai fornitori del servizio universale. Come recita la pagina dedicata dell’Agcom Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, «il processo di liberalizzazione dei mercati dei servizi postali avviato dall’Unione europea con la direttiva 97/67/CE (da ultimo modificata con la direttiva 2008/6/CE) implica, per gli Stati membri, l’abolizione di qualsiasi forma di monopolio, di riserva e di diritti speciali nel settore». Il recepimento della direttiva del 2008, avvenne in Italia con il decreto legislativo n° 58 del 2011 che liberalizza il servizio postale e affida a Poste Italiane la copertura del servizio universale per un periodo di quindici anni, pro tempore e revocabile.
Leggi tutto
coniarerivolta: Lo spauracchio dell’inflazione tra mito e realtà
Lo spauracchio dell’inflazione tra mito e realtà
di coniarerivolta
Il 2018 si è chiuso, per l’Italia, con l’ennesima manovra improntata all’austerità. Dopo una lunga ed inutile pantomima, la partita si è chiusa con un miserrimo 2.04% di deficit rispetto al PIL. Come ben sappiamo, ciò implica un significativo avanzo primario – cioè una sottrazione netta di risorse – e di conseguenza un impatto molto negativo sulla domanda aggregata della nostra economia. Sappiamo anche che, vista la disoccupazione a due cifre, la situazione delle nostre infrastrutture (autostrade, scuole, ospedali) ed uno stato sociale sempre più in sofferenza (salute, istruzione, ambiente), ciò che servirebbe è un robusto stimolo pubblico all’economia, che si tradurrebbe in un deficit di diversi punti percentuali sopra i parametri imposti da Maastricht e, successivamente, dal Fiscal Compact. Per poter fare questo, la rottura della gabbia europea è un necessario ed ineludibile primo passo. Solamente in questa maniera, infatti, si può ribaltare la prospettiva tossica delle ‘risorse scarse’ – che viene strumentalmente usata per impedire, di fatto, la spesa in deficit come strumento di politica economica – ed adottare una conseguente strategia fatta di politiche industriali e spesa pubblica, finanziata da una banca centrale accomodante tramite la creazione di nuova moneta. C’è però un fantasma che incombe e che viene brandito contro chi propone questo tipo di intervento: l’inflazione. L’argomento si potrebbe sintetizzare così: “Sarebbe bellissimo che lo Stato spenda per tutta una serie di cose meritorie quali la salute, l’istruzione, i viadotti autostradali, etc., ma come faremmo poi a controllare l’inflazione che ne deriverebbe?”.
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: I limiti del “partito dei sindaci” e la costruzione del Partito
I limiti del “partito dei sindaci” e la costruzione del Partito
di Tommaso Nencioni
La parola d’ordine con cui la Lega si è fatta forte in campagna elettorale, ha egemonizzato l’azione di governo e che racchiude, sembra, il senso della sua scalata nei sondaggi – Prima gli italiani! – si sta rovesciando in un grottesco Dopo gli stranieri, senza peraltro che la condizione del popolo italiano paia destinata a cambiare grazie all’azione di governo. Almeno a giudicare dalla recente finanziaria, prona ai diktat di Bruxelles che hanno smantellato uno dietro l’altro i provvedimenti in teoria più incisivi come “quota 100” per le pensioni e il reddito di cittadinanza; e per il resto in perfetta continuità con gli ultimi vent’anni di austerità.
E così, in mancanza di meglio, il ministro degli interni Salvini – molto più presente sui social che al Viminale – nulla potendo per il bene degli italiani, si è accanito per male contro 43 migranti riscattati dalle ong dalla deriva nel Mediterraneo. Un atteggiamento, quello del rampollo della Lega, per nulla dissimile da quello dei suoi colleghi spagnoli o francesi, per non parlare di Malta. Ma alla fine, al di là del poco virtuosismo degli altri paesi europei, a questo l’azione di governo si sta riducendo, ad uno spot continuo sulla “chiusura dei porti”. Il fatto inquietante è semmai che, per via della reazione di chi a questo governo si dovrebbe opporre, l’operazione sta riuscendo, e cioè il dibattito si sta polarizzando attorno a questa misura. Un terreno sul quale le forze progressiste perdono in partenza.
Leggi tutto
Mario Agostinelli: Petrolio, carbone e gas salveranno il lavoro?
Petrolio, carbone e gas salveranno il lavoro?
di Mario Agostinelli
I delegati di oltre 200 Paesi delle Nazioni Unite erano arrivati ai colloqui sul clima a Katowice con l’incarico di sostenere l’accordo di Parigi 2015 (vedi www.energiafelice.it). Pur trattandosi di un appuntamento “tecnico” per fare il punto sui progressi o i ritardi rispetto all’agenda fissata tre anni orsono, l’attenzione si è focalizzata sulle responsabilità che i leader mondiali si sarebbero assunti nei confronti dell’emergenza climatica. A un mese dalla conclusione della Conferenza possiamo dire che sono state confermate le previsioni più pessimistiche: in tre anni non solo non si sono verificati miglioramenti apprezzabili ma, alla luce degli ultimi dati diffusi dal Global Carbon Project, le emissioni di gas serra sono aumentate per il secondo anno consecutivo nel 2018.
Preso atto di ciò, si deve constatare che l’incombente crisi climatica sta andando oltre le nostre capacità di controllo: vale allora la pena di andare oltre la ricerca dei colpevoli del passato (peraltro tanto noti quanto insensibili), per metterci in azione come persone e soggetti sociali attivi, capaci con le loro reazioni e comportamenti di imporre un cambiamento di rotta. Tanto urgente da doversi realizzare in un arco temporale breve, che, secondo l’IPCC (vedi http://www.meteoweb.eu/2018/10/cambiamenti-climatici-allarme-ipcc/1161519/ ), non può andare oltre i prossimi quindici anni.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: La Cina abolisce le tasse per i lavoratori e spinge i consumi interni
La Cina abolisce le tasse per i lavoratori e spinge i consumi interni
di Pasquale Cicalese
Si incominciano a delineare i contorni delle misure adottate il 24 dicembre dal Consiglio di Stato cinese, proprio mentre l’Occidente festeggiava il Natale, e di cui abbiamo dato notizia proprio quel giorno su questo sito.
Due premesse. in Cina salari e costi sono molto differenziati a secondo delle zone, per cui il salario dell’Ovest è diverso da quello di Pechino o Nanchino. Inoltre: secondo il sistema fiscale cinese le detrazioni avvengono su base mensile, non annuale, tranne le spese sanitarie.
C’è da sottolineare che già nei mesi scorsi in Cina era diminuita l’Iva, e in tal modo erano stati tagliate le aliquote sia sui redditi medio bassi che su quelli alti. Il tetto dell’imponibile è ora a 5 mila yuan, circa 625 euro.
Con le misure adottate il 24 dicembre ci sono detrazioni fiscali mensili pari a 400 yuan (50 euro) per master o corsi di formazione, 1.000 yuan per spese affitto, 1.000 yuan per ciascun figlio a scuola, 1.000 yuan per cura di ciascun genitore e detrazioni annuali per spese mediche pari a 60 mila yuan (7.500 euro).
In Cina la sanità è a carico dello stato al 70% e del lavoratore per il restante 30%. Con le detrazioni decise a dicembre, in pratica, il lavoratore anticipa mensilmente le spese mediche e poi riavrà un credito di imposta pari al costo sostenuto alla fine dell’anno, questo in vista della costruzione futura del sistema universale della sanità.
Leggi tutto
Vladimiro Giacché: Per una sovranità democratica e popolare. Cioè costituzionale
Per una sovranità democratica e popolare. Cioè costituzionale
L’ultimo libro di Alessandro Somma: “Sovranismi”
di Vladimiro Giacché
Un'ottima recensione di Vladimiro Giacché all'ultimo libro di Alessandro Somma
 Poche
parole hanno conosciuto un improvviso boom negli ultimi anni
come i termini “sovranismo” e
“sovranisti”. Di queste parole, ormai onnipresenti nel nostro
dibattito politico, chi compulsasse i quotidiani anche solo di
due-tre anni
non troverebbe quasi traccia. E francamente di un’altra
parola-contenitore di incerto significato, oltretutto in
genere adoperata come etichetta
denigratoria e dispregiativa, proprio non si sentiva la
mancanza.
Poche
parole hanno conosciuto un improvviso boom negli ultimi anni
come i termini “sovranismo” e
“sovranisti”. Di queste parole, ormai onnipresenti nel nostro
dibattito politico, chi compulsasse i quotidiani anche solo di
due-tre anni
non troverebbe quasi traccia. E francamente di un’altra
parola-contenitore di incerto significato, oltretutto in
genere adoperata come etichetta
denigratoria e dispregiativa, proprio non si sentiva la
mancanza.
Un motivo in più per apprezzare l’ultimo libro di Alessandro Somma, “Sovranismi. Stato, popolo e conflitto sociale” (Roma, Derive/Approdi, 2018), dedicato precisamente al compito di risalire ai diversi significati che oggi assume il concetto di “sovranità”, al quale quello di “sovranismo” confusamente allude, e i limiti ai quali è sottoposto nel contesto dell’Unione Europea. Al termine di questa disamina, l’autore descrive nell’ultimo capitolo i compiti e gli obiettivi di un “sovranismo democratico” che voglia porsi all’altezza delle sfide del presente.
Prima di procedere a un esame sommario dei contenuti di questo testo, la cui facilità di lettura - un pregio ben noto ai lettori dei libri di Alessandro Somma - non deve trarre in inganno (i temi trattati infatti sono molti, importanti e molto ben approfonditi), devo premettere che mi occuperò qui della linea argomentativa che mi pare centrale, mentre per motivi di spazio dovrò lasciare ai lettori del libro il piacere di scoprire numerosi altri temi importanti.
Il testo parte da un assunto forte sulla fase che stiamo vivendo: “L’epoca attuale è indubbiamente caratterizzata dal rigetto del mercato autoregolato e del processo di denazionalizzazione che ha accompagnato la sua affermazione”. Un rigetto che non si verifica oggi per la prima volta: il rifiuto del mercato autoregolato quale fondamento della società si ebbe tra la prima e la seconda guerra mondiale, e diede luogo a esperienze sociali e politiche radicalmente diverse tra loro quali l’Unione Sovietica e i fascismi.
Leggi tutto
Dante Barontini: Come rinasce un movimento di classe sotto i nostri occhi
Come rinasce un movimento di classe sotto i nostri occhi
di Dante Barontini
 La misura della devastazione prodotta nella
cultura della “sinistra” si
è avuta con gli atteggiamenti riservati – non dappertutto,
ma da molte parti – al movimento dei gilet gialli in
Francia.
La misura della devastazione prodotta nella
cultura della “sinistra” si
è avuta con gli atteggiamenti riservati – non dappertutto,
ma da molte parti – al movimento dei gilet gialli in
Francia.
Molti si son fatti persuadere dal vade retro pronunciato dai disinformation maker di Repubblica, Corriere, e financo il manifesto, ormai maggioritariamente rivolto contro tutto ciò che odora di conflitto sociale, “disturbo della quiete pubblica”, esangue retorica umanitaria ben attenta a non intralciare il cammino del capitale globalizzato (che non lo è più tanto, ma è inutile dirglielo).
All’origine di questa operazione stanno le “fonti francesi”, quasi sempre ridotte all’ex entourage di François Hollande, da cui sono usciti sia l’orrido Emmanuel Macron, sia il neo-falangista Manuel Valls (ex primo ministro “socialista”, che si è ricordato delle sue lontane origini catalane solo per candidarsi a sindaco di Barcellona con l’appoggio della destra anti-indipendentista e anti-repubblicana; non va dimenticato che la Spagna conserva sia la monarchia che l’impianto della Costituzione franchista).
Ci si è insomma a tal punto dimenticati di come nascono i movimenti da non riconoscerli neppure quando nascono sotto i nostri occhi. La causa vera – quella che infetta la “cultura politica” e dunque le griglie di lettura del reale – è nella storia dei partiti di massa del secondo Novecento. Un lungo periodo durante il quale le contraddizioni tra le classi, in Europa, venivano gestite con la mediazione tra interessi sociali diversi e le politiche keynesiane. Il bastone del comando restava in mano al capitale, ci mancherebbe, ma gli interessi operai o in senso lato proletari e “popolari” venivano organizzati, incanalati, rappresentati e riconosciuti come legittimi fino a diventare proposte di legge, rivendicazioni di riforme (con qualche successo, dopo aspri conflitti, negli anni ‘70).
Leggi tutto
Alessandro Volpi: Destra e Sinistra
Destra e Sinistra
di Alessandro Volpi
 Marcello
Gisondi ha dato avvio tempo fa, su questa rivista, alla
riflessione sulle
categorie di destra e sinistra, con un articolo dall’eloquente
titolo: “A sinistra di cosa?” in cui si
interrogava sulla validità di questa dicotomia nella lettura
dell’attuale “momento populista”. Condivido l’impostazione
del problema e nella sostanza anche la risposta, tuttavia
credo ci siano alcuni punti che vale la pena approfondire;
cercherò di portare un
piccolo contributo alla discussione.
Marcello
Gisondi ha dato avvio tempo fa, su questa rivista, alla
riflessione sulle
categorie di destra e sinistra, con un articolo dall’eloquente
titolo: “A sinistra di cosa?” in cui si
interrogava sulla validità di questa dicotomia nella lettura
dell’attuale “momento populista”. Condivido l’impostazione
del problema e nella sostanza anche la risposta, tuttavia
credo ci siano alcuni punti che vale la pena approfondire;
cercherò di portare un
piccolo contributo alla discussione.
Già nel 1994, iniziando a scrivere l’ormai classico libro sul tema (Destra e sinistra, Roma: Donzelli, 1994), Norberto Bobbio notava che «non si è mai scritto tanto come oggi contro la tradizionale distinzione fra destra e sinistra […].» [BOBBIO, p. VII] Oggi è ormai senso comune l’idea che le categorie siano saltate, e in Italia questo è accentuato dal fatto che uno dei partiti di governo, il Movimento 5 Stelle, non si definisce né di destra né di sinistra, e rende oggettivamente difficile il lavoro di giornalisti e politologi che cerchino di farlo. Che la nostra percezione si accordi così con quella che aveva Bobbio nel ’94 risponde senza dubbio alla mancata riattivazione politica di queste categoria da parte di chicchessia; più precisamente, oggi, esattamente come allora, viviamo un momento di profonda crisi della fiducia nelle istituzioni e nei soggetti della rappresentanza politica. È stato infatti nel ’94, a due anni dallo scoppio di Mani Pulite, che Berlusconi chiuse la prima repubblica e diede i natali alla seconda, ed è con le elezioni del 4 marzo 2018 che il Movimento 5 Stelle ha aperto una nuova fase politica, appunto una terza repubblica.
Leggi tutto
Carlo Formenti: L'ideologia antistatalista e l'autodistruzione delle sinistre
L'ideologia antistatalista e l'autodistruzione delle sinistre
di Carlo Formenti
Non pochi hanno osservato che, intestandosi la “rivolta dei sindaci” contro il rilancio securitario di Salvini, le sinistre spostano ulteriormente il baricentro dell’iniziativa politica sul tema dei diritti civili (con priorità assoluta al problema dei migranti) sperando così di dimostrare la propria superiorità morale nei confronti della controparte, tuttavia, in questo modo, non solo non indeboliscono l’avversario, ma rischiano – come dimostrato dall’esperienza storica passata e recente – al contrario di rafforzarlo.
Avendo più volte scritto che la débâcle che le sinistre hanno subito negli ultimi decenni è, in larga misura, dovuta proprio a questa dislocazione dal terreno della lotta per i diritti sociali in difesa degli interessi delle classi popolari a quello, tipico della tradizione liberal democratica, della tutela dei diritti individuali e civili, non posso che condividere tale riflessione.
Ciò detto, credo che dietro questo scontro fra potere centrale e poteri locali si celi una ragione ancora più profonda delle nuove, inevitabili sconfitte cui è destinata ad andare incontro la sinistra – una ragione che prescinde dal contenuto della battaglia ideologica in corso (paranoia xenofoba versus utopia no border).
Leggi tutto
Thomas Fazi: Mutui, tassi e spread
Mutui, tassi e spread. Come volevasi dimostrare i "grandi" giornali vi hanno (ancora) mentito e ora sono costretti ad ammetterlo
di Thomas Fazi*
A fine novembre - mentre la grancassa mediatica gridava all'imminente impennata dei mutui a causa dell'aumento dello spread - io ed altri notavamo come fosse improbabile che avremmo assistito a un'impennata dei mutui visto che questi ultimi - sia quelli variabili che, in maniera indiretta, quelli fissi - dipendono perlopiù dai tassi applicati alle banche dalla BCE (cioè dal costo del denaro) che nulla hanno a che vedere con lo spread e che era lecito immaginare sarebbero rimasti molto bassi anche nei mesi a venire, dato il rallentamento generalizzato dell'economia della zona euro.
Bene, proprio oggi il Il Sole 24 ORE - fino a ieri in prima fila nella campagna mediatico-terroristica sull'aumento dei mutui - scrive che «i tassi, sia nella formula a tasso fisso che variabile, dovrebbero restare ancora bassi e vicini ai minimi di tutti i tempi .
.. perché, se l’economia rallenta e non è in grado di generare un livello di inflazione elevato, difficilmente una banca centrale può aumentare il costo del denaro». Adesso chiedetevi se fino a ieri il giornale in questione avesse semplicemente sbagliato analisi - sebbene si trattasse di un'analisi che sarebbe stato in grado di fare anche un bambino con una conoscenza rudimentale dell'economia - o se invece vi stesse semplicemente prendendo per i fondelli.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: Una spregevole sceneggiata
Una spregevole sceneggiata
di Fabrizio Marchi
Prendiamo atto che impedire alle donne di recarsi da sole a vedere un partita di calcio è considerato dalla classe politica e dai media occidentali molto più grave che finanziare e armare i tagliagole dell’ISIS, bombardare un paese, lo Yemen (con armi israeliane, americane, francesi e italiane, è bene essere precisi sulle cose…), fare strage di civili, fra cui migliaia di bambini, condannare a morte un blogger (con taglio della testa sulla pubblica piazza) perché ha scritto cose non gradite al regime, oppure una persona che professa una religione diversa da quella ufficiale wahabita, magari perché ha pubblicamente festeggiato una ricorrenza (per la cronaca, in Arabia Saudita sono stati condannati a morte sia cristiani che musulmani non wahabiti, ad esempio sciiti).
Questo è oggi l’Occidente, dominato dall’ideologia neo liberale e politicamente corretta. La cui finalità, fra le altre cose, è proprio quella di far finta di scandalizzarsi per le discriminazioni subite dalle donne (che condanniamo senza se e senza ma) dimenticandosi o fingendo di dimenticarsi che in Arabia Saudita ce ne sono tante altre e altrettanto gravi. Una fra tutte: a finire con la testa tagliata dopo processi farsa sono nella stragrande maggioranza dei casi lavoratori immigrati sfruttati e trattati come animali (tutti maschi, naturalmente) ma questo non desta l’attenzione delle redazioni dei media occidentali. Insomma, non fa notizia, come si suol dire.
Leggi tutto
Piccole Note: Bolton e Pompeo contro Trump
Bolton e Pompeo contro Trump
di Piccole Note
La pressione su Trump per farlo recedere dal ritiro delle truppe americane in Siria sta raggiungendo il parossismo.
Il tour di Bolton
Il consigliere per la sicurezza militare John Bolton, che si muove come fosse il vero presidente degli Stati Uniti, ha affermato che il ritiro avverrà solo a due condizioni: la sconfitta completa dello Stato islamico, per evitare che torni a minacciare il mondo, e a patto che vi sia la garanzia che i turchi non massacreranno i curdi siriani.
Date tali condizioni, non esisterebbe una tempistica precisa del ritiro, che comunque non riguarderebbe la cruciale base di al Tanf, posta al confine tra Giordania e Israele.
Un chiarimento che invece di chiarire appare teso a seppellire le possibilità di dare un seguito concreto all’ordine presidenziale. Peraltro Bolton ha iniziato un tour in Medio oriente, primo scalo Tel Aviv, nel quale sta diffondendo il suo nuovo verbo.
E per regalare a Netanyahu il Golan, che il premier israeliano reclama da tempo come area “vitale” per la sicurezza di Israele.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 1957
Hits 1881
Hits 1781
Hits 1771
Hits 1769
Hits 1758
Hits 1741
tonino

Sabato Danzilli: Marxismo e questione nazionale
Marxismo e questione nazionale
di Sabato Danzilli
La disputa tra comunisti e nazionalisti nella Germania anni Venti nel nuovo libro di Stefano Azzarà
 Il panorama
politico degli ultimi tempi sembra essere dominato dallo
scontro tra i
sostenitori acritici dell’integrazione europea e i
“sovranisti” euroscettici. Si tratta di una contrapposizione
che si rivela
fittizia e del tutto interna a fazioni della classe dominante.
Essa tuttavia ha coinvolto anche la cosiddetta sinistra di
classe, che si dimostra
incapace nel suo elemento maggioritario di sfuggire dal fare
codismo all’una o all’altra posizione. Il fronte di chi invoca
una supposta
maggiore sovranità e democrazia, possibile solo sul terreno
dello Stato-nazione, si allarga infatti sempre di più, e
aumenta il numero
di chi propone un’alleanza che vada oltre la destra e la
sinistra, in nome di un comune interesse nazionale, contro il
neoliberismo e il
capitalismo finanziario dell’alta borghesia cosmopolita.
Il panorama
politico degli ultimi tempi sembra essere dominato dallo
scontro tra i
sostenitori acritici dell’integrazione europea e i
“sovranisti” euroscettici. Si tratta di una contrapposizione
che si rivela
fittizia e del tutto interna a fazioni della classe dominante.
Essa tuttavia ha coinvolto anche la cosiddetta sinistra di
classe, che si dimostra
incapace nel suo elemento maggioritario di sfuggire dal fare
codismo all’una o all’altra posizione. Il fronte di chi invoca
una supposta
maggiore sovranità e democrazia, possibile solo sul terreno
dello Stato-nazione, si allarga infatti sempre di più, e
aumenta il numero
di chi propone un’alleanza che vada oltre la destra e la
sinistra, in nome di un comune interesse nazionale, contro il
neoliberismo e il
capitalismo finanziario dell’alta borghesia cosmopolita.
Il libro di Stefano G. Azzarà, Comunisti, fascisti e questione nazionale. Germania 1923: fronte rossobruno o guerra d’egemonia?[1], uscito di recente per i tipi Mimesis, giunge a fare chiarezza sui rapporti tra marxismo e questione nazionale in un momento in cui il dibattito su questi temi è particolarmente vivace. Azzarà affronta il problema da un punto di vista storico, confrontandosi con una situazione che presenta forti parallelismi con l’attualità e che, più di altre, può dunque fornire chiavi di lettura per un’analisi più consapevole della fase storica presente. Come esplicitato dal sottotitolo, il momento storico considerato è quello della Germania dei primi anni Venti. L’occupazione francese della Ruhr in rappresaglia ai ritardi nei pagamenti delle riparazioni di guerra da parte tedesca e la debole “resistenza passiva” del governo guidato da Cuno rendeva urgente la riflessione sulla reale indipendenza del paese. Nella prima parte del volume l’Autore esamina nel dettaglio la polemica del 1923 tra i comunisti e i gruppi neonazionalisti. Essa era seguita a un ricordo di Leo Schlageter, un militante nazionalista tedesco ucciso dai soldati francesi, che Karl Radek aveva fatto in un discorso pronunciato a una seduta dell’esecutivo dell’Internazionale Comunista.
Leggi tutto
Alessandro Somma: Liberalismo, Democrazia, Sovranità
Liberalismo, Democrazia, Sovranità
Moreno Pasquinelli intervista Alessandro Somma
Alétheia si confronta con il noto professore di Diritto Comparato autore di “Sovranismi”
 Alessandro Somma
è stimato professore ordinario di Diritto comparato
all’Università di Ferrara. Per
DeriveApprodi ha appena pubblicato il saggio Sovranismi.
Stato, popolo e conflitto sociale. Si
tratta di un testo
ad alta densità teorica che, dopo aver ricostruito il
dibattito filosofico e politico sul concetto di sovranità,
giunge sino alla
nascita degli Stati costituzionali di diritto, quindi
all’oggi. Somma considera che la Costituzione della
Repubblica italiana rappresenta uno
dei momenti più alti del costituzionalismo moderno, poiché i
suoi capisaldi sono la democrazia economica e l’eguaglianza
sostanziale. Proprio per questo, essa è fatta oggetto di
un’aggressiva decostruzione da parte delle forze
neoliberiste. Va dunque difesa,
non per un mero ritorno al già stato, ma poiché sulle sue
basi è di nuovo possibile immaginare un’alternativa
all’ordine sociale e politico esistente.
Alessandro Somma
è stimato professore ordinario di Diritto comparato
all’Università di Ferrara. Per
DeriveApprodi ha appena pubblicato il saggio Sovranismi.
Stato, popolo e conflitto sociale. Si
tratta di un testo
ad alta densità teorica che, dopo aver ricostruito il
dibattito filosofico e politico sul concetto di sovranità,
giunge sino alla
nascita degli Stati costituzionali di diritto, quindi
all’oggi. Somma considera che la Costituzione della
Repubblica italiana rappresenta uno
dei momenti più alti del costituzionalismo moderno, poiché i
suoi capisaldi sono la democrazia economica e l’eguaglianza
sostanziale. Proprio per questo, essa è fatta oggetto di
un’aggressiva decostruzione da parte delle forze
neoliberiste. Va dunque difesa,
non per un mero ritorno al già stato, ma poiché sulle sue
basi è di nuovo possibile immaginare un’alternativa
all’ordine sociale e politico esistente.
Alétheia ha intervistato Somma, intanto per rendere esplicito ciò che sembra implicito in Sovranismi, poi per comprendere quale sia il suo giudizio sul delicato momento politico che attraversa il nostro Paese.
* * * *
La Costituzione del ’48 è in assoluto la protagonista del tuo libro. Sembra di capire che tu ritenga che contiene il punto geometrico di equilibrio tra democrazia e capitalismo, altrimenti destinati a confliggere. Davvero possono coabitare capitalismo e democrazia?
Penso che la Costituzione individui un punto di equilibrio ottimale tra capitalismo e democrazia, ma penso anche che si tratti di un equilibrio assolutamente instabile: destinato a essere messo in crisi e a produrre il superamento del capitalismo o quello della democrazia. Sul finire dei ’30 gloriosi si sono intrapresi passi significativi nella prima direzione, tanto che poi si è subito imposta la seconda, significativamente descritta in termini di ritorno alla normalità capitalistica.
Restiamo alla Costituzione. Tu ritieni che la Carta sia un risultato avanzato di quello che definisci “Stato (costituzionale) di diritto” dal momento che respinge l’idea liberista del “mercato autoregolato” e contiene invece impliciti i concetti di “democrazia economica” e di “democrazia sostanziale”. Cosa intendi per “democrazia economica” e “democrazia sostanziale”?
Leggi tutto
Giovanna Baer: Guinzaglio al Web
Guinzaglio al Web
L’Europa e il copyright
di Giovanna Baer
 Il 12
settembre è stata
approvata la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e
del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale”
(1), una
proposta di legge pressoché sconosciuta al grande pubblico, ma
che ha visto spaccarsi in due il fronte politico e gli attori
della digital
economy. Il testo, che era stato respinto il 5 luglio
scorso, è stato riproposto con una serie di emendamenti dal
relatore Axel Voss
(eurodeputato tedesco cristiano-democratico), ed è passato con
438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Hanno votato
a favore la
maggioranza dei Popolari (Ppe) e dei Socialisti e Democratici
(S&D), mentre gli eurodeputati della Lega e del M5s hanno
votato contro, insieme alla
maggioranza dei Verdi. Il gruppo dei liberali (Alde) si è
spaccato, così come il gruppo delle destre (Enf). Ora l’iter
legislativo
prevede che vengano avviati i negoziati con il Consiglio e la
Commissione Ue per arrivare alla definizione del testo finale
e, in seguito, il voto del
Parlamento europeo sulla versione definitiva.
Il 12
settembre è stata
approvata la “Proposta di Direttiva del Parlamento Europeo e
del Consiglio sul diritto d’autore nel mercato unico digitale”
(1), una
proposta di legge pressoché sconosciuta al grande pubblico, ma
che ha visto spaccarsi in due il fronte politico e gli attori
della digital
economy. Il testo, che era stato respinto il 5 luglio
scorso, è stato riproposto con una serie di emendamenti dal
relatore Axel Voss
(eurodeputato tedesco cristiano-democratico), ed è passato con
438 voti a favore, 226 contrari e 39 astensioni. Hanno votato
a favore la
maggioranza dei Popolari (Ppe) e dei Socialisti e Democratici
(S&D), mentre gli eurodeputati della Lega e del M5s hanno
votato contro, insieme alla
maggioranza dei Verdi. Il gruppo dei liberali (Alde) si è
spaccato, così come il gruppo delle destre (Enf). Ora l’iter
legislativo
prevede che vengano avviati i negoziati con il Consiglio e la
Commissione Ue per arrivare alla definizione del testo finale
e, in seguito, il voto del
Parlamento europeo sulla versione definitiva.
Il presidente dell’europarlamento ed ex giornalista Antonio Tajani (Forza Italia) l’ha definita una vittoria di tutti i cittadini che, a suo dire, difenderà “la cultura e la creatività europea e italiana, mettendo fine al far west digitale” (2). Anche il Pd ha aderito al fronte degli estimatori (insieme alla FNSI, Federazione Nazionale Stampa Italiana, e alla FIEG, Federazione Italiana Editori di Giornali) e Silvia Costa, deputata e membro della Commissione cultura al Parlamento europeo, l’ha messa addirittura sul mitico: “Ha vinto l’Europa della cultura e della creatività contro l’oligopolio dei giganti del web” (3). Di segno opposto l’opinione di Isabella Adinolfi, eurodeputata M5s, che ha definito l’approvazione della proposta “una pagina nera per la democrazia e la libertà dei cittadini.
Leggi tutto
Roberto Antolini: Il Mussolini di Scurati
Il Mussolini di Scurati
di Roberto Antolini
L’uscita in settembre di “M il figlio del secolo” di Antonio Scurati (Bompiani, 839 p., € 24,00) è stato indubbiamente uno dei momenti significativi della stagione letteraria 2018. Per quello che Scurati ha tentato di fare con questo libro – coronato da un immediato successo di pubblico – intrecciando in modo nuovo Storia e Letteratura, come viene chiarito nella premessa: «Fatti e personaggi di questo romanzo documentario non sono frutto della fantasia dell’autore. Al contrario, ogni singolo accadimento, personaggio, dialogo o discorso qui narrato è storicamente documentato e/o autorevolmente testimoniato da più di una fonte. Detto ciò, resta pur vero che la storia è un’invenzione cui la realtà arreca i propri materiali. Non arbitraria però». Il progetto di Scurati, dunque, va oltre il programma del solito romanzo-storico, nel quale una vicenda di fiction viene inserita nel contesto di un’epoca storica ricostruita sullo sfondo in modo storiograficamente attendibile (almeno nelle intenzioni), e mescolando personaggi storici ad altri di fantasia. Scurati definisce diversamente il suo lavoro: “romanzo documentario”.
Non sono mancate le polemiche, arrivate fin alle bacchettate accademiche, piuttosto antipatiche, di Galli della Loggia sul Corriere della Sera.
Leggi tutto
Enzo Pennetta: “L’ottavo blog” non è ancora nato e già provoca reazioni allarmate
“L’ottavo blog” non è ancora nato e già provoca reazioni allarmate
di Enzo Pennetta
Sulla Stampa di Torino un articolo critica il progetto della Rai 2 di Freccero di fare una trasmissione sull’informazione alternativa. Ma l’informazione non dovrebbe sempre prevedere l’esame di punti di vista differenti?
Qual è l’informazione che la Stampa vuole difendere?
L’articolo è stato pubblicato martedì 8 gennaio su La Stampa a firma di Jacopo Iacoboni con il titolo “Un programma sui siti sovranisti. Rivoluzione Freccero Foa“, il cui testo integrale è stato ripreso su Dagospia. Nell’articolo si critica l’idea di Freccero ricorrendo ad un argomento che fa riflettere e che soprattutto dovrebbe far riflettere. Leggiamo infatti:
Se il motto di Rt, la tv del Cremlino, è «question more», metti tutto in dubbio, premessa per rivedere – diciamo così – il concetto di verità nel giornalismo, la Rai 2 di Freccero-Foa propone un programma giornalistico che, parole di Freccero, sarà «una rassegna dell’ informazione che non deve essere divulgata
Perché mettere in dubbio quello che riportano i quotidiani dovrebbe essere un pericolo? Il dubbio è una cosa positiva, al riguardo vediamo cosa riporta la Treccani:
è proprio la sua collocazione all’interno del processo di ricerca, il suo carattere problematico, che ha costituito il valore permanente del d. nella storia del pensiero filosofico, sia che esso venga considerato come operazione preliminare a ogni ricerca di verità, come premessa all’acquisizione della certezza (d. metodico), sia come constatazione dell’impossibilità di raggiungere certezze (d. scettico).
Leggi tutto
Zones Subversives: Otto Gross contro l'ordine morale
Otto Gross contro l'ordine morale
di Zones Subversives
La psicoanalisi consente di arricchire il pensiero rivoluzionario. Certo, le strutture sociali, economiche e politiche del capitalismo vanno distrutte. Tuttavia, appare indispensabile attaccare anche le norme e i vincoli sociali. I marxisti distinguono le sovrastrutture, con i loro apparati ideologici, dalle infrastrutture economiche. La psicoanalisi consente una critica della famiglia, dell'educazione e della repressione sessuale, per politicizzare la vita quotidiana. Soprattutto, Otto Gross e la corrente freudo-marxista incarnata da Wilhelm Reich hanno aspirato a trasformare il mondo per riuscire a cambiare l'insieme delle relazioni umane. Per liberare l'individuo, bisogna distruggere la società e organizzare una rivoluzione totale.
Un freudiano eterodosso
Il giovane Otto Gross, nato nel 1877 ed educato in un ambiente borghese, seguendo la volontà del padre, intraprende gli studi di medicina. Come studente si rivela timido, poco socievole, «di spirito conformista, è sfuggente verso le donne e l'alcol», secondo lo scrittore Franz Jung. Dopo il dottorato, Otto Gross diventa medico sui piroscafi che collegavano la Germania con l'America Latina, paese in cui provò l'oppio e diverse altre droghe. Scopre quello che è il lavoro di Freud, e si orienta progressivamente alla neurologia, alla psichiatria ed alla psicoanalisi.
Leggi tutto
Mauro Gallegati: Il reddito di cittadinanza come Jobs Act 2
Il reddito di cittadinanza come Jobs Act 2
di Mauro Gallegati
Per come è stato formulata la misura detta “reddito di cittadinanza” non è altro un sussidio temporaneo di disoccupazione con un certo guadagno per le imprese: in pratica un Jobs act 2. La filosofia è la stessa: come aiutare la flex-security senza usare la leva fiscale a fini redistributivi
Il 2018 è stato un anno orribile per il reddito di cittadinanza, ritirato in quasi tutti i Paesi che lo avevano sperimentato per via di costi insostenibili se non sono accompagnati da adeguate politiche redistributive. Eppure economisti e imprenditori nelle élite della tecnologia lo considerano una risposta adeguata alla disoccupazione tecnologica – le perdite di posti di lavoro causate dall’automazione.
L’idea è che tutti i cittadini ricevano una certa quantità di denaro dal governo per le spese di cibo, alloggio e abbigliamento – indipendentemente dal reddito o dalla condizione lavorativa come “reddito di base incondizionato”, ovvero modulato se reddito di cittadinanza. I sostenitori dicono che aiuterà a combattere la povertà dando alle persone la flessibilità di trovare lavoro e rafforzare la loro rete di sicurezza, o che offre un modo per supportare le persone che potrebbero essere negativamente influenzate dall’automazione. Per i detrattori favorisce l’ozio a spese di quanti lavorano.
La notizia per quanto allarmante non deve però preoccupare il Governo. Quello che loro definiscono “reddito di cittadinanza” è in realtà un “sussidio temporaneo di disoccupazione”.
Leggi tutto
Riccardo Bellofiore: Euro: dopo vent’anni, riforma cercasi disperatamente
Euro: dopo vent’anni, riforma cercasi disperatamente
Intervista a Riccardo Bellofiore*
 Lo
scorso primo gennaio sono trascorsi vent’anni
dall’introduzione dell’euro come valuta: un
anniversario che arriva in un anno cruciale per l’Unione
europea, con le elezioni del prossimo maggio, e impone
un bilancio complessivo
di un processo di integrazione monetaria europea, delle sue
contraddizioni e del suo futuro possibile. Punto di arrivo
di un tortuoso processo di
integrazione dei mercati nel Continente e, secondo i suoi
fautori, primo passo di una sempre maggiore integrazione
politica, la moneta unica
dell’Europa dopo la crisi dei debiti sovrani si pone oggi
come problema primario per la tenuta e legittimità
dell’intero progetto
europeo e degli stessi Stati membri. Le ferite ancora parte
della crisi e l’erosione di una solidarietà europea sotto la
scure
dell’austerità e dei vincoli fiscali legano sempre di più il
destino dell’euro a quello delle democrazie e dei diritti
sociali, rendendo urgente e necessario interrogarsi sulle
promesse tradite della moneta unica e su quelle
irrealizzabili. Quali sono state le ragioni
che hanno portato all’introduzione della moneta unica? Quali
i suoi limiti e le prospettive di una riforma dell’eurozona?
Ne abbiamo
parlato con Riccardo Bellofiore, Professore di
Economia Politica all’Università di Bergamo.
Lo
scorso primo gennaio sono trascorsi vent’anni
dall’introduzione dell’euro come valuta: un
anniversario che arriva in un anno cruciale per l’Unione
europea, con le elezioni del prossimo maggio, e impone
un bilancio complessivo
di un processo di integrazione monetaria europea, delle sue
contraddizioni e del suo futuro possibile. Punto di arrivo
di un tortuoso processo di
integrazione dei mercati nel Continente e, secondo i suoi
fautori, primo passo di una sempre maggiore integrazione
politica, la moneta unica
dell’Europa dopo la crisi dei debiti sovrani si pone oggi
come problema primario per la tenuta e legittimità
dell’intero progetto
europeo e degli stessi Stati membri. Le ferite ancora parte
della crisi e l’erosione di una solidarietà europea sotto la
scure
dell’austerità e dei vincoli fiscali legano sempre di più il
destino dell’euro a quello delle democrazie e dei diritti
sociali, rendendo urgente e necessario interrogarsi sulle
promesse tradite della moneta unica e su quelle
irrealizzabili. Quali sono state le ragioni
che hanno portato all’introduzione della moneta unica? Quali
i suoi limiti e le prospettive di una riforma dell’eurozona?
Ne abbiamo
parlato con Riccardo Bellofiore, Professore di
Economia Politica all’Università di Bergamo.
* * * *
A vent’anni dall’adozione dell’euro come valuta, quale l’origine e le ragioni storiche dell’adozione dell’euro?
Innanzitutto credo che si debba capire che unificazione monetaria ed euro non sono essenzialmente la stessa cosa. Noi ormai siamo abituati a chiamare l’euro “moneta unica” in opposizione alle monete nazionali dei Paesi che poi hanno fatto parte dell’eurozona. In realtà questa è a mio avviso una falsa alternativa.
Leggi tutto
Salvatore Biasco: L’eredità di Marx per un economista laico
![]()
L’eredità di Marx per un economista laico1
di Salvatore Biasco
 Premessa
Premessa
Marx è stato il mio imprinting giovanile e, più che Marx, la produzione di vari autori marxisti (e non marxisti, che comunque a lui si riferivano). Il bagaglio si era confusamente già definito, quando la mia formazione si è indirizzata verso l’economia, consolidandosi soprattutto a Cambridge (negli anni d’oro della Faculty of Economics) e, in Italia, nell’Istituto (si chiamavano così i Dipartimenti) diretto da Sylos Labini, quindi in un universo intellettualmente laico. Avere alle spalle quel piccolo bagaglio marxiano è stato importante poiché da subito ha contributo a farmi guardare l’economia da un punto di vista sociologico, nella consapevolezza che dietro le relazioni stilizzate vi è la struttura della società. Oggi - dopo tanti anni (nei quali c’è in mezzo il confronto continuo sul tema negli ’70 con Salvati, Vianello, Ginzburg, Lippi e tanti altri in quella fucina di idee che era allora l’Università di Modena) e dopo tutte le maturazioni (accettatemi il termine) che ha avuto la mia riflessione intellettuale - cosa rimane di Marx? Qual’è il consuntivo di insegnamenti che il confronto con la realtà e con la disciplina è andato distillando dentro di me e che mi sentirei di proporre come guida a un giovane che si avvicini oggi a lui? Quali considerazioni ci stimola anche nelle parti della sua produzione che ci appaiono più lontane dall’evoluzione del mondo corrente?
Ovviamente, in ciò che segue, il Marx che presento è come io l’ho sistemato nella mia mente ed è un Marx riferito al bagaglio analitico che ci ha trasmesso. Il Marx che si proietta in un finalismo storico non l’ho mai considerato rilevante e, sotto sotto, è anche una forzatura interpretativa. Il filosofo, lo storico, l’economista, il sociologo, l’umanista che in ciascun campo dà il “là a un modo originale di vedere le cose è, invece, di grande rilievo.
Leggi tutto
Temps critiques: Un abito giallo che fa comunità
Un abito giallo che fa comunità
di "Temps critiques"
 Il movimento dei Gilet
Gialli sembra confermare una rottura del
filo storico della lotta di
classe. La cosa aveva già avuto inizio a livello mondiale
durante le Primavere Arabe, poi con il
movimento
Occupy, e con i movimenti delle Piazze che
erano tutti alla testa di quelle mobilitazioni che
rivendicavano o domandavano
libertà, uguaglianza, e condizioni di vita in generale; il
posto di lavoro, piuttosto che le condizioni lavorative. È
stato anche per
questo motivo che questi movimenti si rivolgevano assai più
allo Stato che ai Padroni, nella misura in cui il processo di
globalizzazione/totalizzazione del capitale porta gli Stati a
gestire la riproduzione dei rapporti sociali a livello
territoriale, pur restando
dipendente dalle esigenze della globalizzazione.
Il movimento dei Gilet
Gialli sembra confermare una rottura del
filo storico della lotta di
classe. La cosa aveva già avuto inizio a livello mondiale
durante le Primavere Arabe, poi con il
movimento
Occupy, e con i movimenti delle Piazze che
erano tutti alla testa di quelle mobilitazioni che
rivendicavano o domandavano
libertà, uguaglianza, e condizioni di vita in generale; il
posto di lavoro, piuttosto che le condizioni lavorative. È
stato anche per
questo motivo che questi movimenti si rivolgevano assai più
allo Stato che ai Padroni, nella misura in cui il processo di
globalizzazione/totalizzazione del capitale porta gli Stati a
gestire la riproduzione dei rapporti sociali a livello
territoriale, pur restando
dipendente dalle esigenze della globalizzazione.
In Francia, la forza di resilienza del movimento operaio tradizionale aveva ancora mantenuto l'idea della lotta di classe del lavoro contro il capitale. Nella primavera del 2016, la lotta contro la riforma del diritto al lavoro aveva proseguito sulla strada della «classe operaia innanzitutto» senza ottenere dei risultati tangibili. Qualche anno prima, le mobilitazioni generate a partire dal movimento delle Piazze non avevano consentito un'effettiva ripresa, poiché avevano privilegiato il formalismo delle assemblee a scapito del contenuto della lotta. Una lotta che sembrava aver trovato un legame più promettente in seno al movimento spagnolo, che vedeva il movimento delle Piazze virare verso la solidarietà di quartiere, legandosi ai problemi dell'alloggio.
In tutte queste lotte, comprese quelle contro la loi-travail, la questione dello sciopero generale, o quella del blocco della produzione a partire dalle fabbriche, non è stata posta, così come non è stata posta in seno al movimento dei Gilet Gialli.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Italia e Ue votano per i missili Usa in Europa
Italia e Ue votano per i missili Usa in Europa
di Manlio Dinucci
Presso il Palazzo di Vetro delle Nazioni Unite, a New York, c’è una scultura metallica intitolata «il Bene sconfigge il Male», raffigurante San Giorgio che trafigge un drago con la sua lancia. Fu donata dall’Unione sovietica nel 1990 per celebrare il Trattato Inf stipulato con gli Stati uniti nel 1987, che eliminava i missili nucleari a gittata corta e intermedia (tra 500 e 5500 km) con base a terra. Il corpo del drago è infatti realizzato, simbolicamente, con pezzi di missili balistici statunitensi Pershing-2 (prima schierati in Germania Occidentale) e SS-20 sovietici (prima schierati in Urss).
Ora però il drago nucleare, che nella scultura è raffigurato agonizzante, sta tornando in vita. Grazie anche all’Italia e agli altri paesi dell’Unione europea che, all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, hanno votato contro la risoluzione presentata dalla Russia sulla «Preservazione e osservanza del Trattato Inf», respinta con 46 voti contro 43 e 78 astensioni.
L‘Unione europea – di cui 21 dei 27 membri fanno parte della Nato (come ne fa parte la Gran Bretagna in uscita dalla Ue) – si è così totalmente uniformata alla posizione della Nato, che a sua volta si è totalmente uniformata a quella degli Stati uniti. Prima l’amministrazione Obama, quindi l’amministrazione Trump hanno accusato la Russia, senza alcuna prova, di aver sperimentato un missile della categoria proibita e hanno annunciato l’intenzione di ritirarsi dal Trattato Inf.
Leggi tutto
Francesco Cancellato: Lettera aperta a chi applaude Salvini: col decreto sicurezza la pacchia è finita per voi
Lettera aperta a chi applaude Salvini: col decreto sicurezza la pacchia è finita per voi
di Francesco Cancellato
Paradossi italiani: gli abitanti delle periferie dovrebbero scendere in piazza a fianco dei Sindaci ribelli, per protestare contro un decreto che scarica tutte le tensioni sociali nei quartieri popolari e alimenta la guerra tra poveri, anziché mitigarla. Svegliamoci, prima che sia troppo tardi
Possiamo entrare nel merito delle questioni, per qualche minuto? Perché la verità è che dovremmo svegliarci tutti, non solo in sindaci ribelli, soprattutto chi ancora oggi pensa che il pugno di ferro di Salvini sia sinonimo di sicurezza sociale. Perché chiunque abbia un minimo di buonsenso dovrebbe avere la lucidità di leggersi il decreto cosiddetto sicurezza e chiedersi se davvero la sua vita migliorerà, discriminando chi sta sotto di lui nella piramide sociale. Perché, come a Lodi con il caso mense, è difficile non vedere le discriminazioni dentro il decreto sicurezza. Negare l’iscrizione all’anagrafe ai richiedenti asilo, per dire, vuol dire negare loro le cure sanitarie e ai loro figli la possibilità di andare a scuola. E cancellare la protezione umanitaria, trasformando in dalla sera alla mattina decine di migliaia di persone in clandestini che non possono nemmeno cercare una casa o un lavoro che non sia irregolare.
Leggi tutto
Eos: Mussolini e Salvini
Mussolini e Salvini
di Eos
In relazione all’articolo di Paolo Favilli, “Fascismo: il nome, la cosa” — recentemente pubblicato da Micromega —il cui fine politico e retorico è tutto sostanziato dal motivo di fondo del salvinismo come forma di neo-fascismo, occorre tornare ai fondamenti stessi della filosofia politica e della teoria del pensiero politico.
L’eccesso di storia sociale e di empirismo conduce inevitabilmente all’economicismo, l’economicismo conduce al determinismo astratto, allontanandoci dal regno della “polis” e della pura politicità. I risultati di tale metodologia postmarxista, che Favilli sembra incarnare alla perfezione, nella storia del Socialismo, e per il movimento operaio, son stati disastrosi, come anche il Nostro è costretto a riconoscere allorquando stigmatizza con grande onestà quei dirigenti socialisti che aprirono un’autostrada al futuro duce del fascismo nel momento in cui, dagli anni della guerra in avanti, dichiararono un nemico il corpo dei volontari della Grande guerra, gli arditi, i corpi d’elite militare, l’esercito tutto e l’idea stessa d’Italia.
Leggendo ciò che oggi scrive la nuova sinistra (da Left a Giacobin, dal Manifesto ai vari siti) possiamo dire che la Storia non è affatto maestra per tutti costoro e che lo Storicismo politico-filosofico è passato invano.
Leggi tutto
Alessandra Ciattini: Fare i conti con la sinistra latinoamericana del XXI secolo
Fare i conti con la sinistra latinoamericana del XXI secolo
di Alessandra Ciattini
Solo l’analisi approfondita può farci comprendere a cosa veramente tende un’organizzazione politica, anche senza saperlo
Fare i conti con la sinistra latinoamericana del XXI secolo e con il suo addentellato, il socialismo del o nello stesso, non è un vano esercizio, ma una riflessione utile anche a focalizzare meglio l’attuale congiuntura italiana, sempre che si voglia ragionare, dando pane al pane, e non schematizzare in grossolane opposizioni dicotomiche, del tipo chi critica Lula da Silva è uno scherano dello spietato imperialismo statunitense.
Riflessione anche opportuna per cercare di fare un po’ di luce nell’attuale confusione che domina i vari gruppuscoli comunisti italiani, che non riescono a trovare un denominatore comune per costituire un fronte aggregante in vista delle prossime elezioni europee, e per rilanciare l’arduo processo di ricostruzione della coscienza di classe dissolta da decenni di politiche liberiste sedicenti di sinistra e di ipocrita buonismo verso i cosiddetti ultimi. Del resto, la coscienza tende a rattrappirsi quando l’individuo si trova di fronte al costante ricatto di chi ti intima: se vuoi campare queste sono il salario (irrisorio) e le condizioni di lavoro (pessime), facendoci comprendere che il problema non è mai esclusivamente ideologico.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Alessandro Pascale: Marxisti cinesi e italiani a confronto
Hits 2159
Elisabetta Teghil: Nodi irrisolti
Hits 2102
Hits 1978
Hits 1894
Hits 1794
Hits 1787
Hits 1781
Hits 1751
tonino

Emiliano Alessandroni: Nei Quaderni filosofici di Lenin: lo studio della Logica e la lettura del proprio tempo
Nei Quaderni filosofici di Lenin: lo studio della Logica e la lettura del proprio tempo
di Emiliano Alessandroni
Abstract. In the 50s and 60s of the twentieth century, Lucio Colletti developed a requisition against Hegel and against those elements of his philosophy that had penetrated into Marxism. The main thesis is simple and clear: the more Marxism is contaminated with Hegelism the more it loses scientific consistency. This thesis ends up investing the judgment on the work of Lenin too. The essay in question will show the opposite: the concepts that the Russian revolutionary will find in Hegel’s Logic provide him the tools usefull to avoid the ideological deviations of his time and to identify the theoretical errors committed by Trotsky and the exponents of the Second International, both prisoners of the abstract intellect and of mechanistic ways of thinking. This judgment also belonged to Gramsci, who was not by chance a reader and a profound admirer of Hegel. Both Gramsci and Lenin often accuse Trotsky and the Second Internationalists of not having been able to internalize the dialectical logic, with very serious and dangerous political repercussions
 Nel corso degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento,
collocandosi
lungo la scia tracciata da Galvano Della Volpe, Lucio Colletti
sviluppa in Italia una requisitoria contro Hegel e
segnatamente contro quegli elementi
della filosofia hegeliana che, in modo più o meno volontario,
erano penetrati all’interno del marxismo, inficiandone, a suo
avviso, la
consistenza scientifica. Tre i vizi speculativi tramandati,
secondo lo studioso italiano, dalla Scienza della logica e
dalla Fenomenologia dello
Spirito: 1) l’assorbimento del quadro storico nel quadro
ontologico, vale a dire il complessivo disinteresse verso la
«molteplicità
del reale», portata a vanificarsi entro «una genericità o
un’idea che non rimanda né si riferisce a questo o a
quell’aspetto del reale, ma si presenta al contrario essa
stessa come la sola e intera realtà»1; 2) lo
«scambio», per usare la terminologia aristotelica, «del genere
con la specie»2; 3) la tendenza a cedere
reiteratamente alle lusinghe delle «ipostasi», categorie
incapaci «di servire come ipotesi e criteri per l’esperienza»
in quanto non desunte da scrupolose osservazioni dell’Oggetto,
ma apparse come «un’introduzione surrettizia di contenuti
immediati, non controllati»3.
Nel corso degli anni ‘50 e ‘60 del Novecento,
collocandosi
lungo la scia tracciata da Galvano Della Volpe, Lucio Colletti
sviluppa in Italia una requisitoria contro Hegel e
segnatamente contro quegli elementi
della filosofia hegeliana che, in modo più o meno volontario,
erano penetrati all’interno del marxismo, inficiandone, a suo
avviso, la
consistenza scientifica. Tre i vizi speculativi tramandati,
secondo lo studioso italiano, dalla Scienza della logica e
dalla Fenomenologia dello
Spirito: 1) l’assorbimento del quadro storico nel quadro
ontologico, vale a dire il complessivo disinteresse verso la
«molteplicità
del reale», portata a vanificarsi entro «una genericità o
un’idea che non rimanda né si riferisce a questo o a
quell’aspetto del reale, ma si presenta al contrario essa
stessa come la sola e intera realtà»1; 2) lo
«scambio», per usare la terminologia aristotelica, «del genere
con la specie»2; 3) la tendenza a cedere
reiteratamente alle lusinghe delle «ipostasi», categorie
incapaci «di servire come ipotesi e criteri per l’esperienza»
in quanto non desunte da scrupolose osservazioni dell’Oggetto,
ma apparse come «un’introduzione surrettizia di contenuti
immediati, non controllati»3.
Leggi tutto
Guido Ortona: Cosa sta succedendo
Cosa sta succedendo
di Guido Ortona
I sostenitori di politiche sbagliate non sono quasi mai in mala fede. Prima di proporle riescono quasi sempre a convincere sé stessi che sono giuste (U.D.)
 1. In breve. Che la terra sia
sferica è ovvio per
chiunque la guardi dallo spazio, ma non lo è per chi si trova
al livello del suolo. Analogamente, quello che sta capitando
oggi in Italia
sembra molto confuso se si segue la cronaca politica mentre
diventa più chiaro se si usa una prospettiva storica. Se
adottiamo questa ottica
scopriamo che ciò che sta capitando è un fenomeno non nuovo, e
non nuove sono alcune caratteristiche che ne conseguono.
1. In breve. Che la terra sia
sferica è ovvio per
chiunque la guardi dallo spazio, ma non lo è per chi si trova
al livello del suolo. Analogamente, quello che sta capitando
oggi in Italia
sembra molto confuso se si segue la cronaca politica mentre
diventa più chiaro se si usa una prospettiva storica. Se
adottiamo questa ottica
scopriamo che ciò che sta capitando è un fenomeno non nuovo, e
non nuove sono alcune caratteristiche che ne conseguono.
In breve: l’Italia è al centro di un processo di annessione a uno stato più forte, la nascente Europa a egemonia tedesca, come area debole destinata a essere colonizzata. E’ possibile che la nascente Europa dei padroni esploda nella culla per eccesso di ingordigia, come la rana della favola. Ma è meglio non farci troppo affidamento. Se ciò non avviene, il destino dell’Italia sarà analogo a quello dell’Italia meridionale nei confronti di quella settentrionale o degli Stati Confederati americani a seguito della guerra civile, vale a dire la condanna al sottosviluppo (rispetto alle aree forti), a seguito della subordinazione a leggi e istituzioni proprie degli stati vincitori e non solo inadatte a quelli subordinati, ma tali in molti casi da propiziare il loro sfruttamento. Con tutto ciò che ne è conseguito; in particolare la cooptazione delle classi dominanti delle aree subordinate nel sistema di potere di quelle vincitrici, e la subornazione culturale delle aree subordinate. Forse siamo ancora in grado di impedire tutto ciò. Vediamo più in dettaglio.
2. Leggi e istituzioni inapplicabili. Le norme europee prevedono che l’Italia sottragga ogni anno circa 50-70 miliardi alla sua economia per pagare interessi sul debito, somme che vengono investite quasi interamente in altri paesi, data la libera circolazione dei capitali. La libera circolazione di capitali è presentata come una norma sensata, progressiva e tale da massimizzare l’efficienza dell’economia mondiale.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Dal Niger al Sudan, l’Africa nella morsa dell’ipocrisia clericosinistra
Dal Niger al Sudan, l’Africa nella morsa dell’ipocrisia clericosinistra
di Fulvio Grimaldi
 Due settimane
davanti a Malta. Sarebbero bastate per sbarcare a Calais,
Dover o Amburgo
Due settimane
davanti a Malta. Sarebbero bastate per sbarcare a Calais,
Dover o Amburgo
Grande dibattito e grande esplosione di hate speech, discorsi dell’odio, rancore, invidia sociale (quelli che venivano attribuiti agli italiani che hanno votato questo governo) da parte dell’unanimismo politico-mediatico globalista e antisovranità, sul decreto sicurezza. Hate speech ulteriormente animati dalle due navi di Ong tedesche che girano per il Mediterraneo meridionale. Ong tedesche, vale a dire di quel paese e appoggiate da quel governo (oltreché da George Soros) che, dopo aver raso al suolo la culla della nostra civiltà (nuovamente barbari, alla faccia di Goethe, Bach, Duerer e Schopenhauer), si sono fatti giustizieri, insieme ai francesi e ai burattini di Bruxelles, del timido tentativo italiano di invertire il flusso della ricchezza perennemente dal basso verso l’alto.
Navi tedesche, mi viene da riflettere, che nel corso dei 18 giorni in cui andavano lacrimando su mari in tempesta e migranti, secondo l’immaginifico manifesto “in condizioni disperate” (benché rifornite da Malta di tutto il necessario…), tra Malta e Lampedusa, avrebbero potuto raggiungere, che so, New York, o magari Amburgo, visto che così tante città tedesche si erano dichiarate disposte ad ospitare i profughi. O Rotterdam, visto che è olandese la bandiera della Sea Eye. Non vi pare?
Posto che l’unica cosa buona fatta dal socio neoliberista e ultradestro della maggioranza di governo è stato mettere l’opinione pubblica di fronte al ricatto dell’Europa nei confronti dei paesi rivieraschi del Sud – o mangiate la minestra della destabilizzazione sociale ed economica di un’immigrazione incontrollata, o vi buttiamo dalla finestra -, posto che strumento di questo ricatto è la società anonima creata dal colonialismo tra multinazionali predatrici, trafficanti, Ong, santi peroratori dell’accoglienza senza se e senza ma, per sottrarsi a tale ricatto ritengo il decreto sicurezza del, per altri versi detestabile, fiduciario dei padroni, il minimo indispensabile per salvare una serie di paesi destinati al macero.
Leggi tutto
Militant: Fabrizio De André vent’anni dopo
Fabrizio De André vent’anni dopo
di Militant
De André fa parte della grande cultura italiana, nonostante le contraddizioni lancinanti che la sua opera porta con sé. Da decenni è un monumento, per ciò stesso impossibile da affrontare di petto. Cosa si può dire di qualcuno su cui è già stato scritto e detto di tutto, nel bene come nel male? Meglio tacere evitando la certezza del già sentito. Inutile tanto la rimasticazione di temi altrui quanto la provocazione fine a se stessa. De André va salvaguardato dalla sua normalizzazione, un processo d’altronde avviato con lui ancora aggrappato alla vita, e anche questo fa parte delle controversie umane di un uomo d’altri tempi e d’altre tensioni morali. E nonostante ciò, a vent’anni esatti dalla sua morte, mentre il coro mediatico fa gara a ricordarlo, è giusto non lasciare solo ai poveri di spirito la sua memoria.
Fabrizio De André è uno dei pochissimi autori del secondo Novecento italiano in grado di essere “monumentalizzato” senza passare per il nazional-popolare. Fatto questo di per sé significativo della sua grandezza. Una grandezza sempre controversa, in malfermo equilibrio tra cuore e ragione, politica e disimpegno, libertà e religione, intellettualità e popolo. Un uomo che viveva su di sé, rispecchiandola nella sua poetica, tale lacerante incompiutezza. Il senso di colpa è la sua cifra della poetica. L’essenza piccolo-borghese, da cui non si libererà mai, che saprà cogliere lo spirito dei tempi nelle forme ereticali tipiche dei grandi uomini di cultura.
Leggi tutto
Gabriele Bertoncelli e Filippo Bonarroti: Le ragioni del pugile dei gilet gialli
Le ragioni del pugile dei gilet gialli
E il suo appello per continuare la lotta
di Gabriele Bertoncelli e Filippo Bonarroti
Per alcuni è un bravo citoyen, per altri è un “eroe senza macchia e senza paura”. Si chiama Christophe Dettinger ed è l’ex pugile che, stanco della repressione, ha affrontato a mani nude la polizia antisommossa durante una manifestazione dei gilet gialli.
Il tutto è accaduto a Parigi sabato 5, durante l’ottava mobilitazione convocata dai gilet gialli in tutta la Francia. Il suo gesto è stato ripreso dai manifestanti stessi e in breve tempo ha fatto il giro del mondo, facendo di Dettinger un eroe del movimento, e non solo. L’odio per gli apparati repressivi non conosce confini, e anche in Italia sono tanti ad aver provato simpatia per Dettinger, dall’operaio manganellato durante un picchetto alla partita Iva frustrata per una multa.
A non apprezzare è stata la polizia, per la quale Dettinger è immediatamente diventato il gilet giallo più ricercato di Francia. Il boxeur si è costituito lunedì scorso, ma prima di farlo ha registrato un messaggio diretto a tutto il movimento dei gilet gialli. L’obiettivo del video era rispondere alle varie calunnie che i media non avevano perso tempo a lanciare, per i quali non si tratterebbe di un gilet giallo ma di un provocatore o addirittura di un militante dell’estrema destra.
Leggi tutto
Claudio Conti: L’unione Europea “declassata” dagli Stati Uniti
L’unione Europea “declassata” dagli Stati Uniti
di Claudio Conti
Non se ne parla sui giornali e nemmeno a Palazzo Chigi. Se ne bisbiglia nelle cancellerie che contano, se ne preoccupano i funzionari di lungo corso, quelli che sanno cogliere e leggere certi segnali. Perché la decisione di Trump è di quelle che pesano. Sia nei rapporti diplomatici internazionali, sia “sui mercati”.
Dal primo gennaio la rappresentanza diplomatica dell’Unione Europea a Washington è stata declassata da Stato Membro a Organizzazione Internazionale. Come il Wto o il Fmi, insomma. Non più un soggetto con prerogative sovrane, dotato di volontà politica, ma una “associazione di scopo”, temporanea, magari importante, con cui però non si devono fare i conti strategicamente.
Dal punto di vista diplomatico è una autentica retrocessione, visto che questa stessa condizione è durata fino al 2016, quando Barack Obama l’aveva “promossa”.
Lo schiaffo è però molto più pesante, perché non c’è stata – pare – alcuna comunicazione ufficiale, né un preavviso. Come si fa con i “signor nessuno”.
E’ il punto più basso delle relazioni tra le due sponde dell’Atlantico e l’origine – tra i pochi commentatori che se ne occupano – viene fatta risalire alle varie conferenze sul clima (è noto che Trump per ragioni economiche, non riconosce neppure l’esistenza del global warming), come anche al Global Compact sulla gestione dei flussi migratori (ha incatenato il bilancio federale all’approvazione di 5 miliardi di spesa er costruire un “muro d’acciaio” al confine col Messico), a una certa freddezza nei confronti di Isarele (l’unico vero alleato di ferro in Medio Oriente) in seguito all’accordo sul nucleare iraniano o anche alle forche caudine che Bruxelles vorrebbe imporre alla Gran Bretagna per la Brexit.
Leggi tutto
Dino Erba: Cesare
![]()
Cesare
di Dino Erba
A CE' t'hanno
svenduto!
Dopo 'na vita tra rivoluzione, rapine, fughe e
carcere,
t'hanno preso, grazie agli antimperialisti di
plastica.
Nun è 'na novità, Ce'.
Quer monno c'hai cercato 'n tutt' 'r
monno nun c'è.
E nun ce po' esse, d'artra parte.
Quer monno nostro senza
banche ne' galere o è ovunque,
o non è!
Mo' gioiscono
tutti, i porci della politica e della “società civile”.
La stessa che t'ha
costretto a vive' pericolosamente.
E ch'adesso te rinchiude,
de novo, magara pe' sempre.
“Giustizia è fatta Ce'”.
Non certo 'a nostra, però!
Pino, ferroviere
romano del XXI secolo.
La vicenda politica (più che giudiziaria) di Cesare Battisti merita doverose riflessioni. La farò breve, brevissima, so benissimo che pochi, anzi pochissimi, non siano addentro nelle segrete cose dei cosiddetti anni di piombo. Qualche cosa ho scritto e diffuso, per chi volesse approfondire.
Leggi tutto
Roberto Lampa: La chimera del capitalismo di pieno impiego
La chimera del capitalismo di pieno impiego
di Roberto Lampa*
Non saranno le “cassette degli attrezzi” di questo o quell’economista a risolvere il problema della disoccupazione perché non si tratta di un problema tecnico ma di una questione meramente politica

Come è stato possibile continuare per anni a imporre politiche economiche di flessibilizzazione e precarizzazione lavorativa, cioè misure incoerenti sul piano teorico e non corroborate da risultati pratici?
Per quanto riguarda la teoria economica, spesso tirata in ballo per giustificare la fondatezza e l’ineluttabilità delle famigerate “riforme” o “jobs act”, Davide Villani ha richiamato efficacemente, su queste pagine, la controversia sul capitale e la cristallina dimostrazione della fallacia del principio di sostituzione fattoriale tra capitale e lavoro, pietra angolare della quasi-totalità delle pubblicazioni mainstream in materia. Teresa Battista ha poi aggiunto un importante tassello a questa premessa, ricordandoci come anche l’evidenza empirica smentisca categoricamente l’esistenza di una qualsivoglia correlazione tra processi di flessibilizzazione del mercato del lavoro e livello di occupazione, trattandosi invece dell’istituzionalizzazione dei rapporti di forza tra capitale e lavoro.
Alla luce di questi contributi, quella posta all’inizio appare quindi come una domanda cruciale, a cui però il sapere tecnico non è in grado di fornire una risposta. Curioso paradosso, in un’epoca nella quale gli economisti si ergono a depositari della verità assoluta, tanto da arrivare a tacciare di negazionismo economico chiunque osi sfidare le rigide implicazioni di politica economica che discendono dalla teoria economica.
Per poter delineare una risposta è dunque indispensabile uscire dagli schemi abituali e partire da un’importante constatazione. La teoria economica attuale – sia nella sua versione dominante che in quella “eterodossa” – assume come dato esogeno un elemento di cruciale importanza: l’esistenza di un sistema capitalista.
In un certo senso, si può perfino affermare che mai come oggi sia accettato acriticamente (e trasversalmente alle scuole economiche) il famoso aforisma di Milton Friedman secondo cui «non esistono l’economia ortodossa e quella eterodossa, ma solo l’economia buona e quella cattiva».
Leggi tutto
Michelangelo Morelli: La lezione dimenticata di Federico Caffè
La lezione dimenticata di Federico Caffè
di Michelangelo Morelli
 Definire Federico Caffè
un semplice economista significa banalizzare molti aspetti che
contribuiscono a renderlo uno dei personaggi più interessanti
del Novecento repubblicano del nostro Paese. Alfiere del
pensiero keynesiano e
del welfare state, antifascista e attento
osservatore della società italiana, Caffè è stato un
intellettuale poliedrico
ed enciclopedico, capace di ragionar d’economia cogliendo le
implicazioni umane, sociali e culturali essenziali per la
costruzione di una
società fondata sul benessere degli individui.
Definire Federico Caffè
un semplice economista significa banalizzare molti aspetti che
contribuiscono a renderlo uno dei personaggi più interessanti
del Novecento repubblicano del nostro Paese. Alfiere del
pensiero keynesiano e
del welfare state, antifascista e attento
osservatore della società italiana, Caffè è stato un
intellettuale poliedrico
ed enciclopedico, capace di ragionar d’economia cogliendo le
implicazioni umane, sociali e culturali essenziali per la
costruzione di una
società fondata sul benessere degli individui.
Federico Caffè nacque il 6 gennaio 1914 a Castellammare Adriatico (Pescara), secondogenito di una famiglia economicamente modesta: il padre Vincenzo era un ferroviere, mentre la madre Erminia integrava il magro bilancio famigliare dirigendo un piccolo laboratorio di ricamo. Caffè rimase sempre molto legato alla madre, ereditando da essa la passione per la cultura letteraria, musicale ed estetica che caratterizzò l’eclettica personalità dell’economista per tutta la vita.
Diplomatosi a pieni voti presso l’Istituto Tecnico Tito Acerbo a Castellammare (riunificata con Pescara nel 1926), Caffè si trasferì a Roma da una cugina per frequentare gli studi universitari presso la facoltà di Economia e Commercio della Sapienza. La frequentazione dell’ateneo romano fu possibile grazie alla madre Erminia, che per raccogliere il denaro necessario vendette un piccolo podere di cui era proprietaria, riacquistato in seguito dallo stesso Caffè.
Caffè si laureò cum laude nell’ateneo romano il 17 novembre 1936 con una tesi intitolata L’azione dello Stato considerata nei suoi strumenti finanziari nell’ordinamento autarchico dell’economia italiana, discussa col Professor Guglielmo Masci, suo maestro assieme a Gustavo Del Vecchio. Il tema della tesi è emblematico di quell’attenzione per il ruolo dell’amministrazione centrale nella vita economica che caratterizzò il percorso intellettuale e professionale dell’economista pescarese.
Leggi tutto
Avery Minnelli: La Tirannia del Tempo: la critica immanente di Moishe Postone
La Tirannia del Tempo: la critica immanente di Moishe Postone
di Avery Minnelli
 Sono dell'opinione che
non esista una cosa che
possa assomigliare ad una lettura "neutrale" o "obiettiva"
di un testo o di un pensatore politico [*1].
Se una
lettura si presenta in tal modo, è molto probabile che dietro
ad essa si nasconde quello che è un appello all'autorità (per
esempio: «Bene, su questo Lenin è ovviamente
d'accordo con me, e Lenin aveva ragione, perciò, ipso
facto, io ho
ragione»). È stato con la consapevolezza che
le interpretazioni sono necessariamente selettive ed
intenzionali, che mi sono
accostata con la mente aperta al libro di Moishe Postone, "Time,
Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s
Critical
Theory" (1993) [Il libro, in
lingua inglese, può essere liberamente scaricato/e letto
cliccando qui] - che da qui in avanti chiamerò TLSD.
È per me di primario interesse il fatto che mi possa essere
utile il punto di vista dell'interpretazione di Postone in
quanto tale, piuttosto
che sapere quanto essa possa riflettere da vicino il punto di
vista di Marx.
Sono dell'opinione che
non esista una cosa che
possa assomigliare ad una lettura "neutrale" o "obiettiva"
di un testo o di un pensatore politico [*1].
Se una
lettura si presenta in tal modo, è molto probabile che dietro
ad essa si nasconde quello che è un appello all'autorità (per
esempio: «Bene, su questo Lenin è ovviamente
d'accordo con me, e Lenin aveva ragione, perciò, ipso
facto, io ho
ragione»). È stato con la consapevolezza che
le interpretazioni sono necessariamente selettive ed
intenzionali, che mi sono
accostata con la mente aperta al libro di Moishe Postone, "Time,
Labor, and Social Domination: A Reinterpretation of Marx’s
Critical
Theory" (1993) [Il libro, in
lingua inglese, può essere liberamente scaricato/e letto
cliccando qui] - che da qui in avanti chiamerò TLSD.
È per me di primario interesse il fatto che mi possa essere
utile il punto di vista dell'interpretazione di Postone in
quanto tale, piuttosto
che sapere quanto essa possa riflettere da vicino il punto di
vista di Marx.
Moishe Postone (1942-2018), è stato spinto a scrivere TLSD dopo aver svolto un approfondito studio dei Grundrisse di Marx. Postone riteneva che la struttura libera di quel testo potesse fornire uno sguardo che avrebbe permesso di visionare il pensiero di Marx, che nei tre volumi del Capitale era stato più dissimulato. Gli argomenti di Postone si basano principalmente sia sui Grundrisse che su Il Capitale; fa ben pochi riferimenti alle opere politiche di Marx, e nel testo Engels è quasi del tutto assente [*2]. In TLSD, Postone imposta il suo progetto come una reinterpretazione di Marx, ponendola in contraddizione con quella che Postone stesso ha definito «Marxismo tradizionale», che egli riteneva non fosse in grado di spiegare quelli che erano stati gli sviluppi avvenuti nel capitalismo post-liberale nel XX secolo.
Leggi tutto
Aristoteles: La disobbedienza populista
La disobbedienza populista
di Aristoteles
L’accusa di “populismo“, in questo nostro inizio di millennio, sembra destinata a rimbalzare da un media all’altro, dalle prime pagine dei giornali alle copertine dei tg.
Populismo è oramai una parola buona per tutte le stagioni, utile a definire spregiativamente una serie di movimenti tendenzialmente “anti-sistema”, che si richiamano ad un “popolo” contrapposto alle élite. Per dirla con Alberto Bagnai, «è il termine con il quale certi sinistri intellettuali etichettano qualsiasi circostanza nella quale il popolo non fa ciò che loro hanno deciso che faccia».
Così come alle élite socio-economiche non interessa definire meglio ciò che è populista, bensì agitarne lo spauracchio, allo stesso modo a noi preme ora – anziché analizzarne la semantica – dare una lettura del populismo alla luce dell’uso che di questo “insulto” fanno i tutori dell’ordine simbolico.
La nostra tesi è che accusare di populismo serva a dare una patina di illegittimità e pericolosità a determinate tesi, per bloccarne la discussione sul nascere. Noi riteniamo, invece, che quello che viene additato come populismo sia innanzitutto una reazione alle difficoltà: una reazione legittima ad un disagio reale.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Cacciari a caccia... di farfalle
Cacciari a caccia... di farfalle
di Leonardo Mazzei
Su l'Espresso del 4 gennaio Massimo Cacciari lancia l'allarme: il collasso della democrazia rappresentativa, cui si assiste in tutto l'occidente, potrebbe rivelarsi inarrestabile.
Il filosofo, ed ex sindaco di Venezia, parte ovviamente dalle travagliate vicende della Legge di bilancio, ma non si ferma ad esse. Attacca il governo e l'odiato populismo, ma riconosce che il problema della crisi della democrazia viene da più lontano.
Al netto della polemica politica contingente l'articolo di Cacciari contiene tre verità (di cui una solo mezza), una confessione (sia pure solo implicita) e due decisive omissioni. Il testo, breve ma denso, è la migliore dimostrazione della crisi esistenziale del pensiero delle èlite. Anche di quella parte che sa guardare più lontano.
Partiamo dalle verità.
La prima verità è che «Il processo surrettizio di svuotamento del parlamento a favore dell’esecutivo è in atto anche da prima di Tangentopoli». Vero, ma sarebbe stato giusto segnalare la cesura rappresentata dal passaggio alla Seconda Repubblica, con le sue leggi maggioritarie ed il costante rafforzamento degli esecutivi. Ma Cacciari non può arrivare a tanto. Segnalando che la crisi della democrazia è un processo di lungo periodo egli, a differenza del pensiero mainstream, ne ammette comunque la profondità sistemica.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Le Gilets Jaunes: “precarizzate, discriminate, ribellate!”
Le Gilets Jaunes: “precarizzate, discriminate, ribellate!”
di Giacomo Marchetti
Le mobilitazioni di sabato 5 e quelle di domenica 6 gennaio hanno dimostrato l’inalterata vitalità del movimento iniziato il 17 novembre, che sta giungendo ad un significativo “giro di boa” mentre entra nel terzo mese della mobilitazione.
Prima della marea gialla, solo due movimenti avevano avuto questa capacità di tenuta temporale, nella Francia contemporanea – escludendo l’esperienza della lotta di liberazione contro gli occupanti nazisti e il regime collaborazionista retto dal Maresciallo Petain – e si tratta delle mobilitazioni durante il “Fronte Popolare” nel 1936 e del più vicino Maggio 1968.
Le mobilitazioni di sabato per l’atto VIII hanno interessato la capitale, gli epicentri regionali delle mobilitazioni in questi mesi ed anche i centri minori. Le immagini, i video ed i reportages prodotti dai partecipanti, dalle testate informative locali e dai media indipendenti danno l’idea di una volontà di riscatto che non è indietreggiata di fronte al progressivo indurimento di un dispositivo repressivo che coniuga la violenza poliziesca e provvedimenti giudiziari.
Dall’inizio della protesta ben 5.339 persone sono state poste in “guarde à vue”!
Domenica le manifestazioni delle donne Gilets Jaunes hanno dato la giusta rappresentazione al protagonismo femminile che ha caratterizzato la mobilitazione sin dal suo nascere, facendo emergere la specificità della condizione femminile all’interno delle classi subalterne.
Leggi tutto
Marco Bersani: Quando la banca chiama
Quando la banca chiama
di Marco Bersani
Dopo aver gridato che i governi precedenti “erano al soldo delle banche”, con la pessima vicenda della Cassa di Risparmio di Genova, anche per il governo del “cambiamento” un altro nodo è venuto al pettine: è arrivato il momento di soccorrere con i soldi di tutti un istituto privato messo in ginocchio da un disegno criminale che serviva solo ad arricchire i vertici dell’istituto ligure. Naturalmente, l’Unione europea non ha nulla da obiettare. Come rileva la rivista Valori, dal 2008 al 2016 l’Ue ha stanziato 1400 miliardi di euro per ri-capitalizzare o coprire le perdite delle banche in crisi, una cifra equivalente a quella con cui finanzia per 10 anni tutti i suoi programmi comunitari che potrebbe essere usata in ben altri modi. Per esempio per garantire 1000 euro al mese per un anno a tutti i cittadini europei a rischio povertà (117,5 milioni di persone)
La “prima volta” è arrivata anche per il governo del cambiamento. Al termine di un Consiglio dei Ministri convocato con urgenza lunedì scorso, la maggioranza gialloverde, a dispetto di tutti i proclami contro i governi precedenti, giudicati “al soldo delle banche”, ha approvato il suo primo decreto salva-banche.
Questa volta riguarda la Cassa di Risparmio di Genova (Carige), le cui difficoltà finanziarie sono facilmente riassumibili, scorrendo le motivazioni della sentenza con cui il Tribunale di Genova ha condannato l’ex Presidente Berneschi e il suo braccio destro Ferdinando Menconi, ex capo del settore assicurativo, rispettivamente a 8 e 7 anni di reclusione.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 1994
Hits 1916
Hits 1854
Hits 1814
Hits 1807
Hits 1803
Hits 1799
Hits 1769
tonino

Fabrizio Antenucci: Protezionismo e delocalizzazioni: perché la politica di Trump è sbagliata
Protezionismo e delocalizzazioni: perché la politica di Trump è sbagliata
di Fabrizio Antenucci
I dazi introdotti da Trump non contrastano le delocalizzazioni perché non colpiscono le imprese con residenza fiscale negli USA. Sarebbe meglio agire su un altro aspetto: controlli dei movimenti di capitale
 Da quando
Trump si è insediato alla Casa Bianca, il protezionismo è tornato ad essere
un
argomento di estrema attualità. Fin dall’inizio della sua
campagna elettorale, il nuovo presidente degli Stati Uniti si
è rivolto
ai lavoratori della manifattura promettendo di recuperare
posti di lavoro nel territorio nazionale, affermando che ogni
decisione riguardante
commercio, tasse, immigrazione, e affari esteri sarebbe stata
“presa a vantaggio dei lavoratori americani e delle famiglie
americane”.
Stando alle sue intenzioni, le misure protezionistiche
avrebbero dovuto da un lato disincentivare le aziende a
delocalizzare la produzione, e
dall’altro ad imporre barriere al commercio internazionale.
Cosa è successo dall’inizio del suo mandato?
Da quando
Trump si è insediato alla Casa Bianca, il protezionismo è tornato ad essere
un
argomento di estrema attualità. Fin dall’inizio della sua
campagna elettorale, il nuovo presidente degli Stati Uniti si
è rivolto
ai lavoratori della manifattura promettendo di recuperare
posti di lavoro nel territorio nazionale, affermando che ogni
decisione riguardante
commercio, tasse, immigrazione, e affari esteri sarebbe stata
“presa a vantaggio dei lavoratori americani e delle famiglie
americane”.
Stando alle sue intenzioni, le misure protezionistiche
avrebbero dovuto da un lato disincentivare le aziende a
delocalizzare la produzione, e
dall’altro ad imporre barriere al commercio internazionale.
Cosa è successo dall’inizio del suo mandato?
Le misure commerciali prese dalla nuova amministrazione vedono coinvolte soltanto indirettamente la Cina e l’Unione Europea: si tratta di dazi imposti su alcune categorie di beni, senza alcun riferimento a specifici paesi. Tali misure, che rivelano preoccupazione per una eccessiva sofferenza dell’economia statunitense nella competizione internazionale, non sono affatto una novità. D’altronde, il saldo delle partite correnti risulta perennemente in negativo dall’amministrazione Reagan. È opinione diffusa, a tal riguardo, che un saldo commerciale negativo rifletta un peggioramento dello stato di salute delle imprese, contribuendo inoltre alla perdita di posti di lavoro. In effetti, a partire dalla fine degli anni ’70, il settore manifatturiero statunitense ha registrato una forte contrazione occupazionale, coinciso di fatto con il peggioramento del saldo delle partite correnti (Borjas et al., 1992). Si tratta di fenomeni entrambi verificati in concomitanza di un progressivo processo di apertura al commercio estero avviato con la ratifica di diversi accordi internazionali tra cui il GATT (Tokyo Round 1973-79, Uruguay Round 1986-1994) e il NAFTA (1994), fino alla costituzione della World Trade Organization (WTO) nel 1995.
Leggi tutto
coniarerivolta: L’euro non è un errore di calcolo
L’euro non è un errore di calcolo
di coniarerivolta
 Lo scorso 1° gennaio
l’euro ha compiuto i suoi primi venti anni di vita. Dovremmo
ormai
aver maturato la giusta consapevolezza su come giudicare
l’attuale progetto di integrazione europea, culminato
nell’unione monetaria del
1999: oltre alle venti candeline, l’Unione
Europea ha spento qualsiasi possibilità di attuazione di
politiche emancipatorie per le
classi meno abbienti e ha contribuito in maniera decisiva alla
depoliticizzazione delle decisioni di politica economica,
ormai dipinte quasi
esclusivamente come scelte tecniche. Una cosa, tuttavia, non è
riuscita ancora a spegnere a distanza di due decenni: anche in
sedi apparentemente
più illustri del bar sotto casa, qualcuno si chiede
ancora perché la parità dell’euro sia stata fissata a 1936.27
lire,
asserendo contestualmente che la situazione di arretratezza
economica e sociale in cui versano da anni i paesi periferici,
Italia in primis,
sia stata in gran parte generata da un cambio ‘sbagliato’.
Lo scorso 1° gennaio
l’euro ha compiuto i suoi primi venti anni di vita. Dovremmo
ormai
aver maturato la giusta consapevolezza su come giudicare
l’attuale progetto di integrazione europea, culminato
nell’unione monetaria del
1999: oltre alle venti candeline, l’Unione
Europea ha spento qualsiasi possibilità di attuazione di
politiche emancipatorie per le
classi meno abbienti e ha contribuito in maniera decisiva alla
depoliticizzazione delle decisioni di politica economica,
ormai dipinte quasi
esclusivamente come scelte tecniche. Una cosa, tuttavia, non è
riuscita ancora a spegnere a distanza di due decenni: anche in
sedi apparentemente
più illustri del bar sotto casa, qualcuno si chiede
ancora perché la parità dell’euro sia stata fissata a 1936.27
lire,
asserendo contestualmente che la situazione di arretratezza
economica e sociale in cui versano da anni i paesi periferici,
Italia in primis,
sia stata in gran parte generata da un cambio ‘sbagliato’.
Semplificando, il tasso di cambio ci indica quante unità della nostra moneta occorrono per acquistare una unità della moneta di un altro Paese. Perché ci occorre acquistare valuta estera? Ad esempio, se avessimo intenzione di acquistare un telefonino da un produttore americano, questo vorrà essere pagato in dollari statunitensi (che potrà ad esempio usare per andare a cena in un ristorante di New York, dove difficilmente saranno accettati euro), e pertanto avremo la necessità di ‘cambiare’ i nostri euro in dollari: di fatto, staremmo cedendo euro in cambio di dollari ad un dato tasso di cambio. Nell’ipotesi che un telefonino sia venduto a 800 dollari, dovremmo pertanto disporre dell’equivalente in euro di quegli 800 dollari, cambiarli da un intermediario (ad esempio, una banca) al tasso di cambio corrente, e una volta ottenuti i dollari (anche se questo passaggio non lo vediamo materialmente, avviene nei terminali degli intermediari) effettuare l’acquisto del telefonino.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: Dove sbaglia la “sinistra sovranista”
Dove sbaglia la “sinistra sovranista”
di Fabrizio Marchi
 Ho letto questo
articolo di Carlo Formenti https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14088-carlo-formenti-l-ideologia-antistatalista-e-l-autodistruzione-delle-sinistre.html
che è in buona parte condivisibile.
Ho letto questo
articolo di Carlo Formenti https://www.sinistrainrete.info/articoli-brevi/14088-carlo-formenti-l-ideologia-antistatalista-e-l-autodistruzione-delle-sinistre.html
che è in buona parte condivisibile.
Tuttavia mi pare che nella sua posizione così come in quelle dei vari esponenti della neonata “sinistra sovranista” ci sia un eccesso di enfasi nei confronti dei concetti di nazione e di patria. Non è un caso che l’autore concluda l’articolo con una citazione del subcomandante Marcos che difende lo stato nazionale contro il tentativo di distruggerlo da parte del grande capitalismo transnazionale.
Ma è soltanto l’ultima in ordine di apparizione. Fino ad ora il più gettonato negli ambienti della suddetta sinistra sovranista è stato sicuramente Palmiro Togliatti, storico leader del PCI che – pur essendo “cosa” completamente altra rispetto a Marcos per cultura, formazione politica e contesto storico-politico – sosteneva la necessità di difendere e rafforzare lo stato nazionale che in Italia – è bene ricordarlo – scaturiva dalla guerra di liberazione contro il nazifascismo ed era il risultato di una gigantesca mediazione tra forze politiche nazionali e internazionali assai diverse che portò al “varo” della Costituzione Italiana.
Ora, la funzione delle citazioni è quella di individuare quei precedenti storici (autorevoli…) con i quali rafforzare e “giustificare” le proprie posizioni, specie quando queste sono tacciate dagli avversari di essere pericolose, ambigue o addirittura reazionarie. A mio parere è un atteggiamento di debolezza e non di forza, perché se si è veramente convinti delle proprie opinioni non c’è necessità di ricorrere ai suddetti “precedenti”, anche perché la storia e la politica non funzionano come la giurisprudenza e ciò che poteva essere valido per il passato potrebbe non esserlo più per l’oggi. Ma non è questo il punto che volevo ora trattare (e mi interessa anche poco).
Leggi tutto
Michele Castaldo: Una macabra danza di disperati per esorcizzare la paura
![]()
Una macabra danza di disperati per esorcizzare la paura
di Michele Castaldo
«Eccolo! Finalmente lo abbiamo preso il criminale comunista! In carcere a scontare l’ergastolo! Cesare Battisti, il simbolo del terrorismo italiano durante gli anni di piombo è stato consegnato alle nostre autorità. Giustizia è fatta!».
Diciamoci la verità: una classe sociale che si accanisce intorno a un fantasma del passato mostra di non avere futuro, cerca di consumare le ultime risorse respiratorie per esorcizzare la paura, quella paura che nasce dalle profondità di una crisi di un sistema sociale che è durato anche troppo e che ha camminato sui morti, sulle stragi quotidiane per estorcere plusvalore e accelerare continuamente l’accumulazione e lo sviluppo capitalistico.
L’individuo è nulla di fronte ai processi storici e tutti noi degli anni ’70 del secolo passato – comunque schierati a sinistra - fummo nulla di fronte all’illusione che stessimo a un passo dal comunismo. Fummo travolti dalla passione di stare dalla parte giusta, di quella della lotta degli oppressi e sfruttati. Fummo ingenui anche quando scambiammo il tifo di settori di massa nei confronti delle formazioni combattenti per disponibilità alla mobilitazione per sostenere la “loro” causa. Cesare Battisti? Uno dei tanti; solo i fatatici del proprio ombelico si esercitano nei distinguo. Pagammo tutti un prezzo, a vario titolo e in vari modi, compresi i tanti che furono comprati da un potere che si fece beffa dei nostri ideali. Sputammo addosso al traditore e al pentito, sopravvalutando così il comprato e sottovalutando il compratore.
Leggi tutto
Francesco Erspamer: Baglioni il buono e il popolo cattivo
Baglioni il buono e il popolo cattivo
di Francesco Erspamer
Si dice che la regina Maria Antonietta, quando finalmente anche a Versailles si accorsero che il popolo era davvero incazzato, si domandasse stupita perché mai, visto che non c’era pane, non mangiassero brioche. Anche suo marito, Luigi XVI, fu profondamente sorpreso dalla rivoluzione, anzi indignato dalla irriconoscenza dei francesi. Così Claudio Baglioni, il ricco, bello, famoso Baglioni, che in vita sua gli sono andate tutte bene e proprio non lo capisce che a quelle condizioni è facile essere buoni e buonisti e anche cosmopoliti: e allora siccome il popolo non è spensierato e generoso e multiculturalista come lo vorrebbe lui, invece di domandarsi quali siano le responsabilità sue e della casta che ha dominato per trent’anni (magari ha sbagliato a imporre le privatizzazioni e la globalizzazione? a celebrare l’individualismo e la superficialità? a promuovere un consumismo compulsivo, il culto del successo e delle celebrity, la deregulation morale e culturale?), invece insomma di fare autocritica o (più in linea con il personaggio) un esame di coscienza, si amareggia e accusa il paese di essere (testuale, Corriere della Sera, 9 gennaio 2019) “disarmonico, confuso, cieco”, peggio, “incattivito e rancoroso”. Chi non è d’accordo, insomma, non solo è fascista e razzista: è proprio cattivo.
Leggi tutto
Riccardo Paccosi: Il Caso Battisti e l’approccio semi-colto agli Anni di Piombo
Il Caso Battisti e l’approccio semi-colto agli Anni di Piombo
Un processo in atto di obliterazione della memoria storica
di Riccardo Paccosi
Tempo fa, avevo scritto che non avrei parlato in rete del caso di Cesare Battisti. Mi sono però un po’ rotto le scatole, in queste ore, di leggere i tanti commenti acriticamente entusiasti per il recente arresto e, quindi, infrango il voto di silenzio.
Il dibattito sugli Anni di Piombo, oggi, trovo sia regredito enormemente rispetto a vent’anni fa. Se un programma come “La Notte della Repubblica” di Sergio Zavoli uscisse ora, finirebbe sotto il tiro d’un fuoco incrociato perché in esso vengono intervistati e fatti parlare i brigatisti. In realtà, nel momento in cui poneva loro domande, Zavoli non era per niente tenero verso questi ultimi: da giornalista, però, egli si rendeva conto che suddette interviste fornivano elementi in più per capire come e perché, in quella fase storica, centinaia di persone avessero scelto la strada delle armi e, soprattutto, come e perché centinaia di migliaia di altre persone simpatizzassero per loro.
E infatti è proprio la valenza sociale del fenomeno della lotta armata che, oggi, si vuole consegnare all’oblio della memoria. La stragrande maggioranza delle persone, fondalmentalmente, non sa o non ricorda nulla di quella fase. Di seguito, descrivo alcuni elementi dell’obliterazione mnemonica in atto:
Leggi tutto
Christian Marazzi: Vizi monetari
Vizi monetari
di Christian Marazzi
Uno fra i tanti fattori d’incertezza che accompagnerà l’evoluzione delle principali economie (Svizzera compresa) nel corso di questo nuovo anno è costituito dalle politiche monetarie delle Banche centrali. Dopo anni di politiche monetarie ultra-espansive volte a mitigare gli effetti della crisi finanziaria esplosa nel 2008, le Banche centrali hanno deciso di ritornare a politiche monetarie più normali, con tassi d’interesse più elevati e minore creazione di liquidità eccezionale da iniettare nel sistema finanziario. L’obiettivo di questa normalizzazione monetaria è quello di permettere alle Banche centrali di prepararsi ad intervenire nell’eventualità di una nuova recessione economica: infatti, se si continua imperterriti con tassi d’interesse prossimi allo zero, come si può poi ridurli nel momento in cui le economie dovessero entrare in recessione? Così, almeno, dice la teoria che sta alla base delle scelte di politica monetaria delle Banche centrali.
Ma che le cose siano un po’ più complesse della teoria (monetarista) lo dimostra il fatto che proprio nel paese in cui l’economia non rallenta, cioè gli Stati Uniti, il presidente Donald Trump teme fortemente che una politica monetaria più normale, cioè meno espansiva, come quella perseguita da qualche mese dalla Federal Reserve, finisca col penalizzare i colossi industriali americani, come ad esempio la Apple o l’industria automobilistica, minacciate dal rallentamento della crescita cinese come anche da uno sviluppo tecnologico cinese fenomenale.
Leggi tutto
Domenico Moro: Rivoluzione in occidente e vincolo europeo
Rivoluzione in occidente e vincolo europeo
Riflessioni a margine di Sovranità o barbarie di Fazi e Mitchell
di Domenico Moro
 Recentemente
è uscito in libreria Sovranità o barbarie di Thomas Fazi e
William Mitchell (Meltemi
editore, euro 20, pp. 315). Si tratta di un testo che
raccomandiamo a chi sia interessato non solo ai temi
dell’Europa, ma anche alla
ricostruzione di una sinistra adeguata alla realtà attuale. A
differenza della maggioranza dei testi sull’euro e sulla Ue,
Sovranità o barbarie non parla solo di economia o soltanto di
diritto e istituzioni europei. La riflessione che vi viene
svolta è
interdisciplinare, offrendo una articolata sintesi delle
implicazioni dell’integrazione europea, oltre che per
l’economia, per lo Stato e
le sue istituzioni, per i concetti di nazione e identità
nazionale e soprattutto per la democrazia. Di semplice
lettura, grazie a una prosa
scorrevole e molto chiara, è un testo, però, mai banale, che
guida il lettore attraverso un intreccio di questioni
complesse e
controverse, che riguardano il “che fare”. Per questo,
Sovranità o barbarie è soprattutto un libro politico, nel
senso
più ampio del termine, e va letto a più livelli, che, anche se
a volte implicitamente, investono tre questioni principali:
Recentemente
è uscito in libreria Sovranità o barbarie di Thomas Fazi e
William Mitchell (Meltemi
editore, euro 20, pp. 315). Si tratta di un testo che
raccomandiamo a chi sia interessato non solo ai temi
dell’Europa, ma anche alla
ricostruzione di una sinistra adeguata alla realtà attuale. A
differenza della maggioranza dei testi sull’euro e sulla Ue,
Sovranità o barbarie non parla solo di economia o soltanto di
diritto e istituzioni europei. La riflessione che vi viene
svolta è
interdisciplinare, offrendo una articolata sintesi delle
implicazioni dell’integrazione europea, oltre che per
l’economia, per lo Stato e
le sue istituzioni, per i concetti di nazione e identità
nazionale e soprattutto per la democrazia. Di semplice
lettura, grazie a una prosa
scorrevole e molto chiara, è un testo, però, mai banale, che
guida il lettore attraverso un intreccio di questioni
complesse e
controverse, che riguardano il “che fare”. Per questo,
Sovranità o barbarie è soprattutto un libro politico, nel
senso
più ampio del termine, e va letto a più livelli, che, anche se
a volte implicitamente, investono tre questioni principali:
-
La descrizione dei meccanismi e le implicazioni su economia e politica dell’integrazione europea, coniugate alla critica al sovra-nazionalismo legato alla mondializzazione;
-
La critica dell’atteggiamento della sinistra europea degli ultimi trenta o quaranta anni rispetto alla mondializzazione e all’integrazione europea;
-
La questione della definizione di una politica di sinistra efficace nei Paesi avanzati, ossia le specificità di quella che Gramsci chiamava la “Rivoluzione in Occidente”.
Oggettivamente, “Sovranità o barbarie”, partendo dalla questione europea, va a investire la questione più complessiva di quale sia, in Europa, la politica da adottare da parte delle classi subalterne e del lavoro salariato su un piano strategico, a fronte a una delle maggiori sconfitte storiche della sinistra.
Leggi tutto
Maria Turchetto: La scoperta del plusvalore relativo
La scoperta del plusvalore relativo
di Maria Turchetto*
Abstract: We analyze the Chapter 10 of Capital’s Volume I «The Concept of Relative Surplus-value» highlighting come important concepts: 1) the industrial and mass character of production as consequences of the relative surplus-value; 2) extra-profits and dissemination of innovations; 3) the combined operation of absolute and relative surplus-value
 1. Tra la terza e la quarta sezione
1. Tra la terza e la quarta sezione
Il cap. 10 del Libro I del Capitale definisce il concetto di «plusvalore relativo», ponendosi tra la terza sezione, dedicata a La produzione del plusvalore assoluto (capp. 5-9) e la quarta sezione, dedicata appunto a La produzione del plusvalore relativo (capp. 10-13). Queste sezioni rappresentano il cuore del Libro I, il nucleo essenziale della rivoluzione scientifica prodotta da Marx.
La terza sezione ci ha condotti «nel segreto laboratorio della produzione sulla cui soglia sta scritto No admittance except on business» (Marx 1975, 212), dove finalmente si svela l’arcano della produzione di plusvalore, rimasto inaccessibile all’analisi degli economisti classici. Com’è noto, la distinzione cruciale introdotta da Marx è quella tra forza-lavoro, oggetto di acquisto nella sfera della circolazione al suo valore di scambio, e lavoro, ossia uso della forza-lavoro nel «processo di produzione immediato». Il processo di produzione immediato, indagato cioè «allo stato puro […] facendo astrazione da tutti i fenomeni che nascondono il giuoco interno del suo meccanismo» e in particolare dal «movimento mediatore della circolazione» (Marx 1975, 694), oggetto dell’intero Libro I (cfr. Marx 1975, 7), rappresenta, come scrive Louis Althusser (2006, 21), l’«enorme svista» degli economisti classici, la zona d’ombra che impedisce loro di riconoscere lo sfruttamento capitalistico. Non si tratta, ovviamente, come Althusser (2006, 21) sottolinea con grande efficacia, di non cogliere un dato, qualcosa che «tuttavia era sotto gli occhi, […] a portata di mano». Si tratta di un più delicato problema di costruzione dell’oggetto scientifico o del campo di indagine.
Leggi tutto
Pierre Dardot e Christian Laval: Con i gilet gialli: contro la rappresentanza, per la democrazia
Con i gilet gialli: contro la rappresentanza, per la democrazia
di Pierre Dardot e Christian Laval
Abbiamo tradotto un contributo sui gilet gialli scritto dal filosofo Pierre Dardot e dal sociologo Christian Laval per il portale d’informazione indipendente francese Mediapart. Lo scritto è del 12 dicembre scorso, ma rimane di indubbia attualità politica proprio alla luce della continuità di eventi insurrezionali e dell’evoluzione organizzativa dei gilet gialli avutasi nell’ultimo mese
 Raramente nella storia un Presidente della
Repubblica è
stato così odiato come lo è oggi Emmanuel Macron. Il suo
solenne discorso televisivo del 10 dicembre e le briciole che
distribuisce con
"compassione" ai più poveri, senza invertire in alcun modo le
misure ingiuste che aveva incoraggiato o deciso - prima come
consigliere di
Hollande, poi come ministro dell'Economia e infine come
presidente - non cambieranno questo dato di fatto.
Raramente nella storia un Presidente della
Repubblica è
stato così odiato come lo è oggi Emmanuel Macron. Il suo
solenne discorso televisivo del 10 dicembre e le briciole che
distribuisce con
"compassione" ai più poveri, senza invertire in alcun modo le
misure ingiuste che aveva incoraggiato o deciso - prima come
consigliere di
Hollande, poi come ministro dell'Economia e infine come
presidente - non cambieranno questo dato di fatto.
La spiegazione di questo rifiuto massiccio è ben nota: il disprezzo di classe che ha dimostrato, sia nelle azioni che nelle parole, gli viene restituito con violenza, con tutta la forza di una popolazione arrabbiata, e non c'è nulla di più meritato. Con la sollevazione sociale dei gilet gialli, il velo si è strappato, almeno per un po'. Il "nuovo mondo" è quello vecchio in peggio: questo è il messaggio principale inviato da chi dallo scorso novembre indossa il gilet giallo.
Nel 2017, Macron e il suo partito-azienda «En marche» hanno sfruttato il profondo odio della classe operaia e della classe media nei confronti dei governanti che fino ad allora avevano solo peggiorato la loro situazione lavorativa e di vita per imporsi contro ogni aspettativa nella corsa alla presidenza. In questa scalata istituzionale, Macron non ha esitato a utilizzare cinicamente il registro populista del dégagisme e di una finta “verginità” politica per vincere, lui che non è mai stato nient’altro che il «candidato dell'oligarchia», in particolare di quella corporazione élitaria che fa capo all'ispettorato finanziario[1].
L’operazione è stata grezza, ma ha funzionato per difetto. Ha vinto, con idee minoritarie, con un doppio voto di rifiuto, al primo turno dei partiti neoliberali-autoritari (i partiti gemelli Socialista e dei Repubblicani) e al secondo turno della candidata del partito neofascista francese.
Leggi tutto
Carlo Clericetti: Blanchard: il debito pubblico non è poi così male
Blanchard: il debito pubblico non è poi così male
di Carlo Clericetti
“Scoperta dell’acqua calda” è un modo di dire per definire qualcosa di scontato, e dunque una scoperta di nessun valore. E invece può succedere a volte che ammettere l’ovvio possa avere quasi il valore di una rivoluzione: dipende da chi sia il protagonista e da quale sia il contesto in cui questo avviene.
Nel nostro caso il protagonista è di assoluto rilievo. Si tratta di Olivier Blanchard, ex capo economista del Fondo monetario e soprattutto autore di quello che è forse il più diffuso manuale di macroeconomia, su cui si formano migliaia di studenti. L’impostazione è quella mainstream, ossia della teoria dominante nell’ultimo mezzo secolo (quella neoclassica) in base alla quale vengono dunque formati i futuri economisti. Tanto che in Italia un altro economista, Emiliano Brancaccio, che fa parte della minoranza critica con questa impostazione, ha scritto una sorta di contro-manuale (l’”Anti-Blanchard”), invitando i docenti ad affiancarlo all’altro in modo da offrire agli studenti anche una interpretazione alternativa di una serie di punti chiave.
Blanchard ha una grande qualità, purtroppo piuttosto rara tra gli economisti: non è dogmatico. Di fronte alle “prove della realtà”, cioè ai risultati dell’applicazione della teoria alla politica economica, è capace di prendere atto e di ammettere: “Ho sbagliato”.
Leggi tutto
Franco Russo: Cosa sono e contro chi sono diretti i Trattati Europei?
Cosa sono e contro chi sono diretti i Trattati Europei?
di Franco Russo
Una scheda riassuntiva elaborata da Franco Russo ricostruisce la natura e gli obiettivi dei Trattati europei dei quali chiediamo la denuncia attraverso un referendum di indirizzo costituzionale
1. La costruzione dell’Unione Europea è stata pensata e realizzata dalle classi dirigenti, dalle élite politiche, economiche e finanziarie per dar vita a un mercato unico sovranazionale, perché uno spazio economico continentale avrebbe favorito lo sviluppo delle imprese capitalistiche e avrebbe costituito una sistema politico capace di competere con gli altri grandi potenze. L’Unione Europea stata costruita per fondare e gestire il mercato capitalistico e per contrastare, soprattutto dopo il 1971 quando Nixon decise l’inconvertibilità del dollaro in oro, l’egemonismo degli USA
2. Le classi dirigenti non hanno mai sottoposto il disegno dell’Unione Europea al voto dei cittadini dei 28 paesi che la costituiscono, e quando in alcuni paesi il Trattato costituzionale è stato sottoposto a referendum, come in Francia e in Olanda nel 2005, i cittadini l’hanno bocciato, e i governi hanno siglato un altro Trattato, quello di Lisbona che regola attualmente il funzionamento dell’Unione Europea.
3. A decidere i Trattati sono gli Stati e i governi. Anche il Trattato internazionale di Lisbona vede gli Stati come le ‘alte parti contraenti’, che hanno avuto come unico obbligo di sottoporlo ai Parlamenti per la ratifica: impossibile per i Parlamenti modificare quello che 28 governi hanno deciso, e quando i governi sono stati costretti a modificarlo sono stati sempre i governi a trattare e a decidere. I Trattati internazionali sono uno dei residui delle prerogative regali che i governi degli Stati si sono riservati.
Leggi tutto
Nicoletta Forcheri: Quando scrivono “Scienza” con la “S” maiuscola
Quando scrivono “Scienza” con la “S” maiuscola
di Nicoletta Forcheri
In un contesto sempre più manipolatorio di massa e pieno di sofismi, Grillo oggi ha firmato Il Patto trasversale per la scienza, lanciato dal famoso professor pro-vax Burioni.
Nel Patto, tra gli 8 punti condivisibili, persino tautologici o ridondanti, che ricordano la necessità di qualsiasi forza politica di sostenere la scienza, spuntano gli indizi del vero intento del testo, nascosto dietro la retorica lapalissiana:
- la parola “Scienza” è scritta con la S maiuscola, quasi ad indicare un nome proprio, e non un metodo, dietro cui si nasconde una univocità che MAI ha caratterizzato la vera scienza: chi dice univocità infatti dice dogma, mentre la scienza da sempre avanza per dubbi, tentativi, ipotesi, sperimenti, interpretazioni e verifiche. Perché, se la Scienza ha l’univocità della religione dogmatica, chi è che ne decide i testi sacri e i dogmi? Chi è che li predica e li interpreta? Chi è che decide infine l’inquisizione e la “penitenza” e o “l’esclusione” dei vari “eretici”, che sempre più dottori/ricercatori subiscono?
Leggi tutto
Ascanio Bernardeschi: Una flat-tax per dividere i lavoratori
Una flat-tax per dividere i lavoratori
di Ascanio Bernardeschi
La flat-tax, oltre a penalizzare i redditi più bassi, divide il mondo del lavoro e produce più rapporti di lavoro fasulli e più precarietà
La proposta di introdurre una flat-tax (tassa piatta) al posto di un’imposizione progressiva venne lanciata dall’economista Milton Friedman a metà degli anni 50 del secolo scorso. Secondo la sua teoria, se si alleggerisse la pressione fiscale sulle classi benestanti, queste ultime avrebbero impiegato i risparmi di imposte in investimenti produttivi, permettendo un più rapido sviluppo del sistema economico. Le sue politiche liberiste in realtà non erano appropriate alla fase post-bellica di grande sviluppo del capitalismo e di ingenti investimenti nella ricostruzione. Saranno invece applicate qualche decennio dopo, per arginare la caduta dei profitti, nel Cile di Pinochet, nell’Inghilterra della Thatcher e negli Stati Uniti di Reagan. Più recentemente sono state applicate nei paesi dell’Est europeo, che hanno riconquistato la “libertà” di fare profitti, e conseguentemente adottato la flat-tax. In realtà, in presenza di profitti calanti, i risparmi di imposta delle classi agiate se ne vanno per lo più a cercare ritorni nella speculazione finanziaria, che infatti negli ultimi decenni è gonfiata fino allo scoppio della bolla del 2007.
Friedman era liberista sì, ma non al punto di non avere il pudore di raccomandare una “no tax area”, cioè un’esenzione dall’imposta diretta sul reddito, per i più poveri. Altri tempi.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2017
Hits 1945
Hits 1912
Hits 1837
Hits 1831
Hits 1808
Luca Michelini: Sovranismo e nazionalismo
Hits 1633
Carlo Galli: La crisi dell’Europa e la sinistra che non c’è
Hits 1594
tonino

Carla Filosa: Tempo di lavoro e salario
Tempo di lavoro e salario
di Carla Filosa*
Abstract: The aim of this article is to clarify the meaning of «wage» and «labour-power» concepts, according to Marxian analysis. The feature of the labour-process as human action aimed at the production of use-values is first highlighted. It is the everlasting nature-imposed condition of human existence. Indeed, the process of creating surplus value is nothing but the continuation of the boundless producing value process. Thus, the prolongation of the working-day beyonds the limits of the natural day – encroaching on all life’s time – has mainly the purpose of realizing increasing surplus value in the labour-power consumpition (i.e. during the commodities production). The “mistery” of poverty – nowadays contended as an enemy – is principally due to a generally known law that the longer the working days the lower the wages are. Indeed, the reproduction of labour-power mass as over-population is the mandatory outcome of the capitalist accumulation general law. Current migration flows show that the existence of huge quantity of (unemployed) human being is a precious disposable reserve army, independently than the limits of the actual increase of population, as a mass of human material always available to be exploited. This paper will deeply discuss about these issues, remarking also the existing differences between wage and (basic) income as well as the different typologies of wage (material, real, relative and nominal). Finally, the strict connection between wage, labour-power value and surplus value, will be validated
 1. Forza-lavoro al tempo del salario
1. Forza-lavoro al tempo del salario
Il concetto di «salario» è stato deliberatamente rimosso attraverso la stessa rarefazione del termine. Molti giovani del III millennio non ne hanno mai sentito parlare, e ricevono, per loro semplicemente, «denaro» – ovvero una «paga» (wage) – in cambio di lavoro, meglio “lavoretto” o “job” (posto di lavoro, incarico, compito) normalizzato, anche senza neppure un contratto, senza mansionario o orario, senza assunzione, senza neppure percepire, né sospettare di dover conoscere, quanto altro tempo di vita viene loro richiesto per ottenere quel compenso magari nemmeno pattuito, ma solo forzosamente accettato. Altri, giovani e non, sono costretti a erogare lavoro gratuito nella speranza di ottenerne uno retribuito in una prospettiva non definibile, ma ignorano di costituire, in diverse fasi, quella quota oscillante dell’«esercito di riserva» di cui Marx analizzò, già quasi due secoli fa, la necessità vitale per il sistema di capitale.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Francia: Atto IX, ovvero l’attualità della rivoluzione
Francia: Atto IX, ovvero l’attualità della rivoluzione
di Giacomo Marchetti
La settimana che ha preceduto l’Atto IX della mobilitazione dei GJ è stata caratterizzata da un notevole innalzamento dei toni da parte dell’entourage macroniano
 Ad aprire le danze era stato lunedì sera, su
TF1, il ministro
Edouard Philippe, che aveva annunciato l’introduzione di
nuove misure legislative di stampo repressivo contro il
diritto a manifestare,
ribattezzate “leggi anti-casseurs”.
Ad aprire le danze era stato lunedì sera, su
TF1, il ministro
Edouard Philippe, che aveva annunciato l’introduzione di
nuove misure legislative di stampo repressivo contro il
diritto a manifestare,
ribattezzate “leggi anti-casseurs”.
Oltre a questa era stata assicurata una “ultra-fermezza” contro l’“ultra-violenza dei manifestanti”, attuando tra l’altro per l’Atto IX il dispiegamento di 80.000 agenti in tutto l’Esagono.
Per ciò che concerne i provvedimenti legislativi, si tratta di un pacchetto di misure come la possibilità di sanzionare chi non rispetta l’ “obbligo” di comunicazione di una manifestazione in Prefettura, di trasformare l’occultamento del viso in reato penale, di introdurre la “responsabilità civile dei casseurs” rispetto agli eventuali danneggiamenti che si verificano in una manifestazione e, da ultimo, l’istituzione di un database di manifestanti a cui verrebbe interdetta la partecipazione alle manifestazioni sul modello – come detto espressamente dal ministro – della diffida per gli eventi sportivi. Tutte cose che in Italia conosciamo bene, ma che messe in campo in Francia danno la misura della trasformazione della “democrazia” in qualcosa di molto meno apprezzabile…
Un progetto di legge depositato dal capo-gruppo dei LR, Bruno Retailleu, discusso lo scorso autunno al Senato, servirebbe da base per questa ennesima stretta repressiva, e verrebbe discusso all’Assemblea Nazionale ai primi di febbraio.
Sui provvedimenti annunciati si è aperta una ampia discussione d’opinione tra esperti di diritto rispetto ai punti di criticità che solleva, soprattutto in merito alla lesione di un diritto fondamentale e dell’accesso allo spazio pubblico – cosa ben diversa dalla possibilità di assistere, a pagamento, ad un avvenimento sportivo in un impianto chiuso – per cui la già più che discutibile tecnica della “diffida” (daspo, in Italia) non potrebbe essere “traslata” sul piano dei diritti politici tout court.
Leggi tutto
Eros Barone: Vicoli ciechi e cambiamenti storici
![]()
Vicoli ciechi e cambiamenti storici
di Eros Barone
 La grande
verità della nostra epoca (conoscerla non è ancora tutto,
ma senza conoscerla non potrà mai trovarsi nessun’altra
verità di una qualche importanza) è che il nostro
continente sprofonda nella barbarie poiché i rapporti di
proprietà sono
vincolati con la violenza ai mezzi di produzione.
La grande
verità della nostra epoca (conoscerla non è ancora tutto,
ma senza conoscerla non potrà mai trovarsi nessun’altra
verità di una qualche importanza) è che il nostro
continente sprofonda nella barbarie poiché i rapporti di
proprietà sono
vincolati con la violenza ai mezzi di produzione.
Bertolt Brecht
1. Un governo reazionario senza opposizione
Come ho avuto modo di rilevare in un articolo precedente,1 a mano a mano che la crisi politica della borghesia italiana si va intrecciando con il destino dell’attuale governo, acquista una crescente plausibilità, come criterio interpretativo, la nozione gramsciana di crisi organica delle classi dominanti italiane.2 Dal punto di vista oggettivo, il destino del governo Salvini-Di Maio è, peraltro, inestricabilmente connesso con gli irrisolti problemi economici del paese e con le principali questioni della nostra società (quella operaia, quella meridionale, quella industriale, quella scolastica, quella vaticana ecc.). Questioni che una coalizione divisa su tutto, tranne che sulla necessità di aggredire i migranti e gli operai in lotta, non potrà mai né impostare né tanto meno risolvere.
Ma va anche detto che il governo non ha un’opposizione che lo contrasti o lo condizioni in qualche modo, data l’irrilevanza politica di Leu e il disfacimento progressivo del Pd. Così, dopo aver abborracciato una finanziaria clientelare e averla imposta al parlamento senza alcun dibattito per via della ‘trattativa a perdere’ sul livello del deficit condotta con i burocrati della Commissione Europea, non senza un notevole scialo di sorrisi emorroidari a uso e consumo del pubblico dei ‘mass media’, dal presidente del consiglio, Conte, e dal ministro dell’economia e delle finanze, Tria, l’esecutivo adesso arranca, lacerato da divergenze profonde ma non insanabili, stante l’inconsistenza dell’opposizione nel parlamento e il vasto consenso di cui esso gode nel paese.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Il trattato di Aquisgrana
Il trattato di Aquisgrana
di Pierluigi Fagan
Il prossimo 22, Merkel e Macron, firmeranno il trattato di Aquisgrana che aggiorna e rilancia l’asse stabilito con il trattato dell’Eliseo del 1963, a suo tempo firmato da De Gaulle ed Adenauer, già riconfermato e rinforzato dall’accordo Mitterand e Kohl del 1988 da cui l'UE e l'euro.
Questa sottile linea rossa nel tempo, verrà intersecata dalla sottile linea rossa dello spazio. Aquisgrana, infatti, è città di confine tra i due Paesi, oltre ad essere stata in passato capitale dei Merovingi, sede principale dell’inquieto Carlo Magno e sede di incoronazione di ben 37 imperatori del Sacro Romano Impero. In realtà, Aquisgrana non è proprio al confine con la Francia ma perfettamente incastonata alla giunzione tra Belgio, Olanda e Germania, poco sopra il Lussemburgo e a 40 km da Maastricht. Siamo dunque nel cuore del cuore del motore storico dei tentativi di superare lo stato-nazionalismo europeo che aveva portato al doppio conflitto bellico della prima metà del Novecento. Quella CECA (1951) promossa da belgi, olandesi, lussemburghesi che, terrorizzati di trovarsi in mezzo ai due giganti che si erano fatti ben sette guerre nel precedente secolo e mezzo, convinsero i francesi a tender la mano ai rivali germanici stremati e paralizzati dal peso della tremenda e mefistofelica eredità prussiano-nazista. L’Italia di De Gasperi venne invitata ad aggiungersi per ragioni cosmetiche, come far sembrare continentale un processo che riguardava specificatamente solo questa problematica parte dello spazio geo-storico che si chiama Europa.
Leggi tutto
Vincenzo Maddaloni: Nell’Italia dei vaccini di povertà si muore
Nell’Italia dei vaccini di povertà si muore
di Vincenzo Maddaloni
Basta con questo Roberto Burioni che getta nel panico le famiglie evocando le pestilenze, con il mainstream che gli dedica sempre grande spazio. Fateci caso, da qualche tempo a questa parte si rispolvera il Burioni, ogniqualvolta il governo gialloverde è in sofferenza. Funziona.
Infatti, è storia recente il chiasso mediatico intorno la svolta pro vax di Grillo che sottoscrive il «Patto per la scienza» a sostegno dell’impiego dei vaccini: un’adesione che viene considerata una svolta per il M5S, il quale in passato era su posizioni dubbie soprattutto sull’utilità dei vaccini. Quanto basta per scatenare la solita campagna mediatica strumentale e a senso unico, che non prevede nessuna forma di ascolto né di contraddittorio. Anzi ogni volta si rincara perché, “gli irriducibili non scendono a patti neppure se c’è l’obbligo. L’importante, però, è ribadire l’ utilità dei vaccini”, come va urlando l’immunologo Guido Silvestri, il promotore del cosiddetto «Patto per la scienza».
Dopotutto la disputa creata con l’ausilio mainstream non esiste, semplicemente perché non esistono dispute fra “No Vax-Sì Vax”, così come vengono dipinte. Lo scenario è nella sostanza molto diverso. Da una parte ci sono sostenitori dell’obbligatorietà da imporre ai genitori; dall’altra parte ci sono quei genitori, i quali non sono contro i vaccini, ma sono contro il “principio di obbligatorietà”.
Leggi tutto
Guido Salza: Macron dichiara guerra ai disoccupati
Macron dichiara guerra ai disoccupati
di Guido Salza
Un decreto del presidente dei ricchi imporrà violente misure di controllo contro chi riceve il sussidio di disoccupazione aumentando così la pressione sui salari
In agosto, l’Assemblea aveva approvato la ‘Legge sull’avvenire professionale’. Il 30 dicembre sulla gazzetta ufficiale è stato promulgato un decreto attuativo della stessa da parte dell’esecutivo che apporta importanti e preoccupanti modifiche al diritto di disoccupazione [1]. Mentre le piazze francesi sono ancora gremite dal movimento dei Gilets Jaunes (questo pezzo esce a poche ore dal loro nono sabato di protesta), Macron spinge sull’acceleratore per mettere in atto la sua agenda di trasformazione in senso ultraliberista della società francese.
Il decreto in questione prevede da una parte l’estensione dell’indennità di disoccupazione ai dimissionari e ad alcune categorie di piccoli lavoratori autonomi (artigiani e commercianti). Tuttavia, solo a certe condizioni, e parecchio restrittive. Per i salariati, queste prevedono oltre la disponibilità al lavoro un progetto di riconversione professionale che debba essere convincente: il richiedente dovrà identificarne gli snodi necessari e dimostrare di rispettarne la tabella di marcia concordata. Per quanto riguarda gli autonomi l’indennità è accordata solo in caso di esistenza di una sentenza di liquidazione giudiziaria, cioè a fronte di un fallimento della loro azienda. Ancora una volta, le concessioni di Macron sono lo specchietto per le allodole per pesanti contro-attacchi di classe.
Leggi tutto
Pablo Stefanoni: Il “regalo” di Evo Morales a Salvini...e al “fratello” Bolsonaro
![]()
Il “regalo” di Evo Morales a Salvini...e al “fratello” Bolsonaro
Sull’arresto e la consegna express di Cesare Battisti
di Pablo Stefanoni 1
Cominciamo dalla fine: domenica 13 gennaio, un aereo con agenti di polizia e dell’intelligence italiana è atterrato all’aeroporto di Viru Viru, a Santa Cruz de la Sierra, per prendere Cesare Battisti. L’attuale scrittore è stato un membro del gruppo armato di estrema sinistra Proletari Armati per il Comunismo (PAC) operante durante gli “anni di piombo” italiani e condannato all’ergastolo in Italia per quattro reati, due come autore materiale e due come complice. È arrivato all’aeroporto militare di Ciampino alle 11.36 di lunedì. Ad attenderlo c’era il ministro dell’Interno e leader del governo italiano Matteo Salvini, un neofascista che fa parte dell’asse xenofobo trumpiano molto spesso criticato dalla Bolivia.
Così, per la sorpresa di molti, Evo Morales ha consegnato Battisti in 24 ore, negandogli non solo la richiesta di rifugio ma, ancora di più, il diritto fondamentale a un processo di estradizione in cui il suo caso potesse essere analizzato. In questo modo, il presidente boliviano si è trovato immerso in un’operazione armata dal nuovo asse italo-brasiliano: entrambi i referenti stanno cercando di dar vita ad un’internazionale dell’estrema destra su scala globale.
Molti media hanno colto la situazione scrivendo nei loro titoli che Jair Bolsonaro sta utilizzando l’arresto dell’ex membro del gruppo armato italiano strizzando “l’occhiolino a Salvini”.
Leggi tutto
Stefano Breda: La dialettica marxiana come critica immanente dell’empiria
La dialettica marxiana come critica immanente dell’empiria
di Stefano Breda*
Abstract: The paper aims to show that a materialist understanding of the method followed by Marx in his critique of political economy requires going beyond both the traditional logical-historical interpretation of dialectics and the logical-systematic interpretation developed within the Neue Marx-Lektüre
 1. Un campo di tensione teorica
1. Un campo di tensione teorica
La questione della specificità del metodo dialettico seguito da Marx nella sua critica dell’economia politica rispetto a una dialettica idealista è stata al centro di accesi dibattiti fin dalla prima pubblicazione del primo libro del Capitale. L’inconsistenza della celebre metafora del capovolgimento attraverso la quale Marx definiva il rapporto tra il suo metodo dialettico e quello di Hegel è stata convincentemente messa in luce da Althusser (1965, 87 ss.), il quale, però, non ha fornito alcuna vera alternativa complessiva. Indicazioni più concrete si possono trovare in alcune fondamentali intuizioni di Adorno e nella loro elaborazione da parte della Neue Marx-Lektüre, la nuova lettura di Marx sviluppatasi in Germania a partire dagli anni Sessanta del secolo scorso. Se si seguono tali indicazioni, il rivoluzionamento della dialettica da parte di Marx non consiste in un capovolgimento di soggetto e predicato rispetto alla sua forma hegeliana, bensì nel riconoscimento del fatto che la dialettica tout court non è che l’espressione filosofica di quegli specifici rapporti sociali in cui soggetto e predicato si presentano oggettivamente capovolti: i rapporti capitalistici (cfr. Reichelt 1970, 81)[1]. Se dunque la dialettica, nella sua forma hegeliana, presenta un mondo capovolto, non la si rimette coi piedi per terra rovesciandola in quanto sistema di pensiero, ma svelandone l’oggettivo radicamento nei rapporti capitalistici e criticando un rovesciamento operante in tali rapporti. Da rovesciare, al più, sono allora i rapporti sociali materiali, non la dialettica: essa va piuttosto demisticizzata, de-naturalizzata, individuandone i presupposti storicamente determinati. Molto più appropriata di ogni immagine legata al capovolgimento è dunque un’immagine legata alla delimitazione: «la forma dialettica d’esposizione è corretta solo se conosce i propri limiti» (MEGA II.2, 91)[2], ovvero i punti nei quali la dialettica, da explanans, diviene essa stessa parte dell’explanandum, in quanto prodotto storico bisognoso di una spiegazione altrettanto storica.
Leggi tutto
Michele Nobile: Rosa Luxemburg
Rosa Luxemburg
Nel centesimo anniversario dell’assassinio
di Michele Nobile
 1.
1.
Rosa Luxemburg morì il 15 gennaio 1919, assassinata poco dopo Karl Liebknecht da elementi dell’esercito tedesco. Non furono gli unici a cadere in quel gennaio berlinese: la stessa sorte toccò, nei combattimenti e nelle esecuzioni sommarie, a molte decine di operai, dirigenti sindacali rivoluzionari e militanti socialisti che si erano lanciati in rivolta, reazione a una deliberata provocazione del governo che, si badi, era un governo socialdemocratico, un governo della sinistra.
Con Rosa Luxemburg scompariva la mente più lucida della teoria e della pratica rivoluzionaria nell’Europa occidentale nei primi due decenni del XX secolo, l’unica a potersi confrontare ad armi pari con Lenin e Trotsky.
A una mente brillante che nel modo migliore argomentò la ragione della rivoluzione socialista corrispondeva una passione inesauribile nel mettere al centro dell’azione dell’avanguardia politica organizzata il movimento sociale dei lavoratori, la dinamica delle loro lotte, la maturazione di una coscienza di classe rivoluzionaria attraverso l’esperienza diretta e l’auto-organizzazione della classe. Lottò perché la politica socialista fosse realmente un tutt’uno con la lotta di classe, intesa come movimento di auto-emancipazione sociale. Sostenne con coerenza ineguagliata la democrazia socialista come fine e come mezzo della lotta politica.
Le implicazioni storiche di quelle esecuzioni - e in particolare di Rosa Luxemburg - furono gravissime. Retrospettivamente portarono un colpo mortale alla direzione socialista e alla possibilità di realizzare la rivoluzione nel Paese più avanzato d’Europa. Quattordici anni dopo lo Stato capitalistico tedesco, la cui ricostruzione si ergeva sulla repressione di quel moto berlinese, si sarebbe denominato Terzo Reich.
Leggi tutto
Ashoka Mody: L’euro, un’idea insensata
L’euro, un’idea insensata
di Ashoka Mody
Intervistato da Tim Black di “Spiked”, Ashoka Mody – professore di economia a Princeton e già dirigente presso il Fondo monetario internazionale – conferma quello che gli economisti sanno, ma la stampa spesso nega: l’euro è stata fin dall’inizio una pessima idea sia economica sia politica. La rigidità intrinseca dei tassi di cambio, le folli regole fiscali, il dominio delle nazioni forti che impongono regole riservate a quelle deboli, creano i presupposti per la divergenza economica e l’inimicizia politica tra le nazioni, anziché promuovere prosperità e pace come propagandano i sostenitori del progetto europeo. Non sono quindi i populisti a essere euroscettici: sono gli euristi che vivono in una bolla di irrealtà, ignorando i più elementari ragionamenti economici e politici
 “Si è trattato di uno
sforzo un po’ solitario”, dice Ashoka Mody – professore di
economia presso l’Università di Princeton, e già
vicedirettore del dipartimento europeo del Fondo monetario
internazionale (Fmi)
– parlando di ”Eurotragedia: un dramma in nove atti”,
la sua brillante, magistrale storia della Ue e dello sviluppo
dell’eurozona.
“La gran parte dell’establishment europeo” continua Mody “o
ha tentato di ignorare o ha contestato quelli che mi
sembrano
principi e dati economici assolutamente basilari”.
“Si è trattato di uno
sforzo un po’ solitario”, dice Ashoka Mody – professore di
economia presso l’Università di Princeton, e già
vicedirettore del dipartimento europeo del Fondo monetario
internazionale (Fmi)
– parlando di ”Eurotragedia: un dramma in nove atti”,
la sua brillante, magistrale storia della Ue e dello sviluppo
dell’eurozona.
“La gran parte dell’establishment europeo” continua Mody “o
ha tentato di ignorare o ha contestato quelli che mi
sembrano
principi e dati economici assolutamente basilari”.
È facile capire perché l’establishment europeo potrebbe essere stato incoraggiato a farlo. Eurotragedia è un atto d’accusa all’intero progetto europeo postbellico, una dissezione meticolosa e abrasiva di tutto quello che è caro all’establishment europeo. Ed è anche un attacco allo stesso establishment, al pensiero di gruppo dei suoi membri, ai loro deliri, alla loro arroganza tecnocratica. Inoltre, tutto questo viene dal principale rappresentante del Fmi in Irlanda durante il suo salvataggio dopo le crisi bancaria post-2008 – una persona cioè che ha visto dall’interno i meccanismi fiscali della Ue.
Spiked ha intervistato Mody per capire meglio la sua analisi critica del progetto europeo, i difetti fatali dell’eurozona e perché l’integrazione europea sta dividendo i popoli.
* * * *
Spiked: Lei pensa che il suo lavoro su Eurotragedia sia stato solitario perché, dopo la Brexit e altri movimenti populisti, l’establishment Ue è al momento molto arroccato sulla difensiva?
Ashoka Mody: Sono sicuro che in parte la ragione è questa. Ma penso che la natura dell’intero progetto sia molto difensiva. Pensate alla dichiarazione di Robert Schuman del 9 maggio 1950, che mise le basi per la Comunità Europea del Carbone e dell’Acciaio due anni dopo – disse che una fonte comune di sviluppo economico doveva diventare il fondamento della federazione europea.
Leggi tutto
Federico Sardo: Il caso Cesare Battisti e quello che accade in Italia oggi
Il caso Cesare Battisti e quello che accade in Italia oggi
di Federico Sardo
Dopo l’arresto di Cesare Battisti si sono levate da tutte le parti parole di giubilo per la fine della latitanza di quello che, forse suo malgrado, era diventato ormai un simbolo vivente della stagione della lotta armata, pur senza averne davvero la caratura.
Battisti era infatti un membro (mai stato il capo) dei PAC, Proletari Armati per il Comunismo, una formazione tra le decine appartenenti alla lotta armata in Italia che non spiccava certo per le sue formulazioni politiche, più vicina alla delinquenza comune che ai proclami e alle teorizzazioni di altri gruppi, attiva soprattutto negli espropri proletari e nella lotta contro le istituzioni carcerarie, e diventata famosa principalmente per il numero di omicidi compiuti (cinque, un numero molto lontano dagli ottantasei delle Brigate Rosse, ma comunque sufficiente a renderla il terzo gruppo armato di quella stagione per numero di attentati).
A contribuire alla loro fama è stata anche la celeberrima foto di Giuseppe Memeo che punta la pistola contro la polizia durante gli scontri del 14 maggio 1977 in via De Amicis.
La latitanza di Cesare Battisti però non ha fatto che renderlo molto più importante di quanto non fosse mai stato, come se dovesse portare sulle spalle tutto il peso degli anni di piombo.
Leggi tutto
Potere al Popolo!: Battisti, un’arma di distrazione di massa per un governo che perde credibilità
Battisti, un’arma di distrazione di massa per un governo che perde credibilità
di Potere al Popolo!
Ma solo a noi sembra di assistere da giorni a un vero e proprio delirio mediatico e politico? Tutti i problemi del nostro paese, il poco stipendio e la precarietà, gli ospedali e i trasporti che non funzionano, tutto quello che ci interessa perché riguarda la nostra vita e i nostri bisogni, scompare di fronte all’arresto di Cesare Battisti. Battisti, di cui tantissimi sanno poco e niente, viene trasformato nel mostro che deve catalizzare l’attenzione pubblica: si fanno dirette sui TG, all’arrivo all’aeroporto si mettono i cecchini sui tetti per dare un po’ di brivido, come se chissà che dovesse succedere, mentre nel nostro paese tanti mafiosi girano a piede libero o vivono indisturbati per anni…
A noi non va di essere mossi dall’alto come dei burattini, non ci va di essere preda di un’emotività indotta. Vogliamo conservare un minimo senso critico. Ci vogliamo chiedere il perché di tutta questa enfasi mediatica, a quali scopi corrisponde? Perché forse tutto questo battage potrebbe essere l’ennesima mossa di Salvini per distogliere l’attenzione dai problemi reali, per costruire consenso a costo zero, fare egemonia culturale, riscrivere la storia a vantaggio dei più forti…
Salvini ci ha ormai abituato a questo modo becero di fare politica: urla sui social, mette in giro fake news, fa uso spregiudicato della propria posizione per creare nemici fittizi.
Leggi tutto
Giacomo Pisani: Una cassetta degli attrezzi per il postmoderno
Una cassetta degli attrezzi per il postmoderno
di Giacomo Pisani
L’avvento dei media e della comunicazione generalizzata ha segnato uno spartiacque decisivo nell’ambito della riflessione filosofica e della teoria sociale contemporanee, soprattutto a partire dalla fine degli anni ’70. Sin da subito è stato evidente il fatto che fosse in atto uno sconvolgimento radicale delle strutture ereditare dalla modernità: dalla comunicazione alle istituzioni sovrane, dalle forme di relazione ai modelli di produzione e di lavoro, nulla sembrava essere escluso da questo movimento vorticoso, tutto in divenire e quindi dagli esiti difficilmente anticipabili.
Gli atteggiamenti filosofici, rispetto a tali sconvolgimenti, hanno spesso oscillato – e in parte continuano a farlo – fra un accoglimento entusiastico dei mutamenti in atto ad un rifiuto categorico dei processi che stavano turbando l’ordine “moderno”, verso il quale molti hanno subito diretto il proprio sguardo nostalgico.
Il “postmodernismo” – etichetta in realtà assai generica e imprecisa, essendo stata utilizzata per comprendere teorie e pensatori anche molto distanti fra loro – può essere fatto rientrare, almeno nella prima fase del suo sviluppo, nella prima prospettiva. Non ci addentreremo qui, per ragioni di spazio, nell’analisi di posizioni specifiche o di alcuni autori in particolare.
Leggi tutto
Ruggero Paladini: La legge di bilancio e la carica di Balaklava
La legge di bilancio e la carica di Balaklava
di Ruggero Paladini
Della manovra si può dire quello che esclamò un generale vedendo la cavalleria all’attacco: “Non è guerra, è follia”. Con la spinta a peggiorare le cose data dalla congiuntura in ritirata e dai demenziali metodi della Commissione, l’effetto non promette nulla di buono. Per il “governo del cambiamento” questa è un’occasione persa
Si può fare una valutazione oggettiva sulla conclusione del lungo braccio di ferro tra il governo del cambiamento e la Commissione europea? Forse sì, e per farlo partirei dal testo del decreto legge sul reddito di cittadinanza e pensioni che circola in rete. L’articolo 12 fissa le somme stanziate per il triennio: 6.110 milioni nell’anno in corso, 7.755 nel 2020 e 8.017 nel 2021. Somme che tutte le stime ritengono nettamente inferiori a quelle necessarie, in base alle stesso articolato del decreto, a cominciare dai 780 euro mensili per i nuclei familiari che non abitano in una casa di proprietà.
Il comma 6 infatti stabilisce una riduzione del beneficio monetario in proporzione all’eccedenza delle domande rispetto alle somme stanziate. Lo fa in modo piuttosto criptico: l’INPS accantona delle somme, un decreto interviene nel momento in cui si arriva ad esaurimento, l’erogazione è sospesa e si da luogo ad una riduzione proporzionata.
Il senso del comma è però chiaro: il governo s’impegna a rimanere nei limiti dello stanziamento, e fornisce l’assicurazione di ciò alla Commissione.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2044
Hits 1961
Hits 1953
Hits 1863
Hits 1841
Hits 1818
Hits 1643
Hits 1602
tonino

Matteo Luca Andriola: L’Europa a destra
L’Europa a destra
Steve Bannon e The Movement: la Lega delle Leghe
di Matteo Luca Andriola
 Ai “numerosissimi
termini politici, [...] nomi di correnti politiche o
ideologiche, modi di concepire la vita
politica e termini tipici del linguaggio parlamentare” (1),
trasferiti dal lessico d’oltralpe a quello italiano dalla
Rivoluzione francese
a oggi, si è aggiunto con prepotenza quello di sovranismo,
che nel 2017 la Treccani ha definito la “posizione politica
che
propugna la difesa o la conquista della sovranità nazionale da
parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche
della
globalizzazione e in contrapposizione alle politiche
sovranazionali di concertazione” (2). Una definizione
demonizzata dall’establishment
e dalla stampa mainstream e considerata sinonimo di
neofascismo o di “stupido” nazionalismo (3), ma che, se presa
così
com’è, non denota necessariamente un’identità di destra,
specie davanti a concetti come quello di sovranità
popolare, presente anche nella Carta costituzionale
italiana, all’art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Principi che,
teoricamente, dovrebbero essere nel dna della sinistra tutta.
Ai “numerosissimi
termini politici, [...] nomi di correnti politiche o
ideologiche, modi di concepire la vita
politica e termini tipici del linguaggio parlamentare” (1),
trasferiti dal lessico d’oltralpe a quello italiano dalla
Rivoluzione francese
a oggi, si è aggiunto con prepotenza quello di sovranismo,
che nel 2017 la Treccani ha definito la “posizione politica
che
propugna la difesa o la conquista della sovranità nazionale da
parte di un popolo o di uno Stato, in antitesi alle dinamiche
della
globalizzazione e in contrapposizione alle politiche
sovranazionali di concertazione” (2). Una definizione
demonizzata dall’establishment
e dalla stampa mainstream e considerata sinonimo di
neofascismo o di “stupido” nazionalismo (3), ma che, se presa
così
com’è, non denota necessariamente un’identità di destra,
specie davanti a concetti come quello di sovranità
popolare, presente anche nella Carta costituzionale
italiana, all’art. 1: “L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata
sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la
esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
Principi che,
teoricamente, dovrebbero essere nel dna della sinistra tutta.
Il processo d’integrazione europea però, che gradualmente la sinistra progressista ha fatto proprio, interiorizzando sia la narrazione propagandistica – la pace, il progresso ecc. – sia l’impostazione economica neoliberista, ha favorito lo sviluppo di movimenti nazional-populisti di destra, lasciando la stessa sinistra spiazzata perché sprovvista di una visione alternativa a quella liberista.
Leggi tutto
Michele Nobile: La Cina, gli Stati Uniti e gli altri - III
La Cina, gli Stati Uniti e gli altri - III
Verso la guerra fredda nel Mar Cinese meridionale?
di Michele Nobile
 1.
2008-2011: cresce la tensione nel Mar cinese meridionale
1.
2008-2011: cresce la tensione nel Mar cinese meridionale
A partire dall’inizio della Grande recessione nel 2008 e dai primi mesi del 2009 la politica marittima della Rpc nella regione del Mar cinese meridionale è stata caratterizzata da un atteggiamento fortemente nazionalista, dall’intensificazione dei controlli e della repressione di attività che considera illegali nelle acque di cui rivendica la sovranità, da misure amministrative e dichiarazioni politiche considerate provocatorie dalla maggior parte dei governi della regione, da azioni coercitive e confronti fisici a rischio di degenerare in scontri armati con le Filippine e il Vietnam. Obiettivamente un insieme di fatti in contrasto con l’idea di costruire un «mondo armonioso» e con la proposta di una nuova «via della seta» marittima, che dovrebbe concretizzarsi in iniziative di «sviluppo congiunto»; insieme allo sviluppo delle capacità di interdizione d’area ciò ha generato l’idea che la Rpc punti a controllare stock e flussi del Mar cinese. La preoccupazione si è estesa a tutta l’area del Pacifico, dall’Indonesia fino all’India. I primi effetti politici si manifestarono nel 2009 e, poco dopo, nella «svolta» verso l’Asia e il Pacifico di Obama.
Ricostruendo la successione degli eventi si possono distinguere due periodi: il primo coincide con gli ultimi anni della presidenza di Hu Jintao (Segretario generale del Pcc dal 2002 al 2012 e Presidente della Rpc dal 2003 al 2013), e del primo ministro Wen Jiabao; il secondo corrisponde ai primi anni della presidenza di Xi Jinping (Segretario generale del Pcc dal novembre 2012 e Presidente della Rpc dal marzo 2013; ma già vice Presidente dal 2008) e del primo ministro Li Keqiang. Volendo essere ottimisti è possibile che nell’estate del 2018 sia iniziato un terzo periodo di conciliazione tra Rpc e Asean, dagli esiti assai incerti.
Leggi tutto
Collettivo EndNotes: La Storia della Sussunzione
La Storia della Sussunzione
di Collettivo EndNotes
 Questo è un periodo di
crisi catastrofica per il capitale, però, allo stesso tempo,
è anche un periodo in cui i vecchi progetti programmatici
della classe operaia non si vedono da nessuna parte. Questo
fatto ineludibile ci
obbliga a ricostruire quelle che sono le discontinuità fra il
passato ed il presente. Comprendere cos'è che distingue il
periodo attuale
può aiutarci a «seppellire i cadaveri»
delle rivoluzioni fallite del XX secolo, e dare così eterno
riposo agli spiriti erranti che continuano a perseguitare
ancora la teoria comunista.
Questo è un periodo di
crisi catastrofica per il capitale, però, allo stesso tempo,
è anche un periodo in cui i vecchi progetti programmatici
della classe operaia non si vedono da nessuna parte. Questo
fatto ineludibile ci
obbliga a ricostruire quelle che sono le discontinuità fra il
passato ed il presente. Comprendere cos'è che distingue il
periodo attuale
può aiutarci a «seppellire i cadaveri»
delle rivoluzioni fallite del XX secolo, e dare così eterno
riposo agli spiriti erranti che continuano a perseguitare
ancora la teoria comunista.
La posta veramente in gioco, relativa alla periodizzazione, è la questione di sapere dove finisce il passato e dove comincia il presente. L'identificazione delle rotture storiche e delle discontinuità ci aiuta ad evitare l'implicita metafisica di una teoria della lotta di classe, in cui alla fine ogni specificità storica viene ridotta all'eterno ritorno dello stesso. Tuttavia, le periodizzazioni possono apparire facilmente, non come il riconoscimento di vere e proprie interruzioni reali, ma piuttosto come se fossero l'imposizione arbitraria di uno schema astratto sulla densa trama della storia. Per ogni linea di rottura che viene tracciata, si possono individuare dei resti, o dei residui, di un'altra epoca storica che sembrano rifiutare la periodizzazione. Ragion per cui, soddisfatti in quanto simili dichiarazioni di rottura non possono assolutamente reggere, potremmo sentirci autorizzati a ripiegare sulla confortevole idea seconda la quale in realtà non cambia mai niente. Ma dal momento che consiste in questo la differenza rispetto allo scettico, ecco che è lo storico stesso a dover assumere la certezza predefinita del buon senso.
Leggi tutto
Alessandro Avvisato: Salvini e Renzi, due brutte facce per il prossimo governo
Salvini e Renzi, due brutte facce per il prossimo governo
di Alessandro Avvisato
Se uno segue la politica italiana stando dietro alle dichiarazioni dei vari “protagonisti”… non capisce mai nulla. Se invece si sta dietro ai movimenti “strutturali” – quali politiche economiche, quali interessi sono in gioco, quali i poteri più forti, ecc – qualcosa si riesce a comprendere prima che accada.
“Il governo è saldissimo! C’è grande unità di vedute!”, strillano ogni giorno Conte, Salvini e Di Maio. Ma solo l’estradizione di Cesare Battisti sembra metterli d’accordo. Sul resto è ormai chiaro che le strade di Cinque Stelle e Lega sono destinate a dividersi il giorno dopo le elezioni europee (fine maggio). Non perché possiedano visioni del mondo davvero differenti – fanno schifo tutte e due le formazioni – ma per un motivo molto più rilevante: i loro elettorati attuali e potenziali hanno interessi materiali, economici, reddituali diversi.
Non si tratta soltanto del Nord della piccola-media impresa contrapposto al “mezzogiorno assistenzialista”, ma di figure sociali che pretendono una risposta in tempi rapidi. Completamente diversa le une dalle altre. Se al Nord vogliono soldi per le imprese e svecchiare i dipendenti sostituendoli con giovani pagati la metà (“quota 100” per soli tre anni, con perdite pesanti, serve solo a questo), al Sud servono soprattutto investimenti che creino occupazione, o almeno reddito spendibile per vitare l’emigrazione di massa e il tracollo sociale.
Leggi tutto
Militant: Battisti e la cattiva coscienza di certi “sinistri”
Battisti e la cattiva coscienza di certi “sinistri”
di Militant
Se c’è qualcosa che rende più cupe queste ore, sono le reazioni di certa “sinistra” di fronte all’arresto di Battisti, e più in generale rispetto all’uso strumentale che viene fatto di questa vicenda per sciorinare giudizi sommari sull’intero ciclo di lotte degli anni Settanta.
Si va dagli strateghi del senno di poi, quelli che sanno per filo e per segno come si dovrebbe fare una rivoluzione (ma che però, chissà perché, queste informazioni importantissime se le sono sempre tenute ben strette) ai manettari di sempre, pronti ad accodarsi al giudice “progressista” di turno nemmeno fosse il pifferaio magico, fino ad arrivare ai dissociati fuori tempo massimo, a quelli a cui nessuno ha chiesto niente, ma che se non si pentono si sentono in colpa.
Lo ripetiamo ancora una volta (anche perché qualche solerte censore ci ha cancellato il post di ieri sulla nostra pagina FB): a noi del fatto che Battisti sia colpevole o meno dei reati che gli vengono imputati ci interessa poco o nulla. Abbiamo ovviamente le nostre idee al riguardo, sappiamo bene cosa abbia significato il regime emergenziale, ma non crediamo sia questo il piano su cui poggia tutta questa questione. Questo Paese, piaccia o meno, è stato scosso per oltre un decennio da una guerra civile a bassa intensità, un conflitto che ha fatto morti e feriti da una parte e dall’altra. Più dalla nostra, in verità, se proprio volessimo indulgere in questa macabra conta.
Leggi tutto
Redazione Contropiano: Potere al Popolo! Quattro punti per affrontare le elezioni europee
Potere al Popolo! Quattro punti per affrontare le elezioni europee
di Redazione Contropiano
Ieri si è chiusa la consultazione delle aderenti e degli aderenti di Potere al Popolo! in merito alla prossima tornata delle Europee. La grande maggioranza dei votanti (73%) si è espressa per partecipare alla competizione. Dunque Potere al Popolo sarà presente alle elezioni.
In merito al come partecipare, due sono state le opzioni maggiormente votate. La prima è risultata essere “Andare alle elezioni con il proprio simbolo e programma” (55%), la seconda invece “Verificare se sui contenuti sono possibili convergenze con altre forze sociali e politiche (collettivi, associazioni, movimenti, partiti)” (48%).
Nessuna delle due opzioni ha raggiunto la maggioranza necessaria del 66% per essere approvata in prima battuta. È quindi prevista una nuova consultazione sulla piattaforma online entro due settimane. Nel frattempo, per verificare la fattibilità della seconda opzione, proponiamo un confronto pubblico a tutte le forze che possono essere interessate a questi punti di merito e di metodo:
1. Crediamo che in questi anni – si pensi alla vicenda greca o alla recente umiliazione del Governo Lega/5 Stelle sulla manovra di bilancio – sia diventato evidente che l’Unione Europea, con i suoi Trattati e il suo sistema di poteri, è l’inevitabile avversario di ogni progetto di eguaglianza sociale e di controllo democratico sul mercato e sulla finanza.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: Il caso Battisti
Il caso Battisti: vincitori e vinti
di Fabrizio Marchi
La premessa è che ciascuno di noi deve assumersi la responsabilità delle proprie azioni. Battisti ha scelto di intraprendere la lotta armata contro lo stato italiano e ha ucciso alcune persone (che con lo stato c’entravano ben poco, ed è questa la sua più grave colpa, per lo meno dal mio punto di vista…). Lui nega di averle uccise ma io non posso sapere se sia sincero o meno. Fatto sta che i giudici lo hanno riconosciuto colpevole e quindi per lo stato italiano lui è l’autore di quegli omicidi. E per quello che ha commesso è giusto che lui si assuma le sue responsabilità fino in fondo e sconti la pena prevista. Sotto questo aspetto c’è ben poco da aggiungere. Non stiamo parlando di una persona perseguitata per le sue idee ma di un uomo che ha ucciso o contribuito ad uccidere altri uomini in un agguato. Battisti non può essere considerato neanche un “combattente”, un “prigioniero di guerra”, perché le azioni che lui e la sua banda ponevano in essere non erano azioni di guerra. Alcune delle BR lo sono state, al di là ora del giudizio etico, umano e politico che ciascuno di noi può avere su quell’esperienza tragica che fu la lotta armata in Italia, prodotto di uno scontro sociale e politico nazionale e internazionale ben più ampio ed esteso.
Per cui non vale e non può valere per Battisti lo “status” di combattente. Con questo non voglio neanche dire che sia un criminale comune.
Leggi tutto
Alessandro Pascale: Il caso Battisti e la guerra civile degli anni '70
Il caso Battisti e la guerra civile degli anni '70
di Alessandro Pascale
 La cattura di Cesare
Battisti riapre una pagina torbida e ancora misconosciuta
del nostro Paese,
quella degli anni ’70, definiti “gli anni di piombo”. Il
Totalitarismo liberale che ci governa ha già messo in campo
tutte le
sue armi per distogliere l’opinione pubblica dai fallimenti
dell’attuale Governo in carica e utilizzare strumentalmente
il caso per dare
la propria versione della Storia. La retorica populista si
salda strettamente con il perbenismo borghese e
democristiano su cui si è chiusa la
Prima Repubblica e costruita la Seconda. Cesare Battisti non
è che un pretesto per riattizzare l’odio verso il grande
nemico storico: il
comunismo. Poco importa che Battisti sia stato o meno
genuinamente comunista. Indifferente è il fatto che non sia
rappresentativo del marxismo,
da lui e da altri “terroristi rossi” ampiamente frainteso.
Battisti è stato elevato dalla borghesia a simbolo del
comunismo e del
peggio offerto in tal senso dalla sinistra degli anni ’70.
Mentre Parigi brucia da settimane e l’Occidente si avvia da
anni lentamente al
suo declino, l’obiettivo vero è rinfocolare l’immagine
sempre più sbiadita del fallimento di ogni alternativa al
sistema
presente. Il rimedio proposto è scontato: ravvivare
un’identità “democratica” fondata sulla legalità, sulla
pace sociale, sull’odio razziale e sull’associazione al
terrorismo per chiunque metta in discussione il regime
sociale vigente: il
capitalismo.
La cattura di Cesare
Battisti riapre una pagina torbida e ancora misconosciuta
del nostro Paese,
quella degli anni ’70, definiti “gli anni di piombo”. Il
Totalitarismo liberale che ci governa ha già messo in campo
tutte le
sue armi per distogliere l’opinione pubblica dai fallimenti
dell’attuale Governo in carica e utilizzare strumentalmente
il caso per dare
la propria versione della Storia. La retorica populista si
salda strettamente con il perbenismo borghese e
democristiano su cui si è chiusa la
Prima Repubblica e costruita la Seconda. Cesare Battisti non
è che un pretesto per riattizzare l’odio verso il grande
nemico storico: il
comunismo. Poco importa che Battisti sia stato o meno
genuinamente comunista. Indifferente è il fatto che non sia
rappresentativo del marxismo,
da lui e da altri “terroristi rossi” ampiamente frainteso.
Battisti è stato elevato dalla borghesia a simbolo del
comunismo e del
peggio offerto in tal senso dalla sinistra degli anni ’70.
Mentre Parigi brucia da settimane e l’Occidente si avvia da
anni lentamente al
suo declino, l’obiettivo vero è rinfocolare l’immagine
sempre più sbiadita del fallimento di ogni alternativa al
sistema
presente. Il rimedio proposto è scontato: ravvivare
un’identità “democratica” fondata sulla legalità, sulla
pace sociale, sull’odio razziale e sull’associazione al
terrorismo per chiunque metta in discussione il regime
sociale vigente: il
capitalismo.
Il caso Battisti diventa così un passo ulteriore per bombardare il popolo con una nuova ondata di revisionismo storico, marcando chiaramente i colpevoli dei peggiori epiteti: assassini, terroristi, violenti, comunisti, fanatici, rivoluzionari, pazzi, ecc. Al gioco delle armi di distrazioni di massa vince chi offre di più nella sagra delle semplificazioni.
I borghesi l’hanno chiamato “terrorismo rosso” perché banalmente hanno vinto loro, e hanno potuto imporre tale etichetta con la complicità dell’intero ordine “democratico”, compresi quei comunisti che avevano scelto la strada della via democratica al socialismo, illudendosi che il sistema potesse cambiare con le urne.
Leggi tutto
Il Pedante: Un patto per Paderno Dugnano
Un patto per Paderno Dugnano
di Il Pedante
 Fa scalpore in questi giorni la
firma apposta da Beppe Grillo accanto a quella dell'ex
premier Matteo Renzi
in calce a un «patto trasversale per la scienza», promosso dai
professori Guido Silvestri e Roberto Burioni. Già. Perché, in
effetti, la scienza e l'antiscienza sono un grave problema nel
nostro Paese, almeno tanto quanto lo era il traffico nella
Palermo di
Johnny Stecchino. L'iniziativa non serve insomma a nulla
e quindi, per la legge ormai nota, se non serve a nulla
serve a qualcos'altro. E
non ci vogliono grandi esegesi per capire che qui si dice la
scienza per dire le vaccinazioni, un po' come
si direbbe l'universo
per dire Paderno Dugnano. Perché oggi usa così:
per riscattarsi dalla miseria semantica la si prende
larghissima e si tirano
in mezzo gli archetipi eterni. Si scomodano i venti cosmici
per parlare di peti.
Fa scalpore in questi giorni la
firma apposta da Beppe Grillo accanto a quella dell'ex
premier Matteo Renzi
in calce a un «patto trasversale per la scienza», promosso dai
professori Guido Silvestri e Roberto Burioni. Già. Perché, in
effetti, la scienza e l'antiscienza sono un grave problema nel
nostro Paese, almeno tanto quanto lo era il traffico nella
Palermo di
Johnny Stecchino. L'iniziativa non serve insomma a nulla
e quindi, per la legge ormai nota, se non serve a nulla
serve a qualcos'altro. E
non ci vogliono grandi esegesi per capire che qui si dice la
scienza per dire le vaccinazioni, un po' come
si direbbe l'universo
per dire Paderno Dugnano. Perché oggi usa così:
per riscattarsi dalla miseria semantica la si prende
larghissima e si tirano
in mezzo gli archetipi eterni. Si scomodano i venti cosmici
per parlare di peti.
La falsa sineddoche ce la spiega Beppe quando fa un esempio di pregiudizio antiscientifico contro cui si dovrebbe lottare: quello «relativamente ad un certo vaccino o modalità di vaccinazione della popolazione». Uno a caso, naturalmente. Come deve essere un caso che tra le centinaia di migliaia di chimici, fisici, astronomi, medici, matematici, geologi, biologi, etologi, agronomi, paleontologi, filologi e altri scienziati che danno lustro al nostro Paese, il patto sia stato partorito da tale Roberto Burioni, omonimo di quel signore che lotta per «i vaccini» come si lottava nel secolo XII per la conversione dei Mori, e da Guido Silvestri, accreditato come consulente del Movimento 5 Stelle in tema di vaccinazioni e ricercatore negli USA per lo sviluppo di un vaccino anti HIV.
Leggi tutto
Antonio Bisaccia: PIL: storia di un grande seduttore, o della macchina celibe
PIL: storia di un grande seduttore, o della macchina celibe
di Antonio Bisaccia
 Io
non voglio essere un prodotto del mio ambiente,
Io
non voglio essere un prodotto del mio ambiente,
voglio che il mio
ambiente sia un mio prodotto.
Martin Scorsese, The Departed- il
bene e il male
Durante l’ondata di contestazione che ha avuto luogo in Francia tra novembre e dicembre 2018, conosciuta come «gilets jaunes», sono emerse le rivendicazioni più diverse. Un contestatore ha detto ai giornalisti: “È urgente preoccuparsi del benessere dei cittadini. Si deve parlare finalmente di potenziale interno di felicità e non del prodotto interno lordo. Ecco che cosa migliorerebbe la produttività. Oggi non si parla più di felicità, ma di remunerazione degli azionisti”.
Frase che, nella sua immediatezza, trafigge il cuore del Pil (se ne avesse uno) per gettare un’ombra immensa “sul numero più potente del mondo” e sul suo sex-appeal.
Il cosiddetto Pil, Prodotto interno lordo, è appartenuto per molto tempo al rango degli arcani che interessavano solo un piccolo gruppo di esperti, come una formula della fisica.
Da qualche tempo, invece, scalda anche gli animi di un pubblico più vasto.
A ragione, direbbe Lorenzo Fioramonti. Il culto del Pil ha prodotto secondo lui un disastro. Il suo libro -che usa criticamente una poderosa mole di letteratura tecnica- è un lungo e stimolante j’accuse sugli effetti devastanti di quello che all’inizio -negli anni Trenta- doveva essere una semplice statistica per aiutare il governo degli Stati Uniti a uscire dalla “grande depressione”. Oggi invece le pubblicazioni trimestrali delle cifre del Pil hanno preso in ostaggio tutte le economie del mondo, e dunque tutte le società: compresa, quindi, anche la vita di ogni cittadino.
In un libro sorprendentemente (vista la materia!) leggibile e stilisticamente accattivante -perché scritto con passione- l’autore ripercorre la storia del Pil e le critiche che gli sono state rivolte -in primis da colui che l’aveva inventato: un paradosso che Fioramonti sottolinea più volte.
Leggi tutto
Stefano Zecchinelli: Indipendenza dall’UE o dagli USA?
Indipendenza dall’UE o dagli USA?
di Stefano Zecchinelli
La capacità principale dei marxisti è sempre stata quella di individuare il nemico principale ovvero l’ostacolo maggiore al processo di emancipazione e liberazione dei lavoratori. Gli antimperialisti, partendo da questi presupposti, hanno il dovere di mettere in guardia dalle contraddizioni della Sinistra anti-Euro e anche di alcuni nazionalisti (progressisti) panafricani; i primi reclamano l’indipendenza soltanto dalla UE mentre i secondi pensano che l’imperialismo francese debba essere considerato il nemico principale. Entrambe le posizioni sono errate.
Che cos’ è l’UE ? E’ l’articolazione economica e politica in Europa della NATO, che è una organizzazione finalizzata e concepita per la guerra imperialista ed egemonizzata dalla borghesia nord-americana. Attraverso lo sbudellamento delle classi dominanti europee, Washington lega il ‘’vecchio’’ continente alle sue politiche di guerra. Negli stessi termini, l’imperialismo francese può sottomettere l’Africa svolgendo il ruolo di gendarme controrivoluzionario per conto dello Stato Profondo USA. Il capitalismo occidentale ruota attorno alla triade: USA, Gran Bretagna e Israele. Polemizzando con Carlo Formenti, Fabrizio Marchi inquadra il problema nel modo migliore:
‘’Forse pensiamo che il capitale abbia intenzione di dissolvere gli USA, la Gran Bretagna o Israele? Ma non scherziamo neanche. Questi tre stati (ma anche altri, ovviamente, seppur con funzioni talvolta relativamente minori) costituiscono la cabina di regia del capitalismo e dell’imperialismo mondiale e sono del tutto sovrapposti e identificati con il capitalismo stesso di cui sono lo strumento principale’’1.
Leggi tutto
Alessandra Riccio: Il pane e le rose
Il pane e le rose
di Alessandra Riccio
Volevamo, vogliamo, vorremo sempre il pane e le rose. La frase è suggestiva e sembra evocare qualcosa di semplice, a portata di mano. Un’elementare richiesta di buona vita, forse addirittura di felicità. Invece, alla prova dei fatti, volere, insieme al pane, anche le rose è una meta ambiziosissima, pretenziosa, scandalosa. E’ come l’utopia secondo Edoardo Galeano, una meta irraggiungibile, ma che ha il pregio di stimolarci a camminare, ad andare sempre avanti, mentre l’orizzonte utopico si allontana, crudele.
Così mi sembra la storia della Rivoluzione cubana, un’esperienza originale, nata nel 1959 ma incubata per cento anni, quando l’isola viveva sotto la sferza colonialista del Regno di Spagna che non voleva mollare l’ultimo gioiello della corona del suo ormai decadente impero e che aveva poi subito l’oltraggio di vedersi scippare la sovranità nazionale dalle imposizioni degli Stati Uniti d’America, intervenuti negli ultimi mesi di guerra per assicurarsi basi militari e controllo totale della vita della nuova repubblica, compreso il diritto di intervento militare sugli affari interni.
La lunga incubazione del progetto nazionale ha portato non solo alla liberazione del paese dall’ultimo tiranno Fulgencio Batista, ma all’arrivo al potere di una generazione di giovanissimi con le idee chiare e un programma di governo davvero rivoluzionario, radicato in un fortissimo consenso popolare che, per quanto eroso nei suoi sessant’anni di governo, è tuttora molto forte.
Leggi tutto
T.J. Coles: Perché una società neoliberale non può sopravvivere
Perché una società neoliberale non può sopravvivere
di T.J. Coles
Da CounterPunch, un’altra denuncia dei risultati tragici di 40 anni di neoliberalismo, l’ideologia che ha conquistato il mondo occupando capillarmente ogni ambito accademico, istituzionale e culturale: mentre anche la sinistra è stata irrimediabilmente infettata dall’ideologia del mercato, gli economisti neoliberali hanno elevato l’egoismo a ideale normativo, improntandone la legislazione con norme anti-sindacali e tagli ai servizi sociali. Con risultati drammatici: crisi economiche, aumento delle diseguaglianze, declino della partecipazione popolare alla vita pubblica, del tenore e addirittura dell’aspettativa di vita, peggioramento delle condizioni sanitarie e aumento della mortalità infantile
Gli esseri umani sono creature complicate. Siamo sia collaborativi che faziosi. Tendiamo ad essere collaborativi all’interno dei gruppi (ad esempio, i sindacati), mentre competiamo con gruppi esterni (ad esempio, una confederazione di aziende). Ma società complesse come le nostre ci costringono anche a cooperare con gruppi esterni – nei vicinati, al lavoro, e così via. Nei sistemi sociali, la selezione naturale favorisce la cooperazione. Inoltre, siamo orientati ai comportamenti etici, così la cooperazione e la condivisione sono apprezzate nelle società umane.
Ma cosa succede quando siamo costretti all’interno di un sistema economico che ci fa competere ad ogni livello? Il risultato logico è il declino o il collasso della società.
Leggi tutto
Giorgio Ferrari, Angelo Baracca: Un Patto scellerato in nome della Scienza
Un Patto scellerato in nome della Scienza
di Giorgio Ferrari, Angelo Baracca
Con preoccupanti finalità interdittive, il patto firmato da Grillo e Renzi, quando annuncia che non saranno tollerate forme di pseudoscienza e pseudomedicina, brandisce la Scienza come una clava con cui colpire i “reprobi” che non ne riconoscono la sacralità
Non è la prima volta che nel nostro paese il mondo della scienza si rivolge alla politica affinché questa si faccia carico di questioni riguardanti il benessere della popolazione. È successo per il clima, per le scelte energetiche e per questioni etiche: ora, sembra, è la volta della salute. Tale infatti l’ambito privilegiato, ma non esclusivo, del Patto Trasversale per la Scienza che tanti consensi ha suscitato sia nei mezzi di informazione che nella stessa politica, al punto da mettere d’accordo persino due noti avversari come Beppe Grillo e Matteo Renzi.
Fuori dal coro dei consensi a noi pare che questa iniziativa abbia qualcosa di inquietante nella forma e nella sostanza del suo testo. Intanto non è un appello, ma un “patto” che le forze politiche tutte sono chiamate a sottoscrivere per finalità non solamente propositive (l’informazione, la ricerca) ma decisamente interdittive. E questa è una spiacevole novità. Di appelli fortemente connaturati alla sacralità della Scienza, ne avevamo già visti in passato e sempre in occasione di forti tensioni culturali e sociali come quelle dei referendum antinucleari.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2092
Hits 1997
Hits 1980
Hits 1884
Hits 1863
Hits 1830
tonino

Guglielmo Forges Davanzati: La teoria marxiana dell’esercito industriale di riserva come teoria della politica economica
La teoria marxiana dell’esercito industriale di riserva come teoria della politica economica
di Guglielmo Forges Davanzati*
Abstract: This paper deals with the relation between labour market deregulation and the path of employment in Italy, based on Marx’s theory of the industrial reserve army. It will be shown that the increase in labour flexibility negatively affected the employment rate in the 2000s. Moreover, it is argued that as unemployment increases, workers’ bargaining power decreases not only in the labour market but also in the political arena, allowing the Government to implement further policies of labour flexibility. The evidence confirms this conjecture
 1. Premessa
1. Premessa
Ammesso che se ne possa dare una definizione univoca, la c.d. eterodossia, in Economia Politica, non è affatto scomparsa nell’Università italiana. Ciò che realmente è scomparso è il marxismo, come diretta conseguenza del processo di depoliticizzazione del discorso economico. La deriva tecnocratica che ha prepotentemente investito la teoria economica (e l’insieme delle scienze sociali) ha generato tre esiti: i) la Storia del pensiero economico intesa come tecnica archivistica; ii) la teoria economica neoclassica declinata come tecnica econometrica; iii) parte dell’eterodossia (la teoria sraffiana) intesa come critica tecnica a una teoria neoclassica non più esistente o comunque non più dominante. Il resto è divenuto indicibile e, non a caso, questo saggio su Marx è pubblicato in una rivista di Filosofia[1].
2. Introduzione
È ben noto che Marx, opponendosi alla teoria malthusiana della sovrappopolazione assoluta, considera la sovrappopolazione relativa – o esercito industriale di riserva (EIR) – una condizione necessaria per la riproduzione capitalistica. Ed è ben noto che, opponendosi a Malthus, Marx considera la sovrappopolazione relativa come prodotto del capitalismo, non la risultante di un dato di natura: «una sovrappopolazione operaia è il prodotto necessario della accumulazione ossia dello sviluppo della ricchezza su base capitalistica, questa sovrappopolazione diventa, viceversa, la leva dell’accumulazione capitalistica e addirittura una delle condizioni d’esistenza del modo di produzione capitalistico. Essa costituisce un esercito industriale di riserva disponibile che appartiene al capitale in maniera così completa come se quest’ultimo l’avesse allevato a sue proprie spese, e crea per i mutevoli bisogni di valorizzazione di esso il materiale umano sfruttabile sempre pronto, indipendentemente dai limiti del reale aumento della popolazione» (Marx 1972, 82).
Leggi tutto
Temps critiques: Quello che può durare nella lotta dei Gilet Gialli
Quello che può durare nella lotta dei Gilet Gialli
di Temps critiques
 La maturazione del movimento
La maturazione del movimento
Quello che si può dire, è che senza trascendere dal suo punto di partenza, il movimento ha già modificato il suo anti-fiscalismo originale a favore di esigenze più sociali e generali (passando dalla giustizia fiscale dei piccoli commercianti o degli imprenditori, alla giustizia sociale). Già la lotta sul prezzo della benzina era una lotta che andava oltre la questione dell'aumento, per denunciare l'arbitrio di un prezzo senza alcun rapporto con qualsivoglia valore. I Gilet gialli non sono degli esperti economisti, ma sanno che il prezzo del barile, e quello del gas variano enormemente, sia in un senso che nell'altro, mentre il prezzo della benzina o del gas sono dei prezzi amministrati, vale a dire, dei prezzi politici. La riforma di Macron aveva una sua base materiale: il rincaro dei costi dei trasporti individuali utilizzati essenzialmente per il lavoro. Ma una semplice analisi marxista, svolta nei termini dell'aumento della difficoltà a riprodurre tale forza lavoro, mancava dell'essenziale, cioè di quello che aveva permesso di passare dal malcontento alla rivolta, vale a dire, la presa progressiva di coscienza che si tratta del «sistema» e non della «piccola causa». Nei paesi capitalisti sviluppati, dove non ci troviamo effettivamente nella situazione delle sommosse a causa della fame, la rivolta riguarda il maggior numero di persone, diversamente da come avveniva per le vecchie tasse sul carburante, come per i camionisti, o per i berretti rossi. Come avverrà successivamente, con la rivendicazione di un aumento dello SMIC [salario minimo interprofessionale di crescita], il movimento vuole innanzitutto sostituire all'arbitrio dello Stato, o a quello dei prezzi di monopolio, una sorta di «prezzo equo », alla Proudhon.
Un'unità che si costruisce...
Il movimento non si basa affatto su un'unità di rottura (per esempio, un'unità direttamente anticapitalista, dal punto di vista ideologico), bensì su un'unità di esistenza a partire dalla condivisione delle condizioni materiali e sociali, perfino anche politiche, percepite come degradate.
Leggi tutto
Martino Avanti: L’egemonia della paura
L’egemonia della paura
di Martino Avanti
Finita l'era dei compromessi forzati, l'attuale equilibrio mondiale fatto di finanziarizzazione e debito si regge sulla demonizzazione dell'altro da sé
 La crisi economica iniziata nel 2008 è una
crisi sistemica del modo di
produzione capitalista. Il capitale, come forza sociale
onnicomprensiva, come disciplina sulla società e sulla natura,
appare sempre meno in
grado di riprodurre adeguatamente la sua base sociale e
naturale. Stiamo tuttavia perdendo la capacità di cogliere
l’intreccio tra storia
e geopolitica alla base dell’avvitamento disfunzionale del
capitalismo. La cosiddetta “scuola di Amsterdam”, nel
combinare marxismo
(gramsciano) e relazioni internazionali ci permette di
afferrare questi nessi strutturali. La recente pubblicazione
di Transnational Capital and Class
Fractions
(curato da Overbeek e Jessop) ne offre un quadro
d’insieme a quarant’anni dai primi lavori. Quanto segue ne
presenta, integrandoli
con l’analisi del presente, i concetti teorici più innovativi,
concentrandosi principalmente sull’opera di Kees Van der Pijl.
La crisi economica iniziata nel 2008 è una
crisi sistemica del modo di
produzione capitalista. Il capitale, come forza sociale
onnicomprensiva, come disciplina sulla società e sulla natura,
appare sempre meno in
grado di riprodurre adeguatamente la sua base sociale e
naturale. Stiamo tuttavia perdendo la capacità di cogliere
l’intreccio tra storia
e geopolitica alla base dell’avvitamento disfunzionale del
capitalismo. La cosiddetta “scuola di Amsterdam”, nel
combinare marxismo
(gramsciano) e relazioni internazionali ci permette di
afferrare questi nessi strutturali. La recente pubblicazione
di Transnational Capital and Class
Fractions
(curato da Overbeek e Jessop) ne offre un quadro
d’insieme a quarant’anni dai primi lavori. Quanto segue ne
presenta, integrandoli
con l’analisi del presente, i concetti teorici più innovativi,
concentrandosi principalmente sull’opera di Kees Van der Pijl.
Concetti onnicomprensivi di controllo
L’egemonia è una forma di dominio di classe che si basa sul consenso piuttosto che sulla forza; consenso che è attivo tra i gruppi che fanno parte del blocco sociale unificato da uno specifico concetto onnicomprensivo di controllo (neoliberalismo/liberalismo corporativo) e passivo per chi non ne fa parte ma manca della forza di modificarlo o concepire il mondo diversamente. Nelle fasi egemoniche, la società nel suo complesso assimila i principi e il modus operandi su cui riposa il dominio della frazione dominante, considerandoli normali.
Non è tuttavia il capitale in generale, quello con la “C” maiuscola, a esercitare l’egemonia, bensì una specifica frazione del capitale totale (produttivo/finanziario/commerciale), i cui esponenti sviluppano quelle che Gramsci chiamava filosofie spontane.
Leggi tutto
Luca Michelini: Il nazionalismo economico nell’analisi di Rosa Luxemburg
Il nazionalismo economico nell’analisi di Rosa Luxemburg
di Luca Michelini
1. La più celebre polemica in cui si è cimentata Rosa Luxemburg (1871-1919) fu quella contro E. Bernstein, che voleva incanalare il movimento operaio verso una strategia riformatrice, abbandonando ogni proposito di rivoluzione. Fu tra le più lucide nel sottolineare che sarebbero state le classi dominanti a tradire i principi liberal-democratici, quando le riforme ne avessero intaccato i privilegi economici. Il socialismo, che era l’unica organizzazione di peso a difendere la democrazia borghese, era cioè obbligato a non rinunciare ai propositi rivoluzionari, perché sarebbe stata la logica storica delle riforme a imporne la razionalità, pena il disfacimento sociale e la nascita di sistemi autoritari. E di disfacimento sociale in effetti si trattò quando i riformisti tedeschi appoggiarono i crediti di guerra, dai quali scaturì il Primo Conflitto Mondiale, che cambiò il volto del Mondo aprendo la stagione della violenza politica e dei totalitarismi. Per altro Luxemburg fu tra le prime a scorgere nella prassi del bolscevismo russo giunto al potere i prodromi di forme di autoritarismo. E fu vittima di una situazione politica dove le tendenze rivoluzionarie, isolate dalla parte più consistente del movimento socialista, diedero l’occasione alle forze della reazione di imporre la propria logica, perfino alla socialdemocrazia. Il fallimento della rivoluzione in Germania fu all’origine di convulsioni sociali e politiche gravide di sciagure devastanti: perché rese realistica la politica del “socialismo in un solo paese” in Russia e perché la Germania si incanalò verso il nazismo e il Secondo Conflitto Mondiale.
Leggi tutto
Patrizia Cecconi: Tutte le bugie del mainstream sul caso dei "Carabinieri a Gaza"
Tutte le bugie del mainstream sul caso dei "Carabinieri a Gaza"
di Patrizia Cecconi*
Un giallo si è svolto ieri [14 gennaio, ndr] a Gaza e ha visto coinvolta l’Italia. Non sappiamo con certezza se anche gli italiani, ma l’Italia sì.
Secondo i nostri media di sicuro sono stati coinvolti anche gli italiani, infatti basta vedere i titoli dei quotidiani, cioè “il” titolo, perché il Corriere come la Repubblica, il Messaggero come il Giornale o il Fattoquotidiano e le agenzie di stampa hanno tutti in sostanza lo stesso titolo, una specie di uniforme da elegante valletto a servizio dallo stesso signore. Tutti hanno parlato di “carabinieri italiani rifugiati nella sede dell’ONU e assediati da Hamas”. Il perfido Hamas, cioè il partito che governa la Striscia di Gaza e che – come ci ricorda Vincenzo Nigro su La Repubblica – “l'Italia considera un movimento terroristico con cui i rapporti politici sono congelati.”
Noi ne prendiamo atto chiedendoci, però, come mai, se i rapporti sono congelati l’Italia manda i suoi carabinieri, non turisti o operatori umanitari, ma rappresentanti dell’Arma, dentro la Striscia? E come li manda? Clandestini?
Bene, corre l’obbligo di spiegare ai quattro lettori che ci seguiranno, che Gaza è sotto assedio israeliano, illegittimo e illegale ovviamente, ma sotto assedio e non si può entrare se non con un permesso speciale di Israele.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Del discredito
Del discredito
di Andrea Zhok
Alle volte, di fronte allo sconcerto di amici europeisti per la ‘rozzezza istituzionale’ dei ‘populisti’ (non solo in Italia), mi chiedo cosa si aspettassero.
Per anni e anni siamo andati avanti in Europa con una (sedicente) ‘avanguardia tecnocratica’, sottratta ad ogni dibattito pubblico e ad ogni controllo democratico, che ha utilizzato i propri agganci tra le élite cosmopolite per pubblicizzare nei singoli paesi il Grande Progetto Europeo come un progetto di ricchezza e fratellanza comune. ”Fidatevi”.
Poi, alla prima difficoltà seria, si è vista una corsa di ciascuno al salvataggio dei propri patrimoni (ad esempio il salvataggio delle banche francesi e tedesche a spese della Grecia), uno scatenarsi di regole asimmetriche valutate arbitrariamente (aiuti di stato, surplus commerciali, procedure di infrazione, ecc.), una rincorsa alla colpevolizzazione del vicino nella più completa ignoranza delle realtà altrui, un’esplosione di ricatti, condizionalità, minacce, e il tutto abbinato ad un impoverimento di ampli strati della popolazione.
In sintesi:
1) i lavoratori europei si sono inizialmente e per decenni consegnati fiduciosamente mani e piedi ad un’élite tecnocratica;
Leggi tutto
Claudio Conti: L’Europa massacrata dall’Unione Europea
L’Europa massacrata dall’Unione Europea
di Claudio Conti
Oggi è giornata di piccole soddisfazioni… Dopo tre settimane, anche i giornali economici italiani – e solo quelli, mentre il mainstream gioca cone le “armi di distrazione di massa” – si sono accorti che la Cina ha messo in campo una colossale manovra di stimolo dei consumi interni, in modo da mettersi almeno in parte al riparo dalla tempesta in arrivo.
Milano Finanza, per esempio, parla di “Asia in festa e futures su Wall Street ben intonati, oggi”, riferendosi soprattutto ai benefici portati da questa manovra sui mercati finanziari. Proprio mentre cominciavano seriamente a preoccuparsi della frenata generale dell’economia mondiale, particolarmente accentuata in Europa (con una media del -2% nella produzione industriale nell’ultimo mese) e specialmente in Germania (-4,7).
Ancora non è diventata consapevolezza generale, invece, che nella recessione incipiente è il “modello mercantilista europeo” quello destinato a saltare. In estrema sintesi: la Germania, tramite i trattati dell’Unione Europea, scritti sempre sotto la propria supervisione (altrimenti non avrebbero passato l’esame della Corte costituzionale di Karlsruhe, l’unica a mantenere prevalente la propria Carta rispetto ai trattati), ha imposto un modello di capitalismo fondato sulla compressione salariale in modo da essere “competitivi” nelle esportazioni.
Leggi tutto
Sergio Marotta: Regionalismo differenziato: cos’è e quali rischi comporta
Regionalismo differenziato: cos’è e quali rischi comporta
di Sergio Marotta
Dal debito pubblico alla rottura dell’unità nazionale. Tutti i rischi del Regionalismo differenziato
 Dalle
Regioni al federalismo differenziato
Dalle
Regioni al federalismo differenziato
Che le Regioni fossero troppo costose per il bilancio dello Stato italiano lo aveva già detto, in Assemblea costituente, Francesco Saverio Nitti che certo di conti pubblici se ne intendeva, essendo stato uno dei massimi studiosi di scienza delle finanze noto e apprezzato in tutta Europa. Eppure lo statista di Melfi non fu ascoltato, come non lo furono Benedetto Croce e Concetto Marchesi, Pietro Nenni e Palmiro Togliatti, Luigi Preti e Fausto Gullo, tutti uniti nell’opposizione all’ordinamento regionale.
Passò la linea del siciliano Gaspare Ambrosini che introduceva una forma di Stato organizzato in Regioni in cui si teneva insieme l’unità della Repubblica e l’autonomia degli enti locali. Alla fine la formula dell’art. 5 dei Principi fondamentali risultò la seguente: «La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento»[1].
Impiegati gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso per passare all’attuazione, con vent’anni di ritardo, degli ordinamenti regionali, si procedette, poi, a un quindicennio di riforme della pubblica amministrazione che iniziarono con la legge sull’ordinamento degli enti locali, la 142 del 1990, che prese il nome dell’allora potentissimo ministro dell’Interno, il democristiano Antonio Gava.
Venne, quindi, il turno delle varie leggi Bassanini dal nome del ministro della Funzione pubblica che le elaborò e, a più riprese, le portò all’approvazione del Parlamento. La prima fu la legge 59 del 1997 che doveva realizzare il federalismo a Costituzione invariata. Era il tempo in cui imperava il verbo della sussidiarietà come forma di avvicinamento del luogo della decisione pubblica al livello più prossimo alla collettività di riferimento. ‘Sussidiarietà’ era la parola magica per realizzare un’azione amministrativa più efficiente, più efficace e più economica.
Leggi tutto
Michele Filippini: Le origini intellettuali della rivoluzione italiana: il ‘68 e la sua genesi
Le origini intellettuali della rivoluzione italiana: il ‘68 e la sua genesi
di Michele Filippini
Abstract: Il ‘68 italiano, rispetto allo stesso movimento in altri paesi europei, si caratterizza per la sua lunga durata e per la sua particolare intensità. Si tratta infatti di un movimento che ha prodotto effetti potenti e duraturi sulla società italiana per almeno un decennio, con un impatto ben visibile nella persistente memoria storica dell’evento che si ripresenta anche ai giorni nostri. Ma lo scoppio del ‘68, come le conquiste sociali e legislative degli anni ‘70, devono le loro condizioni di possibilità a una rottura, politica ma soprattutto teorica, che si è verificata in precedenza, all’inizio degli anni ‘60. Risalire alla genesi della rottura dell’immaginario conservatore degli anni ‘50, oltre ad essere un’operazione di storia intellettuale, può essere utile per indagare come emerge la “novità teorica”, in questo caso attraverso una rottura con la tradizione tesa però alla sua riattivazione
 1. Il movimento, la
politica, la teoria
1. Il movimento, la
politica, la teoria
Se si dovesse scegliere la più rilevante tra le particolarità del ‘68 italiano rispetto al ciclo globale di mobilitazioni di quell’anno, questa sarebbe probabilmente la sua durata. La stessa storiografia ha ripetutamente identificato come “lungo ‘68” il decennio successivo a quell’evento, sottolineando più che la ripetizione – assai diverse sono infatti le fasi, le pratiche, i protagonisti – una specie di effetto a catena che permette di risalire a quella rottura per spiegare le profonde trasformazioni ideologiche, culturali e politiche avvenute in Italia negli anni ‘701. Quella rottura aveva però avuto nel decennio precedente un periodo di incubazione caratterizzato dall’accumularsi di fenomeni nuovi – lo sviluppo economico accelerato, la scolarizzazione crescente, l’emigrazione dal sud al nord del paese – che avevano creato contraddizioni e conflitti. Ha quindi qualche ragione chi fa risalire l’origine della rottura sessantottina al protagonismo giovanile nella rivolta del luglio ‘60 contro il governo Tambroni, alla ripresa del conflitto operaio con gli elettromeccanici a cavallo tra il ‘60 e il ‘61, ai tumulti di Piazza Statuto contro la Uil del ‘62 o alla grande stagione di lotta per i rinnovi contrattuali degli anni ‘62-‘632.
Anche dal punto di vista delle mobilitazioni studentesche, le prime occupazioni universitarie si hanno in Italia in anticipo rispetto al trend internazionale: già nel ‘66 alla Sapienza di Roma (dopo la morte dello studente Paolo Rossi) e a Sociologia a Trento (per il riconoscimento della nuova laurea); nel ‘67 la Cattolica a Milano, Palazzo Campana a Torino, la Statale a Pisa, ancora Trento, poi Napoli, Venezia, Milano Statale e Architettura. Il movimento dura poi a lungo anche dopo l’anno degli studenti3, scomponendosi e ricomponendosi all’interno dei nuovi gruppi extraparlamentari e attraverso esperienze più o meno fortunate di collegamento con i lavoratori (in particolare a Torino) di nuovo in lotta dall’autunno ‘69.
Leggi tutto
Michele Castaldo: Ancora sui Gilet gialli
![]()
Ancora sui Gilet gialli
di Michele Castaldo
 Pur se continua la lotta dei Gilet gialli è già
possibile cominciare
un primo bilancio e tentare di intravedere alcune linee di
tendenza per il futuro. Partiamo dalle risposte fornite da
Macron alle loro richieste. Le
misure promesse con un decreto legge sono sostanzialmente 3:
Pur se continua la lotta dei Gilet gialli è già
possibile cominciare
un primo bilancio e tentare di intravedere alcune linee di
tendenza per il futuro. Partiamo dalle risposte fornite da
Macron alle loro richieste. Le
misure promesse con un decreto legge sono sostanzialmente 3:
♦ Completa defiscalizzazione degli straordinari. Già era previsto di tagliare i contributi sociali a carico dei dipendenti e dei datori di lavoro;
♦ Aumento dello stipendi minimo di 100 euro al mese senza ricarico per i datori di lavoro;
♦ Defiscalizzazione completa delle pensioni sotto i 2000 euro mensili.
Come dire: un medicamento peggiore del male, come versare del sale su una ferita. Ma si sa, i reazionari sollevano un macigno per farselo ricadere poi sui piedi, per dirla con il vecchio e saggio Mao. In realtà si tratta di provvedimenti che non tengono per niente in conto la natura della protesta in atto, e per essere ancora più espliciti diciamo che si tratta di misure “novecentesche”, cioè di chi analizza i fatti odierni con le lenti del passato, molto simili – per fare un paragone e rendere l’idea – agli 80 euro di Renzi che gli spianarono sì la strada per la vittoria elettorale alle elezioni europee, ma poi fu affossato di lì a poco dal nuovo che avanzava. Non a caso quel nuovo che è emerso in Italia – il M5S – sta lanciando una ipotesi di accordo politico ai Gilet gialli mettendo a disposizione la propria piattaforma Rousseau. Sul movimento nazionalista di Salvini, anch’esso “nuovo”, ci occuperemo a parte.
Leggi tutto
Militant: Pietà l’è morta
Pietà l’è morta
di Militant
«Nemici e traditori un altro compagno è morto
ma un
altro partigiano oggi è risorto.
Ma
prima di morire tre volte ha pregato
che Dio
maledica il nemico
alleato.
Che Dio
stramaledica chi ci ha tradito»
La fiera dell’infamità, miserabile natura di questa borghesia stracciona, rancorosa, vigliacca, senza palle e senza onore. Questo il volto emerso dall’infame palco montato a Ciampino in attesa di Battisti, uomo ormai prigioniero, stanco, vinto, senza più amici né compagni, nelle perfide mani dello Stato che sghignazza ben protetto dal corteo di gendarmi attorno al detenuto disumanizzato. Se c’era un punto di non ritorno, il fatidico fondo per antonomasia irraggiungibile, ecco: è stato raggiunto. Un fondo tale da farci rimpiangere Andreotti e Cossiga, Craxi e Berlusconi, o un altro a caso degli aguzzini di ieri. Questi di oggi sono peggio: hanno il ghigno mostruoso dei parvenu, l’inumanità di neofiti secondini bullizzati a scuola e spavaldi oggi, forti dello stuolo di guardie poste a sostegno del loro coraggio. L’unico modo per darsi un tono. Bonafede ad esempio. Avvocaticchio prima, secondino oggi che ha vinto la lotteria del governo. Quale parabola più misera?
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Il «grande gioco» delle basi in Africa
Il «grande gioco» delle basi in Africa
di Manlio Dinucci
I militari italiani in missione a Gibuti hanno donato alcune macchine da cucire all’organizzazione umanitaria che assiste i rifugiati in questo piccolo paese del Corno d’Africa, situato in posizione strategica sulla fondamentale rotta commerciale Asia-Europa all’imboccatura del Mar Rosso, proprio di fronte allo Yemen.
Qui l’Italia ha una propria base militare che, dal 2012, «fornisce supporto logistico alle operazioni militari italiane che si svolgono nell’area del Corno d’Africa, Golfo di Aden, bacino somalo, Oceano Indiano».
A Gibuti i militari italiani non si occupano, quindi, solo di macchine da cucire. Nell’esercitazione Barracuda 2018, svoltasi qui lo scorso novembre, i tiratori scelti delle Forze speciali (il cui comando è a Pisa) si sono addestrati, in diverse condizioni ambientali anche di notte, con i più sofisticati fucili di precisione capaci di centrare l’obiettivo a 1-2 km di distanza.
Non si sa a quali operazioni militari partecipino le Forze speciali, poiché le loro missioni sono segrete; è comunque certo che esse si svolgono prevalentemente in ambito multinazionale sotto comando Usa. A Gibuti c’è Camp Lemonnier, la grande base Usa da cui opera dal 2001 la Task force congiunta-Corno d’Africa, composta da 4000 specialisti in missioni altamente segrete, tra cui uccisioni mirate per mezzo di commandos o droni killer in particolare nello Yemen e in Somalia.
Leggi tutto
Giuliano Santoro: Le nuove mostrine
Le nuove mostrine
di Giuliano Santoro
L'ossessione per "i comunisti", le pistole facili e le manette. Tre simboli per una classe politica che si aggrappa ad un arresto per nascondere le sue debolezze
Chissà se Dino Risi avrebbe trovato un modo analogo per rappresentare i nuovi potenti, il loro essere spietati e deboli allo stesso tempo, ridicoli e disperanti in eguale misura. La scena si svolge su di una pista di atterraggio. Il Mostro torna in Patria tra ali di telecamere, ministri con facce contrite a godersi lo spettacolo, spettatori con la bava alla bocca. Così si conclude la storia della caccia all’uomo durata quarant’anni. Così è sbarcato sul suolo italico lo spettro che da anni incombe sulle cronache, il volto che rappresenta il rimosso e il perturbante degli anni Settanta e della loro rappresentazione caricaturale.
La politica, praticamente tutta, ha scelto di gettarsi su questa figura minore dei cosiddetti anni di piombo, uno di quelli che si è mosso tra le pieghe dei fatti di cronaca al crepuscolo di quel periodo storico. I governanti sgomitano per un posto in prima fila, davanti alle telecamere. Il ministro con le mostrine della polizia si è piazzato ai margini della pista d’atterraggio e ha atteso che il Criminale scendesse dalla scaletta dell’aereo. «È un assassino comunista», aveva detto poche ore dopo la notizia della cattura, poggiando l’accento sulla seconda parola.
Leggi tutto
Bruno Steri: L’esito prevedibile di una manovra senza cambiamento
L’esito prevedibile di una manovra senza cambiamento
di Bruno Steri*
Già a fine ottobre, con la pubblicazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, così commentavamo quella che il governo annunciava come una manovra di “cambiamento”:
«(…) Il governo “giallo-verde” ha annunciato di voler invertire una tendenza sul piano della sensibilità sociale; ma non ha nelle sue corde – nella sua ispirazione di fondo, nel suo impianto ideologico e politico – la capacità di aprire una pagina davvero alternativa alla situazione vigente, più favorevole alle classi popolari in termini di condizione sociale e rapporti di forza. Non sto parlando di prospettive socialiste – cosa del tutto ovvia – ma anche solo di correzione del modello di (sotto)sviluppo imperante. (…) Per siffatte scelte occorrerebbero due decisioni politiche che il governo non vuole o comunque non può fare. In primo luogo, un recupero della propria autonomia in tema di politiche di bilancio, monetarie, fiscali e del lavoro, in sintonia con la fine della sbornia privatizzatrice e il rilancio di un robusto interventismo pubblico: ma ciò significa rotta di collisione con gli orientamenti dell’Unione europea e i vincoli di Maastricht, rimessa in discussione della moneta unica e di questa stessa Unione europea; in secondo luogo, sul piano interno, un travaso di ricchezza da profitti e rendite a salari (diretti, indiretti e differiti) anche attraverso una decisa revisione dei meccanismi di prelievo fiscale, con accentuazione del loro carattere progressivo, e tramite qualche forma di imposta patrimoniale.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2113
Hits 2103
Hits 2005
Hits 1905
Hits 1896
Hits 1841
Hits 1641
tonino

Rossella Latempa: La scuola fabbrica di Capitale Disumano
La scuola fabbrica di Capitale Disumano
di Rossella Latempa
 Scuola,
Università, Ricerca, Lavoro, Vita intera: tutto è
colonizzato dal culto del
Capitale Umano. L’individuo deve diventare puro investimento
di sé, “performer obbligato” costretto a mettere
continuamente in scena la rappresentazione che meglio
risponde alle “regole dello spettacolo”: quelle del
mercato. Il soggetto,
tuttavia, non sceglie liberamente di partecipare alla messa
in scena, ma va educato a farlo. Per questo quella del
Capitale Umano “è
una pedagogia” che ha bisogno delle Grandi
Istituzioni Totali, “custodi della Verità”- Scuola
e
Università – e dei loro “sacerdoti della valutazione”.
Il libro di Roberto Ciccarelli: “Capitale Disumano,
la vita in alternanza scuola lavoro” (Manifestolibri,
2018) è un misto di inchiesta, riflessione teorica,
ricostruzione storica,
esortazione poetica alla liberazione. Una liberazione che
riguarda tutti perché tutti, volenti o nolenti, in parte o
completamente, siamo
Capitale Umano. Quella “maestosa astrazione” che “abita
la regione intermedia tra linguaggio, percezione e
prassi” non è un principio naturale ma un paradosso
storico, un feroce sortilegio che rende in-umani generando
una guerra spietata
di tutti contro tutti. Nel libro si avvicendano, pagina dopo
pagina, le terre di conquista di quella “creatura
fantastica” che
“parla con la nostra bocca e cammina sulle nostre gambe”,
nuovo fondamento della cultura contemporanea.
Scuola,
Università, Ricerca, Lavoro, Vita intera: tutto è
colonizzato dal culto del
Capitale Umano. L’individuo deve diventare puro investimento
di sé, “performer obbligato” costretto a mettere
continuamente in scena la rappresentazione che meglio
risponde alle “regole dello spettacolo”: quelle del
mercato. Il soggetto,
tuttavia, non sceglie liberamente di partecipare alla messa
in scena, ma va educato a farlo. Per questo quella del
Capitale Umano “è
una pedagogia” che ha bisogno delle Grandi
Istituzioni Totali, “custodi della Verità”- Scuola
e
Università – e dei loro “sacerdoti della valutazione”.
Il libro di Roberto Ciccarelli: “Capitale Disumano,
la vita in alternanza scuola lavoro” (Manifestolibri,
2018) è un misto di inchiesta, riflessione teorica,
ricostruzione storica,
esortazione poetica alla liberazione. Una liberazione che
riguarda tutti perché tutti, volenti o nolenti, in parte o
completamente, siamo
Capitale Umano. Quella “maestosa astrazione” che “abita
la regione intermedia tra linguaggio, percezione e
prassi” non è un principio naturale ma un paradosso
storico, un feroce sortilegio che rende in-umani generando
una guerra spietata
di tutti contro tutti. Nel libro si avvicendano, pagina dopo
pagina, le terre di conquista di quella “creatura
fantastica” che
“parla con la nostra bocca e cammina sulle nostre gambe”,
nuovo fondamento della cultura contemporanea.
* * * *
Per introdurre il libro di Roberto Ciccarelli: “Capitale Disumano, la vita in alternanza scuola lavoro” (Manifestolibri, 2018) proviamo a partire dal suo rovescio. La metafora del rovesciamento (di senso, di condizioni, di vita) è spesso presente nelle pagine dell’autore, a cominciare dal titolo. Proprio il “capovolgimento nell’opposto” rappresenta lo stato d’animo di “scissione permanente” (p.31) dell’individuo che vive da Capitale Umano. Qualche anno fa, Piero Cipollone e Paolo Sestito, nomi noti a chi segue le vicende politiche scolastiche (ex commissari straordinari INVALSI, oltre che economisti della Banca d’Italia) scrivevano “Il capitale umano, come far fruttare i talenti” (Il Mulino, 2010).
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Sovranisti, populisti e pure rossobruni
Sovranisti, populisti e pure rossobruni
Fai il bravo o ti viene a prendere Orban
di Fulvio Grimaldi
Questo pezzo, come altri, è a rischio censura di Facebook. Lo potete trovare al sicuro sul blog www.fulviogrimaldicontroblog.info. E potete anche iscrivervi alla mia sicurissima lista email mandandomi il vostro indirizzo a visio...@virgilio.it
 Manco fosse Messina
Denaro. Prima un inciso fuori tema. La cattura ed
estradizione di Cesare Battisti dalla
Bolivia equivale a un rapimento. E’ totalmente illegittima.
Nessuna opposizione all’estradizione è stata concessa in un
paese che,
del resto, non può estradare condannati all’ergastolo, dato
che rifiuta l’ergastolo. Battisti non mi è simpatico, come ho
forti dubbi , se non certezze documentate, non tanto su lui,
quanto su buona parte dei lottatori armati dei fine ’70 e ’80,
a partire
dagli infiltrati e manipolati BR di seconda generazione.
Quelli che al sistema vanno benissimo quando, liberi dopo
poco, pontificano in televisione e
continuano a occultare la verità sul terrorismo di Stato. Che
permise la “normalizzazione” dopo un decennio di lotte di
massa
insurrezionali. Ma quello di Battisti è stato un processo
anomalo, in contumacia, senza la parola dell’imputato, nel
clima del teorema
Calogero. Meriterebbe di essere rifatto. Ma il trionfalismo
vendicativo di questa classe dirigente e dei suoi accoliti e
passeurs, eredi diretti dei
protagonisti del terrorismo da Piazza Fontana a Via Amelio
cospiratori in vista di un totalitarismo 2.0, fa venire la
nausea. Rovesciando insulti su
un uomo inerme e augurandogli di marcire in carcere, quando la
Costituzione impone la rieducazione dei detenuti, ha distrutto
la dignità,
più che di Battisti, di coloro che l’hanno esibito e celebrato
come un trofeo di caccia.
Manco fosse Messina
Denaro. Prima un inciso fuori tema. La cattura ed
estradizione di Cesare Battisti dalla
Bolivia equivale a un rapimento. E’ totalmente illegittima.
Nessuna opposizione all’estradizione è stata concessa in un
paese che,
del resto, non può estradare condannati all’ergastolo, dato
che rifiuta l’ergastolo. Battisti non mi è simpatico, come ho
forti dubbi , se non certezze documentate, non tanto su lui,
quanto su buona parte dei lottatori armati dei fine ’70 e ’80,
a partire
dagli infiltrati e manipolati BR di seconda generazione.
Quelli che al sistema vanno benissimo quando, liberi dopo
poco, pontificano in televisione e
continuano a occultare la verità sul terrorismo di Stato. Che
permise la “normalizzazione” dopo un decennio di lotte di
massa
insurrezionali. Ma quello di Battisti è stato un processo
anomalo, in contumacia, senza la parola dell’imputato, nel
clima del teorema
Calogero. Meriterebbe di essere rifatto. Ma il trionfalismo
vendicativo di questa classe dirigente e dei suoi accoliti e
passeurs, eredi diretti dei
protagonisti del terrorismo da Piazza Fontana a Via Amelio
cospiratori in vista di un totalitarismo 2.0, fa venire la
nausea. Rovesciando insulti su
un uomo inerme e augurandogli di marcire in carcere, quando la
Costituzione impone la rieducazione dei detenuti, ha distrutto
la dignità,
più che di Battisti, di coloro che l’hanno esibito e celebrato
come un trofeo di caccia.
Sovranisti e populisti, orbaniani e rossobruni
La prenderanno per una provocazione, anche se è una semplice constatazione di fatti, quella del mio discorso sul premier ungherese Victor Orban sul quale tutti, proprio tutti, senza essersi magari mai documentati, o averci buttato gambe e occhio, condividono con entusiasmo il parossismo demonizzatore della vulgata UE- sinistri-centrosinistri-centrodestri-destri. Il solito unanimismo dal “manifesto” al “Foglio”. Con Soros che se la ride.
Leggi tutto
Crisi come arte di governo
di Dario Gentili
Perché la crisi è diventata il principale metodo di governo e disciplinamento della popolazione? Per capirlo – sostiene Dario Gentili nel suo ultimo libro, Crisi come arte di governo (Quodlibet, 2018) – bisogna fare una genealogia della stessa krisis, risalendo al momento in cui, nella Grecia antica, si sono consolidati i suoi significati più propri. Del libro pubblichiamo, per gentile concessione dell'autore e dell'editore, che ringraziamo, l'introduzione
 C’è un nesso tra il discorso dominante della
crisi economica che
dal 2008 sta colonizzando le politiche della gran parte dei
Paesi del mondo e i Like/Dislike con cui, attraverso i social
media, i cittadini globali
si esprimono sugli argomenti più svariati e negli ambiti più
disparati? A prima vista tale nesso può sembrare azzardato:
come
può una crisi economica che determina un discorso che vincola
gli Stati a scelte obbligate trovare un corrispettivo nella
più ampia
diffusione e nella più radicale individualizzazione
dell’esercizio della critica? Eppure, a ben vedere, le scelte
obbligate dalla
mancanza di un’alternativa che la crisi impone e la riduzione
della critica all’approvazione o meno di un’alternativa
prestabilita
presuppongono la medesima modalità di giudizio: il giudizio
pro o contro.
C’è un nesso tra il discorso dominante della
crisi economica che
dal 2008 sta colonizzando le politiche della gran parte dei
Paesi del mondo e i Like/Dislike con cui, attraverso i social
media, i cittadini globali
si esprimono sugli argomenti più svariati e negli ambiti più
disparati? A prima vista tale nesso può sembrare azzardato:
come
può una crisi economica che determina un discorso che vincola
gli Stati a scelte obbligate trovare un corrispettivo nella
più ampia
diffusione e nella più radicale individualizzazione
dell’esercizio della critica? Eppure, a ben vedere, le scelte
obbligate dalla
mancanza di un’alternativa che la crisi impone e la riduzione
della critica all’approvazione o meno di un’alternativa
prestabilita
presuppongono la medesima modalità di giudizio: il giudizio
pro o contro.
Infatti, il giudizio pro o contro – tra due opzioni tra loro opposte, che pone la scelta tra due alternative in contrapposizione – passa oggi per essere la modalità di giudizio per antonomasia. Ciò è riscontrabile tanto nelle questioni di portata pubblica quanto in quelle che concernono la condotta dei singoli individui. In generale, esso rappresenta il modello a cui ogni procedimento decisionale deve, in ultima istanza, essere riducibile, affinché si possa infine giungere a una decisione finale e risolutrice – sulla vita della società e sulla propria vita individuale. E tuttavia, sebbene in netta contrapposizione, le alternative che questa crisi e questa società costantemente pongono sembra non abbiano nulla di davvero risolutivo: uscire dalla crisi o imprimere una svolta alla propria personale condizione sociale ed esistenziale. Sembra pertanto che il giudizio pro o contro, per quanto mai come oggi si eserciti così frequentemente e diffusamente, non produca alcuna decisione effettiva – è questo, almeno in prima battuta, il nesso tra la crisi economica e lo statuto della critica al tempo dei social media.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Siamo umani, non europei
Siamo umani, non europei
Del manifesto per la lista unica di Carlo Calenda
di Alessandro Visalli
Noi non siamo europei. Nessun travestimento del nazionalismo, espressione appena domesticata del vecchio, storico, spirito imperialista delle borghesie del continente, ci riguarda.
Del Manifesto per la costituzione di una lista unica, di Calenda, come del precedente[1], non ci convince questo spirito di potenza, questa evocazione di destino che a un orecchio storicamente consapevole rimanda a tempi che devono trascorrere. Tempi da confinare nei libri di storia.
L’Italia è certamente un grande paese, ma non lo è perché ‘protagonista’, non lo è perché vuole avere un “ruolo nel mondo”, non perché vuole imporsi (sotto la foglia di fico della “sicurezza”).
Non va bene iniziare così:
“Siamo europei. Il destino dell’Europa è il destino dell’Italia. Il nostro è un grande paese fondatore dell’Unione Europea, protagonista dell’evoluzione di questo progetto nell’arco di più di 60 anni. E protagonisti dobbiamo rimanere fino al conseguimento degli Stati Uniti d’Europa, per quanto distante questo traguardo possa oggi apparire. Il nostro ruolo nel mondo, la nostra sicurezza – economica e politica – dipendono dall’esito di questo processo”.
L’Italia è un grande paese perché nella sua storia, ed in particolare nella storia popolare di liberazione, delle lotte di popolo, ha saputo trovare sintesi alte ed originali di passione per la libertà, la fratellanza e il reciproco sostegno.
Leggi tutto
Stefano G. Azzarà: Irreversibilità dell'Europa, salvo catastrofi
Irreversibilità dell'Europa, salvo catastrofi
di Stefano G. Azzarà
Il processo di convergenza europea e di costruzione del grande spazio continentale non è il frutto del volontarismo delle elites e nemmeno di un complotto della finanza apolide per sostituire i popoli, ma una dinamica fondata sull'oggettività e cioè inscritta nelle cose stesse e nel loro movimento.
È radicato nella geografia come nella struttura economica del continente come nella sua cultura, e cioè nella materia stessa (per non chiamare in causa l'essenza specifica degli uomini e delle donne che lo popolano, qualunque sia la loro provenienza).
Questo processo è iniziato oltre due secoli fa, nel Settecento almeno, e come conseguenza dell'industria proseguirà per quanto sono soliti procedere i processi storici, e cioè per altri secoli. Attraversando le inevitabili contraddizioni che tutti i fatti della storia incontrano quando si incrociano con i progetti umani, prendendo ora la forma del napoleonismo come della santa alleanza, ora della mitteleuropa come del mito nazista dell'Europa bianca, ora dell'irenismo di Ventotene come della austerità mercatista.
E come è normale, coesistendo per lunghissimo tempo e forse anche per sempre con le nazioni, è e sarà soggetto ai rapporti di forza del momento.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Finalmente è stato pubblicato il Trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania
Finalmente è stato pubblicato il Trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania
Alcune considerazioni
di Giuseppe Masala
Finalmente è stato pubblicato il Trattato di Aquisgrana che Francia e Germania firmeranno il 22 Gennaio. Un Trattato ferale, per l'Italia, per l'amata Francia, per l'Europa tutta. Da non crederci, i francesi si sono consegnati a Berlino. Per l'Italia gli spazi di manovra all'interno della costruzione europoide si restringono sempre di più.
Alcune considerazioni sul Trattato Franco-Tedesco:
1) Strettissimo coordinamento sulle politiche europee. In pratica secondo voi se Francia e Germania si mettono d'accordo ex-ante (ovviamente tutelando i loro interessi nazionali) al Consiglio Europeo quale linea passa? E' inutile pure farli.
2) Coordinamento per far ottenere un seggio permanente al Consiglio di Sicurezza dell'ONU ai crucchi. Leggi: superamento degli assetti post seconda guerra mondiale con tutte le conseguenze del caso.
3) Istituzione del Consiglio dei Ministri franco-tedesco che si riunirà almeno una volta l'anno. Facoltà per un ministro tedesco di partecipare al Consiglio dei Ministri francese e viceversa per un ministro francese presso il Consiglio dei Ministri tedesco.
Leggi tutto
Manolo Monereo, Héctor Illueca e Julio Anguita: Sovranità, democrazia e socialismo
Sovranità, democrazia e socialismo
di Manolo Monereo, Héctor Illueca e Julio Anguita
Da quando Bodin ha scritto “I sei libri della Repubblica” nel 1576, il concetto di sovranità ha percorso un lungo cammino. In principio si associava allo Stato Assoluto e implicava la potestà di sanzionare e derogare leggi e ottenere l’obbedienza dei sudditi senza la necessità di un suo consenso. Tuttavia, una volta che il secolo XVIII irrompe nella storia, dopo un lungo conflitto sociale e politico, si riconosce il popolo come vero titolare della sovranità e si afferma la legge come espressione della volontà popolare. Rousseau aveva fatto la sua apparizione. Da allora, l’idea di sovranità è stata sviluppata e puntualizzata da numerosi pensatori, generalmente nel senso di stabilire limiti al potere dello Stato e introdurre garanzie di fronte all’arbitrarietà. Conservando sempre, però, quella sostanza che aveva identificato Rousseau e che sta alla base della democrazia: la capacità dei popoli di autogovernarsi e decidere il modello sociale, economico e politico nel quale desiderano vivere.
Quindi, l’Unione Europea è la negazione della sovranità e della democrazia. Lo abbiamo detto nel passato e non andiamo a insistere in questo ora. L’Europa neoliberale ha esacerbato la concorrenza tra paesi, ha liquidato i diritti sociali e sta corrompendo i valori civici delle società europee. E ancora, il neoliberalismo ha diviso il continente europeo in un nucleo di paesi industrializzati diretti dalla Germania e una periferia sempre più dipendente dal punto di vista economico.
Leggi tutto
Giulia Dettori: Marxismo e filosofia della prassi
Marxismo e filosofia della prassi
Recensione di Giulia Dettori
Marcello Mustè: Marxismo e filosofia della praxis. Da Labriola a Gramsci, Viella, Lecce 2018, pp. 332, ISBN: 9788867289967
 Il libro di Marcello Mustè Marxismo e
filosofia della
praxis. Da Labriola a Gramsci è un’interessante e
approfondita ricostruzione delle origini del marxismo teorico
in Italia, una
questione che l’autore indaga attraverso l’analisi del
pensiero di Labriola, Croce, Gentile, Mondolfo e Gramsci. Il
volume si articola in
due parti – la prima da Labriola a Mondolfo e la seconda
interamente incentrata su Gramsci – e si serve di un’ampia
bibliografia che
comprende le opere degli autori presi in esame, i carteggi e
diversi studi condotti in precedenza sul medesimo tema. Sulla
base di questo cospicuo
materiale Mustè delinea, con un criterio che cerca di essere
il più possibile cronologico, una traiettoria che parte dal
1895, anno di
pubblicazione del primo saggio sul materialismo storico di
Labriola (In memoria del manifesto dei comunisti),
per arrivare al 1935, quando
Gramsci porta a termine la stesura delle ultime note dei Quaderni
del carcere. È questo l’arco di tempo in cui, secondo
l’autore, nasce il paradigma caratteristico del marxismo
italiano, il cui tratto originale, come si evince dal titolo
dell’opera, è
racchiuso nella formula “filosofia della praxis”, con la quale
questi filosofi hanno cercato di svolgere in termini originali
e di
declinare in una forma nazionale il pensiero di Marx. A fare
da sfondo a questa ricostruzione è il più generale contesto
storico in cui
si dipana la vicenda del movimento operaio europeo, che Mustè
tiene sempre presente e con cui fa dialogare gli autori
trattati per mettere in
evidenza come la formazione di un paradigma marxista in Italia
sia strettamente intrecciata alla più ampia vicenda del
marxismo teorico e ai
suoi passaggi storici fondamentali (l’edificazione della
Seconda Internazionale e la sua crisi, generata dalla
contrapposizione tra ortodossia e
revisionismo, le due guerre mondiali, la rivoluzione
bolscevica e la Terza Internazionale).
Il libro di Marcello Mustè Marxismo e
filosofia della
praxis. Da Labriola a Gramsci è un’interessante e
approfondita ricostruzione delle origini del marxismo teorico
in Italia, una
questione che l’autore indaga attraverso l’analisi del
pensiero di Labriola, Croce, Gentile, Mondolfo e Gramsci. Il
volume si articola in
due parti – la prima da Labriola a Mondolfo e la seconda
interamente incentrata su Gramsci – e si serve di un’ampia
bibliografia che
comprende le opere degli autori presi in esame, i carteggi e
diversi studi condotti in precedenza sul medesimo tema. Sulla
base di questo cospicuo
materiale Mustè delinea, con un criterio che cerca di essere
il più possibile cronologico, una traiettoria che parte dal
1895, anno di
pubblicazione del primo saggio sul materialismo storico di
Labriola (In memoria del manifesto dei comunisti),
per arrivare al 1935, quando
Gramsci porta a termine la stesura delle ultime note dei Quaderni
del carcere. È questo l’arco di tempo in cui, secondo
l’autore, nasce il paradigma caratteristico del marxismo
italiano, il cui tratto originale, come si evince dal titolo
dell’opera, è
racchiuso nella formula “filosofia della praxis”, con la quale
questi filosofi hanno cercato di svolgere in termini originali
e di
declinare in una forma nazionale il pensiero di Marx. A fare
da sfondo a questa ricostruzione è il più generale contesto
storico in cui
si dipana la vicenda del movimento operaio europeo, che Mustè
tiene sempre presente e con cui fa dialogare gli autori
trattati per mettere in
evidenza come la formazione di un paradigma marxista in Italia
sia strettamente intrecciata alla più ampia vicenda del
marxismo teorico e ai
suoi passaggi storici fondamentali (l’edificazione della
Seconda Internazionale e la sua crisi, generata dalla
contrapposizione tra ortodossia e
revisionismo, le due guerre mondiali, la rivoluzione
bolscevica e la Terza Internazionale).
Leggi tutto
Epimeteo: Dall'ontologia del "politico" alla teologia politica
Dall'ontologia del "politico" alla teologia politica
Una riflessione a partire da Il Segreto del potere di Damiano Palano
di Epimeteo*
Questi "appunti di lettura" dedicati al volume di Damiano Palano, Il segreto del politico. Alla ricerca dell'ontologia del "politico" (Rubbettino), sono apparsi sul sito Epimeteo. Materiali di teologia politica dell'Europa e contributi al realismo politico nel novembre 2018
 La prima
impressione che si prova durante la lettura di questo testo
del docente di
Filosofia politica della Cattolica di Milano è il piacere di
reimmergersi in una corrente calda, conosciuta e antica,
quella del realismo
politico dei Tucidide e Machiavelli, Hobbes, Weber e Schmitt,
una corrente che Palano affronta con evidente
compartecipazione, ma nello stesso tempo
senza alcun timore reverenziale, men che meno nei confronti di
quello che è stato, dagli anni ’50 agli anni ’90, il più
importante rappresentante della “scienza politica”
nell’università in cui Palano insegna, ossia Gianfranco Miglio, a cui viene
dedicata
un’analisi approfondita nel quarto capitolo,
significativamente titolato Arcana imperii, in cui
il pensiero di Miglio viene esaminato
nei suoi punti di forza, ma anche nelle sue profonde
antinomie.
La prima
impressione che si prova durante la lettura di questo testo
del docente di
Filosofia politica della Cattolica di Milano è il piacere di
reimmergersi in una corrente calda, conosciuta e antica,
quella del realismo
politico dei Tucidide e Machiavelli, Hobbes, Weber e Schmitt,
una corrente che Palano affronta con evidente
compartecipazione, ma nello stesso tempo
senza alcun timore reverenziale, men che meno nei confronti di
quello che è stato, dagli anni ’50 agli anni ’90, il più
importante rappresentante della “scienza politica”
nell’università in cui Palano insegna, ossia Gianfranco Miglio, a cui viene
dedicata
un’analisi approfondita nel quarto capitolo,
significativamente titolato Arcana imperii, in cui
il pensiero di Miglio viene esaminato
nei suoi punti di forza, ma anche nelle sue profonde
antinomie.
In generale, la lettura di Palano risulta particolarmente efficace nel mettere in rilievo la contraddizione che percorre l’intero arco teorico del realismo politico, ossia il conflitto tra “natura e “cultura”, tra antropologia e storia. In effetti, il realismo politico, in quanto mira alla “verità effettuale” della cosa (Machiavelli), ossia alla realtà del politico così come si dà effettivamente, tematizza come oggetto specifico l’”essere” del politico, al di là del dover essere della morale, dei “quadri valoriali”, delle ideologie e delle utopie: ecco dunque la radice di una “ontologia” del politico, che si rivela essenzialmente come relazione di “dominio dell’uomo sull’uomo”, che si dà come un portato inevitabile della “natura” dell’essere umano nella sua dimensione di continuità evolutiva con l’animale, nella sua aggressività che infine mette capo alla metafora dell’homo homini lupus.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: L’epoca della normalità del male
![]()
L’epoca della normalità del male
di Salvatore Bravo
 Ci sono totalitarismi impliciti e
dunque non riconosciuti che agiscono capillarmente con
modalità pervasive,
difficilmente identificabili. Il problema è il percorso per
riconoscere il totalitarismo implicito e l’integralismo in cui
siamo immersi,
come pesci in acqua. In genere, non si è capaci di discernere
la qualità ambientale ed ideologica che si respira e ci
trasforma, in una
parte di un tutto, poiché la normalità, l’abitudine
all’indifferenza come al parossismo del valore di scambio
congela ogni
attività critica domandante. L’animale è parte integrante
dell’ambiente, è specializzato e funzionale al suo contesto
di sopravvivenza, non lo cambia, non può trasformarlo, perché
in assenza di linguaggio e della rappresentazione non può
agire su
di esso per riconfigurarlo, e quindi ne è passivamente parte,
come il pesce nell’acqua che non può rappresentarsi l’acqua e
di conseguenza non può immaginare un altro modo di vivere. La
tecnocrazia, nella stessa maniera, sempre più persuade che lo
stato
attuale è l’unico mondo possibile, dunque siamo come pesci in
acqua, senza linguaggio per ripensare l’ambiente
socioeconomico in
cui siamo gettati.
Ci sono totalitarismi impliciti e
dunque non riconosciuti che agiscono capillarmente con
modalità pervasive,
difficilmente identificabili. Il problema è il percorso per
riconoscere il totalitarismo implicito e l’integralismo in cui
siamo immersi,
come pesci in acqua. In genere, non si è capaci di discernere
la qualità ambientale ed ideologica che si respira e ci
trasforma, in una
parte di un tutto, poiché la normalità, l’abitudine
all’indifferenza come al parossismo del valore di scambio
congela ogni
attività critica domandante. L’animale è parte integrante
dell’ambiente, è specializzato e funzionale al suo contesto
di sopravvivenza, non lo cambia, non può trasformarlo, perché
in assenza di linguaggio e della rappresentazione non può
agire su
di esso per riconfigurarlo, e quindi ne è passivamente parte,
come il pesce nell’acqua che non può rappresentarsi l’acqua e
di conseguenza non può immaginare un altro modo di vivere. La
tecnocrazia, nella stessa maniera, sempre più persuade che lo
stato
attuale è l’unico mondo possibile, dunque siamo come pesci in
acqua, senza linguaggio per ripensare l’ambiente
socioeconomico in
cui siamo gettati.
Dialettica spazio-tempo
Non è necessario organizzare squadre di pompieri pronte a bruciare libri ed a proibire la lettura come in Fahrenheit 451, il potere economico ha assimilato il potere politico, oggi utilizza mezzi meno palesi, fa appello all’esemplificazione, ai processi di alienazione, alle miserie dell’abbondanza per lobomotizzare l’essere umano, per sottrarre all’ ente generico (Gattungswesen) le sue potenzialità, il suo essere un animale simbolico. Aldo Capitini definiva il totalitarismo consumista una forma di “americanismo-pompeiano”: l’eccesso, la dismisura è la legge dell’integralismo economico. La spazializzazione contro la temporalità vissuta ed in quanto tale storica e dotata di senso, è la dialettica che sostanzia il totalitarismo economico. Per Kant è il tempo l’intuizione che dà senso allo spazio, per il totalitarismo economico, lo spazio deve assimilare lo spirito (Geist).
Leggi tutto
Thomas Fazi: Financial Times: «Ha ragione la MMT»
Financial Times: «Ha ragione la MMT»
di Thomas Fazi
Un articolo uscito ieri sul blog Alphaville del Financial Times sdogana definitivamente e senza mezzi termini la teoria monetaria moderna (#MMT). Anche su questo, insomma, avevamo ragione noi:
«Non c’è nulla di intrinsecamente socialista per ciò che riguarda il debito pubblico. Un governo può emettere debito per pagare qualunque cosa gli piaccia: per combattere una guerra, per abbassare le tasse, per attutire gli effetti di una recessione. Gli Stati Uniti, per esempio, hanno sempre emesso debito per pagare per queste cose. I politici dicono che il debito pubblico spiazza gli investimenti privati, che è insostenibile e trasformerà il paese che ne fa uso nell’Argentina, nella Grecia o nel Venezuela. Ma indipendentemente da ciò che dicono, i politici americani finiscono sempre per fare ricorso al debito.
Leggi tutto
il pedante: Intelligenza o demenza artificiale?
Intelligenza o demenza artificiale?
di il pedante
Ci segnalano, e volentieri pubblichiamo questo pezzo de il pedante che condividiamo nella sostanza, tranne quando tira in ballo Marx come anche lui seguace della concezione della "neutralità della tecnica". Il che non è vero
Non basterebbero molte pagine per commentare l'ultima moda improvvisa e globale della digitalizzazione a tappe forzate, che per qualcuno - i soliti - dischiuderebbe «l’opportunità per pensare un mondo nuovo e per pensare anche un umano nuovo». Qui si può solo abbozzare una ricognizione preliminare sul tema, con l'intento non certo di chiosare le pretese «rivoluzioni» tecnologiche che lo rimpolpano, ma di raschiarne la patina retorica per ritrovarvi le dinamiche più antiche e familiari di un progetto di dominio degli uomini sugli uomini. Di cui la macchina è, insieme, lo strumento e il pretesto.
Da questa ricognizione emergerà che l'«e-government», il governo digitale, è esattamente ciò che dice di essere: l'ultima carnevalesca livrea della tecno-crazia, del potere sedicente tecnico che nel promettere la svolta storica di sottrarre le decisioni alle debolezze degli uomini... le sottrae agli uomini deboli per riservarle ai forti, come è sempre accaduto. Copertasi di sangue e di ridicolo nei campi dell'economia, svelatasi tribale e violenta in quelli della scienza e della medicina, darà spettacolo di sé con gli ultimi gingilli dell'ingegneria. A risultati invariati.
Leggi tutto
comidad: Dopo Battisti anche contro i gilet gialli si prepara il regolamento di conti
Dopo Battisti anche contro i gilet gialli si prepara il regolamento di conti
di comidad
Salvini ha potuto pavoneggiarsi per la cattura ed estradizione di Cesare Battisti ma, anche in questo caso, egli è andato solo a riscuotere il favore che in questi anni gli ha fatto la sedicente “sinistra”. Sono stati infatti i partiti e la stampa di “sinistra” ad alimentare per quaranta anni il clima di odio e di regolamento di conti contro i movimenti degli anni ’70, trasformando in “terroristi” personaggi nei confronti dei quali vi erano solo sospetti. Si è assistito così ad una sorta di maccartismo di “sinistra”, generato dapprima dal vecchio PCI contro i suoi concorrenti a sinistra e che ha coinvolto poi l’intero sistema politico, in tutte le sue ridenominazioni, in modo assolutamente trasversale.
Le prove sono state fabbricate attraverso dubbie testimonianze ed artifici giuridici come il “concorso morale”. Il castello accusatorio ha retto grazie all’omertà giudiziaria, in base alla quale ogni magistrato confermava acriticamente quanto avevano fatto gli inquirenti precedenti. Ma neanche l’omertà giudiziaria sarebbe bastata se a criminalizzare i dubbi non fossero intervenuti ogni volta i leader e i quotidiani di “sinistra”, i quali hanno inventato a supporto addirittura una nuova aristocrazia del sangue: i ”Parenti delle Vittime”.
Ora è la destra a conseguire gli allori per tutta questa opera di vendetta sociale, potendosi magari permettere di accusare la stessa “sinistra” di non aver saputo consegnare Battisti alla Giustizia perché “connivente”. Regolamento di conti su regolamento di conti.
Leggi tutto
CityStrike: Per una politica di classe contro i decreti sicurezza
Per una politica di classe contro i decreti sicurezza
di CityStrike
Sabato 12 gennaio 2019, Potere al Popolo Genova ha partecipato un dibattito dal titolo "Il decreto sotto la pelle" organizzato da CLICI (Coordinamento Ligure Cittadini Immigrati). La discussione è stata molto pratica, su come creare una rete di mutuo soccorso in città. Nell'occasione, è stato prodotto anche prodotto un testo politico che pubblichiamo per chi fosse interessato
Care compagne e cari compagni. Innanzitutto vi ringraziamo, come potere al popolo Genova per l'invito a questo dibattito. Per noi è un onore essere qui ed è un onore poter confrontare la nostra posizione con tutte le altre che qui si alternano.
Crediamo di aver poco tempo quindi andiamo necessariamente per punti, limitandomi a dei cenni sulle cose che sono già state dette, soprattutto quelle con le quali siamo in sintonia.
La prima cosa è che noi oggi parliamo del decreto sicurezza appena approvato dal Ministro dell'odio Salvini ma di decreti di questo livello repressivo in questi anni ne abbiamo visti tanti. Lunedì scorso, a Genova, abbiamo partecipato tutti a un bel presidio/corteo contro il decreto sicurezza. C'eravamo anche noi, pur avendo deciso di non aderire ufficialmente, perché, semplicemente, non potevamo non esserci. E la partecipazione di piazza ci ha risollevato un po' tutti. E questo è un bene.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2018
Hits 1915
Hits 1860
Hits 1665
Hits 1627
Hits 1610
tonino

Alessandro Somma: Lavoro alla spina e welfare à la carte
Lavoro alla spina e welfare à la carte
di Alessandro Somma
Il saggio che segue introduce il volume, a cura di Alessandro Somma, “Lavoro alla spina, welfare à la Carte. Lavoro e Stato sociale ai tempi della gig economy” (Meltemi). Si occupa tra l’altro della sentenza con cui il Tribunale di Torino ha respinto le richieste dei raider di Foodora di riconoscere il loro rapporto di lavoro come subordinato: richiesta parzialmente accolta dalla sentenza della Corte di appello dello scorso 11 gennaio
 1. Dalla catena di montaggio all’economia dei
lavoretti
1. Dalla catena di montaggio all’economia dei
lavoretti
Alcuni anni or sono l’Economist, noto settimanale nato nella seconda metà dell’Ottocento per promuovere l’ideologia del libero mercato, ha dedicato l’articolo di copertina alla cosiddetta economia on demand, celebrandola come una sorta di completamento della rivoluzione iniziata al principio del Novecento con l’introduzione della catena di montaggio. Quest’ultima, utilizzata per la prima volta nella produzione di autoveicoli da Henry Ford, avevo reso accessibile a un largo pubblico un bene fino ad allora considerato di lusso e dunque precluso ai più. Allo stesso modo un numero di imprese innovative in crescita esponenziale sta trasformando le abitudini di consumo con riferimento a una vasta gamma di servizi un tempo esclusivi: è il caso del noleggio con autista fornito da Uber, della pulizia della casa realizzata attraverso Handy, della fornitura di pasti a domicilio recapitati da SpoonRocket, o della consegna della spesa assicurata da Instacart. Conclusione: “a San Francisco una giovane programmatrice di computer può già vivere come una principessa”[1].
Le imprese protagoniste di questa rivoluzione, chiarisce l’articolo dell’Economist, possono fornire servizi a basso costo sfruttando le potenzialità offerte dalle tecnologie informatiche. Esse infatti “uniscono potere dei computer e lavoro freelance”, riuscendo così a “suddividere compiti complessi nelle loro singole componenti e a subappaltarle a specialisti in giro per il mondo”. Il tutto contribuendo a ridisegnare la geografia politica dell’umanità, finalmente non più divisa, come inteso da Karl Marx, tra i ricchi proprietari dei mezzi di produzione e i poveri che lavorano per loro.
Leggi tutto
Alexander Höbel:Crisi capitalistica, questione europea
Crisi capitalistica, questione europea
Per l’autonomia culturale e un nuovo internazionalismo del movimento operaio
di Alexander Höbel

1. Premessa
Qualche mese fa, come “Marxismo Oggi” online, decidemmo di avviare una discussione sulla questione europea, ma più in generale sul quadro internazionale, le dinamiche della crisi e le possibili strategie del movimento dei lavoratori per rispondere a tale quadro, in cui il rischio che il capitale trascini nella sua crisi anche i suoi antagonisti storici appare sempre più concreto.
All’apertura del dibattito, con un impegnato saggio di Emiliano Alessandroni (http://www.marxismo-oggi.it/saggi-e-contributi/saggi/275-economicismo-o-dialettica-un-approccio-marxista-alla-questione-europea), corrispose sui social network qualche scomposta e confusa polemica, condotta sulla base della logica binaria bianco/nero, amico/nemico, con un approccio insomma agli antipodi del metodo dialettico. Su tale tipo di atteggiamenti, che hanno già prodotto fin troppi danni nella storia del movimento comunista, si può solo commentare che essi sono parte del problema, ossia della difficoltà del movimento operaio di individuare una via d’uscita dalla grave situazione in cui si trova.
Per arricchire il confronto, oltre a ospitare vari interventi esterni alla redazione (Fosco Giannini, Domenico Moro), abbiamo anche ripreso contributi apparsi in altre sedi, dal saggio di Andrea Catone sui mutamenti del quadro mondiale, gli Usa di Trump, la Ue e l’Italia, a un articolo di Emiliano Brancaccio contro le “sinistre codiste”. Il dibattito, naturalmente, è appena agli inizi, ed è opportuno che esso continui a svilupparsi, nel reciproco rispetto e in modo costruttivo. E tuttavia qualche osservazione è possibile fare sin d’ora.
2. Una crisi di lunga durata
In primo luogo, credo che si debba fare un passo indietro dal punto di vista cronologico-storico, che può servirci a inquadrare meglio la questione anche sul piano teorico.
Leggi tutto
Roberto Romano: Crescita o recessione, narrazioni e prospettiva storica
Crescita o recessione, narrazioni e prospettiva storica
di Roberto Romano
Se la crescita è “misurabile”, stagnazione e recessione si prestano a diverse interpretazioni. Ma come mai le stime della Commissione tra il 2015 e 2018 per l’Italia sono sistematicamente più basse rispetto alla crescita effettiva? E a prendere sul serio le previsioni Bankitalia 2019 sarebbe da suonare un allarme rosso. Perché non scatta?
 Preambolo
Preambolo
La discussione relativa alle prospettive economiche del Paese e dell’Europa, con tutte le implicazioni dal lato della sostenibilità dei conti pubblici, è viziata da un approccio ragionieristico dei conti pubblici. Sebbene i conti pubblici siano legati all’andamento del reddito1, i compiti dell’economia pubblica non possono essere piegati alla sola sostenibilità dei conti pubblici. Se questa è poi vincolata ai così detti vincoli del Fiscal Compact, l’economia pubblica rinuncia al suo ruolo storico di governo dello sviluppo. Le recenti stime della crescita del PIL, particolarmente severe per il 2019, dovrebbero suggerire più di una cautela. Infatti, se la dinamica del PIL per il 2019 è caduta in soli due mesi da una prospettiva di crescita dell’1% a 0,6% (Banca Italia), più che di sostenibilità economica dei conti pubblici, la politica (economica) dovrebbe predisporre delle misure tese a sostenere la crescita per evitare l’avvitamento di tutto il sistema produttivo, industriale e del lavoro. In altri termini, le proiezioni di crescita per il 2019 così basse sono un allarme per il sistema economico e non per i conti pubblici. Sebbene Banca Italia e Commissione Europea abbiano segnalato un significativo rallentamento del PIL, l’esito di questa proiezione non può essere quella di prefigurare delle manovre correttive per garantire i saldi finanziari. Se le Istituzioni del Capitale europee e nazionali registrano un avvitamento del sistema economico così veloce, con dei sospetti rispetto alla tempistica2, dovrebbero essere le prime a prefigurare e suggerire delle misure espansive. Il 2007 e il 2011 dovrebbero aver ben insegnato qualcosa circa gli effetti negativi dell’austerità espansiva. Sebbene caduta nel dimenticatoio la lezione di R. A. Musgrave, padre di tutti gli economisti pubblici, i compiti della pubblica amministrazione sono ancora validi.
Leggi tutto
Guido Salerno Aletta: La Cina frena? Niente paura
La Cina frena? Niente paura
di Guido Salerno Aletta
Riproponiamo l'editoriale di Guido Salerno Aletta apparso su Milano – Finanza del 19 gennaio
Per l’economia cinese, il nuovo anno è cominciato con notizie poco rassicuranti. La prima doccia fredda è arrivata ai primi di gennaio, con il dato relativo al PMI (Purchasing Managers Index) del settore manifatturiero: a dicembre, il grado di contrazione è stato maggiore del previsto, quotando 49,4 anziché 49,9 . Per fortuna, il comparto dei servizi aveva confermato un buon andamento: 53,9 punti, dopo i 53,8 di novembre.
Le contromisure non si sono fatte attendere: la Banca del popolo cinese è intervenuta abbassando di un punto percentuale il coefficiente di riserva obbligatoria delle banche (RRR), portandolo al 19,5% per le grandi banche e al 16% per le piccole, liberando risorse liquide che potrebbero arrivare al controvalore di 194 miliardi di dollari. E’ stato ipotizzato che questa somma servirà soprattutto per far emergere le situazioni di finanziamento ancora poco trasparenti, quello delle aziende che ricorrono allo shadow banking e che sarebbero numerose anche fra quelle più vicine al sistema di governo locale. Questa decisione di stimolo monetario ha destato a sua volta una certa preoccupazione, visto che il livello del credito totale interno della Cina è già arrivato al 252% del pil. In dollari, sono circa 34 mila miliardi, di cui l’84% a carico del settore privato.
Leggi tutto
Pier Paolo Dal Monte: Perché la scienza non può essere un dogma
Perché la scienza non può essere un dogma
di Pier Paolo Dal Monte
Cosa potrebbe accadere se la scienza diventasse ideologia e venisse canonizzata in guisa di articolo di fede, se ogni critica fosse stigmatizzata come eresia e su di essa si avventasse il Malleus Maleficarum del potere e del suo clero opportunista? Questo mi pare l’obiettivo del malaccorto “Patto trasversale per la scienza” promosso da Burioni e firmato, tra gli altri, dai noti epistemologi Matteo Renzi e Beppe Grillo.
Come già evidenziato da Ivan Cavicchi, questo cosiddetto patto appare come un rabberciato coacervo di tautologie, tenuto assieme da una concezione di scienza ottocentesca, pedissequamente informata da un meccanicismo riduzionista. Una visione apodittica e fideistica che vorrebbe delimitare la sfera del concepibile definendo de jure, le categorie di ciò che può essere chiamato “scienza”, bandendo qualsiasi critica, anche fondata, dal consesso del lecito e, per ciò stesso, dell’esprimibile.
La scienza diventa così un potente metodo “governamentale”, perché, allo stesso modo delle notizie propalate dai mezzi di comunicazione di massa, crea l’immagine della realtà determinando l’“orizzonte del possibile”, ovvero i confini entro i quali devono essere delimitati il pensiero e la conoscenza.
Leggi tutto
Stefano Paterna: Siria, tre sorprese per un Paese unito e indipendente
Siria, tre sorprese per un Paese unito e indipendente
di Stefano Paterna
La scelta del ritiro da parte di Trump toglie l’ostacolo a un accordo tra Assad e i curdi
Nel 2015 nessuno avrebbe scommesso un centesimo bucato sulla sopravvivenza politica (e fisica) di Bashar al Assad e sulla sconfitta dell’insurrezione islamista armata in Siria. All’inizio di quell’anno era accaduta un’altra cosa del tutto inaspettata: la capitale politica della Rivoluzione curda in Siria, Kobane, aveva resistito tra le macerie della città e aveva fermato con il sangue delle/dei sue/suoi combattenti l’avanzata dello Stato islamico. Solo qualche settimana fa, infine, a dicembre 2018, è arrivata la terza sorpresa: l’annuncio del ritiro delle truppe Usa in Siria da parte del presidente Donald Trump.
La storia spesso si rivela così sorprendente: ora si tratta di prendere atto delle conseguenze politiche delle tre sorprese e concludere un’alleanza che consenta alla Siria di andare avanti.
I rischi e gli errori
Tuttavia, la guerra non è terminata ancora. Ancora incombono molti pericoli sul popolo siriano sulle sue aspirazioni all’indipendenza e alla libertà.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Conte-stare la narrazione occidentale del Sahel
![]()
Conte-stare la narrazione occidentale del Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, gennaio 2019. Ha soggiornato 24 ore a Niamey e poi è partito per N’Djamena, la capitale del Ciad. Prima di Conte erano già passati da queste parti Paolo Gentiloni, Federica Mogherini, Angela Merkel, Emmanuele Macron e molti alti funzionari dell’Occidente. Il primo ministro Conte ha confermato, nel breve e inoffensivo soggiorno a Niamey, la narrazione che, senza colpo ferire, è assunta come l’unica possibile. Per lui come per altri prima di lui, ci si ostina a recitare un’unica Conte-stabile narrazione che si spaccia per autentica. Non si sbagliava George Orwell quando, nel suo noto romanzo ‘1984’, affermava che, nel sistema totalitario che dipinge, la menzogna diventava verità e passava alla storia. Di certo l’autore non conosceva il Sahel e non poteva immaginare che qui la storia è raccontata solo dalla sabbia. Lo stesso ha fatto Conte che liquida in 24 ore la complessità e i drammi di cui il Niger e il Sahel incarnano l’attualità. L’ignoranza è forza, dice Orwell nel libro menzionato.
Che l’ignoranza è forza è uno degli slogan del libro incisi sulla facciata del ‘ministero della verità’ che non è altro che sabbia buttata alla rinfusa nelle diplomazie di 24 ore. Solo l’ignoranza di ciò che da anni si vive nel Sahel può spingere a credere che il problema principale sia quello del controllo dei migranti o del terrorismo djihadista.
Leggi tutto
Redazione Contropiano: Venezuela. L’Italia non sia complice del colpo di stato. Sabato manifestazioni
Venezuela. L’Italia non sia complice del colpo di stato. Sabato manifestazioni
di Redazione Contropiano
- Sul colpo di stato in Venezuela anche nel nostro paese si vanno delineando posizioni dirimenti. C’è chi, come lo Spi Cgil o gli europeisti di destra o di sinistra, sostengono il rovesciamento del governo bolivariano e di Maduro, e c’è chi sostiene la piena legittimità del governo del Venezuela e delle esperienze progressiste in America Latina. Sul come ci si posizionerà in questo frangente deriveranno conseguenze sul piano politico anche nel nostro paese.
- Sabato 26 gennaio alle ore 12.00 è stata convocata una manifestazione di solidarietà con il governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela. Appuntamento in via Tartaglia davanti all’ambasciata venezuelana. Anche a Milano sempre sabato ci sarà una manifestazione di solidarietà al consolato del Venezuela.
 Pubblichiamo qui di seguito alcuni
comunicati che prendono apertamente posizione contro il golpe
il Venezuela.
Pubblichiamo qui di seguito alcuni
comunicati che prendono apertamente posizione contro il golpe
il Venezuela.
***********
No al Golpe contro il Venezuela Bolivariano. L’italia non deve essere complice di questo crimine
di Potere al Popolo
Il 23 gennaio 2019 si sono materializzati a Caracas i piani orchestrati in queste settimane a Washington. Guaidò, un semisconosciuto appartenente al partito Voluntad Popular, nominato lo scorso 5 gennaio Presidente della Asamblea Nacional (il Parlamento venezuelano, ritenuto illegittimo dal Tribunal Supremo de Justicia per aver incorporato tre parlamentari accusati di aver comprato voti), si è autoproclamato legittimo presidente del Venezuela. Pochi minuti ed è arrivata l’investitura ufficiale di Trump, dopo che già il giorno precedente era giunta quella del suo vice, Mike Pence.
Leggi tutto
Redazione: Le critiche, la nostra risposta
Le critiche, la nostra risposta
di Redazione
L'articolo di Piemme sul "decretone" del governo ha suscitato diversi commenti critici, proviamo a rispondere come redazione
 Le critiche che ci vengono rivolte sono
fondamentalmente due. La prima riguarda il
giudizio sulle due misure prese, "quota 100" e Reddito di
cittadinanza (Rdc). La seconda, più politica, è una critica al
"sostegno
critico" al governo gialloverde ad 8 mesi dalla sua nascita.
Le critiche che ci vengono rivolte sono
fondamentalmente due. La prima riguarda il
giudizio sulle due misure prese, "quota 100" e Reddito di
cittadinanza (Rdc). La seconda, più politica, è una critica al
"sostegno
critico" al governo gialloverde ad 8 mesi dalla sua nascita.
Sul primo punto — "quota 100" e Reddito di cittadinanza (Rdc) — bisognerebbe innanzitutto distinguere tra la critica alle misure del governo e quella al nostro giudizio politico su di esse. I commentatori tendono a non operare questa distinzione, ma in ogni caso la sostanza delle critiche è chiara: "il Rdc così come uscito nel decreto è solo un intervento caritatevole ed assistenziale di cui pochi usufruiranno". Esso andrebbe perciò respinto sia per la sua inadeguatezza, sia per la sua natura liberista.
Si tratta di una critica fondata, che ha dalla sua diversi argomenti, fatta da persone (anche se talvolta anonime) che sappiamo non essere animate da visioni pregiudiziali, che arriva tuttavia a conclusioni politiche che consideriamo errate.
Entriamo dunque nel merito, notando però una curiosità, forse rivelatrice assai. Tutte le critiche sono rivolte al Rdc, nessuna a "quota 100". Ora, siccome non pensiamo che i commentatori siano dei leghisti, il problema sta probabilmente altrove. Dove, ci arriveremo con il ragionamento.
Ha scritto Piemme nell'articolo contestato:
«Non ci sfuggono di certo gli enormi limiti delle due misure simbolo dei "populisti". Dovessimo fare l'elenco delle loro evidenti criticità supereremmo forse l'armata dei detrattori. Tuttavia, al netto di questi enormi limiti, queste due misure vanno nel senso di invertire le politiche austeritarie che vengono avanti da quasi trent'anni in nome del dogma liberista del pareggio di bilancio».
Sembrerà strano, ma se diciamo "profondi limiti" intendiamo profondi limiti.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Francia Atto X: premesse, sviluppi e prospettive
Francia Atto X: premesse, sviluppi e prospettive
di Giacomo Marchetti
 La settimana che ha
preceduto l’Atto X ha visto l’inizio del “Grand Débat”
proposto da
Macron.
La settimana che ha
preceduto l’Atto X ha visto l’inizio del “Grand Débat”
proposto da
Macron.
È stato un incipit piuttosto problematico visto che i luoghi in cui si sono tenuti – lunedì Grand-Bourgetheroulde nell’Eure, dove ha incontrato 600 sindaci della Normandia, e venerdì a Souliac nel Lot – sono stati teatro di mobilitazioni dei Gilets Jaunes ma non solo, e ci sono state alcune prese di posizione importanti da parte dei sindaci che hanno partecipato alle tappe di questa “consultazione”, come quello di Saint-Cirgues che durante l’incontro ha detto al presidente di smetterla nel “stigmatizzare e di disprezzare”.
In realtà il carattere “virtuale” di questo dibattito è stato più volte messo in luce, perché l’entourage governativo ha ripetutamente chiarito che non cambierà l’indirizzo delle proprie scelte, cercando di fatto di cooptare gli eletti locali nella politica di tagli alla spesa pubblica previsti, rimodulandoli a seconda di ciò che emerge, ma senza mettere in discussione i rigidi paletti di austerity nel budget economico.
Il Débat appare una operazione di cosmesi politica, un’arma di distrazione di massa tesa a ri-orientare la discussione – dalla coniugazione tra rivendicazioni politiche e sociali come si è imposta all’attenzione dell’opinione pubblica dall’inizio della marea gialla – verso temi che permettono il recupero alla destra, il cui programma, già notevolmente compatibile con le istanze che premono maggiormente all’establishment d’oltralpe – la Le Pen, per esempio, è contro l’innalzamento dello SMIC (il salario minimo intercategoriale) e il ripristino della patrimoniale – è stato ulteriormente sagomato sulle esigenze delle élites europee, annullando le critiche alla moneta unica e alla costruzione politica dell’Unione Europea.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Se i “sovranismi” di destra rientrano nei ranghi
Se i “sovranismi” di destra rientrano nei ranghi
di Carlo Formenti
Sovranisti più vicini all’Europa, recita il titolo di un fondo di Maurizio Ferrara sul Corriere della Sera di sabato 19 gennaio. Prendendo atto delle recenti dichiarazioni di Marine Le Pen, secondo cui l’uscita della Francia dall’area euro non è più necessaria, perché ora ci sono le condizioni per riformare la Ue restandone all’interno, e dell’evidente, progressivo ammorbidimento delle posizioni antieuropeiste di Salvini, l’autore del pezzo tira un sospiro di sollievo scrivendo: “L’avvicinarsi delle elezioni sta accelerando la normalizzazione in senso europeo dei sovranisti. Da partiti di lotta antisistema, alcuni di loro sono diventati partiti di governo (a cominciare dalla Lega)”.
Ciò che questo articolo, come quelli di molti altri commentatori e opinionisti, nascondono, è il fatto che ad attribuire alla Lega (come agli altri movimenti populisti di destra) il carattere di “partiti antisistema”, sono stati i tradizionali partiti di orientamento liberista (di destra, centro e sinistra) e i media di regime. Per chiunque sia dotato di un minimo di onestà intellettuale, infatti, è sempre stato evidente:
1) che questi partiti e movimenti non hanno mai messo in discussione i valori e i principi del neoliberismo (né tantomeno quelli dell’economia capitalista);
Leggi tutto
Andrea Muratore: Che cos’è il franco Cfa, la moneta “coloniale” di Parigi
Che cos’è il franco Cfa, la moneta “coloniale” di Parigi
di Andrea Muratore
Nel mondo politico italiano, il recente rinfocolamento del problema migratorio ha fatto scoppiare la polemica sul franco Cfa. Il presidente di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, intervenendo a “Non è l’Arena” su La 7, ha mostrato una banconota del franco Cfa e la foto di un bambino del Burkina Faso che lavora in una miniera d’oro e ha detto: “La soluzione non è prendere gli africani e spostarli in Europa ma liberare l’Africa da certi europei, come i francesi, che la sfruttano”. Dichiarazioni che hanno fatto il paio con quelle poi pronunciate da Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, che hanno puntato il dito contro Parigi, accusata di essere la principale potenza sfruttatrice dei Paesi del continente africano.
L’argomento è, per certi versi, sicuramente semplificatorio: le problematiche dell’Africa sono molte e ben profonde, questioni geopolitiche, economiche e sociali a cui si aggiungono una forte corsa per il controllo del continente da parte delle maggiori potenze e questioni come il land grabbing che sottraggono ampie porzioni dei territori africani alla sovranità dei loro popoli. Tuttavia, in certi contesti l’ingerenza di Parigi è ravvisabile e macroscopica. E il franco Cfa si presenta come strumento fondamentale per questa ingerenza.
Leggi tutto
Marco Dotti: Il volto demoniaco della stupidità al potere
Il volto demoniaco della stupidità al potere
di Marco Dotti
Il segreto di un agitatore politico, scriveva Karl Kraus, è quello di «rendersi stupido come i suoi ascoltatori, così che questi credano di essere intelligenti come lui». È una vecchia lezione. Non di meno, è una lezione inascoltata.
Per quanto contenga un nocciolo di verità universale che la rende applicabile a tutto – dal serpente biblico alla Congiura degli Uguali, dalle sette del nichilismo russo a quelle del nichilismo mediatico odierno e nostrano – richiede pur sempre quel briciolo di fatica che si chiama autocritica.
Così, anche oggi, davanti a un tempo mutato e nuovo molti preferiscono la via breve e facile del sarcasmo (pensiamo al fenomeno dei “meme” o ai profili fake dei politici, che ironizzano, senza mai sovvertirlo, l’ordine del discorso violento). Il sarcasmo è certamente un’arma, ma solitamente esplode tra le mani di chi la usa e quando re e buffone coincidono nella stessa figura, la questione si fa maledettamente pericolosa.
Passaggio all’atto
Sul Venerdì di Repubblica del 18 gennaio, l’attenta Gabriella Saba (del suo libro parleremo nella prossim puntata della rubrica) presenta un personaggio che potrebbe offrire infiniti spunti a chi è vena di sarcasmo.
Leggi tutto
Francesco Coniglione: Di quale “patto” per la scienza ha bisogno la ricerca scientifica in Italia?
Di quale “patto” per la scienza ha bisogno la ricerca scientifica in Italia?
di Francesco Coniglione
Che senso ha un “patto trasversale per la scienza” comequello proposto da Roberto Burioni e firmato persino da Beppe Grillo con grande disappunto dei suoi seguaci, che hanno visto in ciò un tradimento della politica no-vax sino ad ora sostenuta? E in particolare quale il significato di proporsi di difendere la “scienza”, quando tutta la nostra società, sin nei suoi più minuti gangli produttivi, è pervasa da essa e ad essa è indirizzata, sicché il dissenso e la critica sono semmai diretti non alla scienza in quanto tale, bensì a sue particolari teorie scientifiche, a sue specifiche conoscenze e a certe forme in cui essa si manifesta? Ecco dunque il primo punto da chiarire: cosa si intende per scienza? Infatti essa può essere concepita come il patrimonio di tutte le teorie e leggi, cioè le conoscenze scientifiche, attualmente disponibili, depositate nei manuali e professate nei corsi universitari. Essa è così un patrimonio di conoscenze a disposizione della società, che sono consolidate e non sono messe in discussione, sicché chi è esterno al suo dominio può solo avere un atteggiamento passivo, di fruitore. È di solito di essa che si fa divulgazione. Ma essa può anche essere intesa come quella attività di ricerca portata avanti da ogni bravo scienziato, che in questa veste non fa il divulgatore: essa è aperta, mai conclusiva, provvisoria, spesso imbocca strade cieche.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2035
Hits 1937
Hits 1679
Hits 1651
Hits 1618
Hits 1615
tonino

Giordano Sivini: La grande inversione: dalla valorizzazione alla finanziarizzazione
La grande inversione: dalla valorizzazione alla finanziarizzazione
di Giordano Sivini
 Dallo studio delle
grandi trasformazioni che scandiscono la storia del
capitalismo emergono, secondo
Giovanni Arrighi, cicli successivi di accumulazione,
attraversati ciascuno da fasi di espansione materiale e fasi
di espansione finanziaria, in spazi
di crescente ampiezza governati da Stati che ad ogni ciclo
acquistano la supremazia sugli altri. La fase di espansione
finanziaria si avvia quando i
profitti derivanti dalla produzione e dai commerci cominciano
a calare a causa di una competizione sempre più forte. Il
capitale si riversa in
forma liquida verso le agenzie dello Stato egemone che hanno
la capacità di gestirla, provocando una grande redistribuzione
di ricchezza in
favore dei gruppi sociali dominanti.
Dallo studio delle
grandi trasformazioni che scandiscono la storia del
capitalismo emergono, secondo
Giovanni Arrighi, cicli successivi di accumulazione,
attraversati ciascuno da fasi di espansione materiale e fasi
di espansione finanziaria, in spazi
di crescente ampiezza governati da Stati che ad ogni ciclo
acquistano la supremazia sugli altri. La fase di espansione
finanziaria si avvia quando i
profitti derivanti dalla produzione e dai commerci cominciano
a calare a causa di una competizione sempre più forte. Il
capitale si riversa in
forma liquida verso le agenzie dello Stato egemone che hanno
la capacità di gestirla, provocando una grande redistribuzione
di ricchezza in
favore dei gruppi sociali dominanti.
Le trasformazioni della vita materiale non sono oggetto di considerazione da parte di Arrighi, né per la fase attuale di espansione finanziaria né per quelle del passato, quando “l’indebitamento eccessivo di Stati o dinastie (…) non si era mai esteso alla riproduzione sociale in quanto tale, diventandone l’anima”1 . Per trattarne è necessario cambiare il quadro teorico e passare da quello di Arrighi che, combinando Marx con Weber, inquadra l’evoluzione storica del capitalismo, a quello che, interpretando in vario modo Marx, si concentra sulle forme di riproduzione dei rapporti sociali determinate dal movimento del capitale attraverso la creazione di ricchezza scandita dal valore e misurata dal denaro.
Questa è la prospettiva di David Harvey, di Robert Kurz e di Ernst Lohoff, per i quali il passaggio dalla fase di espansione economica alla fase di espansione finanziaria può essere spiegata dall’inversione del rapporto tra capitale produttivo di merce e capitale produttivo di interesse.
Leggi tutto
Jacques Sapir: La lettera del Presidente, la questione del potere d’acquisto e l’euro
La lettera del Presidente, la questione del potere d’acquisto e l’euro
di Jacques Sapir
 Nella lettera con cui
si è rivolto ai Francesi dopo le imponenti manifestazioni
dei “Gilet
Gialli” – espressione dell’esasperazione dei cittadini
sempre più impoveriti – Emmanuel Macron non fa cenno alla
questione cruciale: la perdita del potere d’acquisto da
parte dei lavoratori. L’economista Jacques Sapir spiega ancora una volta il perché
di questo
silenzio: finché la Francia resta intrappolata nel
sistema dell’euro, alzare il livello dei salari non è
possibile,
perché – nell’impossibilità di svalutare la moneta – questo
comporterebbe una perdita di competitività dei
prodotti sui mercati esteri peggiorando il deficit
commerciale del Paese. E Macron vuole restare nell’euro a
ogni costo. Sapir dimostra come una
svalutazione della moneta avrebbe un importante effetto
redistributivo a favore dei salari più bassi. Fino a quando
l’Europa – la
vera Europa, l’Europa dei cittadini – potrà tollerare le
follie dell’Unione europea e la dittatura della moneta
unica, un
sistema totalmente asservito agli interessi dei più ricchi?
Nella lettera con cui
si è rivolto ai Francesi dopo le imponenti manifestazioni
dei “Gilet
Gialli” – espressione dell’esasperazione dei cittadini
sempre più impoveriti – Emmanuel Macron non fa cenno alla
questione cruciale: la perdita del potere d’acquisto da
parte dei lavoratori. L’economista Jacques Sapir spiega ancora una volta il perché
di questo
silenzio: finché la Francia resta intrappolata nel
sistema dell’euro, alzare il livello dei salari non è
possibile,
perché – nell’impossibilità di svalutare la moneta – questo
comporterebbe una perdita di competitività dei
prodotti sui mercati esteri peggiorando il deficit
commerciale del Paese. E Macron vuole restare nell’euro a
ogni costo. Sapir dimostra come una
svalutazione della moneta avrebbe un importante effetto
redistributivo a favore dei salari più bassi. Fino a quando
l’Europa – la
vera Europa, l’Europa dei cittadini – potrà tollerare le
follie dell’Unione europea e la dittatura della moneta
unica, un
sistema totalmente asservito agli interessi dei più ricchi?
* * * *
Il presidente della Repubblica ha inviato la sua “lettera ai francesi”. Un testo assai ampio, che copre molti argomenti. Eppure in questo documento, a volte inutilmente lungo, manca un argomento importante: la questione del potere d’acquisto. Questo problema non è affrontato in nessuno dei quattro punti, benché sia essenziale. Per essere più precisi, la questione è trattata, in maniera estremamente parziale, solo nell’ottica di una possibile riduzione delle tasse. Si tratta di un punto di vista molto angusto. Tuttavia, nella “lettera” c’è un’ammissione: “…perché i salari sono troppo bassi perché tutti possano vivere dignitosamente grazie ai frutti del loro lavoro…”. Questa, in effetti, è una delle cause della rabbia che è stata espressa per due mesi dal movimento dei Gilet Gialli, accanto a rivendicazioni riguardanti la democrazia.
Leggi tutto
Gennaro Carotenuto: Cosa c’è in ballo in Venezuela col golpe Gaidó
Cosa c’è in ballo in Venezuela col golpe Gaidó
di Gennaro Carotenuto
 È perfino comprensibile che in pochi si
straccino le vesti per le sorti del
governo di Nicolás Maduro per molti motivi. Ma nella nomina di
un antipapa ghibellino da parte di Trump e Bolsonaro, nella
persona del carneade
Juan Gaidó, ci sono almeno altrettanti motivi del perché sia
necessario riflettere su un passaggio cruciale della storia
latinoamericana
del XXI secolo.
È perfino comprensibile che in pochi si
straccino le vesti per le sorti del
governo di Nicolás Maduro per molti motivi. Ma nella nomina di
un antipapa ghibellino da parte di Trump e Bolsonaro, nella
persona del carneade
Juan Gaidó, ci sono almeno altrettanti motivi del perché sia
necessario riflettere su un passaggio cruciale della storia
latinoamericana
del XXI secolo.
È senz’altro vero che da tempo le cose in Venezuela vadano male. Il governo Maduro – al di là delle proprie colpe e debolezze non si possono mai scontare del tutto le responsabilità di chi è al governo – non sembra avere le chiavi per uscire da una crisi che è magnificata dall’iperinflazione, di gran lunga il maggior fattore di destabilizzazione e di peggioramento delle condizioni di vita della popolazione. È anche vero che negli ultimi anni, usciti dall’auge di consenso e anche economica dei migliori anni del chavismo, il successore dell’odiato negraccio dell’Orinoco, abbia operato una serie di forzature istituzionali (che definire colpi di Stato è però strumentale, della contesa AN/Costituente dirò poi). In particolare, eludendo il referendum revocatorio previsto dalla Costituzione del 1998, e che a suo tempo aveva troncato ogni discussione sulla legittimità di Chávez con un trionfo storico, ha minato quell’ineccepibilità democratica del chavismo stesso, che aveva tenuto a bada i più malintenzionati dei detrattori.
Questo può portare benissimo a considerare il governo Maduro un pessimo governo e a desiderare di cambiarlo, ma pensare di farlo attraverso un processo di regime change, o rivoluzione colorata, che è quanto sta accadendo in queste ore, giocando col fuoco di una guerra civile di un paese armato fino ai denti, contrappone a una discutibile legittimità una sicura illegittimità.
Leggi tutto
coniarerivolta: Reddito di cittadinanza: poche risorse, molte insidie
Reddito di cittadinanza: poche risorse, molte insidie
di coniarerivolta
Come noto, lo scorso dicembre il Governo ha redatto la ‘Legge di bilancio’, all’interno della quale è stato previsto uno stanziamento per il cosiddetto ‘reddito di cittadinanza’ (RDC). Tuttavia, questa misura ha visto la luce solo la scorsa settimana grazie ad un decreto legge che, assieme a ‘quota 100’, avrebbe dovuto contenere le misure a maggiore impatto sociale proposte dalla compagine governativa. In maniera non sorprendente, ed in maniera analoga al provvedimento sulle pensioni, il RDC è ancora una volta ben rappresentativo di una politica economica perfettamente compatibile sia con i dettami dell’austerità, viste le scarse risorse ad esso destinate (dovute al cedimento immediato alle pressioni europee per portare il deficit dal 2,4% al 2,04%), sia con un più generale impianto neoliberista, viste le pressioni al ribasso che tale provvedimento comporterà su salari e condizioni di lavoro.
Una prima stima, eravamo a marzo 2018, prevedeva un costo intorno ai 14-16 miliardi di euro e avrebbe dovuto coprire circa 9 milioni di persone. Ad ottobre 2018 il Governo dichiarava che sarebbe stato stanziato un fondo da circa 9 miliardi di euro, dopo aver inserito alcune condizionalità alla percezione piena dei 780 euro mensili (su tutte, il non essere proprietari di una casa e un ISEE inferiore a 9.360 euro annui).
Leggi tutto
Paolo Massucci: La dura lotta intercapitalista
La dura lotta intercapitalista
di Paolo Massucci*
Un articolo preso dal Sole 24 Ore (qui) ci permette di fare una breve anche se ovvia riflessione...
L'articolo in sintesi evidenzia come più o meno tutti i Paesi dell'Eurozona registrino forti avanzi delle partite correnti e mette ciò in relazione con il rallentamento economico prima, con la stagnazione e poi con la vera e propria recessione registrata in questi giorni nell'Eurozona.
Le spiegazioni si limitano al fatto, relativamente noto, che se troppi Paesi basano la propria economia sull'export anziché bilanciare le partite correnti con i consumi interni, allora nascono difficoltà, ovvie, di sbocco delle merci esportate: infatti se un paese è esportatore netto, un'altro necessariamente deve essere importatore netto. Ad esempio gli USA di Trump, ribaltando il modello precedente, con le loro politiche protezioniste e i dazi sulle importazioni stanno sostenendo investimenti produttivi e produzione interna e ostacolando le importazioni (dunque in sostanza si assiste ad un riorientamento a vantaggio dell'export contro l'import).
Quello che l'articolo omette di chiarire esplicitamente è che in Europa (ma anche nel mondo) le politiche neoliberiste (sono infatti le oligarchie capitalistico-finanziarie che orientano le politiche economiche dei governi) portano a ridurre le imposte sul capitale e ridurre il costo del lavoro.
Leggi tutto
Il Pedante: Un’idea vecchia per un Mondo Nuovo
Un’idea vecchia per un Mondo Nuovo
di Il Pedante
Nel commentare il controverso «Patto per la scienza» firmato da Beppe Grillo e Matteo Renzi sotto gli auspici del professor Burioni (ce ne siamo già occupati qui), Ivan Cavicchi ha scritto che l’idea di scienza che vi si esprime è «vecchia e superata», «un rottame d’altri tempi che nonostante ciò ha la pretesa di proporsi come metafisica, cioè valore assoluto, incontestabile, autoritario e impositivo».
In effetti, in quel breve testo si chiede ai politici firmatari un impegno duplice e contraddittorio: da un lato di elevare la scienza a «valore universale di progresso dell’umanità» (intento lodevole ma inutile, non avendo mai alcuno affermato il contrario), dall'altro di non prestarsi «a sostenere o tollerare in alcun modo forme di pseudoscienza e/o di pseudomedicina che mettono a repentaglio la salute pubblica» e, quindi, di «fermare l’operato di quegli pseudoscienziati che con affermazioni non dimostrate e allarmiste creano paure ingiustificate tra la popolazione nei confronti di presidi terapeutici validati dall’evidenza scientifica e medica». Come se la scienza si riducesse solo alla medicina e alla salute pubblica, oltre tutto (qui una critica epistemologica dello stesso Cavicchi, qui una di Pier Paolo Dal Monte).
La contraddizione del messaggio risiede chiaramente nel fatto che il rispetto della scienza come «valore universale di progresso» non può coniugarsi con il suo assoggettamento a forze politiche che ne censurino i risultati o ne «ferm[ino]» i protagonisti.
Leggi tutto
Raffaele Cimmino: La falsa alternativa di Salvini ed un nuovo blocco sociale tutto da costruire
La falsa alternativa di Salvini ed un nuovo blocco sociale tutto da costruire
di Raffaele Cimmino
La vicenda Battisti, con i suoi aspetti anche grotteschi, dice molto dello stato dello spirito pubblico del paese. Su due questioni. La prima: con questa vicenda arriva al punto più alto il populismo penale che da anni avvelena il dibattito pubblico e che è stato il varco da cui è entrato e si è consolidato un senso comune retrivo che Salvini alimenta e manipola ma che gli preesiste. Non perché gli italiani siano di destra e lo siano sempre stati. Questo è il comodo alibi di molti fallimenti. Ma perché nella crisi sociale e antropologica il lavoro culturale della destra – svolto via media e durato un quarto di secolo, con la compiacenza bipartisan dei suoi presunti antagonisti – ha avvelenato i pozzi. Con questa realtà bisogna fare i conti, perché è il terreno che è arato agevolmente dalla destra e dal suo nuovo leader, Matteo Salvini. Una realtà che andrebbe smontata e cambiata di segno, se fosse possibile, non assecondata come intende fare qualcuno.
La seconda: con la sua intemerata sugli assassini comunisti, Salvini non solo manda un segnale a tutta la teppaglia fascista di cui è diventato ormai un riferimento, ma preannuncia i termini della lotta politica quando non ci saranno più il movimento di Casaleggio e i contratti di governo a fare da argine se non altro per motivi di concorrenza. Siamo, insomma, nei paraggi di Orbàn che fa abbattere la statua di Imre Nagy e fa scomparire e probabilmente distruggere l’archivio del filosofo comunista Gyorgy Lukacs. La guerra al passato per egemonizzare il presente.
Leggi tutto
Giulio Marcon: Una manovra bis all’orizzonte
Una manovra bis all’orizzonte
di Giulio Marcon
A tre settimane dal varo della Legge di Bilancio, già mancano all’appello 5-6 miliardi di euro, ed è probabile che a primavera, dopo le europee, arrivi una manovra correttiva. La situazione internazionale non è rosea. Ma il governo ci ha messo del suo facendo il contrario di ciò che si sarebbe dovuto fare
Dopo appena tre settimane dal varo della Legge di Bilancio, mancano all’appello già 5-6 miliardi di euro. I motivi sono diversi: i conti approssimativi e un po’ truccati, la revisione al ribasso delle stime della crescita, le difficoltà dell’economia mondiale. Non è da escludere, dunque, che già dopo il varo del DEF (e dopo le elezioni europee) possa esserci l’annuncio di una correzione dei conti.
Nel giro di un paio di mesi la stima (del Governo) di crescita nel 2019 è passata da 1,5% all’1,0%. Banca d’Italia qualche giorno fa – suscitando le ire del Governo – ha ridotto ulteriormente le stime di crescita allo 0,6%, come del resto ha confermato ieri anche il Fondo Monetario Internazionale. Un paio di settimane fa il ministro dell’Economia Tria ha detto “siamo in una situazione di stagnazione” e ha aggiunto “speriamo di non entrare in recessione”. Di fatto già lo siamo.
Intanto registriamo pesanti battute d’arresto sui consumi e la produzione industriale. Non aiuta la situazione dell’economia mondiale, con la diminuzione dei tassi di crescita della Cina e con la guerra dei dazi. E non aiuta la situazione dell’Unione Europea, priva di una politica economica e fiscale comune.
Leggi tutto
Matteo Luca Andriola: Il franco CFA, fra 'sinistra imperiale' e 'Materialismo Storico'
Il franco CFA, fra 'sinistra imperiale' e 'Materialismo Storico'
Quando i marxisti si schierano col 'Negus Macron' pur di andar contro ai 5Stelle
di Matteo Luca Andriola
 In questi due giorni s’è ampiamente parlato sui
social network –
la nuova agorà virtuale che oramai ha sostituito i vecchi
spazi d’aggregazione – del cosiddetto franco CFA
(originalmente franco
delle Colonie Francesi d’Africa, ora “…della Comunità
Finanziaria Africana”).. Il tutto è nato quando
l’esponente del M5S Alessandro Di Battista, intervistato da
Fabio Fazio a Che tempo che fa (Rai 1 ), nel parlare
sull’annoso tema
delle migrazioni, ha espresso forti perplessità su questa
valuta, individuandola come uno dei motivi dei flussi
migratori verso
l’Europa, dicendo che
In questi due giorni s’è ampiamente parlato sui
social network –
la nuova agorà virtuale che oramai ha sostituito i vecchi
spazi d’aggregazione – del cosiddetto franco CFA
(originalmente franco
delle Colonie Francesi d’Africa, ora “…della Comunità
Finanziaria Africana”).. Il tutto è nato quando
l’esponente del M5S Alessandro Di Battista, intervistato da
Fabio Fazio a Che tempo che fa (Rai 1 ), nel parlare
sull’annoso tema
delle migrazioni, ha espresso forti perplessità su questa
valuta, individuandola come uno dei motivi dei flussi
migratori verso
l’Europa, dicendo che
“Attualmente la Francia, vicino Lione, stampa la moneta utilizzata in 14 paesi africani, tutti paesi della zona subsahariana. I quali, non soltanto hanno una moneta stampata dalla Francia, ma per mantenere il tasso fisso, prima con il franco francese e oggi con l’euro, sono costretti a versare circa il 50 per cento dei loro denari in un conto corrente gestito dal tesoro francese…. Ma soprattutto la Francia, attraverso questo controllo geopolitico di quell’area dove vivono 200milioni di persone che utilizzano le banconote di una moneta stampata in Francia, gestisce la sovranità di questi paesi impedendo la loro legittima indipendenza, sovranità fiscale, monetaria, valutaria, e la possibilità di fare politiche economiche espansive.”
L’esponente grillino ha poi strappato in diretta televisiva una banconota di 10mila franchi CFA, sostenendo che, finché non saranno tolte queste ‘manette’ all’Africa mai si risolverà l’annoso problema delle migrazioni. È seguita un’esternazione simile da parte di Giorgia Meloni, leader della destra populista Fratelli d’Italia, erede del Msi e di An. Il franco CFA, indica due valute che accomunano 14 stati africani quali Camerun, Ciad, Gabon, Guinea Equatoriale, Repubblica Centrafricana, Repubblica del Congo, Benin, Burkina Faso, Costa d’Avorio, Guinea-Bissau, Mali, Niger, Senegal e Togo, che costituiscono la cosiddetta “zona franco”, tutti, eccezion fatta per Guinea-Bissau e Guinea Equatoriale, ex colonie francesi. Alcuni degli stati sono membri dell’Uemoa, altri della Cemac , usando tali valute.
Leggi tutto
Alessandro Mangia: Oggi Merkel e Macron firmano la fine dell’Unione Europea
Oggi Merkel e Macron firmano la fine dell’Unione Europea
Federico Ferraù intervista Alessandro Mangia
Oggi ad Aquisgrana Emmanuel Macron e Angela Merkel firmano un nuovo Trattato di cooperazione e di integrazione franco-tedesco. Con buona pace di tutti gli europeisti
 E’ stato il grande assente dalle
cronache politiche di questi giorni, ma è il fatto più
rilevante nella politica europea dopo la Brexit e, “in
qualche misura, ne è una conseguenza diretta” spiega
Alessandro Mangia,
ordinario di diritto costituzionale nell’Università
Cattolica di Milano. Oggi ad Aquisgrana Emmanuel Macron e
Angela Merkel firmeranno un
nuovo Trattato di cooperazione e di integrazione
franco-tedesco. Una firma che dovrebbe sollevare più di un
interrogativo nel ceto
“pensante” dell’europeismo nostrano: proprio nella
città-simbolo dove si assegna il Premio Carlo Magno, Merkel
e Macron, alla
bisogna sovranisti veri, sottoscrivono un trattato
politico-militare che “formalizza quell’idea di Europa core
che finora aveva
avuto cittadinanza solo a livello finanziario”. E gli altri
paesi? O vassalli, o colonie da tenere in riga, meglio se
più povere di
prima. Fantasie? Basta leggere il
testo.
E’ stato il grande assente dalle
cronache politiche di questi giorni, ma è il fatto più
rilevante nella politica europea dopo la Brexit e, “in
qualche misura, ne è una conseguenza diretta” spiega
Alessandro Mangia,
ordinario di diritto costituzionale nell’Università
Cattolica di Milano. Oggi ad Aquisgrana Emmanuel Macron e
Angela Merkel firmeranno un
nuovo Trattato di cooperazione e di integrazione
franco-tedesco. Una firma che dovrebbe sollevare più di un
interrogativo nel ceto
“pensante” dell’europeismo nostrano: proprio nella
città-simbolo dove si assegna il Premio Carlo Magno, Merkel
e Macron, alla
bisogna sovranisti veri, sottoscrivono un trattato
politico-militare che “formalizza quell’idea di Europa core
che finora aveva
avuto cittadinanza solo a livello finanziario”. E gli altri
paesi? O vassalli, o colonie da tenere in riga, meglio se
più povere di
prima. Fantasie? Basta leggere il
testo.
“Quel che è certo – spiega Mangia – è che questo Trattato accelera il processo di disgregazione dell’Unione Europea. Il Regno Unito è stato, fino al 2016, il solo contraltare alla coppia franco-tedesca a livello politico e di occupazione degli spazi burocratici. Usciti di scena gli inglesi, che assieme a Italia, Spagna ed altri paesi potevano fare da contrappeso, gli equilibri di potenza in Europa sono saltati, il quadro è mutato, e lo spazio europeo si è improvvisamente contratto”.
* * * *
E in che modo questo riequilibrio spiegherebbe l’operazione franco-tedesca?
Senza Gran Bretagna, l’Unione non ha capacità di proiezione esterna e il suo spazio di manovra sullo scenario mondiale, che nemmeno prima era granché, si è ulteriormente ristretto. Il Trattato è una manovra classica da arrocco: la mossa difensiva di due potenze diverse, ma entrambe in grande difficoltà fuori dallo scenario europeo.
Leggi tutto
Michael Heinrich: Rileggendo Marx: nuovi testi e nuove prospettive
Rileggendo Marx: nuovi testi e nuove prospettive
di Michael Heinrich*
 Permettetemi
di iniziare con un’osservazione personale sulla mia lettura de
Il capitale. Sono circa 43 anni che leggo Il
capitale, e devo dire che non mi sono ancora annoiato.
Leggerlo è come compiere
un avventuroso viaggio intellettuale, ma per godere appieno di
quest’esperienza è richiesto un tipo di impegno diverso da
quello a cui ci
ha ormai abituato il sistema universitario europeo, per il
quale «leggere» significa solamente individuare in maniera
grossolana alcune
delle tesi principali esposte in un’opera.
Permettetemi
di iniziare con un’osservazione personale sulla mia lettura de
Il capitale. Sono circa 43 anni che leggo Il
capitale, e devo dire che non mi sono ancora annoiato.
Leggerlo è come compiere
un avventuroso viaggio intellettuale, ma per godere appieno di
quest’esperienza è richiesto un tipo di impegno diverso da
quello a cui ci
ha ormai abituato il sistema universitario europeo, per il
quale «leggere» significa solamente individuare in maniera
grossolana alcune
delle tesi principali esposte in un’opera.
Leggere Il capitale significa comprenderne la struttura argomentativa, i diversi livelli di astrazione e, non da ultimo, per un autore come Marx, riconoscere il ruolo giocato dalle metafore all’interno del testo. Marx non ha utilizzato come fonti solo economisti, ma anche filosofi, teologi, e scrittori come Shakespeare e Goethe. Non si tratta solo di abbellimenti destinati al pubblico più colto: molte di queste metafore sono cruciali per comprendere i ragionamenti marxiani.
Di seguito, parlerò in primo luogo di una nuova interpretazione di Marx, e poi di alcuni nuovi testi e intuizioni che potremmo ricavare dalla nuova MEGA.
1. Le vecchie interpretazioni
Se si parla di nuove interpretazioni, devono certamente essercene di vecchie. Le vecchie interpretazioni che ho in mente, sono le letture de Il capitale dominanti nella prima metà del XX secolo. Queste vecchie letture dipendevano dall’intera situazione politico-sociale, dallo stato delle lotte di classe e così via, ma mi limiterò a circoscrivere tre delle caratteristiche che le hanno contraddistinte.
Leggi tutto
Guglielmo Forges Davanzati: I venti anni dell’euro. Un bilancio
I venti anni dell’euro. Un bilancio
di Guglielmo Forges Davanzati
L’euro compie venti anni ed è tempo di stilare un bilancio sull’adozione della moneta unica. Va detto in premessa che alla fine degli anni novanta, vi era un diffuso consenso – anche e soprattutto in Italia – sugli effetti favorevoli che avrebbe comportato l’adozione di una moneta comune. Gli argomenti, in particolare, erano due:
a) si riteneva auspicabile, per ragioni ideali, un’unificazione europea basata sull’assenza di conflitti armati nel continente, in una prospettiva di solidarietà fra i popoli europei sulla scia del Manifesto di Ventotene.
b) Si riteneva necessario – soprattutto nel caso italiano – dotarsi di un ‘vincolo esterno’ (il vincolo del 3% del deficit in rapporto al Pil), che, per così dire, legasse le mani a politici eccessivamente spendaccioni. Questo argomento fu largamente condiviso, soprattutto perché si attribuivano i problemi dell’economia italiana a un debito pubblico eccessivamente alto e perché questo veniva imputato agli eccessi di spesa pubblica improduttiva dei decenni precedenti. Si riteneva anche che la riduzione dei tassi di interesse combinata con l’impossibilità di ricorrere a svalutazioni per recuperare margini di profitto avrebbe incentivato gli investimenti[1].
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Israele, licenza di uccidere
Israele, licenza di uccidere
di Manlio Dinucci
Dopo che Israele ha ufficializzato l’attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria, sui media italiani nessuno ha messo in dubbio il «diritto» di Tel Aviv di attaccare uno Stato sovrano per imporre quale governo debba avere
«Con una mossa davvero insolita, Israele ha ufficializzato l’attacco contro obiettivi militari iraniani in Siria e intimato alle autorità siriane di non vendicarsi contro Israele»: così i media italiani riportano l’attacco effettuato ieri da Israele in Siria con missili da crociera e bombe guidate. «È un messaggio ai russi, che insieme all’Iran permettono la sopravvivenza al potere di Assad», commenta il Corriere della Sera.
Nessuno mette in dubbio il «diritto» di Israele di attaccare uno Stato sovrano per imporre quale governo debba avere, dopo che per otto anni gli Usa, la Nato e le monarchie del Golfo hanno cercato insieme ad Israele di demolirlo, come avevano fatto nel 2011 con lo Stato libico.
Nessuno si scandalizza che gli attacchi aerei israeliani, sabato e lunedì, abbiano provocato decine di morti, tra cui almeno quattro bambini, e gravi danni all’aeroporto internazionale di Damasco, mentre si dà risalto alla notizia che per prudenza è rimasta chiusa per un giorno, con grande dispiacere degli escursionisti, la stazione sciistica israeliana sul Monte Hermon (interamente occupato da Israele insieme alle alture del Golan).
Leggi tutto
Gianfranco Viesti: Verso la secessione dei ricchi
Verso la secessione dei ricchi
di Gianfranco Viesti
L’Italia potrebbe essere investita a breve da un profondo cambiamento nell’organizzazione e nel finanziamento di gran parte dei suoi servizi pubblici, con il decentramento ad alcune regioni tanto di estese competenze quanto di risorse finanziarie assai ingenti (sottratte conseguentemente a tutte le altre). Ma questo tema, di fondamentale importanza e su cui è indispensabile una approfondita discussione culturale e politica, è avvolto nel più totale silenzio.
È comprensibile che la Lega, promotrice e sostenitrice di questo processo, preferisca perseguirlo silenziosamente: sta cercando infatti di acquisire consensi al di là delle sue tradizionali regioni di insediamento, e certo una discussione pubblica non le gioverebbe: farebbe emergere un consistente travaso di risorse finanziarie a favore di Lombardia e Veneto in particolare e a danno di tutte le altre. Quel che colpisce è il totale silenzio degli altri partiti. Di quelli di opposizione, in particolare del Partito democratico: evidentemente incapace di prendere una posizione pubblica; segno, anche questo, della profondissima crisi politica e di valori di riferimento che ne sta paralizzando l’azione. E dei 5 Stelle: che pure dalle regioni del Centro Sud che sarebbero pesantemente penalizzate da questo processo hanno tratto una parte decisiva del loro consenso. Allo stesso modo, totale è il silenzio dei grandi mezzi di informazione, a stampa e radio-televisivi.
Leggi tutto
Paolo Bartolini: Neri o bianchi che siano
![]()
Neri o bianchi che siano
di Paolo Bartolini
Il tema delle migrazioni e dei numerosi esseri umani morti in mare, o lasciati in abbandono tra le onde in attesa di un porto disposto ad accoglierli, meriterebbe un intervento circostanziato e approfondito. Forse non ne sono capace, forse non è questo il luogo adatto. Eppure, per sommi capi, è il caso di specificare qualcosa. Siamo tutti d'accordo, ma con coscienze diverse, sul fatto che molti giovani dovrebbero essere aiutati a non lasciare il loro paese d'origine. Servono investimenti importanti e piani di sviluppo per l'Africa e altri paesi vittime del nostro colonialismo. Ma uno "sviluppo" non all'occidentale, concertato, rispettoso di culture e valori differenti dai nostri. Ci vorranno decenni per impostare politiche siffatte, sempre che chi detiene le leve del comando si decida a fare qualcosa pressato dall'opinione pubblica. Nel mentre i flussi migratori vanno regolati, non c'è dubbio, ma è pazzo chi pensa che possano essere arrestati. I porti chiusi e la retorica di questo governo di signori giallo-verdi sono pura ipocrisia. Fanno voti con la pancia della gente fingendo di avercela con i trafficanti di uomini. La realtà è semplice: nessuno sano di mente dice a queste persone in fuga "Venite tutti da noi e accoglieremo chiunque". Però potremmo dire ben altro, distinguendoci dai razzisti che si riempiono la bocca con il neologismo più stupido degli ultimi lustri: il famigerato "buonismo".
Leggi tutto
Daniele Gullì: La legge di bilancio ai tempi della campagna elettorale permanente e della coperta troppo corta
![]()
La legge di bilancio ai tempi della campagna elettorale permanente e della coperta troppo corta
di Daniele Gullì
Con una lettera scritta il 12 febbraio del 1981 indirizzata al Governatore di Banca d’Italia Carlo Azeglio Ciampi, l’allora Ministro del Tesoro Beniamino Andreatta iniziava quel breve ma tortuoso percorso politico che avrebbe portato ad una delle rivoluzioni istituzionali più importanti ed impattanti della storia della Repubblica italiana: il “divorzio” tra Banca d’Italia e Tesoro. Da quel momento, non avendo la Banca Centrale più l’obbligo di comprare i Titoli di Stato direttamente sul mercato primario, sarà il libero agire del Mercato dei Capitali a fissare il tasso di interesse sui BTP.
Trentasette anni dopo, con una celebrante manifestazione inscenata il 27 settembre del 2018, l’attuale Ministro del Lavoro, nonché leader della forza di maggioranza del sedicente “Governo del cambiamento”, annuncia dai balconi di Palazzo Chigi, tra bandieroni e festanti colleghi, l’accordo raggiunto nel Consiglio dei Ministri in merito alla quota di deficit del Def per il 2019, fissandolo al 2,4% sul Pil. Da quel momento l’andamento crescente dei tassi d’interesse sui BTP riporterà stabilmente lo Spread attorno ai 300 punti base.
Lontani nel tempo, come nelle modalità d’azione, queste due significative vicende segnano i punti estremi delle parabole che hanno avuto economia e comunicazione nella storia politica degli ultimi 40 anni del nostro Paese.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2064
Hits 1952
Hits 1699
Hits 1673
Hits 1659
Hits 1634
Hits 1619
Hits 1599
tonino

coniarerivolta: Cottarelli, il signoraggio e la favola della scarsità delle banane
Cottarelli, il signoraggio e la favola della scarsità delle banane
di coniarerivolta
 L’Enciclopedia Treccani definisce
tabu una “proibizione di carattere magico-religioso
nei confronti di
oggetti, persone, luoghi considerati di volta in volta sacri,
oppure contaminanti, impuri e dunque potenzialmente
pericolosi.” Sembra proprio
che una simile proibizione copra il complesso tema del
rapporto tra banca centrale e debito pubblico, un vero e
proprio tabu che la RAI, in
seconda serata, ha osato provare a scalfire con un brevissimo
servizio del programma “Povera Patria”, il quale aveva ad
oggetto il
cosiddetto ‘signoraggio’, ossia il potere esclusivo di creare
moneta a corso legale detenuto dalle banche centrali. In
appena due
minuti, il
servizio afferma che in Italia questo potere, prima degli anni
Ottanta, veniva sfruttato per finanziare la spesa pubblica in
disavanzo a beneficio
della collettività e senza particolari limitazioni; questo
circolo virtuoso tra creazione di moneta e spesa in disavanzo
sarebbe venuto meno in
seguito a due passaggi fondamentali: prima con il ‘divorzio’
tra Banca d’Italia e Tesoro e poi con l’adesione alla moneta
unica, con la definitiva perdita di sovranità monetaria
connessa alla subordinazione della Banca d’Italia alla Banca
Centrale Europea
(BCE).
L’Enciclopedia Treccani definisce
tabu una “proibizione di carattere magico-religioso
nei confronti di
oggetti, persone, luoghi considerati di volta in volta sacri,
oppure contaminanti, impuri e dunque potenzialmente
pericolosi.” Sembra proprio
che una simile proibizione copra il complesso tema del
rapporto tra banca centrale e debito pubblico, un vero e
proprio tabu che la RAI, in
seconda serata, ha osato provare a scalfire con un brevissimo
servizio del programma “Povera Patria”, il quale aveva ad
oggetto il
cosiddetto ‘signoraggio’, ossia il potere esclusivo di creare
moneta a corso legale detenuto dalle banche centrali. In
appena due
minuti, il
servizio afferma che in Italia questo potere, prima degli anni
Ottanta, veniva sfruttato per finanziare la spesa pubblica in
disavanzo a beneficio
della collettività e senza particolari limitazioni; questo
circolo virtuoso tra creazione di moneta e spesa in disavanzo
sarebbe venuto meno in
seguito a due passaggi fondamentali: prima con il ‘divorzio’
tra Banca d’Italia e Tesoro e poi con l’adesione alla moneta
unica, con la definitiva perdita di sovranità monetaria
connessa alla subordinazione della Banca d’Italia alla Banca
Centrale Europea
(BCE).
Più che il servizio in sé, troviamo davvero interessante il coro di reazioni isteriche che si è immediatamente levato da ogni dove: Davide Serra, Carlo Cottarelli, Luigi Marattin, Mario Seminerio, Riccardo Puglisi e tanti altri si sono gettati nella mischia nel disperato tentativo di screditare le tesi esposte sulla RAI. La tesi di fondo che ha mandato il tilt le tastiere dei liberisti del venerdì sera è l’idea che la monetizzazione del debito pubblico possa funzionare. Quando lo Stato spende risorse, mette in moto l’economia e genera crescita; se quelle risorse, però, sono prelevate dall’economia stessa attraverso tasse e imposte, in ossequio al pareggio di bilancio, allora l’impatto positivo della spesa pubblica sulla crescita ne risulta contenuto.
Leggi tutto
Giacomo Gabellini: Il Venezuela nel mirino
Il Venezuela nel mirino
di Giacomo Gabellini
Lo scatenamento del caos in Venezuela non è spontaneo come si potrebbe credere dalle notizie che vengono diffuse. In una approfondita analisi di Giacomo Gabellini le similitudini con il caso Siria e le rivoluzioni colorate
 La decisione di Trump – e dei suoi alleati
nel continente
latino-americano (Brasile, Argentina, Paraguay,
Colombia), a cui si è aggiunto l’immancabile presidente
canadese Justin Trudeau
– di riconoscere come legittimo leader di Caracas il
capo dell’Assemblea Nazionale Juan Gaidò rischia di far
scivolare la
situazione venezuelana sul piano inclinato della guerra civile
rendendola sempre più affine a quella delineatasi in Siria nel
2011.
Un’analogia che emerge anche – e soprattutto – per quanto
concerne il pesante coinvolgimento degli Stati Uniti
nell’escalation.
La decisione di Trump – e dei suoi alleati
nel continente
latino-americano (Brasile, Argentina, Paraguay,
Colombia), a cui si è aggiunto l’immancabile presidente
canadese Justin Trudeau
– di riconoscere come legittimo leader di Caracas il
capo dell’Assemblea Nazionale Juan Gaidò rischia di far
scivolare la
situazione venezuelana sul piano inclinato della guerra civile
rendendola sempre più affine a quella delineatasi in Siria nel
2011.
Un’analogia che emerge anche – e soprattutto – per quanto
concerne il pesante coinvolgimento degli Stati Uniti
nell’escalation.
Nei mesi scorsi, Washington ha infatti cercato accanitamente di privare il presidente Nicolas Maduro dell’appoggio interno istituendo il divieto per cittadini e imprese Usa di fare affari con lui e la sua cerchia, decretando il congelamento dei beni venezuelani che si trovavano sotto la giurisdizione statunitense e varando misure dirette contro il settore petrolifero – che a causa dell’impossibilità di accedere alle tecnologie straniere ha dimezzato la produzione – e le forze armate. Le agenzie di rating, dal canto loro, hanno collaborato all’offensiva decretando una serie di declassamenti del debito venezuelano rendendo alquanto difficile per le autorità di Caracas il compito di piazzare i titoli di Stato. Combinandosi con le misure di Trump, le quali hanno impedito l’acquisto di debito venezuelano, di titoli della società pubblica che controlla il petrolio, di ogni altra impresa venezuelana e di società a partecipazione pubblica, nonché bloccato ogni finanziamento in dollari al Paese, le bordate delle agenzie di rating hanno avuto l’effetto di estromettere il Venezuela dal mercato internazionale dominato dal dollaro. A risentirne, ha rilevato l’ambasciatore del Venezuela in Italia Juliàn Isaìas Rodrìguez Dìaz durante un convegno a Roma, sono state «le importazioni di cibo, medicinali, pezzi di ricambio e così via. Si tratta dei provvedimenti punitivi più gravosi che abbiano mai colpito un Paese latino-americano nell’intera storia del Sud America; peggiori rispetto a quelle comminate contro Cuba».
Leggi tutto
Ivan Cavicchi: Regionalismo differenziato: il ministro Grillo sta avallando la fine del Ssn
Regionalismo differenziato: il ministro Grillo sta avallando la fine del Ssn
di Ivan Cavicchi
Sul regionalismo differenziato serve una mediazione intelligente ma serve anche qualcuno in grado di proporla. Il governo, quindi il presidente del consiglio dei ministri Conte, prenda in mano la questione perché se essa ci sfugge di mano sono dolori per tutti
 Relativamente alle dichiarazioni fatte ieri dal
ministro Grillo sul
regionalismo differenziato (QS 23
gennaio 2019) rispondo: no, caro ministro Grillo tra “il
rischio di una giungla normativa” e quello di “non
erogare i servizi” ci dovrebbe essere un ministro della Salute
capace di fare il suo mestiere con intelligenza, con onestà
intellettuale,
con spirito riformatore e soprattutto con coerenza nei
confronti del mandato politico che ha ricevuto dai propri
elettori, nell’interesse
primario del suo governo e del suo paese.
Relativamente alle dichiarazioni fatte ieri dal
ministro Grillo sul
regionalismo differenziato (QS 23
gennaio 2019) rispondo: no, caro ministro Grillo tra “il
rischio di una giungla normativa” e quello di “non
erogare i servizi” ci dovrebbe essere un ministro della Salute
capace di fare il suo mestiere con intelligenza, con onestà
intellettuale,
con spirito riformatore e soprattutto con coerenza nei
confronti del mandato politico che ha ricevuto dai propri
elettori, nell’interesse
primario del suo governo e del suo paese.
Lei come ministro dovrebbe, prima di ogni cosa fare il suo dovere quindi proporci politiche adeguate per evitare sia la giungla normativa che la non erogazione dei servizi.
Se non è il governo a farlo mi dica ministro, chi dovrebbe farlo?
Che senso ha far fare alle regioni quello che dovrebbe fare lei come governo ma che non fa?
La mia impressione è che lei:
- non abbia ancora capito che il regionalismo differenziato è la modifica del riparto costituzionale delle competenze in materia di salute tra Stato e regioni cioè è la rinuncia da parte dello Stato centrale quindi del governo di potestà legislative, senza le quali questo sistema smette di essere universalistico
- non abbia ancora capito che l’autonomia differenziata consente l'attribuzione alle regioni di competenze statali relative ai principi fondamentali in materia di salute e ricerca scientifica e che grazie a questa attribuzione il SSN non ci sarà più
Lei ministro Grillo sta avallando la fine del SSN. Se ne rende conto o no?
Leggi tutto
Thomas Fazi: "Le ineffabili "catene globali del valore"
"Le ineffabili "catene globali del valore"
Tallone d'Achille degli oppositori della moneta unica?
di Thomas Fazi
C'è una tesi molto diffusa in ambito altreuropeista, cioè tra coloro che riconoscono i difetti dell'Unione europea e in particolare della moneta unica ma che ritengono velleitario e controproducente l'ipotesi di un recupero della sovranità nazionale - e in particolare della sovranità monetaria - in un contesto globale di integrazione economica sempre più profonda, esemplificata dalla diffusione delle cosiddette "catene globali del valore", cioè dalla dispersione internazionale della produzione (sarebbe a dire che è ormai comune per molti paesi esportare prodotti che a loro volta contengono componenti importati da altri paesi, ecc.).
L'assunto di fondo di questa argomentazione è che tale livello di integrazione produttiva presuppone inevitabilmente un movimento verso forme sempre più avanzate di integrazione commerciale (come il mercato unico europeo) e monetaria (come, appunto, l'euro) e che - per contro - le monete nazionali, i cambi fluttuanti e più in generale qualunque ostacolo posto alla libera circolazione delle merci e dei capitali sono da intendersi come fondamentalmente incompatibili con la "globalizzazione" e con il commercio internazionali e condurrebbero presumibilmente all'autarchia. Da cui la netta - e comprensibile, secondo tale logica - opposizione a qualunque ipotesi di fuoriuscita dalla moneta unica.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Francia: la prima “assemblea delle assemblee” dei Gilets Jaunes
Francia: la prima “assemblea delle assemblee” dei Gilets Jaunes
di Giacomo Marchetti
Sabato 26 gennaio a Commercy si è svolta la prima “assemblea delle assemblee” del movimento dei Gilets Jaunes. Questa prima tappa di confronto e di coordinamento nazionale ha visto discutere circa 75 realtà territoriali che hanno espresso una delegazione (un uomo ed una donna).
Chi ha introdotto l’assemblea ha ricordato la natura “processuale” data a questa esperienza, che è un vero e proprio laboratorio di educazione politica, come ha detto un GJ intervenuto: “la democrazia non è facile, bisogna impararla”.
La sala che ha ospitato l’incontro era stipata, oltre i portavoce erano presenti osservatori e operatori dell’informazione anche a livello internazionale, che hanno potuto partecipare al meeting e filmare solo nella prima delle tre fasi dell’incontro, a differenze degli organi d’informazione dei GJ.
Questa prima giornata, dopo l’accoglienza mattutina e il pranzo, ha visto prendere voce realtà dei GJ di tutto l’Esagono, che hanno relazionato sull’attività svolta facendo una breve storia delle mobilitazioni locali, affrontando poi i punti previsti dall’ordine del giorno e che saranno maggiormente sviscerati nei differenti gruppi tematici la domenica.
Leggi tutto
Francesco Asante: “Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web” di Nick Srnicek
“Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web” di Nick Srnicek
di Francesco Asante
Recensione a: Nick Srnicek, Capitalismo digitale. Google, Facebook, Amazon e la nuova economia del web, LUISS University Press, Roma, 2017, pp. 136, 12 euro (scheda libro)
Platform Capitalism, tradotto in Italia con il titolo Capitalismo digitale. Google, Facebook Amazon e la nuova economia del web è un testo di Nick Srnicek, pubblicato nel 2016 ed edito in Italia nel 2017 dalla Luiss University Press. Esso è un tentativo di lettura del ruolo delle piattaforme come elementi che compongono il paesaggio economico contemporaneo, in riferimento a quella che viene definita economia digitale.
Con questo termine non si intende soltanto l’idea che l’economia odierna sia sempre più basata sull’impiego di canali digitali, e quindi sul progressivo ridursi del contatto fisico tra i soggetti del processo economico; né indica il settore tecnologico così come definito dalle classificazioni standard[1], il cui sviluppo ne costituisce la base, ma non ne esaurisce il senso. Con economia digitale Srnicek si riferisce a «quel tipo di imprese che sempre più fanno affidamento sulla information technology, sui dati e su internet per il proprio modello di business»[2].
L’oggetto del testo sono quindi le piattaforme, considerate in relazione al loro progressivo configurarsi come infrastruttura dell’economia presa nel suo complesso.
Leggi tutto
Andrea Muratore: L’Fmi non ne becca una: 100% di stime errate
L’Fmi non ne becca una: 100% di stime errate
di Andrea Muratore
L’economia è il regno dell’incertezza e, anzi, un celebre adagio che circola tra gli addetti ai lavori nella disciplina sottolinea come il ruolo dell’economista sia quello di spiegare domani perché ieri non si è riusciti a prevedere ciò che sarebbe accaduto oggi. Una battuta che basterebbe da sola a mettere nell’angolo coloro che si ostinano a ritenere l’economia una branca delle hard sciences, una disciplina maneggiabile attraverso stime, regressioni e modelli capaci di avere il crisma dell’universalità, come esperimenti ripetuti in laboratorio.Questo, nelle intenzioni di una serie di economisti di origine o formazione anglosassone, svilisce l’economia negandone il ruolo di scienza sociale, intrinsecamente connessa al contesto in cui un sistema viene ad emergere e a precise dinamiche politiche. La volontà di governare l’economia con equazioni e modelli considerati universalmente validi porta a negare i presupposti politici che, ad esempio, spingono a definire in maniera più o meno elevato l’effetto di moltiplicazione che un aumento o diminuzione della spesa pubblica avrà sul totale del Pil (tragicamente previsto al ribasso dal team Fmi che nel 2010 si occupò della Grecia) o concetti come quello di “Pil potenziale” e output gap alla base della recente diatriba tra governo italiano e Commissione Europea sulla manovra.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Tempo astratto e tempo rivoluzionario
![]()
Tempo astratto e tempo rivoluzionario
di Salvatore Bravo
Il tempo del capitalismo assoluto è il tempo astratto. La percezione del tempo si fa concreta nella consapevolezza dell’aprirsi al mondo, nel tempo della partecipazione al mondo ed a se stessi, è il tempo vissuto, in cui il fluire si organizza non nella dispersione di sé, ma nel raccoglimento, nel processo di soggettivizzazione attiva. Il tempo diviene, così, dimensione della qualità dialogica e dialettica che accoglie il mondo, le rappresentazioni, i suoi stereotipi per rielaborarli nella creatività. C’ è un tempo rivoluzionario, in cui il soggetto, non più individuo, atomo nel mondo al traino delle forze dei modi di produzione, diventa persona per vivere la soggettività autentica e condividerla. L’individualismo, espressione sostanziale del turbo capitalismo, si caratterizza per la temporalità generica ed astratta, il soggetto non vive il proprio tempo, ma il tempo del modo di produzione, vive al ritmo del dicitur, non osa essere libero. Gli è sconosciuta la dimensione interiore, del conflitto tra la rappresentazione del mondo e l’elaborazione personale e condivisa di un'altra modalità di vivere e rapportarsi al mondo. Il tempo fluido, martellante, fa del soggetto una parte organica del sistema, è il tempo del silenzio, non vi sono parole, ma solo silenzi. La caverna di Platone non è solo buio ed immagini, è il silenzio del tempo che scorre senza la dimensione del simbolico. Il tempo dei dormienti è l’invisibile forma che assume il nichilismo, avvolge, rassicura con un fluire che mentre chiede tutto, svuota il soggetto della sua capacità simbolica.
Leggi tutto
Thomas Fazi: Signoraggio, "divorzio" e debito pubblico
![]()
Signoraggio, "divorzio" e debito pubblico
Facciamo chiarezza una volta per tutte
di Thomas Fazi
 Sta facendo molto discutere il servizio di
Alessandro Giuli sulle origini del debito
pubblico italiano andato in onda qualche giorno fa all’interno
del nuovo programma di Rai 2, “Povera Patria”. Secondo i
critici
– tra cui luminari dell’economia come Riccardo Puglisi, Mario
Seminerio e, ça va sans dire, l’immancabile Luigi Marattin -,
le colpe del servizio sarebbe sostanzialmente tre: di aver
“propagandato” sulla televisione pubblica la presunta madre di
tutte le bufale
economiche: il signoraggio (ussignor!); di aver individuato
nel cosiddetto “divorzio” del 1981 tra Banca d’Italia (BdI) e
Tesoro la
causa principale della successiva esplosione del debito
pubblico italiano; e di aver insinuato – seppur indirettamente
– che la soluzione
al problema del debito pubblico sarebbe di tornare ad un
regime simile a quello pre-divorzio, cioè di monetizzazione
(più o meno
parziale) del deficit/debito pubblico da parte della banca
centrale.
Sta facendo molto discutere il servizio di
Alessandro Giuli sulle origini del debito
pubblico italiano andato in onda qualche giorno fa all’interno
del nuovo programma di Rai 2, “Povera Patria”. Secondo i
critici
– tra cui luminari dell’economia come Riccardo Puglisi, Mario
Seminerio e, ça va sans dire, l’immancabile Luigi Marattin -,
le colpe del servizio sarebbe sostanzialmente tre: di aver
“propagandato” sulla televisione pubblica la presunta madre di
tutte le bufale
economiche: il signoraggio (ussignor!); di aver individuato
nel cosiddetto “divorzio” del 1981 tra Banca d’Italia (BdI) e
Tesoro la
causa principale della successiva esplosione del debito
pubblico italiano; e di aver insinuato – seppur indirettamente
– che la soluzione
al problema del debito pubblico sarebbe di tornare ad un
regime simile a quello pre-divorzio, cioè di monetizzazione
(più o meno
parziale) del deficit/debito pubblico da parte della banca
centrale.
Tanto per cominciare, cosa dice il servizio? Esso sostiene che le cause del debito pubblico italiano sarebbero da sostanzialmente da rintracciarsi nel signoraggio, che viene descritto – in maniera a dir poco approssimativa – come «il guadagno del “signore” che stampa la nostra moneta, che si fa pagare il valore di quella moneta, da cui sottrae il costo per produrla». Il servizio sostiene che la storia del signoraggio in Italia si snoda in tre fasi: una prima fase in cui lo Stato italiano, «attraverso la banca centrale di sua proprietà stampa moneta e la presta a se stesso per offrire servizi e [finanziare le opere pubbliche]»; una seconda fase in cui – come conseguenza del divorzio – «la banca centrale diventa un istituto privato ma continua a stampare moneta prestandola allo Stato con tanto di interessi», facendo così lievitare il debito pubblico; e una terza fase in cui «la fine della lira, l’adozione dell’euro e la nascita della BCE completano l’espropriazione [della sovranità dell’Italia]».
Leggi tutto
Maria Grazia Meriggi: La giornata lavorativa
La giornata lavorativa
di Maria Grazia Meriggi*
 Parlerò da storica soprattutto e quindi
cercando di dare conto della
pertinenza delle analogie ed esemplificazioni storiche che
Marx fornisce intorno al tema della giornata lavorativa e
ricordando inoltre, per
semplificare, che la durata cronologica della giornata
lavorativa, legale e poi anche contrattuale, è il frutto dei
rapporti di forza prodotti
nel conflitto di classe. Si inizia a definire che cos’è – al
di sotto dell’evidenza empirica e contrattuale – la
giornata lavorativa.
Parlerò da storica soprattutto e quindi
cercando di dare conto della
pertinenza delle analogie ed esemplificazioni storiche che
Marx fornisce intorno al tema della giornata lavorativa e
ricordando inoltre, per
semplificare, che la durata cronologica della giornata
lavorativa, legale e poi anche contrattuale, è il frutto dei
rapporti di forza prodotti
nel conflitto di classe. Si inizia a definire che cos’è – al
di sotto dell’evidenza empirica e contrattuale – la
giornata lavorativa.
Una precisazione si rende però necessaria. Dei molti modi in cui sono presenti le narrazioni storiche nel Capitale ne sottolineo soprattutto due. Marx talvolta riassume e sintetizza comprimendo nel tempo in una narrazione in raccourci vicende che si sono sviluppate secondo le linee di tendenza da lui indicate in un lungo arco di tempo. Esempio caratteristico: l’accumulazione originaria in cui Marx comprime il passaggio secolare dall’agricoltura di villaggio con ampie aree comuni alla formazione di una eccedenza di popolazione che alimenta il proletariato industriale passando attraverso le enclosures. Agli inizi del Novecento Paul Mantoux (1906) ha ricostruito analiticamente i passaggi indicati da Marx, attraverso la formazione di un numeroso proletariato di salariati agricoli, attestandone anche la lucidità interpretativa. Altre volte invece – come nel caso di questo capitolo – Marx descrive processi in atto e ricorre a fonti di prima mano che sono le stesse cui ricorrono anche gli storici successivi dell’economia e della società inglesi ed europee del XIX secolo. Queste fonti sono gli atti ufficiali e i materiali statistici prodotti dagli ispettorati del lavoro che di mano in mano si formano presso i ministeri economici. In particolare i famosi blue books, i «libri azzurri» degli ispettori incaricati di verificare il rispetto della legislazione sulle fabbriche. In questo caso Marx è al tempo interprete e cronista appassionato dei processi che descrive con grande fedeltà.
Leggi tutto
Sandro Mezzadra e Maurizio Ricciardi: Nel segno del “Sessantotto”
Nel segno del “Sessantotto”
di Sandro Mezzadra e Maurizio Ricciardi*
Abstract. Questa introduzione apre il numero monografico tracciando un percorso che parte dal Sessantotto per arrivare al neoliberalismo come sua risposta più articolata, senza la pretesa di darne un quadro esaustivo bensì per illuminare la complessità e la radicalità di una cesura. In questa ricostruzione il Sessantotto comincia molto prima, tanto che non è possibile stabilirne una data e un luogo d’inizio precisi. La contestazione dell’autorità, la messa in discussione del patriarcato, l’attivazione di soggetti eterogenei e spesso “imprevisti”: la critica spietata dell’esistente produce una crisi di legittimità che investe lo Stato, la società, il capitalismo e la scienza. In questo senso il Sessantotto si è dato come rivoluzione incompleta e anche per questo mai terminata
 1. Il “Sessantotto”, a
cui è dedicata questa sezione di «Scienza & Politica», non
può
certo essere ridotto a un anno solare – e deve dunque
necessariamente essere scritto tra virgolette. È cominciato
molto prima di
quell’anno e non è possibile stabilirne una data e un luogo
d’inizio assoluti. Dien Bien Phu e la battaglia d’Algeri,
l’avvio della decolonizzazione in Africa con l’indipendenza
del Ghana, le poteste di Berkeley e i freedom riders
nel sud degli
Stati Uniti, il movimento del black power, la
conferenza tricontinentale a L’Avana, le lotte operaie in
Italia nei primi anni Sessanta,
l’instaurazione della Comune di Shangai all’inizio del 1967,
la manifestazione del 2 giugno di quello stesso anno contro lo
Scià di
Persia a Berlino, durante la quale la polizia uccise lo
studente Benno Ohnesberg: sono solo alcune istantanee, utili
per dare conto della
complessità della genealogia del Sessantotto per quanto
riguarda sia le sue geografie sia le sue determinazioni
soggettive. La lista potrebbe
continuare, e sarebbe altrettanto facile nominare alcuni
momenti iconici dell’anno 1968 – dalla “battaglia di Valle
Giulia”
tra studenti e polizia a Roma alle barricate del Maggio
parigino, dal massacro di Tlatelolco in Messico il 2 ottobre
alle mobilitazioni studentesche
in Polonia, Jugoslavia e Giappone, dai ghetti in fiamme dopo
l’omicidio di Martin Luther King ai pugni guantati di nero
alzati al cielo da
Tommie Smith e John Carlos durante le Olimpiadi di Città del
Messico, dall’assalto al grattacielo di Springer a Berlino
alle rivolte
studentesche, operaie e contadine a Calcutta e nel Bengala
occidentale. E ancora: il Sessantotto è andato ben oltre la
fine dell’anno
solare, per esempio con il Cordobazo, la grande insurrezione
di operai e studenti che destabilizzò la dittatura di Onganía
in Argentina
nel maggio del 1969, con la rivolta operaia in Corso Traiano a
Torino, seguita dall’Autunno caldo nel 196970, con la
tumultuosa crescita in
tutto il mondo del femminismo, con il trionfo dei Vietcong nel
1975, con il movimento del ‘77 in Italia.
1. Il “Sessantotto”, a
cui è dedicata questa sezione di «Scienza & Politica», non
può
certo essere ridotto a un anno solare – e deve dunque
necessariamente essere scritto tra virgolette. È cominciato
molto prima di
quell’anno e non è possibile stabilirne una data e un luogo
d’inizio assoluti. Dien Bien Phu e la battaglia d’Algeri,
l’avvio della decolonizzazione in Africa con l’indipendenza
del Ghana, le poteste di Berkeley e i freedom riders
nel sud degli
Stati Uniti, il movimento del black power, la
conferenza tricontinentale a L’Avana, le lotte operaie in
Italia nei primi anni Sessanta,
l’instaurazione della Comune di Shangai all’inizio del 1967,
la manifestazione del 2 giugno di quello stesso anno contro lo
Scià di
Persia a Berlino, durante la quale la polizia uccise lo
studente Benno Ohnesberg: sono solo alcune istantanee, utili
per dare conto della
complessità della genealogia del Sessantotto per quanto
riguarda sia le sue geografie sia le sue determinazioni
soggettive. La lista potrebbe
continuare, e sarebbe altrettanto facile nominare alcuni
momenti iconici dell’anno 1968 – dalla “battaglia di Valle
Giulia”
tra studenti e polizia a Roma alle barricate del Maggio
parigino, dal massacro di Tlatelolco in Messico il 2 ottobre
alle mobilitazioni studentesche
in Polonia, Jugoslavia e Giappone, dai ghetti in fiamme dopo
l’omicidio di Martin Luther King ai pugni guantati di nero
alzati al cielo da
Tommie Smith e John Carlos durante le Olimpiadi di Città del
Messico, dall’assalto al grattacielo di Springer a Berlino
alle rivolte
studentesche, operaie e contadine a Calcutta e nel Bengala
occidentale. E ancora: il Sessantotto è andato ben oltre la
fine dell’anno
solare, per esempio con il Cordobazo, la grande insurrezione
di operai e studenti che destabilizzò la dittatura di Onganía
in Argentina
nel maggio del 1969, con la rivolta operaia in Corso Traiano a
Torino, seguita dall’Autunno caldo nel 196970, con la
tumultuosa crescita in
tutto il mondo del femminismo, con il trionfo dei Vietcong nel
1975, con il movimento del ‘77 in Italia.
Leggi tutto
Dario Gentili: Politica e inoperosità
Politica e inoperosità
di Dario Gentili
L’edizione integrale pubblicata da Quodlibet rappresenta di Homo sacer, per usare i termini dello stesso Giorgio Agamben, l’edizione «definitiva, aumentata e corretta». Per quanto Agamben abbia in più occasioni precisato che il progetto ventennale di Homo sacer sia da considerare concluso in quanto «abbandonato», ciò non toglie che l’edizione Quodlibet è definitiva quantomeno poiché consente di considerare l’opera nella sua unitarietà. È invece ancora presto per dire quale contributo specifico questa edizione possa apportare alla ricezione di Homo sacer, che, nei più di vent’anni trascorsi dalla pubblicazione del primo libro del progetto (col sottotitolo Il potere sovrano e la nuda vita, Einaudi 1995), ha già una propria storia. Infatti, le figure di pensiero di Homo sacer – solo per nominarne alcune: la nuda vita, lo stato d’eccezione, la teologia economica, la forma di vita, l’uso – hanno caratterizzato già diverse fasi della sua ricezione. Fasi diverse per quanto diversa era la congiuntura storica, politica ed economica su cui ognuno dei nove volumi del progetto è intervenuto, portandola a «leggibilità». Insomma, difficile se non impossibile è stabilire ora come un’edizione definitiva possa configurare ed eventualmente modificare o spingere a riconsiderare la storia della ricezione di Homo sacer. Per questo, ci sarà tempo – un tempo che, come un’edizione definitiva esige, non può essere esclusivamente quello della congiuntura attuale. Preferibile è allora soffermarsi sull’altro termine con cui Agamben contraddistingue questa edizione: «aumentata».
Leggi tutto
Enzo Pennetta: Il neoliberismo non esiste
Il neoliberismo non esiste
di Enzo Pennetta
L’esponente dell’Istituto Bruno Leoni (Andrea Mingardi) e il politologo del Corriere, Angelo Panebianco, spiegano che le paure delle persone sono ingiustificate e che inoltre tendono a creare nemici più o meno immaginari, uno di questi è il neoliberismo.
Che però non esiste
Uno degli aspetti della narrazione neo-darwinista che sono stati messi in evidenza da subito sia qui su CS che nel libro “Inchiesta sul darwinismo”, è che una volta fatta passare l’organizzazione capitalista e in seguito neoliberista, come semplici manifestazioni di leggi della natura, sarebbe stato impossibile criticare questi sistemi senza passare per qualcuno che nega la realtà naturale.
A conferma di ciò vediamo in questo estratto della presentazione de libro “La verità vi prego sul neoliberismo”, il Presidente dell’Istituto Bruno Leoni, Alberto Mingardi (autore), e Angelo Panebianco, politologo firma del Corriere della Sera, affermare che il neoliberismo semplicemente “non esiste”, che è solo la proiezione delle nostre paure.
Leggi tutto
Fabrizio Poggi: Venezuela: la 'democrazia' criminale del PD
Venezuela: la 'democrazia' criminale del PD
di Fabrizio Poggi
Non che qualcuno dubitasse o avvertisse il bisogno di conferme della posizione che avrebbero assunto i liberal-democristiani del PD sul tentativo di golpe in atto in Venezuela. L'esperienza, a proposito delle loro sortite “pacifiste”, è stata sempre, interamente, a senso unico: Libia, Siria, Ucraina, per non andare tanto indietro nel tempo – tipo, ex Jugoslavia.
Ma loro hanno voluto ugualmente farsi notare per quei “democratici” che sono. E allora ecco che citano nomi, cognomi e indirizzi di arcangeli e giardini dell'eden liberale d'Europa e d'America, schierati “a difesa della democrazia” e di “libere elezioni”; e al contempo additano al pubblico ludibrio i mefistofili orientali o mediorientali dal piede caprino, che danzano attorno al “dittatore Maduro”. La qual cosa, a loro dire, dovrebbero confermare la stretta osservanza ai “principi della democrazia” degli uni, di contro all'infernale ghigno “dittatoriale” degli altri.
Nel mezzo, ovviamente, il “popolo”: oppresso, affamato, ridotto in schiavitù dai demoni che requisiscono, statalizzano, collettivizzano tutti i beni del paese; un “popolo” chiamato alla riscossa della “democrazia”, della “libertà del mercato”, delle “libere elezioni” dagli arcangeli dei parlamenti “liberamente eletti”.
Leggi tutto
Franco Piperno: Per una critica della scienza e dello scientismo: Burioni chi?
Per una critica della scienza e dello scientismo: Burioni chi?
di Franco Piperno
Abbiamo chiesto a Franco Piperno un contributo a partire dal “Patto trasversale per la scienza” promosso da Roberto Burioni che ha messo d'accordo tutti, da Grillo a Renzi. Tale patto è un modo per dire che il sapere scientifico divulgato da Burioni e company non può essere messo in discussione, che la scienza che loro diffondono è al di sopra di ogni discussione politica, perciò neutra, oggettiva, insindacabile. Ci sembra che, al di là delle mistificazioni buone per la sinistra, la realtà sia un’altra: Burioni non sta difendendo la scienza in maniera astratta, ma il potere che da essa ne deriva, il fatto che a parlare di scienza sia solo un’èlite al servizio dell’accumulazione di capitale e di dominio. In parole povere: difendere la scienza diventa un modo per giustificare un intero sistema politico, economico, di comando.
La sinistra e molti compagni fungono da utili idioti, appoggiano in pieno questa visione distorta: basti pensare agli atteggiamenti che hanno nei confronti dei No Vax che, al di là di posizioni talora ben più che discutibili, sono trattati meramente come una massa di incolti barbari. Andando oltre la questione specifica, ci pare che si dovrebbe ragionare sulla messa in discussione dell'autorità medica, dei saperi istituzionali e della neutralità dei responsi della scienza, ed è curioso che chi da anni cita Foucault ora irrida a una cosa che dovrebbe far riflettere in tale direzione. Il risultato è il ritorno al potere oggettivo del progresso e della scienza, cioè alla ragione illuminista – che poi, del resto, è la natura della sinistra.
Leggi tutto
Ascanio Bernardeschi: Con la recessione alle porte non basta stampare moneta
Con la recessione alle porte non basta stampare moneta
di Ascanio Bernardeschi
Gli ultimi dati congiunturali annunciano la recessione. Il quantitative easing di Draghi non ha risolto niente. Serve una politica di investimenti pubblici e di equità fiscale: l’opposto della manovra del governo
La nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza (NaDef), nella sua versione iniziale, prevedeva per il 2019 una crescita del Pil reale dell’1,5%. Ai dubbi dell’Ufficio parlamentare di bilancio, il ministro replicò: “La previsione di una crescita del Pil reale dell’1,5 per cento nel 2019 è corretta” [1].
Tuttavia, in sede di approvazione della legge di bilancio definitiva, dopo la nota della Commissione europea e la successiva trattativa, tale previsione venne ridotta a un più mite 0,9%, che comunque si sta dimostrando eccessivamente ottimistico. Infatti, nubi oscure si aggirano su cieli d’Europa che preannunciano una nuova recessione, ammesso che davvero ci sia stata la ripresina. Ce lo comunica, fra gli altri, Alessandro Penati sul Sole 24 ore del 15 gennaio scorso, che considera la recessione dell’Eurozona, “una quasi certezza” [2].
L’articolista osserva che già nel terzo trimestre del 2018 Germania e Italia avevano avuto non una crescita ma una caduta del Pil. Per la Germania la diminuzione è stata dello 0,2%, con un aumento del 7% delle produzioni rimaste invendute. Per l’Italia l’Istatcertifica un calo dello 0,1% e un più sensibilmente accentuato peggioramento nel mese di Ottobre [3].
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2104
Hits 1976
Hits 1733
Hits 1726
Hits 1655
Hits 1654
Hits 1653
Hits 1582
tonino

Carlo Formenti: Il socialismo è morto. Viva il socialismo
Il socialismo è morto. Viva il socialismo
di Carlo Formenti
Pubblichiamo la prefazione del nuovo libro di Carlo Formenti. Come lui stesso afferma, “se “La variante populista” aveva suscitato un vivace dibattito, questo non mancherà di provocarne uno ancora più feroce. Per rendervene conto vi basterà dare un’occhiata alla Prefazione”
 Prefazione
Prefazione
Secondo gli storici, la formula rituale “il re è morto, viva il re” sarebbe stata recitata per la prima volta nelle corti francesi del tardo medioevo, per poi diffondersi in altre nazioni europee. Questa ricostruzione storica mi interessa relativamente; più importante – considerato il titolo che ho scelto di dare a questo libro – mi sembra invece ragionare sul senso e sulla funzione dell’atto linguistico in questione. Il significato più banale è rintracciabile nella versione popolare che ne è stata coniata con il detto “morto un papa se ne fa un altro”: questa volgarizzazione ha il merito di mettere l’accento sulla continuità di un’istituzione (la Chiesa) che sopravvive nel tempo, trascendendo i singoli individui (i papi) chiamati di volta in volta a incarnarne l’esistenza e l’unità (senza dimenticare la valenza ironica del proverbio: cambiano gli interpreti, ma non cambia lo spartito di un potere che opprime chi sta sotto). Il tema della continuità è ancora più pregnante nella versione originale: dal momento che la vita stessa dell’istituzione monarchica è indissolubilmente associata al corpo del re, occorre che non si dia cesura temporale fra dipartita del sovrano e ascesa al trono del successore. Di qui, da un lato, l’ossessione per le politiche familiari intese a garantire la nascita di uno o più eredi al trono, dall’altro lato – considerato il rischio di intrighi, conflitti dinastici, ecc. da cui possono derivare vuoti di potere e guerre di successione -, il tono imperativo che affiora dietro le parole: “il re è morto, viva il re” è una frase performativa che intende non solo asserire, ma creare una situazione di fatto: la successione è avvenuta, l’unità dello stato è garantita.
Dal momento che non è mai facile sbarazzarsi del peso della tradizione, voglio sgombrare il campo da possibili equivoci. In primo luogo, scegliendo di titolare questo lavoro “Il socialismo è morto, viva il socialismo” non avevo in testa alcun intento ironico (non riusciremo mai a liberarci di questo mito, o simili); ma soprattutto non avevo alcuna intenzione di rivendicare una continuità: questo perché è mia convinzione che il socialismo sia realmente morto nelle forme storiche che ha conosciuto dalle origini ottocentesche all’esaurirsi delle spinte egualitarie novecentesche, prolungatesi per pochi decenni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale.
Leggi tutto
Enrico Grazzini: Quantitative easing: un bilancio fallimentare
Quantitative easing: un bilancio fallimentare
di Enrico Grazzini
 Quale è il bilancio finale del Quantitative
Easing? Ha funzionato oppure
no, nell'eurozona e in Italia? Il QE appena terminato è stato
sufficiente per evitare una nuova crisi dell'eurozona? La
risposta non può
che essere negativa. Il programma di espansione monetaria
lanciato dalla Banca Centrale Europea nel marzo 2015 e
terminato alla fine di dicembre 2018
ha creato dal nulla moneta per ben 2600 miliardi di euro: una
somma enorme, pari a circa il 20% del PIL dell'eurozona!
Questa colossale
liquidità è stata immessa a favore delle maggiori banche
dell'area euro con l'obiettivo ufficiale di contrastare le
tendenze
deflazionistiche e produrre reflazione. Quale il risultato? Il
QE ha temporaneamente salvato l'eurozona ma gli effetti del QE
sono complessivamente
molto deludenti. L'euro è sempre a rischio e l'eurozona
potrebbe presto subire una nuova crisi. Nonostante il QE tutte
le previsioni e tutti
gli indici sono in netto peggioramento.
Quale è il bilancio finale del Quantitative
Easing? Ha funzionato oppure
no, nell'eurozona e in Italia? Il QE appena terminato è stato
sufficiente per evitare una nuova crisi dell'eurozona? La
risposta non può
che essere negativa. Il programma di espansione monetaria
lanciato dalla Banca Centrale Europea nel marzo 2015 e
terminato alla fine di dicembre 2018
ha creato dal nulla moneta per ben 2600 miliardi di euro: una
somma enorme, pari a circa il 20% del PIL dell'eurozona!
Questa colossale
liquidità è stata immessa a favore delle maggiori banche
dell'area euro con l'obiettivo ufficiale di contrastare le
tendenze
deflazionistiche e produrre reflazione. Quale il risultato? Il
QE ha temporaneamente salvato l'eurozona ma gli effetti del QE
sono complessivamente
molto deludenti. L'euro è sempre a rischio e l'eurozona
potrebbe presto subire una nuova crisi. Nonostante il QE tutte
le previsioni e tutti
gli indici sono in netto peggioramento.
In effetti la BCE ha messo una enorme pezza solo per salvare le banche afflitte dal peso dei titoli tossici (comprati soprattutto dagli USA al tempo dei subprime e pari a 6800 miliardi, una somma astronomica concentrata per il 75% soprattutto negli istituti di Germania e Francia) e dei crediti deteriorati (900 miliardi); e per salvare gli stati in forte difficoltà di bilancio – Spagna, Portogallo, Irlanda, Italia – o in via di fallimento, come la Grecia. Tuttavia la banca centrale europea non è riuscita a centrare né l'obiettivo ufficiale del QE – inflazione stabilmente sotto, ma vicino al 2% - né l'obiettivo strategico: l'eurozona infatti è sempre in crisi e gli indicatori dell'economia sono ancora pericolosamente declinanti.
Del resto probabilmente la BCE non poteva fare molto meglio di quanto è riuscita a fare. La BCE è infatti una banca centrale dimezzata: a differenza di tutte le altre banche centrali, in base al suo Statuto deciso a Maastricht non può aiutare gli stati in difficoltà stampando moneta per monetizzare il loro debito pubblico.
Leggi tutto
Thierry Drapeau: L’anti-colonialismo di Karl Marx
L’anti-colonialismo di Karl Marx
di Thierry Drapeau
Dopo l'incontro con il movimento cartista e il poeta Ernest Jones, il filosofo tedesco maturò la convinzione dell'importanza delle caratteristiche multirazziali della classe e delle lotte contro la schiavitù, per combattere il capitalismo
 Nel suo film
Il giovane Marx, il regista Raoul Peck include una
scena in cui un francese di discendenze africane fa un
accorato intervento a uno dei
discorsi parigini di Pierre-Joseph Proudhon. In contrasto con
la folla di lavoratori radunata lì davanti, un elegante
gentleman nero, vestito
di tutto punto, interrompe il famoso oratore per incalzarlo a
parlare anche della libertà di proletari e sottoproletari –
“muratori, meccanici, fonditori!” – oltreché di quella degli
artigiani, il cui lavoro era minacciato dalla crescita
dell’industria. Marx e la sua partner di vita e militanza,
Jenny, siedono proprio accanto al citoyen de couleur,
e sembrano entrambi
deliziati dalla critica che questi ha mosso al padre
dell’anarchismo francese.
Nel suo film
Il giovane Marx, il regista Raoul Peck include una
scena in cui un francese di discendenze africane fa un
accorato intervento a uno dei
discorsi parigini di Pierre-Joseph Proudhon. In contrasto con
la folla di lavoratori radunata lì davanti, un elegante
gentleman nero, vestito
di tutto punto, interrompe il famoso oratore per incalzarlo a
parlare anche della libertà di proletari e sottoproletari –
“muratori, meccanici, fonditori!” – oltreché di quella degli
artigiani, il cui lavoro era minacciato dalla crescita
dell’industria. Marx e la sua partner di vita e militanza,
Jenny, siedono proprio accanto al citoyen de couleur,
e sembrano entrambi
deliziati dalla critica che questi ha mosso al padre
dell’anarchismo francese.
La scena è certamente significativa, poiché non è Marx ma un nero – probabilmente legato, direttamente o indirettamente, a un passato di colonialismo e schiavitù – che esorta Proudhon ad avere una visione della working class inclusiva del proletariato industriale. Nella scena la discussione non tocca mai direttamente la questione dei proletari schiavizzati e razzializzati del mondo coloniale. Implicitamente, tuttavia, lo fa. Attraverso questo personaggio nero Peck ci ricorda che Marx viveva e pensava dal cuore dell’impero coloniale, con possedimenti oltreoceano ancora dominati dalla schiavitù razziale, e che tale contesto più ampio plasmava inesorabilmente anche la composizione della working class metropolitana.
Eppure, nel film come nella storia, il Marx parigino non era ancora interessato, intellettualmente e politicamente, al colonialismo e alla schiavitù. È per questo che Peck non fa parlare il suo Marx con l’interlocutore nero, del quale condivide chiaramente la prospettiva, ma con Proudhon, con cui era fortemente critico. Questo punto cieco di natura colonialista che il regista haitiano sottolinea nel pensiero del giovane Marx non è una semplice idiosincrasia personale. Rispecchia la visione politica della working class che Marx stesso aveva avuto modo di scoprire e con cui era entrato in contatto nei caffè, nei salotti e nei banchetti della Ville Lumière tra il 1843 e il 1845.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: La trappola
La trappola
di Alessandro Visalli
La sinistra ha perso la battaglia politica per continuare ad avere una base di massa. Questa sconfitta storica è maturata, anche se su radici antiche, in questi ultimi dieci anni e si è manifestata il 4 marzo. La ristrutturazione dell’intero assetto mondiale del capitalismo, avviata nel 2008, ha portato per ora a concentrare ancora più tutta la ricchezza in pochissime mani. L’emergere di nuove tecnologie di disintermediazione, e di piattaforme fondate su inedite forme di lavoro debole, rivolte non solo ai tradizionali segmenti di classe ma estesi a forme di lavoro cognitivo e relazionale, ha creato un enorme vuoto nel centro della società ed ha destabilizzato tutte le basi di consenso.
La sinistra non ha capito nulla, altri sono stati più sensibili e rapidi, ed hanno capitalizzato sulla paura e sul legittimo sentimento di protezione.
Quando la frattura si è prodotta è emerso un tipo di discorso populista che in Italia ha tradizioni radicate, di cui una versione recente è stato Berlusconi, poi Renzi, ed ora è interpretato in modo esemplare da Salvini. Un populismo di destra che si nutre di deviazione del dolore e della rabbia verso feticci da indicare al pubblico odio. I “comunisti”, i “vecchi ceti politici” (sempre i comunisti alla fine), gli “immigrati”. Questo discorso tenta di creare popolo e darsi una base di massa indicando un “noi” sano al quale si contrappone il “loro” fonte del male che ci tocca.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Venezuela, golpe dello Stato profondo
Venezuela, golpe dello Stato profondo
di Manlio Dinucci
L'arte della guerra. Il riconoscimento di Juan Gualdó come «legittimo presidente» del Venezuela è stato preparato in una cabina di regia sotterranea all’interno del Congresso e della Casa Bianca. Principale operatore è il senatore repubblicano della Florida Marco Rubio, «virtuale segretario di stato per l’America Latina, collegato al vicepresidente Mike Pence e al consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton
L’annuncio del presidente Trump, che riconosce Juan Gualdó «legittimo presidente» del Venezuela è stato preparato in una cabina di regia sotterranea all’interno del Congresso e della Casa Bianca. La descrive dettagliatamente il New York Times (26 gennaio).
Principale operatore è il senatore repubblicano della Florida Marco Rubio, «virtuale segretario di stato per l’America Latina, che guida e articola la strategia dell’Amministrazione nella regione», collegato al vicepresidente Mike Pence e al consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton. Il 22 gennaio, alla Casa Bianca, i tre hanno presentato il loro piano al presidente, che l’ha accettato. Subito dopo – riporta il New York Tmes – «Mr. Pence ha chiamato Mr. Gualdó e gli ha detto che gli Stati uniti lo avrebbero appoggiato se avesse reclamato la presidenza».
Il vicepresidente Pence ha poi diffuso in Venezuela un video messaggio in cui chiamava i dimostranti a «far sentire la vostra voce domani» e assicurava «a nome del presidente Trump e del popolo americano: estamos con ustedes, siamo con voi finché non sarà restaurata la democrazia», definendo Maduro «un dittatore che mai ha ottenuto la presidenza in libere elezioni».
Leggi tutto
Enzo Acerenza: Landini: chiacchiere e distintivo
Landini: chiacchiere e distintivo
di Enzo Acerenza
Serviva alla CGIL un personaggio che rompesse il grigiore della gestione Camusso. La gestione Camusso è stata la gestione di un fallimento. Il nuovo segretario si agiterà di più ma non cambierà strategia.
Non sono stati difesi in alcun modo gli interessi, non del lavoro, ma di chi lavora, non di chi genericamente lavora (dal parlamentare al minatore) ma degli operai che lavorano per un salario da fame, in regime di schiavitù, quando va bene. Altrimenti c’è la miseria della disoccupazione. Si può capire: quando si mette al centro di un programma il mito- lavoro si finisce sempre per sacrificare chi viene costretto al lavoro per sopravvivere, quando si vogliono rappresentare i lavoratori in generale si finisce per diventare portavoce degli strati più alti dagli impiegati, dei dirigenti industriali, dei funzionari dello Stato. Si abbandonano al loro destino gli operai veri e propri, se poi sono stranieri, dipendenti di cooperative, arruolati a termine, non vengono nemmeno presi in considerazione se non in qualche dichiarazione di facciata. Questa realtà, di un sindacato che fallisce nella difesa degli interessi degli strati operai , attivi e di riserva, si è resa manifesta proprio nella FIOM, il sindacato diretto da Landini che ora, raccomandato dalla Camusso prende il controllo della CGIL.
Leggi tutto
German Cano: L’intelligenza e il disprezzo del popolo
L’intelligenza e il disprezzo del popolo
di German Cano
“Gilet gialli”, Brexit, ascesa dei populismo di sinistra e di destra… Sembra che il momento storico sia caratterizzato da un duplice disprezzo, il disprezzo del popolo. Ma, capiamoci, un disprezzo ambivalente. Da un lato, quello di un mondo fino ad ora egemonico verso ciò che esso qualifica come “populismo”; dall’altro, il risentimento verso qualsiasi forma di mediazione o ‘establishment’. Una doppia ferita che si retro-alimenta con due tipi di retorica: l’autosufficienza condiscendente dell’adulto – le élite minacciate e presuntamene assediate –, la cui ‘maturità’ disprezza quella realtà adolescente, ribelle, egoista, incapace di conservare le buone maniere intellettuali; e il presuntuoso ‘enfant terrible’, l’‘outsider’ antisistema, non di rado maschio alfa.
Il primo tipo di disprezzo non può fare a meno di trattare il suo oggetto come un minorenne e di solito proviene da intellettuali vicini al potere, che vedono se stessi come estranei al consorzio sociale. In questo senso Christopher Lasch parlava negli anni ’90, strizzando l’occhio a Ortega y Gasset, de ‘La ribellione delle élite’. Un’attitudine paternalista che, come un maestro indolente, interpella il popolo. Di fronte a ciò, compare oggi un nuovo e secondo disprezzo come “espressione – nelle parole di Angela Nagle – di un ‘qualcosa’ liberato dai legami delle convenzioni del discorso e dal politically correct […] che si relaziona più con il Marchese de Sade che con Edmund Burke”. Due risentimenti antitetici ma gemelli, quello dell’ira antipolitica e quello delle potenti élite incapaci di rispettare il contratto sociale.
Leggi tutto
Andrea Cavazzini: Lavoro e letteratura tra libertà e servitù
Lavoro e letteratura tra libertà e servitù
Un percorso
di Andrea Cavazzini
 Il tema «Lavoro e letteratura» fa parte di una
costellazione
complessa fin dall’inizio. Nel sistema topico delle pratiche
umane sviluppatosi nella modernità – diciamo tra il XVIII
secolo e la
fine del Novecento – entrambi questi termini sono portatori di
una tensione, o forse di una contraddizione, che è quella tra
libertà e necessità, tra autenticità e alienazione, tra
autonomia e eteronomia. Impossibile qui ricostruire tale
costellazione
nel dettaglio e nel suo divenire, che comporterebbe lo studio
approfondito di figure quali Adorno, Barthes, Bataille, Simone
Weil (per restare al
Novecento). Ci basterà delinearne le tensioni tematiche e
concettuali.
Il tema «Lavoro e letteratura» fa parte di una
costellazione
complessa fin dall’inizio. Nel sistema topico delle pratiche
umane sviluppatosi nella modernità – diciamo tra il XVIII
secolo e la
fine del Novecento – entrambi questi termini sono portatori di
una tensione, o forse di una contraddizione, che è quella tra
libertà e necessità, tra autenticità e alienazione, tra
autonomia e eteronomia. Impossibile qui ricostruire tale
costellazione
nel dettaglio e nel suo divenire, che comporterebbe lo studio
approfondito di figure quali Adorno, Barthes, Bataille, Simone
Weil (per restare al
Novecento). Ci basterà delinearne le tensioni tematiche e
concettuali.
Ricordiamo in ogni caso che un punto di arrivo, o comunque un vertice di intensità, di questa problematica è il testo di Franco Fortini, Opus servile, dei primi anni Novanta del ventesimo secolo, in cui l’attività letteraria è categorizzata attraverso l’assiomatica del lavoro fornita da Hegel nella “dialettica del servo e del padrone”. È chiaramente a partire da questa categorizzazione, che implica una discussione dei generi letterari e del loro rapporto con il tempo e il linguaggio, che sarebbe possibile ricostruire le figure del tema «Lavoro e letteratura» negli autori citati e in quanti ne sviluppano oggi la problematica (due tra tutti: Jacques Rancière e Giorgio Agamben).
1. Duplicità del lavoro
La parola “lavoro” fa parte del nostro discorso politico quotidiano. Ma parliamo veramente della stessa cosa, e della stessa nozione, nei discorsi dei teorici post-marxisti sul potenziale emancipatore del “lavoro immateriale”, nelle mobilitazioni contro la precarietà e misure quali l’infausto jobs act, nella constatazione che un numero crescente di persone sono escluse dal lavoro nei paesi “sviluppati”, nella rivendicazione da parte dei migranti di accedere a dei lavori regolari?
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Colin Crouch, “Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo”
Colin Crouch, “Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo”
di Alessandro Visalli
 Leggeremo il recentissimo nuovo libro del famosissimo politologo
inglese Colin
Crouch, reso letteralmente una star dal suo libro del 2000, “Postdemocrazia” quando era
direttore dell’Istituto di Governance e Public Management
alla Business School dell’Università di Warwick. Il libro del
2000 ha avuto un indubbio merito, e per questo è
inevitabilmente presente in ogni opera successiva: quello di
aver sollevato la questione
dell’erosione della democrazia ad opera dell’estremismo
liberale quando ancora poche voci[1] si erano
alzate ad avvertire del rischio. Successivamente sarà una
valanga[2],
e poi dal 2008 una eruzione[3]. Lo stesso Crouch fa peraltro
seguire al suo primo libro di grande successo altri due libri
significativi[4].
Leggeremo il recentissimo nuovo libro del famosissimo politologo
inglese Colin
Crouch, reso letteralmente una star dal suo libro del 2000, “Postdemocrazia” quando era
direttore dell’Istituto di Governance e Public Management
alla Business School dell’Università di Warwick. Il libro del
2000 ha avuto un indubbio merito, e per questo è
inevitabilmente presente in ogni opera successiva: quello di
aver sollevato la questione
dell’erosione della democrazia ad opera dell’estremismo
liberale quando ancora poche voci[1] si erano
alzate ad avvertire del rischio. Successivamente sarà una
valanga[2],
e poi dal 2008 una eruzione[3]. Lo stesso Crouch fa peraltro
seguire al suo primo libro di grande successo altri due libri
significativi[4].
Ma se nel 2000 Crouch, che in fondo insegnava in scuole di economia, parla di cercare di ‘conservare il dinamismo e lo spirito intraprendente del capitalismo’[5] (scendendo a patti con il capitalismo finanziario), ma vede come “chiedere la luna” l’ipotesi di “porre tale richiesta a livello globale” oggi sembra aver cambiato completamente idea; allora le grandi organizzazioni sovranazionali[6] “sta[va]no andando nella direzione opposta”, per cui intravedeva ed indicava “spazio per contrattaccare a livello nazionale sul piano economico” (p.121), riducendo la confusione di funzioni e competenze tra governo ed imprese, adesso più o meno gli stessi fatti conducono a conclusioni opposte. Nella battaglia, cui ha deciso di partecipare da una parte specifica, tra globalismo e resistenze nazionali (preferirei dire, anche nei termini del libro del 2000 del nostro ‘tra globalismo e democrazia’) oggi Crouch ritiene che “possiamo avere un qualche controllo su un mondo caratterizzato da un’interdipendenza sempre maggiore solo attraverso lo sviluppo di identità e istituzioni democratiche e di governo in grado di spingersi oltre la dimensione dello Stato-nazione” (p.5).
Leggi tutto
Michele Basso: Il processo di liberazione dei popoli e delle classi
Il processo di liberazione dei popoli e delle classi
di Michele Basso
 Marx ed Engels avevano come scopo
principale la liberazione del proletariato dalle catene della
schiavitù salariale,
e, in conseguenza di ciò, la liberazione dell'umanità. Questo
presupponeva uno studio delle cause storiche di questa
schiavitù,
analizzando gli sviluppi attraverso lo schiavismo, il
feudalesimo,il capitalismo. Nozioni importanti sul processo di
liberazione dei popoli si trovano
negli scritti sulla questione irlandese. L'Irlanda del suo
tempo, nonostante le mascherature istituzionali, era una
colonia. Marx, dapprima, si
attendeva la sua liberazione dall'avanzata del movimento
operaio inglese, poi capì che proprio i rapporti di sudditanza
dell'Irlanda erano il
terreno su cui si sviluppavano le correnti più reazionarie, e
che il dominio dei landlord in Irlanda permetteva loro di
avere un peso
determinante anche in Inghilterra, mentre l'emigrazione in
Inghilterra degli irlandesi scacciati dalle terre dai landlord
creava le condizioni per
contrasti con gli autoctoni, per la divisione del movimento
operaio.
Marx ed Engels avevano come scopo
principale la liberazione del proletariato dalle catene della
schiavitù salariale,
e, in conseguenza di ciò, la liberazione dell'umanità. Questo
presupponeva uno studio delle cause storiche di questa
schiavitù,
analizzando gli sviluppi attraverso lo schiavismo, il
feudalesimo,il capitalismo. Nozioni importanti sul processo di
liberazione dei popoli si trovano
negli scritti sulla questione irlandese. L'Irlanda del suo
tempo, nonostante le mascherature istituzionali, era una
colonia. Marx, dapprima, si
attendeva la sua liberazione dall'avanzata del movimento
operaio inglese, poi capì che proprio i rapporti di sudditanza
dell'Irlanda erano il
terreno su cui si sviluppavano le correnti più reazionarie, e
che il dominio dei landlord in Irlanda permetteva loro di
avere un peso
determinante anche in Inghilterra, mentre l'emigrazione in
Inghilterra degli irlandesi scacciati dalle terre dai landlord
creava le condizioni per
contrasti con gli autoctoni, per la divisione del movimento
operaio.
Dopo essermi occupato per anni della questione irlandese, sono giunto al risultato che il colpo decisivo contro le classi dominanti in Inghilterra (ed esso sarà decisivo per il movimento operaio all over the world [in tutto il mondo n.d.t.]) può essere sferrato non in Inghilterra, bensí soltanto in Irlanda. «D'altro canto: se domani l'esercito e la polizia inglese si ritirano dall'Irlanda, voi avrete immediatamente an agrarian revolution [una rivoluzione agraria N.d.T.] in Irlanda. La caduta dell'aristocrazia inglese in Irlanda condiziona, a sua volta, e ha come conseguenza necessaria la sua caduta in Inghilterra. Ciò soddisfarrebbe la condizione preliminare per la rivoluzione proletaria in Inghilterra. Poiché in Irlanda, sino ad oggi, la questione agraria è stata la forma esclusiva della questione sociale, poiché essa è una questione di pura sopravvivenza, una questione di vita o di morte, per l'immensa maggioranza del popolo irlandese, poiché, al tempo stesso, essa è inscindibile dalla questione nazionale, l'annientamento dell'aristocrazia fondaria inglese in Irlanda è un'operazione infinitamente piú facile che non in Inghilterra. Tutto ciò a prescindere dal carattere, piú passionale e rivoluzionario degli irlandesi, rispetto agli inglesi."(1)
Leggi tutto
Carlo Clericetti: Ashoka Mody: come uscire dall’“Eurotragedia”
Ashoka Mody: come uscire dall’“Eurotragedia”
di Carlo Clericetti
Il “dividendo dell’euro” non c’è mai stato. Si usa di solito quella formula per indicare quanto accadde nel primo periodo della moneta unica, più o meno i primi anni del secolo e fino alla crisi. Tassi bassi – quindi risparmi sul costo del debito – crescita discreta, inflazione moderata, disoccupazione vicino ai minimi. Ma, alla luce di ciò che dice Ashoka Mody, più che dall’euro tutto questo derivò da una congiuntura internazionale particolarmente favorevole, e dunque le cose sarebbero andate bene anche senza la moneta unica.
Mody è stato vicedirettore del dipartimento europeo del Fondo monetario, e in quella veste ha partecipato alla missione in Irlanda che varò gli aiuti dopo lo scoppio della crisi. Oggi insegna economia politica internazionale a Princeton, e ha scritto un libro il cui titolo (”Eurotragedia: un dramma in nove atti”) non lascia dubbi su come la pensi in proposito.
I nove atti sono quelli in cui Mody ha scandito la costruzione europea, che ha studiato fin dai suoi inizi. Dopo aver lasciato il Fondo monetario, anche per il profondo disaccordo con le ricette imposte dalla Troika, l’economista aveva pensato di scrivere un libro sulla storia della crisi, ma durante il lavoro ha sentito la necessità di andare più indietro nel tempo per esaminare la storia dell’Unione europea fin dalle sue origini, nel dopoguerra.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: PaP alla corte di Giggino
PaP alla corte di Giggino
di Leonardo Mazzei
Come nel gioco dell'oca, Pap (Potere al popolo) torna alla casella di partenza. In autunno aveva rotto con Rifondazione per non andare alle europee con De Magistris; oggi torna invece a bussare da Giggino per entrare nella Sua lista. In questo modo la sinistra europeista aggancia l'ultimo vagone che gli mancava...
Mentre scrivo non ci sono ancora comunicati ufficiali, ma solo questo video di Giorgio Cremaschi e Viola Carofalo. Ma basta ed avanza per capire lo stato di Potere al Popolo.
Alla fine di dicembre commentando il documento di Pap, preparatorio della consultazione online degli aderenti, rilevavo come la posizione assunta fosse ormai quella del "ridisegno dell'architettura europea".
Così scrivevo un mese fa:
«Avete capito bene. L'obiettivo è quello di ridisegnare "l'architettura europea", ovviamente stravolgendola da cima a fondo. Ora, se si fa per discorrere poco male, ma chi mai darebbe credito ad una simile impostazione ove vi fosse la pazienza di volerla prendere sul serio? Dovessimo stare alla lettera non potremmo che classificare quanto scritto da Pap come una sconclusionata versione estremista del sempre inconcludente altreuropeismo.
Leggi tutto
Riccardo Paccosi: Venezuela: provare a ragionare fino allo stremo o cedere alla polarizzazione?
Venezuela: provare a ragionare fino allo stremo o cedere alla polarizzazione?
di Riccardo Paccosi
Un dubbio amletico sorge dalla disconnessione logico-retorica che si manifesta nel dibattito sul Venezuela: provare a ragionare fino allo stremo oppure cedere alla polarizzazione?
Dinanzi a una situazione di manifesta irrazionalità e dove le minime basi di logica e di linguaggio comuni vengono meno, cosa bisogna fare? Contrapporsi a questa situazione e, quindi, provare a ragionare a oltranza? Oppure è meglio comprendere che la partita è in tal senso persa, che dunque è meglio cedere alla polarizzazione scommettendo che, alla fine, il proprio punto di vista diverrà egemonico a discapito di quello avversario?
La domanda è legittima di fronte a un dato di evidente disconnessione logica con cui la retorica e l’ideologia rendono impossibile, in queste ore, una qualsivoglia discussione sul Venezuela.
Esiste, da tempo, un dibattito politico trasversale sulla natura del socialismo bolivariano: chi lo considera un modello regressivo (sinistra liberale e tutte le destre) e chi invece vi ravvisa elementi di alternativa, parziale ma comunque positiva, al modello liberista (marxisti e poco altro). Ebbene, si dà il caso che suddetto dibattito non abbia NULLA a che vedere con la contraddizione in corso in queste ore e riguardante lo stato venezuelano. In questo momento, il tema oggetto di controversia internazionale è di tutt’altra natura e il giudizio sul chavismo, negativo o positivo che sia, non c’entra assolutamente nulla.
Leggi tutto
Piccole Note: Venezuela: Maduro è illegittimo?
Venezuela: Maduro è illegittimo?
di Piccole Note
Nicolas Maduro è presidente illegittimo. Ciò deriverebbe, secondo il presidente del Parlamento venezuelano, Juan Guaidò, e altri, dagli articoli 233 e 333 della Costituzione (cliccare qui per leggerla).
La Costituzione del Venezuela
Citiamo l’articolo 233: “Sono cause di impedimento permanente del Presidente della Repubblica: la morte, la rinuncia, o la destituzione decretata con sentenza dal Tribunale Supremo di Giustizia; l’incapacità fisica o mentale permanente accertata da una commissione medica designata dal Tribunale Supremo di Giustizia e con l’approvazione dell’Assemblea Nazionale; l’abbandono dell’incarico, dichiarato come tale dall’Assemblea Nazionale, e la revoca popolare del suo mandato”.
Nessuna di queste condizioni si è avverata. Né è previsto che il presidente del Parlamento dichiari non valido il presidente in carica.
Anche il cenno alla “revoca popolare”, che sembra l’unico appiglio al quale si possa ascrivere la pretesa di Guaidò, non assegna alcun potere in tal senso al presidente del Parlamento.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: Trump e asse franco-tedesco frenano l’Italia sulla Via della Seta
Trump e asse franco-tedesco frenano l’Italia sulla Via della Seta
di Pasquale Cicalese
Si è svolto ieri alla Farnesina e a Villa Madama il nono Comitato Intergovernativo Italia Cina con la presenza del Ministro degli Esteri italiani Moavero Milanesi e il Ministro degli Esteri cinese Wang Yi. Alla fine dei lavori si è adottato un Comunicato Congiunto che spazia in vari ambiti, dal partenariato strategico globale, al Memorandum per investimenti in Paesi Terzi, principalmente Africa, dalla collaborazione in materia sanitaria, previdenziale e culturale allo sport.
In particolare due sono gli ambiti in cui il Partenariato strategico Italia Cina, in vista del 50° anniversario dell’allacciamento dei rapporti diplomatici che cadrà l’anno prossimo, si esplica maggiormente.
Il primo è la connettività euroasiatica: in questo campo i due ministri hanno raggiunto un accordo per implementare e rafforzare gli investimenti lungo la Via della Seta nelle connessioni ferroviarie, aerospaziali e marittime, con specifico intervento sulla logistica e sulla portualità marittima.
Il secondo punto è la collaborazione Italia Cina in ambito spaziale: l’Italia fornirà nei prossimi anni i moduli abitativi della futura stazione spaziale cinese e collaborerà nei progetti lunari.
Non si è ancora, però, firmato il Memorandum di adesione alla Via della Seta. Secondo il Sole24ore online di ieri, la firma slitta con la visita a marzo in Italia di Xi Jinping o al massimo al forum della Via della Seta che si svolgerà a Pechino il 25 aprile.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2121
Hits 1996
Hits 1793
Hits 1747
Hits 1679
Hits 1667
tonino

Rete dei Comunisti: L’unità della sinistra? E’ un falso problema
L’unità della sinistra? E’ un falso problema
di Rete dei Comunisti
 In questi anni più si è
parlato di “unità dei comunisti” e più ci sono state
scissioni e nascita di “partiti comunisti”, più si parla di
“unità della sinistra” e più si sono prodotte
divisioni nella sinistra. L’invocazione all’unità si è
dimostrata inversamente proporzionale ai risultati che ha
prodotto,
sia tra i militanti comunisti che nel mondo della sinistra.
In questi anni più si è
parlato di “unità dei comunisti” e più ci sono state
scissioni e nascita di “partiti comunisti”, più si parla di
“unità della sinistra” e più si sono prodotte
divisioni nella sinistra. L’invocazione all’unità si è
dimostrata inversamente proporzionale ai risultati che ha
prodotto,
sia tra i militanti comunisti che nel mondo della sinistra.
E’ evidente che qualcosa non funziona, che non può funzionare, che non funziona più! Appaiono poi ingannevoli e devastanti i tentativi di resuscitare l’unità della sinistra in occasione di appuntamenti elettorali nazionali, locali o europei che siano.
Con l’esaurimento della funzione di fiancheggiamento/subordinazione dei partiti comunisti o della sinistra radicale ai governi del centro-sinistra, alle loro politiche subalterne ai diktat europei e alla centralità degli interessi privati rispetto a quelli collettivi, sia i comunisti che la sinistra hanno via via condiviso con l’Ulivo prima e il Pd poi l’ostilità nel senso comune popolare. E oggi se ne pagano ancora tutti i prezzi. Sia le ipotesi fortemente identitarie e auto-centrate dei comunisti sia le ipotesi di cartelli larghi e inclusivi della sinistra, in tale contesto, non hanno prodotto risultati significativi né dignitosi. Non li hanno prodotti sul piano elettorale (per molti unica ragione di esistenza politica e metro di misura) né sul piano strategico attraverso la rimessa in campo di una ipotesi di trasformazione rivoluzionaria sufficientemente solida per affrontare le tappe di un programma di transizione di classe anche di tipo “riformista”.
Questa mancata rimessa a fuoco di una ipotesi rivoluzionaria in una fase controrivoluzionaria, non poteva che accentuare la crisi dei partiti comunisti residuali o dei residui della sinistra radicale.
Leggi tutto
Roberto Fineschi: Una storia complessa. La teoria dell’accumulazione in Marx
Una storia complessa. La teoria dell’accumulazione in Marx
di Roberto Fineschi*
Abstract: «Accumulation» is a crucial concept in Marx’ theory of capital. Next only to the value form, this is the part that underwent the most significant changes in the different drafts of his work, since it plays a crucial role in its general structure. Its function, more than the transformation of values into prices of production, is the key point to think the continuity/discontinuity between the different abstraction levels of the theory. In this essay, we shall try to show this development and explain its more general meaning
 1. Introduzione
1. Introduzione
L’accumulazione nella struttura teorica del capitale costituisce uno snodo fondamentale, senza il quale l’intero sistema non starebbe in piedi. Non a caso è una delle parti che è stata soggetta ai rimaneggiamenti più consistenti man mano che l’intelaiatura andava definendosi, seconda in questo forse solo alla forma di valore. Rispetto a questa, tuttavia, sempre collocata all’inizio dell’opera, l’accumulazione ha via via cambiato posizione, si è articolata in più passaggi e sezioni nei tre libri, fino a diventare la vera cifra dello sviluppo della teoria di Marx e dei suoi cambiamenti tra le varie redazioni.
La ragione per cui questa parte della teoria è così importante è legata alla metodologia marxiana, in questo eminentemente dialettica. In tale prospettiva, nella propria articolazione interna essa deve produrre come propri risultati quelli che inizialmente erano dei presupposti da essa stessa non posti. Realizzare ciò significa produrre dei “presupposti-posti”: solo grazie a questo il capitale può effettivamente essere un processo, ovvero muovere da se stesso per porre se stesso. Questo modo di procedere per cui la teoria, come dire, ritorna su se stessa autofondandosi è, nell’ottica di Marx, connesso a un’altra tematica che potrebbe sembrare muovere in direzione opposta; vale a dire esso solleva il tema dei “limiti della dialettica” e, più in generale, della concezione materialistica della storia. Infatti, Marx intende mostrare come il modo di produzione capitalistico abbia un punto di partenza non posto da esso stesso, per sostenere come non sia possibile un corso storico universale a priori; le leggi della dialettica teorizzano i rapporti di produzione via via correnti in virtù della loro logica intrinseca che è storicamente determinata e non è generalizzabile in astratto: non la si può estendere come tale ad altri modi di produzione, i quali vanno invece ricostruiti sulla base della logica loro propria. Se questo pone in termini radicali la discontinuità, d’altra parte presenta il rischio teorico di avere una teoria sempre deficitaria in quanto dipendente da elementi esogeni per cui in ogni istante la sua coerenza potrebbe venir meno venendo a mancare tale elemento esogeno.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: L’impotenza della ridentificazione
![]()
L’impotenza della ridentificazione
di Salvatore Bravo
 La scomparsa dell’identità in
olocausto dello sviluppo economico è un dato palese; non si ha
sufficiente consapevolezza del prezzo che quotidianamente ogni
suddito del sistema capitale paga al capitalismo assoluto. Il
nichilismo
dell’identità è occultato da una serie di compensativi
anestetici del dolore che procura la quotidiana lotta per
ritagliare una
momentanea forma-identità nel tumulto dello sviluppo
economico: la merce che promette l’Eden in terra, il corpo
liberato da ogni limite e
confine, i viaggi del turismo acquisitivo e narcisistico
svolgono la stessa funzione del Paradiso, per i mortali
sofferenti nelle religioni
monoteiste. Il capitalismo si rivolge alla pancia, per
occultare la sofferenza di un’umanità senza volto e senza
appartenenza.
L’identità è divenuta una forma complementare alla volontà di
onnipotenza: l’atomo-individuo in assenza del
fondamento veritativo scolpisce la propria identità. L’inganno
non è mai svelato, si spingono i sudditi liberati da ogni
vincolo
ontologico, alla perenne riqualificazione e rigenerazione
delle identità, l’uomo modulare si compone e ricompone a
seconda dei desideri.
In verità è il mercato tecnocratico a soffiare verso alcune
scelte piuttosto che altre in relazione alle necessità dello
stesso e
quindi dei prodotti da immettere. La merce-mercato decide le
identità e nello stesso tempo le istituzioni affiancano il
mercato elaborando
l’illusione della scelta, difendendo, quale valore sacrale
irrinunciabile, la scelta dell’identità plurale. La volontà di
potenza si rovescia nella pratica dell’impotenza: nessuno è se
stesso, ma ciascuno è come gli altri. Bauman nei suoi scritti
definisce il tempo del capitalismo assoluto “puntiforme”
non vi è continuità, non vi è progetto, i momenti
temporali sono paragonati ad un punto, il quale è assenza di
spazio e quindi di tempo, al soggetto non è concessa
un’identità che consenta di scolpire il senso del proprio
tempo, ma il tempo puntiforme è similare all’identità
precaria, liquida pronta ad essere consumata, dopo averla
utilizzata per vivere l’esperienza del momento.
La scomparsa dell’identità in
olocausto dello sviluppo economico è un dato palese; non si ha
sufficiente consapevolezza del prezzo che quotidianamente ogni
suddito del sistema capitale paga al capitalismo assoluto. Il
nichilismo
dell’identità è occultato da una serie di compensativi
anestetici del dolore che procura la quotidiana lotta per
ritagliare una
momentanea forma-identità nel tumulto dello sviluppo
economico: la merce che promette l’Eden in terra, il corpo
liberato da ogni limite e
confine, i viaggi del turismo acquisitivo e narcisistico
svolgono la stessa funzione del Paradiso, per i mortali
sofferenti nelle religioni
monoteiste. Il capitalismo si rivolge alla pancia, per
occultare la sofferenza di un’umanità senza volto e senza
appartenenza.
L’identità è divenuta una forma complementare alla volontà di
onnipotenza: l’atomo-individuo in assenza del
fondamento veritativo scolpisce la propria identità. L’inganno
non è mai svelato, si spingono i sudditi liberati da ogni
vincolo
ontologico, alla perenne riqualificazione e rigenerazione
delle identità, l’uomo modulare si compone e ricompone a
seconda dei desideri.
In verità è il mercato tecnocratico a soffiare verso alcune
scelte piuttosto che altre in relazione alle necessità dello
stesso e
quindi dei prodotti da immettere. La merce-mercato decide le
identità e nello stesso tempo le istituzioni affiancano il
mercato elaborando
l’illusione della scelta, difendendo, quale valore sacrale
irrinunciabile, la scelta dell’identità plurale. La volontà di
potenza si rovescia nella pratica dell’impotenza: nessuno è se
stesso, ma ciascuno è come gli altri. Bauman nei suoi scritti
definisce il tempo del capitalismo assoluto “puntiforme”
non vi è continuità, non vi è progetto, i momenti
temporali sono paragonati ad un punto, il quale è assenza di
spazio e quindi di tempo, al soggetto non è concessa
un’identità che consenta di scolpire il senso del proprio
tempo, ma il tempo puntiforme è similare all’identità
precaria, liquida pronta ad essere consumata, dopo averla
utilizzata per vivere l’esperienza del momento.
Leggi tutto
Militant: Il Venezuela e i sinistri “critici-critici”
Il Venezuela e i sinistri “critici-critici”
di Militant
L’autoproclamazione di Guaidò rappresenta a tutti gli effetti un tentativo di colpo di Stato, ed è davvero difficile, se non impossibile, provare a descrivere diversamente quello che sta avvenendo in questi giorni in Venezuela. Un tentativo che fortunatamente, almeno per ora, non ha avuto gli sviluppi che auspicavano a Washington, ma che però è ben al di la dall’essere stato scongiurato, come dimostra l’esproprio dei conti bancari della PDVSA negli Stati Uniti. Miliardi di dollari pubblici sottratti allo stato venezuelano e messi arbitrariamente a disposizione di un golpista, il tutto in barba ad ogni legge del diritto internazionale.
Ora immaginate solo per un momento cosa sarebbe accaduto se Bernie Sanders si fosse dichiarato unilateralmente Presidente degli Stati Uniti invitando l’esercito alla diserzione, magari contestando l’irregolarità delle presidenziali del 2016 adducendo come prova l’interferenza dei russi nel processo elettorale. Con ogni probabilità il “mondo civilizzato” che oggi plaude al “giovane ribelle” di Caracas lo avrebbe preso per matto, oppure ignorato. Probabilmente sarebbe stato anche arrestato e processato nel giro di qualche ora, visto che l’ordinamento giuridico nordamericano prevede il reato di cospirazione.
Oppure pensate a cosa sarebbe accaduto se Jeremy Corbyn, dallo speaker corner di Hyde Park, avesse annunciato urbi et orbi di aver spodestato Theresa May, garantendogli però, magnanimamente, l’amnistia.
Leggi tutto
Alessandro Avvisato: Gialloverdi in crisi di nervi, governo in piedi fino alle europee
Gialloverdi in crisi di nervi, governo in piedi fino alle europee
di Alessandro Avvisato
La breve esperienza del governo “gialloverde” sembra già all’epilogo. Non c’è giornae che in questi gkorni non abbia registrato il crescendo di momenti di scontro tra Lega e Cinque Stelle, con il contorno indicativo di parole al limite dell’insulto, ben dentro il normale turpiloquio da osteria.
Al contrario dei media mainstream, però, a noi sembra che dietro l’allargamento delle rime di frattura tra i due azionisti di governo pesino più le questioni globali (economiche ed internazionali) che non i mal di pancia pre-elettorali. Certo la necessità di distinguersi in vista delle elezioni europee – in cui corrono facendo riferimento a “famiglie” politiche piuttosto diverse, con i 5S che ancora “cercano casa” – stimola la conflittualità, e di sicuro il se votare o no l’autorizzazione a procedere per Salvini costituirà da solo un buon motivo per rompere, quando se ne saranno determinate le condizioni necessarie.
Altrettanto di sicuro pesano i mugugni delle rispettive basi elettorali deluse chi dall’esiguità delle risorse a favore del “reddito di cittadinanza” (constringerà tanti a vere e proprie forche caudine per sentirsi poi rifiutare il modesto contributo), chi dalle trappole esplosive poste intorno a “quota 100”, che certificano come la “legge Fornero” rimanda tranquillamente in vigore, alla faccia degli annuncia sulla sua “rottamazione”.
Leggi tutto
Francesco Maria Pezzulli: Sul reddito di cittadinanza e il movimento 5 stelle
Sul reddito di cittadinanza e il movimento 5 stelle
di Francesco Maria Pezzulli
\ «assolver non si
può chi non si pente /né pentere e volere insieme puossi/per
la contraddizion che nol consente»
\ poco tempo fa si pensava che: «se i 5S non daranno
prova di essere davvero
“il nuovo” verranno anch’essi seppelliti dai meridionali che
li hanno provvisoriamente eletti a speranza per il
futuro»
\ per come stanno andando le cose tutto lascia
presagire che non appena "si daranno le condizioni propizie
"i meridionali ormai liberi da padrini e patroni faranno
fare loro la fine del
precedessore toscano"
Caro lettore,
mi piacerebbe che tu leggessi questa mia nota come se fosse una tappa, né la prima né l’ultima, di un discorso sul sud e l’attualità politica che non intende descrivere l’esistente ma cogliere il futuro che nel presente già si intravede. Mi piacerebbe considerare queste note, sperando nella tua voglia e pazienza, come i frammenti di un mosaico da costruire assieme, un po’ per volta, da una ipotesi ad un’altra successiva. Un mosaico con i contorni e parte dello sfondo ancora confusi ma con il disegno complessivo che comincia a prendere forma, i tratti del bassorilievo a delinearsi e i colori a vivacizzarsi, seppur il tutto sia ancora a macchia di leopardo.
Ti avviso sin d’ora lettore che alcuni frammenti coincideranno, per colore e dimensioni, al disegno per come viene a manifestarsi, altri lo saranno meno e altri non lo saranno affatto, ma anche questi ultimi saranno importanti, perché ci faranno rendere conto degli errori commessi, delle ipotesi infondate o mal congegnate, delle cose che non siamo riusciti a vedere e dei colori ai quali non abbiamo dato giusta luce.
Leggi tutto
Prisca Amoroso: I filosofi e la politica
I filosofi e la politica
di Prisca Amoroso
Una recensione a “I filosofi e la politica. Teoria e pratica a confronto” (ETS, Pisa, 2017), il volume curato da Cassandra Basile
Cinquant’anni dopo il Maggio 1968, la questione del rapporto dei filosofi con la politica si trova priva di una sua riconoscibilità propriamente politica e sembra mostrarsi, nelle sue rare occorrenze, come un problema di interesse soprattutto filologico e accademico. Alcune recenti pubblicazioni, tuttavia, non limitandosi a registrare questo “infiacchirsi” della voce del filosofo nella società, rilanciano la questione dello statuto della filosofia e si propongono come interventi attivi nella battaglia in favore di un ruolo costruttivo – e non solamente critico – del pensiero. Penso al libro di Gianluca Briguglia, L’animale politico. Agostino, Aristotele e altri mostri medievali (Salerno Editrice, Roma, 2015), che, con un agile percorso nella filosofia medievale, mette in luce come tornare a riflettere sulla “natura” sociale e politica dell’essere umano significhi stare «sul perimetro possibile di costruzione della società e della politica», o a quello, recentissimo, di Donatella Di Cesare, Sulla vocazione politica della filosofia (Bollati Boringhieri, Torino, 2018), che a una carrellata storica di grandi figure del pensiero filosofico politico a partire da Eraclito, accosta una proposta attuale di filosofia engagée.
Leggi tutto
Michael Löwy: La rivoluzione è il freno di emergenza
La rivoluzione è il freno di emergenza
Saggio su Walter Benjamin
di Michael Löwy
Con l’autorizzazione dell’autore pubblichiamo la prefazione a La révolution est le frein d’urgence. Essais sur Walter Benjamin, il nuovo libro di Michael Löwy in uscita il 7 febbraio prossimo presso le Editions de l’éclat. La prefazione è apparsa sul blog dell’autore ed è tradotta per tysm da Alessandro Simoncini
Ho scoperto Walter Benjamin verso il 1978, quando ho iniziato a lavorare sul messianesimo rivoluzionario nella cultura ebraica dell’Europa centrale. Sono stato subito colpito, come con un pugno, dalla scoperta delle Tesi sul concetto di storia(1940): come dico nel libro, che è dedicato a questo documento unico, nel mio itinerario intellettuale c’è un prima e un dopo questa illuminazione profana.
A partire da quel momento ho iniziato a leggere, studiare, discutere e rimuginare molti degli altri scritti di Benjamin, cercando di comprendere il suo percorso spirituale e politico. I saggi raccolti in questo volume sono il prodotto di questo tentativo, che si estende su … due secoli (il ventesimo e il ventunesimo).
Come si può comprendere leggendo l’indice di questa raccolta i temi dei testi sono molto diversi tra loro. Testimoniano anche di una lettura molto selettiva: alcuni tra gli scritti più importanti, o più conosciuti, di Benjamin non sono nemmeno menzionati. Non porto esempi, il lettore attento si renderà subito conto di queste lacune.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: L'infinita Eurotragedia italiana
L'infinita Eurotragedia italiana
di Giuseppe Masala*
 E dunque la tanto attesa e temuta recessione
tecnica è arrivata tra noi, con
tanto di bollinatura ufficiale dell'Istat. Immediatamente si è
scatenata - soprattutto nell'agone politico nazionale - un
assordante rumore di
fondo dove ciascuna parte politica tenta di accusare gli
avversari di quella che è la terza recessione in undici anni.
Un vero unicum
nella storia nazionale dall'avvento dello stato unitario.
E dunque la tanto attesa e temuta recessione
tecnica è arrivata tra noi, con
tanto di bollinatura ufficiale dell'Istat. Immediatamente si è
scatenata - soprattutto nell'agone politico nazionale - un
assordante rumore di
fondo dove ciascuna parte politica tenta di accusare gli
avversari di quella che è la terza recessione in undici anni.
Un vero unicum
nella storia nazionale dall'avvento dello stato unitario.
Se è certamente vero che la scintilla che ha scatenato l'ennesimo psicodramma italiano è ascrivibile ad un chiaro rallentamento della congiuntura internazionale dovuta probabilmente anche alla guerra commerciale in corso tra USA e Cina e ai timori di una hard Brexit possiamo certamente dire che le cause profonde del male oscuro italiano sono altre. Proverò ad indagare in questo spazio quelle che mi paiono le più importanti.
Recessione tecnica o infinita depressione strategica?
Certamente se guardiamo all'andamento del Pil italiano dall'ottica dell'anno rispetto all'anno precedente o del trimestre rispetto al trimestre precedente ciò che appare è che nell'ultima decade abbiamo vissuto una tripla recessione. Ognuna delle quali variamente spiegabile. La prima causata dal grande crollo di Wall Street del 2008, la seconda causata dall'impellente necessità di riportare in pareggio la nostra bilancia commerciale e il saldo delle partite correnti. Operazione, sia detto per inciso, riuscita mirabimente (anche se a costi sociali altissimi) grazie al governo guidato dal Prof. Monti. E ora la terza, causata come detto sopra, dal rallentamento della domanda mondiale a causa della guerra commerciale in corso tra Cina e USA e dalle aspettative di una Hard Brexit che potrebbe gelare il sistema economico europeo. Tutto sembra chiaro, ma se cambiamo punto di osservazione le cose se possibile appaiono ancora peggiori.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Cosa vive e cosa muore a Caracas
Cosa vive e cosa muore a Caracas
Il tramonto dell'Occidente
di Fulvio Grimaldi

“Già oggi cominciamo a sentire in noi e intorno a noi i primi sintomi di un fenomeno del tutto simile quanto a decorso e a durata, il quale si manifesterà nei primi secoli del prossimo millennio, il «tramonto dell'Occidente” (Osvald Spengler, “Il Tramonto dell’Occidente”).
“Siamo invisi agli Stati Uniti perché abbiamo qualcosa di molto più importante delle ricchezze materiali che è lo spirito bolivariano che ci muove e che abbiamo risvegliato negli altri paesi. Siamo un esempio per il mondo intero, per tutti quei popoli che vogliono emanciparsi, che vogliono difendere la propria dignità e la pace. Questo è considerato per gli Stati Uniti una minaccia” (Olga Alvarez, costituzionalista venezuelana).
“Spero che quel regime comunista cada il più presto possibile” (Matteo Salvini).
Nancy e Roberto presidenti
Nancy Pelosi, speaker (presidente) della Camera bassa Usa, è apparsa a Baltimora da dove ha lanciato la sfida al presidente eletto, Donald Trump, proclamandosi nuovo presidente – ad interim – degli Stati Uniti in virtù del fatto che quello in carica è un usurpatore essendo stato eletto, sì ai termini della Costituzione e della legge elettorale vigente, ma contro la effettiva volontà del popolo, espressosi a maggioranza per Hillary Clinton. A parte qualche pigolìo contrario di rappresentanti di terzo e quarto livello, la Comunità Internazionale ha condiviso l’azione di Pelosi. Alcuni ne hanno riconosciuto subito la titolarità, altri hanno intimato all’usurpatore di indire nuove elezioni entro otto giorni e di ricordarsi che “tutte le opzioni sono sul tavolo” a sostegno dell’autonominata. Uno spiazzatissimo Trump, che aveva dato spago a un’analoga novità istituzionale in Venezuela, non ha potuto far altro che capovolgersi per l’ennesima volta e chiamare i suoi sostenitori della Rust Belt a unirsi ai bolivariani del presidente di quel paese nella resistenza agli infervorati presidenti golpisti delle Camere di tutto il mondo.
Accomodatasi nella posizione di usciere alla porta orientale del palazzo e guadagnatasi il sussidio di sussistenza per la riconferma del suo servizio – costi quel che costi – a Usa, Nato e UE, l’Italia si è immediatamente allineata all’impresa interamericana.
Leggi tutto
Stefano Oricchio: Proletari di tutto il mondo, imprenditorializzatevi!
Proletari di tutto il mondo, imprenditorializzatevi!
di Stefano Oricchio
Etnografia di una forza-lavoro nomade e intraprendente: “Entreprecariat” di Silvio Lorusso
 Si è soliti pensare che la ricerca di un lavoro
rappresenti un
passaggio pressoché obbligato nella vita di ognuno. Da qualche
tempo tuttavia, soprattutto tra le nuove generazioni, si fa
largo l’idea
che esso vada piuttosto inventato. In questo senso, lo
sviluppo delle tecnologie digitali ha spalancato un mondo,
creando nuovi mercati, ruoli
professionali e opportunità di inserimento. Non si tratta,
però, di un processo pacifico e lineare: anzi, le attuali
possibilità
si sono intrecciate ancora più a fondo con le solite
necessità.
Si è soliti pensare che la ricerca di un lavoro
rappresenti un
passaggio pressoché obbligato nella vita di ognuno. Da qualche
tempo tuttavia, soprattutto tra le nuove generazioni, si fa
largo l’idea
che esso vada piuttosto inventato. In questo senso, lo
sviluppo delle tecnologie digitali ha spalancato un mondo,
creando nuovi mercati, ruoli
professionali e opportunità di inserimento. Non si tratta,
però, di un processo pacifico e lineare: anzi, le attuali
possibilità
si sono intrecciate ancora più a fondo con le solite
necessità.
La nuova potenziale forza-lavoro è infatti impegnata in una una competizione fratricida, il cui livello si è innalzato parallelamente a quello di una scolarizzazione sempre crescente per far fronte alle esigenze del capitalismo cognitivo e immateriale. Per emergere, o per uscire quantomeno vivi dalla società dell’incertezza (cfr. Bauman, 1999), occorre allora inventarsi qualcosa, rischiare, sapersi pubblicizzare, essere creativi, multimediali, flessibili e possibilmente poliglotti: occorre, cioè, adottare uno spirito imprenditoriale sulla propria persona che tuttavia non è ascritto alla nascita e bisogna investire risorse che, allo stesso modo, non tutti posseggono. Il risultato è, come si diceva, un intreccio di possibilità e necessità affascinante per alcuni ma terrificante per molti altri.
I dettagli, le modalità, gli effetti e le contraddizioni di questo processo di precaria imprenditorializzazione del mondo sono l’oggetto di Entreprecariat – Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro, un prezioso lavoro firmato da Silvio Lorusso.
Una Divina Commedia attualizzata
Entreprecariat riunisce, completa e sistematizza diversi materiali con cui l’autore è già intervenuto a gamba tesa su alcune delle più recenti trasformazioni del lavoro, ben etichettate da questo fortunato neologismo anglofono in cui si fondono imprenditoria e precarietà.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: La Cina abbandona la “carta” finanziaria
La Cina abbandona la “carta” finanziaria
di Pasquale Cicalese
Si sono conclusi due giorni fa i colloqui tra Usa e Cina per risolvere la disputa sui dazi. Che qualcosa di grosso stesse succedendo lo si è potuto capire il pomeriggio del 29 gennaio, quando il sito in italiano di Radio Cina Internazionale batteva la notizia che, oltre allo stratega vice Premier Lui He, nella delegazione cinese vi era il Governatore della People’s Bank of China, la banca centrale cinese, Yi Gang e il vice Presidente della Commissione per le riforme e la pianificazione Jintze, cioè colui il quale decide i mega investimenti cinesi.
Poco si sa dei colloqui, tutto è rimandato ad un summit tra Trump e Xi Jinping a fine febbraio. In ogni caso la Cina negli stessi giorni comunicava che il 5 marzo l’Assemblea del Popolo avrebbe approvato una legge sugli investimenti esteri che permette agli operatori oltre confine di avere la maggioranza e di non trasferire tecnologia. Inoltre, sembra comunque che i servizi finanziari americani avranno accesso al mercato cinese.
Dunque, parte del risparmio cinese vola a Wall Street. Inflessibili i cinesi nel rifiutare qualsiasi modifica degli assetti strutturali della loro economia, basati sui colossi statali, che nel 2018 hanno fatturato 4300 miliardi di dollari, 1/3 del pil cinese.
Leggi tutto
Alessandro Somma: L’Europa difende lo Stato di diritto per affossare il welfare
L’Europa difende lo Stato di diritto per affossare il welfare
di Alessandro Somma
Infrazione delle norme sullo Stato di diritto: la proposta della Commissione emendata dal Parlamento europeo si distingue per l’enfasi con cui invoca una gestione tecnocratica delle procedure destinate a individuare le violazioni dello Stato di diritto ma senza tutelare lo Stato sociale dalle ingerenze del mercato
Alcuni mesi or sono la Commissione europea ha formulato una proposta di regolamento rivolto ai Paesi membri nei quali si adottano politiche che determinano una “carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto” [1]. Nel testo, appena approvato con emendamenti dal Parlamento europeo[2], si prevede che queste politiche siano sanzionate con la riduzione o la sospensione dei finanziamenti relativi a impegni esistenti, e con il divieto di assumere nuovi impegni.
La proposta definisce in apertura il concetto di Stato di diritto, che comprende in particolare il principio di legalità, il principio della certezza del diritto e il principio della separazione dei poteri, ovvero il divieto di arbitri del potere esecutivo ai danni dell’indipendenza delle corti e dell’uguaglianza davanti alla legge. Questo modo di intendere lo Stato di diritto compare in altri documenti della Commissione, dove si sottolinea il nesso con la promozione dei diritti fondamentali: “non può esistere rispetto dei diritti fondamentali senza rispetto dello Stato di diritto, e viceversa”[3].
Leggi tutto
Paolo Riberi: La rinascita gnostica, da Matrix a Twin Peaks
La rinascita gnostica, da Matrix a Twin Peaks
Adriano Ercolani conversa con Paolo Riberi
Pochi libri mi hanno colpito negli ultimi due anni come Pillola rossa o Loggia Nera? di Paolo Riberi (Lindau) , volume, intelligente quanto agile, che esplora e analizza la proliferazione (benedetta!) di “messaggi gnostici nel cinema tra Matrix, Westworld e Twin Peaks”.
L’autore aveva già affrontato gli scritti apocrifi dei primi secoli del Cristianesimo in testi precedenti, quali L’Apocalisse di Adamo. La Genesi degli Gnostici (sempre per Lindau) e Maria Maddalena e le altre(L’Età dell’Acquario).
Stavolta decide di calare le sue riflessioni nella contemporaneità. E ci riesce in maniera molto convincente. La renaissance gnostico-esoterica (dopo l’esplosione confusa di fine anni’60 che ha fatto traboccare di falsa conoscenza il calderone New Age) ha evidentemente ispirato alcuni delle menti più fervide delle ultime generazioni.
Assistiamo a una dinamica paradossale quanto affascinante: una conoscenza che per anni è stata condannata come eretica e custodita in maniera occulta solo tra pochi iniziati ora diventa lo sfondo e la struttura riconoscibile di opere che dominano l’immaginario collettivo.
Riberi è abile nel conciliare il tono divulgativo (non si tratta di temi di immediata seduzione per il grande pubblico, per definizione) con l’analisi rigorosa dei simboli e degli archetipi nei film e nelle serie tv più amate degli ultimi anni.
Leggi tutto
Piotr: Venezuela: dove sta la destra e dove sta la sinistra nel mondo
Venezuela: dove sta la destra e dove sta la sinistra nel mondo
di Piotr
Finalmente, dopo France insoumise e da noi Potere al Popolo e importanti esponenti del Movimento 5 Stelle, la formazione tedesca Die Linke (La Sinistra) ha preso una posizione ufficiale sul Venezuela. Ecco qui sotto la traduzione da RedGlobe:
“La sinistra condanna il tentativo di colpo di stato contro il governo in Venezuela. Il riconoscimento dell'autoproclamatosi presidente provvisorio da parte degli Stati Uniti e di altri governi e la minaccia di utilizzare mezzi militari costituiscono una violazione del diritto internazionale, che in nessun caso può essere accettato. L'epoca dei tentativi di colpo di stato orchestrati dagli Stati Uniti deve finalmente terminare.”
Toni simili anche da parte della Federazione Sindacale Mondiale.
Il Manifesto invece pasticcia, nel senso letterale. Mentre nel sommario dell'articolo “Guaidó e Trump più isolati di Maduro: l’Osa si spacca” si dice che “Sedici paesi americani su 35 non appoggiano il golpe” nel testo leggiamo che è il contrario: solo 16 paesi su 35 hanno appoggiato il golpista Guaidó. E va bene: un “non” di troppo nel sommario.
Strafalcione però anche su Bernie Sanders, che secondo il Manifesto si opporrebbe al golpe perché ha dichiarato che gli Usa “dovrebbero appoggiare lo stato di diritto e l’autodeterminazione del popolo venezuelano”.
Leggi tutto
Luca Picotti: “Crepe nel sistema. La frantumazione dell’economia globale” di Fabrizio Saccomanni
“Crepe nel sistema. La frantumazione dell’economia globale” di Fabrizio Saccomanni
di Luca Picotti
Recensione a: Fabrizio Saccomanni, Crepe nel sistema. La frantumazione dell’economia globale, Il Mulino, Bologna 2018, pp. 208, 19 euro, (scheda libro)
Il panorama economico e geo-politico globale è caratterizzato, in questo delicato passaggio storico, da un’intrinseca contraddittorietà, nonché da numerose crepe che ne delineano il volto disarmonico. A dieci anni dalla crisi finanziaria, nuovi problemi si profilano all’orizzonte senza che i vecchi siano stati risolti o quantomeno affrontati con risolutezza. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina sta rallentando il commercio globale, mentre l’inasprimento della politica monetaria della Fed – con il progressivo innalzamento dei tassi di interesse – inizia a generare le prime conseguenze su alcune economie emergenti, come Turchia, Brasile e Argentina, con deflussi di capitale e svalutazioni del cambio rispetto al dollaro.
In Europa, nel frattempo, sembra interessare più il dibattito sulle migrazioni che quello su una potenziale riforma dell’architettura istituzionale e finanziaria, con il risultato che le numerose criticità insite all’Unione continuano a minacciarne la sopravvivenza.
Fabrizio Saccomanni, economista dalla lunga esperienza istituzionale, prima come Direttore Generale della Banca d’Italia poi come Ministro dell’economia e delle finanze nel Governo Letta, passando per gli incarichi presso il Fondo monetario internazionale, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca centrale europea, nel suo ultimo libro Crepe nel sistema.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2135
Hits 2008
Hits 1841
Hits 1767
Hits 1700
Hits 1684
Hits 1678
Hits 1676
tonino

Biagio Borretti e Italo Nobile: Lo Stato Italiano molla il Mezzogiorno
Lo Stato Italiano molla il Mezzogiorno
di Biagio Borretti e Italo Nobile
 Il 15 febbraio – a
Roma – in occasione della probabile approvazione, da parte
del Consiglio
dei Ministri, del Decreto sull’Autonomia Differenziata,
è stato convocato un presidio di lotta a Montecitorio per
protestare
contro questo dispositivo normativo che accentuerà gli
squilibri territoriali del nostro paese, aumenterà il
divario Nord/Sud, le
disuguaglianze sociali ed il complesso degli strumenti
deregolamentazione dell’unità politica e materiale dei
settori
popolari.
Il 15 febbraio – a
Roma – in occasione della probabile approvazione, da parte
del Consiglio
dei Ministri, del Decreto sull’Autonomia Differenziata,
è stato convocato un presidio di lotta a Montecitorio per
protestare
contro questo dispositivo normativo che accentuerà gli
squilibri territoriali del nostro paese, aumenterà il
divario Nord/Sud, le
disuguaglianze sociali ed il complesso degli strumenti
deregolamentazione dell’unità politica e materiale dei
settori
popolari.
Si pone, quindi, di nuovo, la necessità di una ripresa della discussione su una nuova “Questione/Contraddizione Meridionale/Mediterranea” che sappia descrivere le attuali dinamiche del corso della crisi e delle conseguenti trasformazioni che stanno configurando la nuova mappa del comando economico e sociale del paese dentro le convulsioni che l’Azienda/Italia vive nel gorgo della competizione internazionale.
Ripubblichiamo – per favorire il dibattito dei compagni e degli attivisti – una scheda, redatta da Biagio Borretti ed Italo Nobile, su un libro che ha segnato la qualità del dibattito sul Sud e sulle trasformazioni della forma/stato nel Mezzogiorno d’Italia.
Nei prossimi giorni daremo conto di altri contributi che stanno giungendo al nostro sito[La redazione del sito della Rete dei Comunisti].
* * * *
Il lavoro di Ferrari Bravo, di cui di seguito si offre una scheda sintetica, è per molti versi superato dalle modifiche profonde che si sono susseguite sul piano materiale, della formazione economico-sociale negli ultimi decenni e, di conseguenza, anche nel campo del politico. L’analisi della forma-stato, di una particolare forma-stato, storicamente e socialmente determinata, risulta oggi, a tratti, addirittura “incomprensibile”, tali sono stati i cambiamenti, anche sul piano istituzionale.
Leggi tutto
Miguel Abensour: Marx, quale critica dell'utopia?
Marx, quale critica dell'utopia?[1]
di Miguel Abensour
La redazione di Thomasproject.net pubblica online il lungo articolo di Miguel Abensour dedicato al rapporto che Karl Marx intrattenne col pensiero utopico. L’articolo è stato inserito nella recente pubblicazione collettanea dal titolo Alle frontiere del capitale, l’ultimo volume della collana Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico curata da Pier Paolo Poggio della Fondazione Micheletti di Brescia, uscito da poco in libreria
 La questione proposta può sembrare accademica,
invecchiata, anzi,
completamente sorpassata. Se negli anni Settanta ebbe un senso
politico e filosofico evidente, ora nella congiuntura presente
– sotto il segno
del «realismo», del ritorno del diritto e dello Stato di
diritto – appare come un oggetto di controversia erudita, un
punto di
storia della filosofia o delle dottrine, capace al massimo di
attrarre l’attenzione di qualche marxologo e «utopiologo», da
tempo,
se posso dirlo, fuori dal servizio attivo.
La questione proposta può sembrare accademica,
invecchiata, anzi,
completamente sorpassata. Se negli anni Settanta ebbe un senso
politico e filosofico evidente, ora nella congiuntura presente
– sotto il segno
del «realismo», del ritorno del diritto e dello Stato di
diritto – appare come un oggetto di controversia erudita, un
punto di
storia della filosofia o delle dottrine, capace al massimo di
attrarre l’attenzione di qualche marxologo e «utopiologo», da
tempo,
se posso dirlo, fuori dal servizio attivo.
Di più. Non sarebbe una questione crepuscolare, consistente nel dissertare dottamente su due forme di vita entrambe irrimediabilmente invecchiate? In breve, saremmo nel grigiore più pieno.
Non è così, però, ai miei occhi. Si tratta piuttosto di una questione intempestiva – contro lo spirito del tempo – inattuale, altra dall’attuale. Dal lato di Marx: si può, in effetti, considerare che il crollo dei regimi che si richiamavano al marxismo abbia avuto paradossalmente l’effetto di restituirci Marx. Voglio dire, cioè, che la lettura filosofica, critica, finora tentata solo da alcuni (M. Rubel, M. Henry, P. Ansart, C. Castoriadis), diventa ormai una modalità di lettura accessibile a tutti, purché disposti a rompere con l’ideologizzazione a cui l’opera di Marx è stata sottoposta. Quest’opera ci è di nuovo offerta come un’opera di pensiero, con le sue ambiguità, le sue contraddizioni, la sua incompiutezza, le sue opacità. Essa ci appare ormai come se si elaborasse alla prova della sua propria divisione. E ci attrae più per i cammini di pensiero che ha dischiuso e percorso fino a un certo punto, che non per le «tesi» cui sarebbe pervenuta. Noi riscopriamo un Marx suscettibile di rilanciare la nostra interrogazione, anziché fornirci un focolare di certezze. All’occorrenza questo significa che ci è ormai possibile riesaminare la questione della critica dell’utopia, della sua vera portata, al di fuori delle diverse ortodossie che se ne sono impadronite, facendo riemergere l’operazione complessa di Marx nei confronti delle utopie.
Leggi tutto
Matteo Montaguti: La rivoluzione nella nostra vita
La rivoluzione nella nostra vita
di Matteo Montaguti
Emiliana Armano e Raffaele Sciortino (a cura di), Revolution in our lifetime. Conversazione con Loren Goldner sul lungo Sessantotto, Colibrì 2018, pp. 112, € 14,00.
 «Il problema per me
è sempre stato quello di usare la scrittura come arma»
«Il problema per me
è sempre stato quello di usare la scrittura come arma»
Loren Goldner
Nel cinquantesimo anniversario del Sessantotto, caduto nell’anno appena passato, sono state numerose le pubblicazioni, accademiche e non, che ne hanno tentato un bilancio, perlopiù di tipo storiografico, memorialistico o sociologico, oppure di basso taglio giornalistico. Ben poche, invece, quelle che hanno provato a farne un bilancio politico nitido, di lungo corso e soprattutto di parte. Tra queste va sicuramente segnalato, anche rispetto alla ricorrenza del mezzo secolo che ci separa dalla rivolta operaia del 1969, Revolution in our lifetime. Conversazione con Loren Goldner sul lungo Sessantotto, curata da Emiliana Armano e Raffaele Sciortino per i tipi di Edizioni Colibrì.
Loren Goldner, settantenne militante marxista e atipico intellettuale statunitense, è una figura poco conosciuta in Italia ma di spessore internazionale: ha al suo attivo un’infaticabile attività teorica e di pubblicista, con numerosi saggi di critica dell’economia politica, filosofici, letterari (alcuni dei quali tradotti anche in italiano, come L’avanguardia della regressione. Pensiero dialettico e parodie post-moderne nell’era del capitale fittizio e, in concomitanza con la crisi dei subprime in America, il volume Capitale fittizio e crisi del capitalismo, entrambi delle edizioni PonSinMor) e conduce da diversi decenni un recupero critico della storia di classe e una rigorosa analisi sulle trasformazioni del capitale, in particolare per quanto riguarda la sua finanziarizzazione, rileggendo la nozione marxiana di “capitale fittizio” alla luce della lunga crisi del dollaro iniziata dopo la rottura degli accordi di Bretton Woods.
Il volume curato da Armano e Sciortino è un denso ma agile strumento utile per la difficile operazione di definire un punto di vista militante e un metodo di pensiero autonomo che sappiano confrontarsi, oggi, con i tempi, le espressioni e le forme globali della lotta di classe – e quindi di un agire politico di parte – senza cedere alla rassegnazione dello sguardo contingente, alla vana nostalgia per il passato («la nostalgia non è un’emozione da marxisti […] cerchiamo di guardare al futuro a partire da una valutazione lucida e realistica del presente», p.72), alle facili narrazioni egemoni e alle difficili impasse della propria fase.
Leggi tutto
coniarerivolta: La curiosa democrazia di Draghi: voi votate, i mercati decidono
La curiosa democrazia di Draghi: voi votate, i mercati decidono
di coniarerivolta
La letteratura gialla e quella noir sono ricche di personaggi che, avendo commesso un orribile crimine, provano a tenere nascosta la propria colpa, ma vengono costretti da un insopprimibile istinto a rivelare, in un modo o nell’altro e più o meno esplicitamente, il delitto che hanno compiuto.
Lunedì scorso il Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, ha tenuto un discorso alla Commissione Affari Economici del Parlamento Europeo. Il Presidente ha fatto il punto su quella che secondo lui è la situazione economica dell’Eurozona e ha elencato i rischi ai quali vanno incontro gli incauti Paesi che non applicano le ricette consigliate dalle istituzioni comunitarie. Alcune frasi pronunciate da Draghi sono interessanti e vale la pena approfondirne il significato: come vedremo, questo esercizio ci sarà utile a comprendere come l’indipendenza di una banca centrale dal Governo si traduca nella perdita di uno strumento vitale di perseguimento dei più concreti obiettivi di equità sociale e piena occupazione.
Scorrendo i resoconti di stampa forniti dai vari giornali che si sono affrettati a diffondere il suo Verbo, scopriamo che secondo il Governatore «un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto»: a quel punto, infatti, «sono i mercati che decidono». Ne consegue che ogni decisione di politica «deve essere scrutinata dai mercati, cioè da persone che non votano e che sono fuori dal processo di controllo democratico».
Leggi tutto
Manlio Dinucci: L’affossamento Usa con la complicità dell’Europa
L’affossamento Usa con la complicità dell’Europa
di Manlio Dinucci
Usa/Russia. Anche l’Unione europea ha dato luce verde alla possibile installazione di nuovi missili nucleari Usa in Europa, Italia compresa. Su una questione di tale importanza il governo Conte, come i precedenti, si è accodato sia alla Nato che alla Ue. E dall’intero arco politico non si è levata una voce per richiedere che fosse il Parlamento a decidere come votare all’Onu sul Trattato Inf
La «sospensione» del Trattato Inf, annunciata ieri dal segretario di stato Pompeo, avvia il conto alla rovescia che in sei mesi porterà gli Usa a uscire dal Trattato. Già da oggi, comunque, gli Usa si ritengono liberi di testare e schierare armi della categoria proibita dal Trattato.
Si tratta di missili nucleari a gittata intermedia (tra 500 e 5500 km), con base a terra. Appartenevano a tale categoria i missili nucleari schierati in Europa negli anni Ottanta: i missili balistici Pershing 2, schierati dagli Stati uniti in Germania Occidentale, e quelli da crociera lanciati da terra, schierati dagli Stati uniti in Gran Bretagna, Italia, Germania Occidentale, Belgio e Olanda, con la motivazione di difendere gli alleati europei dai missili balistici SS-20, schierati dall’Unione sovietica sul proprio territorio.
Il Trattato sulle Forze nucleari intermedie, firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e Reagan, eliminava tutti i missili di tale categoria, compresi quelli schierati a Comiso. Il Trattato Inf è stato messo in discussione da Washington quando gli Stati uniti hanno visto diminuire il loro vantaggio strategico su Russia e Cina.
Leggi tutto
Guido Viale: Un buco nel cervello degli economisti
Un buco nel cervello degli economisti
di Guido Viale
L’ossessione degli economisti e dei “grandi” media resta la crescita. Intanto le conseguenze dei cambiamenti climatici si fanno ogni giorno sempre più evidenti e incontrollabili. In realtà abbiamo bisogno prima di tutto che vengano abbandonati progetti e investimenti inutili e insensati, pensati solo per inseguire la crescita, per adottare qui e ora migliaia di iniziative diffuse di conversione ecologica per garantire un futuro a noi e a chi verrà dopo di noi: impianti di fonti di energia rinnovabili sufficienti a soddisfare il fabbisogno di tutti; progetti di efficienza nell’uso dell’energia e dei materiali; un’agricoltura ecologica, di prossimità, gestita da imprese di piccola taglia insieme a una revisione radicale della nostra alimentazione; un’edilizia sostenibile, fondata soprattutto sul recupero del già costruito, ponendo un argine al consumo di suolo; la rigenerazione degli assetti idrogeologici del territorio e la salvaguardia degli ecosistemi
C’è, in tutti gli articoli, i commenti, le interviste e le analisi economiche pubblicate da giornali, riviste o reti, qualcosa che lascia una sensazione di estraneità, come se parlassero di un mondo chiuso in un comparto stagno che lo separa da tutto ciò che ci succede intorno; quasi che nel cervello degli economisti si fosse aperto un buco che impedisce loro di “guardar fuori”. Le cose che gli economisti non vedono sono tante, ma la principale è senz’altro il cambiamento climatico, ormai palesemente in corso.
Leggi tutto
Maurizio Franzini: Tecnologie digitali, potere economico e democrazia
Tecnologie digitali, potere economico e democrazia
di Maurizio Franzini
Questo testo si basa sull’intervento tenuto alla Camera dei Deputati il 18 gennaio 2019 nel seminario “Democrazia digitale” in ricordo di Stefano Gorelli
Per preparare questo mio breve intervento ho dovuto fare ricorso a un piccolo trucco con me stesso. Non riuscivo a preparare un discorso in memoria di Stefano Gorelli, non riuscivo a parlare per lui invece che con lui. E allora ho immaginato che, come è successo altre volte per altri temi, Stefano mi avesse chiesto di pensare se valesse la pena di organizzare un convegno sul tema delle tecnologie digitali, del potere economico e della democrazia. Ecco quello che avrei potuto dirgli.
Quando si parla delle tecnologie digitali le questioni di rilevanza economica e sociale che vengono alla mente sono molte. Più frequentemente ci si concentra sul probabile impatto che esse avranno sul lavoro, e specialmente sul rischio della fine del lavoro umano. Si tratta, ovviamente, di un tema rilevante. Però io partirei dalle conseguenze che le disuguaglianze, anche alterando le forme e la forza del potere economico, possono avere sul funzionamento della democrazia.
Gli effetti delle tecnologie digitali a cui penso sono essenzialmente due e tra di esse, come cercherò di dire, può instaurarsi un circolo vizioso assai maligno per la democrazia.
Leggi tutto
Riccardo Paccosi: La sinistra liberal-progressista e le sue tre alternative di decesso politico
La sinistra liberal-progressista e le sue tre alternative di decesso politico
di Riccardo Paccosi
Premessa: questo post nasce dal desiderio di capire come funziona una certa cosa – in questo caso una cultura politica. Non c’è alcun interesse, da parte mia, a ripetere considerazioni etico-morali rispetto alle quali tutto quello che c’era da dire è ormai stato detto e ri-detto un milione di volte. Nella fattispecie, non m’interessa in alcun modo stabilire, per l’ambito qui analizzato e per le figure sotto menzionate, la vigenza di buona fede o di strumentalità. Mi interessa, semplicemente, comprendere il nodo strategico dal punto di vista del soggetto collettivo preso in esame. Nient’altro
Due giorni fa, Massimo D’Alema ha dichiarato che la nuova leadership del PD dovrebbe “avere il coraggio di aprire una riflessione critica su questi anni”, che “sarebbe un suicidio per la sinistra convergere in un’ammucchiata con tutti quelli che difendono l’Europa così com’è contro la barbarie sovranista”, che il male d’orgine non è il sovranismo bensì “l’egemonia neoliberista”. Con queste dichiarazioni, si palesa il bivio che – teoricamente – si profila all’orizzonte della sinistra liberale nel tentare di rilanciarsi.
Indipendentemente dalle reali scelte sul terreno sociale ed economico, infatti, in campo liberal-progressista si stanno profilando due linee incompatibili sul versante della strategia di comunicazione di massa: vi è una linea auto-critica (rappresentata, oltre che da D’Alema, dal candidato alla segreteria Nicola Zingaretti) e una linea a varie gradazioni identitaria nonché rivendicante tutto il percorso degli ultimi anni (rappresentata dagli altri due candidati alla segreteria, Maurizio Martina e Roberto Giachetti).
Leggi tutto
Emiliano Alessandroni: Quale Marx?
Quale Marx?
Lo scontro egemonico tra Gramsci e Gentile
di Emiliano Alessandroni
 Premessa
Premessa
Nel paragrafo 235 del Quaderno 8, dal titolo Introduzione allo studio della filosofia, Gramsci sostiene l'importanza di «rivedere» e «criticare tutte le teorie storicistiche di carattere speculativo», predisponendo, sull'esempio di Engels, le idee per la composizione di «un nuovo Antidühring, che», afferma, «potrebbe essere un AntiCroce, poiché in esso potrebbe riassumersi non solo la polemica contro la filosofia speculativa, ma anche, implicitamente, quella contro il positivismo e le teorie meccanicistiche, deteriorazione della filosofia della praxis»1. Più avanti, in Q 10b, 11, egli specifica che «un Anti-Croce deve essere anche un Anti-Gentile»2.
La lotta contro le teorie dei due filosofi idealisti costituisce per Gramsci una delle vie maestre per procedere ad una corretta esposizione di quella «filosofia della praxis» che individuava in Marx ed Engels i propri padri fondatori. Il primo oggetto del contendere è dunque il materialismo storico e vedremo come le riflessioni di Gramsci, tanto quelle dei Quaderni quanto quelle degli scritti precedenti, forniscano gli elementi fondamentali oltre che per la stesura di un Anti-Croce anche per quella di un Anti-Gentile3.
Nell'accostarsi a questo tema occorre tenere in considerazione due questioni fondamentali 1) Gentile non è mai stato marxista; 2) elementi del marxismo sono penetrati nella prospettiva di Gentile. Contrariamente a quanto da un primo sguardo possa apparire, di questi due punti è il secondo a costituire il dato meno sorprendente. Gramsci stesso ci induce invero a supporre che dopo Marx non esiste autore della storia della filosofia nel quale non si possano rintracciare testimonianze della sua lezione.
Leggi tutto
Teresa Battista: Il lavoro ci interessa, ma pure il salario
Il lavoro ci interessa, ma pure il salario
di Teresa Battista*
In un editoriale del "Corriere della sera" Ferruccio De Bortoli sostiene che il lavoro c'è, a mancare sono i giovani talenti interessati a lavorare. Ma la realtà è un'altra e parla di precarietà, basse retribuzioni ed emigrazioni dall'Italia
 Pare che i
liberali del nostro paese non possano fare a meno di biasimare
quotidianamente disoccupati e poveri, quali soggetti privi di
ogni etica e intrinsecamente oziosi, scansafatiche. Proprio
qualche giorno fa dalle
pagine del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli
si lancia in un’invettiva contro la
classe
lavoratrice precaria e disoccupata, usando come alibi il
discusso e discutibile “reddito di cittadinanza” da poco
approvato dal governo,
quale meccanismo che disincentiverebbe i disoccupati a darsi
da fare e accettare le centinaia di migliaia di posti di
lavoro disponibili. Insomma,
parafrasando il titolo dell’articolo citato, secondo lui il
lavoro c’è ma non ci interessa. Figuriamoci con un po’ di
reddito
di sudditanza a disposizione.
Pare che i
liberali del nostro paese non possano fare a meno di biasimare
quotidianamente disoccupati e poveri, quali soggetti privi di
ogni etica e intrinsecamente oziosi, scansafatiche. Proprio
qualche giorno fa dalle
pagine del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli
si lancia in un’invettiva contro la
classe
lavoratrice precaria e disoccupata, usando come alibi il
discusso e discutibile “reddito di cittadinanza” da poco
approvato dal governo,
quale meccanismo che disincentiverebbe i disoccupati a darsi
da fare e accettare le centinaia di migliaia di posti di
lavoro disponibili. Insomma,
parafrasando il titolo dell’articolo citato, secondo lui il
lavoro c’è ma non ci interessa. Figuriamoci con un po’ di
reddito
di sudditanza a disposizione.
Le argomentazioni adottate discendono direttamente dalla teoria neoclassica secondo cui un aumento dei sussidi ridurrebbe l’incentivo per i disoccupati a cercare lavoro perché potrebbero godere di un reddito seppur modesto, rifiutando la fatica del lavoro a cui sono costretti dalla propria condizione sociale. Tuttavia, la realtà e la ricerca scientifica smentiscono ormai da decenni questi argomenti. Il tentativo di riportare i fatti dentro il guscio ideologico del liberismo appare sempre più goffo e velleitario. Vale però la pena ricordare che il contrasto a una politica di sussidi in caso di disoccupazione e/o disagio sociale fa parte di quella corrente teorica che vede ogni protezione delle condizioni di vita dei lavoratori, e più in generale delle fasce subalterne della società, come uno spreco che inibisce il buon operare del mercato e la competitività delle imprese. Abbiamo già visto dove la pluridecennale liberalizzazione e flessibilizzazione del lavoro ci ha portati, con il mondo del lavoro come bersaglio privilegiato delle politiche di deflazione e austerità, di cui fanno parte il blocco del turnover nella pubblica amministrazione e l’esternalizzazione di ampi servizi pubblici.
Leggi tutto
Massimo Filippi: Le trecce di Derrida
Le trecce di Derrida
 Accedere
al laboratorio filosofico di Derrida – come è il caso delle
nove
lezioni del corso Teoria e prassi tenuto nel
1975-1976 presso l’École Normale Supérieure di Parigi – è
sempre un’esperienza che provoca sentimenti ambivalenti. Da un
lato, l’innegabile gioia di rintracciare i nuclei
incandescenti di
formazioni di pensiero in magmatica evoluzione trasformativa e
dall’altro – per riprendere le parole a cui, già nelle
primissime
righe del testo, lo stesso Derrida fa ricorso di fronte
all’enormità del tema che si trova a dover fronteggiare –
«l’immensa difficoltà» a districarsi tra la proliferante e
sorprendente disseminazione di piste che, più o meno
tracciate, si aprono, si perdono, si intrecciano, si
cancellano, e si sovrappongono a ogni svolta della sua
riflessione fino a far emettere, sia al
lettore che al filosofo francese, «un sospiro di
scoraggiamento».
Accedere
al laboratorio filosofico di Derrida – come è il caso delle
nove
lezioni del corso Teoria e prassi tenuto nel
1975-1976 presso l’École Normale Supérieure di Parigi – è
sempre un’esperienza che provoca sentimenti ambivalenti. Da un
lato, l’innegabile gioia di rintracciare i nuclei
incandescenti di
formazioni di pensiero in magmatica evoluzione trasformativa e
dall’altro – per riprendere le parole a cui, già nelle
primissime
righe del testo, lo stesso Derrida fa ricorso di fronte
all’enormità del tema che si trova a dover fronteggiare –
«l’immensa difficoltà» a districarsi tra la proliferante e
sorprendente disseminazione di piste che, più o meno
tracciate, si aprono, si perdono, si intrecciano, si
cancellano, e si sovrappongono a ogni svolta della sua
riflessione fino a far emettere, sia al
lettore che al filosofo francese, «un sospiro di
scoraggiamento».
Molteplici sono le linee di forza/frattura/fuga che, pagina dopo pagina, tracciano il testo di questo corso, pubblicato da Galilée nel 2017 e prontamente reso disponibile in italiano, nel novembre dello scorso anno, grazie alla cura di Gianfranco Dalmasso e Silvano Facioni e alla pregevole traduzione dello stesso Dalmasso e di Marco Maurizi. Quattro trecce, però, innervano l’incedere del corso in maniera più evidente di altre, costituendone una sorta di impalpabile e sfuggente architettura. Queste trecce – iper-tracce o infra-tracce in cui si annodano, forsennatamente e rizomaticamente, gli innumerevoli fili che le compongono, che le sfilano l’una nell’altra e che le fanno sfilare – sono tra loro difficilmente separabili, rendendo di fatto impossibile il compito di recensirle. Ma, nonostante tutto, «si deve fare», direbbe Derrida.
Ecco, allora, quasi d’incanto, venirci incontro la prima treccia – «faut le faire» –, che vede in Marx e Althusser i suoi aiutanti. «Si deve fare» è l’espressione che (ri)taglia il testo derridiano da cima a fondo. Prima treccia che risuona con tonalità differenti a seconda che l’enfasi, come accade molto spesso nell’idioma derridiano, cada sul fare o sul deve.
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: Venticinque anni dopo. La favola consolatoria della crisi del berlusconismo
Venticinque anni dopo. La favola consolatoria della crisi del berlusconismo
di Tommaso Nencioni
Il 26 gennaio del 1994 Berlusconi annunciava, con un celebre messaggio televisivo, la sua “discesa in campo”. Venticinque anni dopo, lo stesso Berlusconi si trova ingloriosamente fuori dal Parlamento; la sua riabilitazione giudiziaria ha permesso l’annuncio di una sua nuova candidatura alle imminenti elezioni europee; ma il suo movimento politico appare in piena crisi, diviso e sfibrato, e la Lega salviniana sta occupando tutto l’intero spazio politico che fu di “centro-destra”. Si può tuttavia parlare di “fallimento del berlusconismo”?
Non certo del fallimento della cultura politica di cui Berlusconi si è fatto portatore. Il suo “anti-antifascismo” – come lo ha classificato il suo più lucido studioso, Giovanni Orsina –,fino agli anni Ottanta relegato in posizioni minoritarie dello spettro politico, si basava e si basa su una critica organica al carattere programmatico dell’antifascismo, ben tradotto nella nostra Costituzione. Ebbene, è purtroppo difficile negare che il “discorso” berlusconiano sui limiti e i difetti congeniti della carta costituzionale (e della democrazia dei partiti da essa scaturita) mantenga una salda egemonia nel senso comune di tutti gli attuali schieramenti politici. A questo mirava la battaglia delle idee della destra italiana, e questo obiettivo ha raggiunto grazie al berlusconismo.
Leggi tutto
comidad: La Framania frana subito col Venezuela
La Framania frana subito col Venezuela
di comidad
Il patto firmato da Macron e dalla Merkel il 22 gennaio scorso ad Aquisgrana, antica capitale del Sacro Romano Impero di Carlo Magno, ricalca altrettanto antiche ipotesi geopolitiche. Si è molto discusso in passato sul fatto che Francia e Germania costituirebbero assieme una nuova superpotenza globale. Tutte chiacchiere, ovviamente. Vari commentatori hanno fatto opportunamente notare che due leader politici come Macron e Merkel, deboli in patria e nel contesto internazionale, possono oggi trovare il loro unico sfogo nel bullizzare gli altri partner europei.
Se la Framania non ha funzionato neppure ai tempi di Carlo Magno e si sciolse immediatamente alla sua morte, niente fa supporre che possa funzionare adesso e le prove inconfutabili di ciò sono arrivate tempestivamente con la crisi venezuelana. Macron e la Merkel hanno mandato avanti il loro vassallo spagnolo a sostenere una linea anti-Maduro assolutamente priva di qualsiasi appiglio nel diritto internazionale: o convochi subito nuove elezioni o riconosceremo il presidente “autoproclamato” Guaidò. La posizione “europea” avrebbe potuto avere un senso se si fosse limitata a chiedere elezioni immediate in Venezuela minacciando in caso contrario una rottura dei rapporti diplomatici. La minaccia di riconoscere un altro presidente assume invece il senso di una plateale istigazione alla guerra civile. Un vero e proprio crimine internazionale, del tutto analogo a quelli già commessi con la Libia e con la Siria.
Leggi tutto
Fabio Ciabatti: Sartre e il razzismo come sistema di iper-sfruttamento
Sartre e il razzismo come sistema di iper-sfruttamento
di Fabio Ciabatti
Iside Gjergji, “Uccidete Sartre!” Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant, con quattro scritti di Jean-Paul Sartre, Ombre Corte 2018, p. 118, € 10,00
Possiamo considerare il razzismo come il prodotto di credenze e idee che nascono da una relazione negativa con l’alterità? La risposta appare ovvia per coloro che, partendo da un punto di vista liberal-democratico, cercano di contrapporsi alle falsità palesi di una propaganda che straparla di invasione della patria da parte di orde di extracomunitari coadiuvati da perfidi scafisti. Se, dati alla mano, la calata dei barbari non c’è, quale altra interpretazione dare al razzismo diffuso se non l’ignoranza e la paura dell’altro? Ebbene, secondo Sartre, un’altra spiegazione c’è: il razzismo non è un’ideologia separabile dalla pratica, ma una “violenza che si dà la propria giustificazione”, una “praxis illuminata da una ‘teoria’”. In altri termini, deve essere sempre pensato come “razzismo-operazione”1. Sottigliezze, si dirà. Non proprio, se seguiamo il ragionamento di Iside Gjergji nel suo libro Uccidete Sartre! Anticolonialismo e antirazzismo di un revenant, pubblicazione che raccoglie anche quattro testi del filosofo francese (Il razzismo è un sistema, “Voi siete formidabili”, Una vittoria e “Da una Cina all’altra”).
Leggi tutto
Laura Paulizzi: L’emancipazione ai tempi dei social
L’emancipazione ai tempi dei social
Considerazione a margine sul dibattito Quarto potere ed oltre
di Laura Paulizzi
La nostra epoca è caratterizzata dalla possibilità di accesso ad una grande pluralità di contenuti grazie a tecnologie disponibili di facile utilizzo per tutti. La compartecipazione che le nuove tecnologie sono in grado di offrire, non richiama una dimensione di presenza effettiva, anzi è molto simile alla condizione inautentica dell’esistenza quotidiana descritta da Heidegger in Essere e tempo, una quotidianità in cui ci si trova. Un Si riflessivo, das Man, ombra di un agire umano privo di scelta, condizionato e trascinato dall’andamento della massa. Una presenza, quella dell’individuo nella sua singolarità, che si conforma ad una collettività da cui viene inglobato senza riflessione, senza mediazione. A questa esistenza Heidegger fa corrispondere il linguaggio della Gerede (§35), la chiacchiera, che caratterizza l’espressione linguistica propria della comprensione e dell’interpretazione dell’esserci quotidiano. Questo tipo di comunicazione non penetra nell’essenza del contenuto di cui si discute. Il discorso non si fa garante dell’esattezza e della conformità delle cose trattate, non si appropria della cosa ma diviene la diffusione e la ripetizione di se stesso:
«La capacità media di comprensione del lettore non sarà mai in grado di decidere se qualcosa è stato creato e conquistato con originalità o se è frutto di semplice ripetizione. La comprensione media non sentirà mai neppure il bisogno di una distinzione di questo genere, visto che essa comprende già tutto. La totale infondatezza della chiacchiera non è un impedimento per la sua diffusione pubblica ma un fattore determinante. La chiacchiera è la possibilità di comprendere tutto senza alcuna appropriazione preliminare della cosa da comprendere»[1]
Leggi tutto
Mauro Armanino: Bilal a Niamey. Il Niger come casa di sabbia
![]()
Bilal a Niamey. Il Niger come casa di sabbia
di Mauro Armanino
Niamey, gennaio 2019. E’nato in Libia da una madre che ha cercato di togliersi la vita dopo il parto. Salvata da un miracolo di passaggio l’ha in seguito chiamato Bilal perchè è nato al settimo mese. Salvato dalle acque, del mare Mediterraneo porta solo l’allusione. Bilal è un nome arabo che significa ‘acqua e freschezza’. Sua madre vive adesso a Niamey, assieme ad altre centinaia di rifugiati che le prigioni libiche detenevano torturando. A quattordici anni era fuggita dall’Etiopia, con un’amica di sedici, dopo aver perso tutto in patria. Già nel vicino Soudan avevano subito ricatti e violenze senza fine da parte di ‘passeurs’ criminali. Nel viaggio verso la Libia l’amica muore e lei, raggiunto il Paese, scopre di essere incinta. La creatura di sabbia nasce al settimo mese e lei cerca di togliersi la vita. La salva Bilal, nome che significa ‘acqua e freschezza’. Per ora la sua casa è a Niamey. Una casa di sabbia, precaria come la sua vita, grazie al servizio delle Nazioni Unite per i Rifugiati, che ha come simbolo due mani a forma di casa. Bilal, con sua madre, abitano proprio sotto quelle due mani di acqua fresca.
Dovete capire/ che nessuno mette i figli su una barca/a meno che l’acqua non sia più sicura della terra/...(Dalla poesia HOME, della somala Warsan Shire)
Nel Sudan un gruppo di ribelli brucia il villaggio dove abitava coi suoi genitori. Riescono a raggiungere la Libia e solo dopo alcuni mesi di trattative si imbarcano per l’Italia.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2017
Hits 1865
Hits 1779
Hits 1735
Hits 1722
Hits 1696
Hits 1686
Hits 1684
tonino

coniarerivolta: Quando la dignità è precaria: note sul Jobs Act 2.0
Quando la dignità è precaria: note sul Jobs Act 2.0
di coniarerivolta
 Nel bel mezzo dell’estenuante iter
di predisposizione della Legge di bilancio, quasi sotto
traccia il 1° novembre
scorso sono entrate a tutti gli effetti in vigore le modifiche
in tema di contratti di lavoro a termine e di licenziamenti
illegittimi previste dal
famigerato “Decreto Dignità” (D.L. n 87/2018, convertito in L.
n 96/2018), di fatto il primo provvedimento di marca
grillino-leghista.
Nel bel mezzo dell’estenuante iter
di predisposizione della Legge di bilancio, quasi sotto
traccia il 1° novembre
scorso sono entrate a tutti gli effetti in vigore le modifiche
in tema di contratti di lavoro a termine e di licenziamenti
illegittimi previste dal
famigerato “Decreto Dignità” (D.L. n 87/2018, convertito in L.
n 96/2018), di fatto il primo provvedimento di marca
grillino-leghista.
La gestazione del Decreto Dignità è stata accompagnata da un acceso dibattito e da un ampio ventaglio di polemiche. Da un lato, le roboanti dichiarazioni del Ministro Di Maio, secondo cui il Decreto Dignità metterebbe, una volta per tutte, la parola fine alla precarietà del lavoro in Italia e al Jobs Act di renziana memoria. Dall’altro, il codazzo liberista formato da esponenti dell’opposizione (PD in prima linea con la buona compagnia dei compagni di merende di Confindustria), dall’Inps di Tito Boeri, e dalla stampa padronale, secondo cui il decreto è in realtà lesivo per i lavoratori, in quanto generatore di disoccupazione, licenziamenti e di una riduzione dell’attività produttiva, fino ad arrivare a posizione ondivaghe ed ambigue da parte dei sindacati confederali.
Ebbene, per comprendere se ci troviamo di fronte ad una pur blanda riconfigurazione dell’assetto degli attuali rapporti di forza tra imprese e lavoratori, può essere utile evidenziare le implicazioni politiche derivanti dal Decreto Dignità, in particolare i riflessi immediati in termini di conflitto di classe. Ci concentreremo in questo pezzo solo su alcuni aspetti del decreto, in particolare sul ritorno delle causali per i contratti a tempo determinato, sulla riduzione della durata dei contratti a termine e sull’aumento delle indennità per i licenziamenti illegittimi.
Con riferimento ai contratti di lavoro a termine, il Decreto Dignità prevede i seguenti quattro punti.
A) Se il primo contratto a termine stipulato tra la singola impresa e il singolo lavoratore ha una durata superiore ai 12 mesi, o se comunque si tratta di un contratto a termine successivo al primo stipulato tra la stessa impresa e lo stesso lavoratore, l’assunzione a termine deve essere giustificata dal datore di lavoro sulla base di esigenze temporanee dell’impresa, vale a dire indicando le cosiddette causali, che il Jobs Act aveva del tutto eliminato.
Leggi tutto
Fernanda Mazzoli: Ripensare la scuola
Ripensare la scuola
di Fernanda Mazzoli
Oggi, la questione prioritaria da affrontare, se ci si vuole efficacemente opporre alla deriva economicistica e mantenere aperta, all’interno dell’istituzione scolastica, quella dimensione “utopica” così intimamente legata all’idea stessa di educazione, idea che comporta una tensione intrinseca verso “un altrove” che nulla ha a che vedere con l’adattamento al presente
 Da anni l’istruzione è
al centro di un’ambiziosa campagna ideologica di segno
neoliberista che ha investito significativamente
organizzazione, contenuti disciplinari, modalità didattiche e
finalità educative del
sistema scolastico, fino alla messa in discussione dell’idea
stessa di scuola, come è venuta storicamente configurandosi.
L’opinione comune secondo la quale la scuola, nel nostro
Paese, sarebbe la Cenerentola dell’agenda politica e delle
priorità
sociali è infondata: perlomeno da un ventennio essa è oggetto
di pesanti attenzioni da parte dei diversi governi
succedutisi, dei
burocrati del MIUR, degli specialisti in Scienze
dell’educazione dei Dipartimenti accademici, dei centri studi
di fondazioni imprenditoriali e
bancarie, delle Commissioni per la cultura europee. Tutti
questi attori – politici, economici, culturali – hanno ben
chiaro il carattere
strategico dell’istituzione e hanno agito di conseguenza,
secondo una linea di sostanziale continuità e complementarità.
Azienda
tra le aziende del territorio nella società di mercato,
specializzata nell’erogazione di un bene formativo, alla
scuola spetterebbe ormai
il compito di promuovere, sin dal primo ciclo, l’educazione
all’auto-imprenditorialità di uno studente dotato di quei
requisiti di
adattabilità, flessibilità, competitività ed efficienza
operativa richiesti dalle imprese e di quelle competenze
tecnologiche
indispensabili alla riproduzione del sistema. La scuola è
chiamata a divenire laboratorio pedagogico di un modello
distopico di società
ruotante intorno alla “cultura d’impresa”, fondata sul primato
dell’economia e sulla sua pretesa di colonizzare ogni ambito
della vita, rimodellando le condotte individuali e le
politiche sociali secondo i principi dell’interesse
individuale e della competizione.
Da anni l’istruzione è
al centro di un’ambiziosa campagna ideologica di segno
neoliberista che ha investito significativamente
organizzazione, contenuti disciplinari, modalità didattiche e
finalità educative del
sistema scolastico, fino alla messa in discussione dell’idea
stessa di scuola, come è venuta storicamente configurandosi.
L’opinione comune secondo la quale la scuola, nel nostro
Paese, sarebbe la Cenerentola dell’agenda politica e delle
priorità
sociali è infondata: perlomeno da un ventennio essa è oggetto
di pesanti attenzioni da parte dei diversi governi
succedutisi, dei
burocrati del MIUR, degli specialisti in Scienze
dell’educazione dei Dipartimenti accademici, dei centri studi
di fondazioni imprenditoriali e
bancarie, delle Commissioni per la cultura europee. Tutti
questi attori – politici, economici, culturali – hanno ben
chiaro il carattere
strategico dell’istituzione e hanno agito di conseguenza,
secondo una linea di sostanziale continuità e complementarità.
Azienda
tra le aziende del territorio nella società di mercato,
specializzata nell’erogazione di un bene formativo, alla
scuola spetterebbe ormai
il compito di promuovere, sin dal primo ciclo, l’educazione
all’auto-imprenditorialità di uno studente dotato di quei
requisiti di
adattabilità, flessibilità, competitività ed efficienza
operativa richiesti dalle imprese e di quelle competenze
tecnologiche
indispensabili alla riproduzione del sistema. La scuola è
chiamata a divenire laboratorio pedagogico di un modello
distopico di società
ruotante intorno alla “cultura d’impresa”, fondata sul primato
dell’economia e sulla sua pretesa di colonizzare ogni ambito
della vita, rimodellando le condotte individuali e le
politiche sociali secondo i principi dell’interesse
individuale e della competizione.
Ben venga, dunque, una ricerca come quella promossa dall’IRRE Lombardia (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) che ha visto un gruppo di docenti universitari e della Secondaria interrogarsi sui fondamenti teorici e i fini sociali di una cultura autenticamente riformatrice nella scuola, nella comune convinzione che scuola ed educazione, invece di assecondare l’attuale stato delle cose, abbiano un carattere fortemente utopico.
Leggi tutto
Francesco Farina: Draghi sulle crisi: come affrontarle in un’area valutaria?
Draghi sulle crisi: come affrontarle in un’area valutaria?
di Francesco Farina
 Nel discorso tenuto in dicembre in
occasione della Laurea Honoris Causa in Economics
dell’Università Sant’Anna di Pisa – un denso excursus
sulla vicenda europea – il Presidente della BCE Mario
Draghi si è espresso con la libertà di giudizio che nella sua
posizione ci si conquista soltanto a fine mandato. Draghi ha
rilevato come
la crisi finanziaria abbia portato alla luce i seri problemi
di aggiustamento agli shock che si celano nell’impianto
dell’euro. Molti, ed
altrettanto enormi, sono tuttavia anche i vantaggi dell’euro:
all’incremento dimensionale dei mercati di sbocco dei
prodotti, permesso dai
vari allargamenti del mercato unico, ha fatto seguito
l’abbattimento dell’incertezza sulla redditività attesa degli
investimenti;
esso ha consentito alle imprese dell’area valutaria di trarre
il massimo vantaggio dallo sfruttamento delle economie di
scala. Draghi ha
sottolineato inoltre, correggendo il giudizio sulla stasi
ventennale della produttività in Italia, che incrementi in
realtà ce ne sono
stati. Se i dati sulla performance del nostro
sistema economico non sono in grado di esibirli è perché tali
progressi sono
occultati nella sequenza di beni intermedi italiani inseriti
nelle più importanti “catene di valore” europee. Il vasto
settore
manifatturiero italiano vanta infatti una significativa
partecipazione – che riguarda ben mezzo milione di lavoratori
– alla rete dei
processi produttivi di imprese europee che esportano in tutto
il mondo. Inoltre, nell’accrescere il contenuto di
importazioni delle esportazioni
(i beni intermedi che entrano nella produzione dei beni finali
esportati), le “catene di valore” europee finiscono per
annullare gran
parte del miglioramento della bilancia commerciale che ci si
potrebbe attendere dalla svalutazione del cambio di una nostra
ipotetica valuta.
“In un mondo sempre più dominato dalle economie di scala –
conclude Draghi – l’Italia ha mantenuto le sue fondamentali
caratteristiche (…) e si è profondamente integrata nei
processo produttivo europeo attraverso il Mercato Unico e la
moneta
unica”.
Nel discorso tenuto in dicembre in
occasione della Laurea Honoris Causa in Economics
dell’Università Sant’Anna di Pisa – un denso excursus
sulla vicenda europea – il Presidente della BCE Mario
Draghi si è espresso con la libertà di giudizio che nella sua
posizione ci si conquista soltanto a fine mandato. Draghi ha
rilevato come
la crisi finanziaria abbia portato alla luce i seri problemi
di aggiustamento agli shock che si celano nell’impianto
dell’euro. Molti, ed
altrettanto enormi, sono tuttavia anche i vantaggi dell’euro:
all’incremento dimensionale dei mercati di sbocco dei
prodotti, permesso dai
vari allargamenti del mercato unico, ha fatto seguito
l’abbattimento dell’incertezza sulla redditività attesa degli
investimenti;
esso ha consentito alle imprese dell’area valutaria di trarre
il massimo vantaggio dallo sfruttamento delle economie di
scala. Draghi ha
sottolineato inoltre, correggendo il giudizio sulla stasi
ventennale della produttività in Italia, che incrementi in
realtà ce ne sono
stati. Se i dati sulla performance del nostro
sistema economico non sono in grado di esibirli è perché tali
progressi sono
occultati nella sequenza di beni intermedi italiani inseriti
nelle più importanti “catene di valore” europee. Il vasto
settore
manifatturiero italiano vanta infatti una significativa
partecipazione – che riguarda ben mezzo milione di lavoratori
– alla rete dei
processi produttivi di imprese europee che esportano in tutto
il mondo. Inoltre, nell’accrescere il contenuto di
importazioni delle esportazioni
(i beni intermedi che entrano nella produzione dei beni finali
esportati), le “catene di valore” europee finiscono per
annullare gran
parte del miglioramento della bilancia commerciale che ci si
potrebbe attendere dalla svalutazione del cambio di una nostra
ipotetica valuta.
“In un mondo sempre più dominato dalle economie di scala –
conclude Draghi – l’Italia ha mantenuto le sue fondamentali
caratteristiche (…) e si è profondamente integrata nei
processo produttivo europeo attraverso il Mercato Unico e la
moneta
unica”.
Leggi tutto
Alessandro Robecchi: I poveri che non lavorano prenderanno come quelli che lavorano, perbacco!
I poveri che non lavorano prenderanno come quelli che lavorano, perbacco!
di Alessandro Robecchi
Uno spettacolo impareggiabile, quello dei poveri che picchiano i poveri, una battaglia deprimente che ognuno può vedere come vuole attraverso le sue lenti: un effetto del darwinismo sociale quotidiano, oppure un’abile strategia per dividere i poveracci tra buoni (quelli che lavorano e sono poveri) e cattivi (quelli che non lavorano e prenderanno il reddito di cittadinanza, restando peraltro poveri).
Il nodo della questione l’hanno sollevato in parecchi (nessun povero) l’altro giorno: se diamo 780 euro ai poveri disoccupati senza casa, chi vorrà andare a lavorare per 800 euro? Lo hanno chiesto in rapida successione il presidente dell’Inps Boeri e Pierangelo Albini di Confindustria (auditi in Commissione Lavoro) e l’immancabile Carlo Calenda (cuoricinato via twitter). Siccome è tradizione tirare in ballo i morti che non possono mandarti a quel paese, Calenda si è addirittura nascosto dietro il grande leader del passato: “Berlinguer sarebbe inorridito davanti a un sussidio superiore a un reddito da lavoro”.
(Qui vorrei aprire una parentesi. Se dovessimo chiederci davanti a quali cose degli ultimi trent’anni sarebbe inorridito Berlinguer, la lista comincia qui e finisce a Pasqua, quindi lasciamo perdere, ma temo che Calenda sarebbe nell’elenco, vabbé, torniamo al punto).
Leggi tutto
Piotr: Umiliazione e vassallaggio
Umiliazione e vassallaggio
di Piotr
ll in all you’re just another brick in the wall
(Rogers Waters, The Wall)
Dopo il leader della sinistra francese Jean-Luc Mélenchon, dopo il leader laburista britannico Jeremy Corbin, dopo Noam Chomsky, dopo i leader della Linke tedesca, anche il grande Roger Waters si schiera contro il golpe yankee in Venezuela, l’ennesimo colpo di stato fascista ordito dagli Usa in Sudamerica. A Roger Waters, come ben si sa, l’ordine costituito dei prepotenti non è mai piaciuto.
Il famoso “Hey, teachers, leave them kids alone” di The Wall si è trasformato in un immenso:
“STOP THIS LATEST US INSANITY, LEAVE THE VENEZUELAN PEOPLE ALONE. THEY HAVE A REAL DEMOCRACY, STOP TRYING TO DESTROY IT SO THE 1% CAN PLUNDER THEIR OIL.”
Roger Waters (@rogerwaters) 3 febbraio 2019
Fermate quest’ultima pazzia statunitense, lasciate in pace il popolo venezuelano. Hanno una vera democrazia. Basta coi tentativi di distruggerla così che l’1% può saccheggiare il loro petrolio.
Intanto in Italia quasi soltanto Potere al Popolo e importanti esponenti del Movimento 5 Stelle hanno deciso di raccogliere la migliore tradizione della sinistra antimperialista italiana, mentre il PD, LeU e i loro giullari sedicenti intellettuali, con in testa l’immancabile Roberto Saviano, si schierano col golpe sostenuto da Trump e Bolsonaro, in compagnia della Meloni e di Berlusconi.
Leggi tutto
Lorenzo Vita: Adesso Macron fa il despota
Adesso Macron fa il despota
E blocca la libertà d’informazione
di Lorenzo Vita
Liberté, Égalité, Fraternité: questo è il motto su cui si è costruita la Francia repubblicana. Ma da qualche tempo, nessuno dei tre concetti può dirsi realmente applicato nel Paese di Emmanuel Macron. Da quando i gilet gialli sono esplosi nella loro violenta protesta contro il presidente, la stretta sulla libertà d’espressione è stata feroce. A tal punto che in molti, adesso, gridano alla repressione.
La questione è stata sottolineata più volte. Da quando le proteste hanno invaso la Francia e paralizzato gran parte del Paese per diverse settimane, esplodendo in violenza pura soprattutto a Parigi, Macron ha deciso che andava cambiato radicalmente il modo di fare informazione. Un giro di vite che parte da lontano, da quando si è iniziato parlare di legge contro le cosiddette fake news. E che adesso, con la sua entrata in vigore a novembre, può far calare la scure sulla classe giornalistica ma anche sui siti di informazione che, nella maggior parte dei casi, criticano l’Eliseo e i partiti tradizionali.
Come spiega Euronews, la legge, concepita dal presidente Macron, è stata respinta due volte dal Senato prima di essere approvata dal parlamento. Questo indica già l’esistenza di un dubbio estremamente forte del legislatore francese.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Washington, la ragione della forza
Washington, la ragione della forza
di Manlio Dinucci
L’escalation Usa, dall’incoronazione di Guaidò alla sospensione del Trattato Inf
Due settimane fa Washington ha incoronato presidente del Venezuela Juan Guaidò, pur non avendo questi neppure partecipato alle elezioni presidenziali, e ha dichiarato illegittimo il presidente Maduro, regolarmente eletto, preannunciando la sua deportazione a Guantanamo. La scorsa settimana ha annunciato la sospensione Usa del Trattato Inf, attribuendone la responsabilità alla Russia, e ha in tal modo aperto una ancora più pericolosa fase della corsa agli armamenti nucleari. Questa settimana Washington compie un altro passo: domani 6 febbraio, la Nato sotto comando Usa si allarga ulteriormente, con la firma del protocollo di adesione della Macedonia del Nord quale 30° membro.
Non sappiamo quale altro passo farà Washington la settimana prossima, ma sappiamo qual è la direzione: una sempre più rapida successione di atti di forza con cui gli Usa e le altre potenze dell’Occidente cercano di mantenere il predominio unipolare in un mondo che sta divenendo multipolare. Tale strategia – espressione non di forza ma di debolezza, tuttavia non meno pericolosa – calpesta le più elementari norme di diritto internazionale. Caso emblematico è il varo di nuove sanzioni Usa contro il Venezuela, con il «congelamento» di beni per 7 miliardi di dollari appartenenti alla compagnia petrolifera di Stato, allo scopo dichiarato di impedire al Venezuela, il paese con le maggiori riserve petrolifere del mondo, di esportare petrolio.
Leggi tutto
Gianluca Baldini: La solidarietà europea non esisterà mai
La solidarietà europea non esisterà mai
di Gianluca Baldini*
Nell’ultimo viaggio a Collarmele ho ascoltato il dibattito tra l’ex chief economist del FMI Olivier Blanchard ed Emiliano Brancaccio.
Al termine del confronto, il professore napoletano, nel rispondere alle domande provenienti dal pubblico, riferisce un aneddoto molto interessante: in occasione di un invito che aveva ricevuto da Massimo D’Alema e Laurent Fabius all’atto della candidatura di François Hollande alla presidenza della repubblica francese, Brancaccio intervenne nell’assemblea del Parti Socialiste per illustrare la sua idea di “standard retributivo europeo”, che incoraggerebbe uno spostamento del peso dei riequilibri commerciali sulle spalle dei paesi creditori.
È chiaramente estremamente meno costoso impedire alla Germania di fare deflazione salariale piuttosto che costringere i paesi della cosiddetta periferia a seguirla esasperando le sofferenze delle crisi con la disoccupazione crescente e il gioco al ribasso dei diritti dei lavoratori.
Brancaccio dice che questa proposta venne accolta con estremo apprezzamento da tutti i presenti rappresentanti dei paesi europei. Quando la parola passò ai rappresentanti della Germania, nelle figure di un segretario della IG Metall (la nostra FIOM, per intenderci, il sindacato più rappresentativo dei metalmeccanici) e di un segretario dello SPD, questi dichiarano che Brancaccio non aveva capito niente di come funzionasse l’Europa, perché “l’UE non è nata su basi solidaristiche, di coordinamento, ma sulla competizione, e che così dovrà restare”.
Leggi tutto
Carlo Lozito: Centenario della rivoluzione bolscevica: riproporne l’attualità
Centenario della rivoluzione bolscevica: riproporne l’attualità
di Carlo Lozito
 Nonostante
gli innumerevoli
tentativi di infiocchettarla da parte di un esercito di
apologeti borghesi, la violenza dei rapporti di produzione
borghesi è tale che si
impone, a coloro che con occhi disincantati guardano lo stato
di cose attuale, il compito di cambiare un sistema così
ingiusto e antistorico
tornando a ripensare la società dei liberi produttori
associati indicataci da Marx. Sono in gioco il futuro
dell’umanità e la
vivibilità del pianeta.
Nonostante
gli innumerevoli
tentativi di infiocchettarla da parte di un esercito di
apologeti borghesi, la violenza dei rapporti di produzione
borghesi è tale che si
impone, a coloro che con occhi disincantati guardano lo stato
di cose attuale, il compito di cambiare un sistema così
ingiusto e antistorico
tornando a ripensare la società dei liberi produttori
associati indicataci da Marx. Sono in gioco il futuro
dell’umanità e la
vivibilità del pianeta.
“Ogni cosa oggi sembra portare in sé la sua contraddizione. Macchine, dotate del meraviglioso potere di ridurre e potenziare il lavoro umano, fanno morire l’uomo di fame e lo ammazzano di lavoro. Un misterioso e fatale incantesimo trasforma le nuove sorgenti della ricchezza in fonti di miseria. Le conquiste della tecnica sembrano ottenute a prezzo della loro stessa natura. Sembra che l’uomo nella misura in cui assoggetta la natura, si assoggetti ad altri uomini o alla propria abiezione. Perfino la pura luce della scienza sembra poter risplendere solo sullo sfondo tenebroso dell’ignoranza. Tutte le nostre scoperte e i nostri progressi sembrano infondere una vita spirituale alle forze materiali e al tempo stesso istupidire la vita umana, riducendola a una forza materiale. Questo antagonismo fra l’industria moderna e la scienza da un lato e la miseria moderna e lo sfacelo dall’altro; questo antagonismo fra le forze produttive e i rapporti sociali della nostra epoca è un fatto tangibile, macroscopico e incontrovertibile. Qualcuno può deplorarlo; altri possono desiderare di disfarsi delle tecniche moderne per sbarazzarsi dei conflitti moderni o possono pensare che un così grande progresso nell’industria esiga di essere integrato da un regresso altrettanto grande nella politica. Da parte nostra non disconosciamo lo spirito malizioso che si manifesta in tutte queste contraddizioni. Nei segni che confondono la borghesia e i meschini profeti del regresso riconosciamo la mano del nostro valente amico, Robin Goodfellow, la vecchia talpa che scava tanto rapidamente, il grande minatore: la rivoluzione. La storia è il giudice e il proletariato il suo esecutore.”
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Tav-Guaidò: per i Cinque Stelle hic Rhodus, hic salta
Tav-Guaidò: per i Cinque Stelle hic Rhodus, hic salta
di Fulvio Grimaldi
Il latino dice: “Qui è Rodi, qui salta” ed è l’intimazione fatta da Esopo a uno che afferma di sapere fare salti altissimi. Di fronte al bivio TAV-Venezuela, va fatta ai 5 Stelle
 Il tradimento dei figli
Il tradimento dei figli
L’Italia di Dante, Leopardi, Fenoglio, Caravaggio, Montessori; la Spagna di Cervantes, Unamuno, Dolores Ibarruri, Picasso; La Germania di Goethe, Schopenhauer, Brecht, Sophie Scholl; l’Inghilterra di Shakespeare, Byron, Dickens, Melville; la Francia di Cartesio, Olympe De Gouges, Diderot, Balzac, Verlaine….. Hanno concesso ai loro (il)legittimi governanti di decretare il Tramonto dell’Occidente. Di quell’Occidente, non colonialista, non ipocrita e sanguinario, non capitalista, in sostanza non cristiano, che era stato tenuto a battesimo da Omero, Prassitele, Euripide, Socrate, Seneca, Ovidio.
Scusate se vi mitraglio con questa grandine di nomi.. E’ che continuano a venirmi in testa, loro e tanti altri, al cospetto dell’enormità di quanto va accadendo sotto i nostri antichissimi e, oggi anche vecchi, occhi, nella sostanziale passività dei figli di quegli uomini e donne. A me, a noi, che credevamo di averla scampata, che le previsioni, ammettiamolo, ottimistiche al cospetto di quanto va precipitando, non si sarebbero avverate del tutto prima della fine del nostro passaggio, visto che ci proteggeva l’ombra di tali giganti…che almeno le parvenze, la forma, sarebbero state mantenute, tanto da non farci buttare l’ultima occhiata su una infinita distesa di ghiaccio.
Non di inverno nucleare si tratta qui, ma di un inverno che seppellisce sotto la sua lastra di ghiaccio intelligenza, coscienza, convivenza civile, progresso umano, quello di cui quegli spiriti avevano plasmato l’anima.. Bene lo stanno rappresentando in simbolo le temperature artiche che paralizzano nel gelo le più gloriose città, la più pregiata natura del Nord America. Sto parlando dell’accondiscendenza concessa, da alcuni con impudico trasporto, da altri intingendo le mani nel catino di Ponzio Pilato e, infine, da coloro di cui noi siamo partorienti cronici: i né-né.
Leggi tutto
Anselm Jappe: Ludd, o il Sessantotto trascendente
Ludd, o il Sessantotto trascendente
di Anselm Jappe
 Tra il 1968 e il 1978 l’Italia,
com’è noto, ha vissuto la più lunga stagione contestataria di
tutti i paesi occidentali in quel periodo, mentre altrove “il
Sessantotto” era generalmente tanto intenso quanto breve. Era
anche
l’unico paese dove le proteste videro una sostanziale
partecipazione operaia e popolare. Allo stesso tempo, l’Italia
ha dato
un’elaborazione teorica tutta sua di quegli eventi e della
loro novità: l’operaismo, le cui propaggini si estendono fino
a oggi. In
retrospettiva, l’operaismo e le organizzazioni da esso
influenzate (Potere Operaio, Lotta continua, poi Autonomia
operaia) sembravano occupare
tutto lo spazio a sinistra del PCI, vista anche la scarsa
importanza che ebbero maoisti e trotzkisti, diversamente dagli
altri paesi europei. In
effetti, esiste ormai una ricca letteratura sull’operaismo.
Tuttavia, a margine c’erano altre correnti che si volevano più
radicali
e che si ispiravano soprattutto ai situazionisti francesi e
alla tradizione anti-leninista dei Consigli operai. Questa
piccola area di
“comunisti eretici”, che spiccava più per lucidità che per
impatto immediato sulle lotte sociali, va sotto il nome di
“Critica radicale”. Il suo raggruppamento più importante fu
Ludd. Benché sia esistito per appena un anno, dal 1969 al
1970,
coinvolgendo solo alcune decine di persone, soprattutto a
Genova e Milano, e ne rimangano essenzialmente tre bollettini
e alcuni volantini, Ludd
è diventato nel corso del tempo una “leggenda” per quegli
ambienti della critica sociale che si richiamano alle idee
situazioniste,
oggi forse più numerosi che quarant’anni fa.
Tra il 1968 e il 1978 l’Italia,
com’è noto, ha vissuto la più lunga stagione contestataria di
tutti i paesi occidentali in quel periodo, mentre altrove “il
Sessantotto” era generalmente tanto intenso quanto breve. Era
anche
l’unico paese dove le proteste videro una sostanziale
partecipazione operaia e popolare. Allo stesso tempo, l’Italia
ha dato
un’elaborazione teorica tutta sua di quegli eventi e della
loro novità: l’operaismo, le cui propaggini si estendono fino
a oggi. In
retrospettiva, l’operaismo e le organizzazioni da esso
influenzate (Potere Operaio, Lotta continua, poi Autonomia
operaia) sembravano occupare
tutto lo spazio a sinistra del PCI, vista anche la scarsa
importanza che ebbero maoisti e trotzkisti, diversamente dagli
altri paesi europei. In
effetti, esiste ormai una ricca letteratura sull’operaismo.
Tuttavia, a margine c’erano altre correnti che si volevano più
radicali
e che si ispiravano soprattutto ai situazionisti francesi e
alla tradizione anti-leninista dei Consigli operai. Questa
piccola area di
“comunisti eretici”, che spiccava più per lucidità che per
impatto immediato sulle lotte sociali, va sotto il nome di
“Critica radicale”. Il suo raggruppamento più importante fu
Ludd. Benché sia esistito per appena un anno, dal 1969 al
1970,
coinvolgendo solo alcune decine di persone, soprattutto a
Genova e Milano, e ne rimangano essenzialmente tre bollettini
e alcuni volantini, Ludd
è diventato nel corso del tempo una “leggenda” per quegli
ambienti della critica sociale che si richiamano alle idee
situazioniste,
oggi forse più numerosi che quarant’anni fa.
Per la prima volta, una larga documentazione su Ludd e i suoi “precursori” è disponibile su carta stampata (il materiale era già disponibile sul sito nelvento.net). Un’utile introduzione di Leonardo Lippolis spiega il contesto storico. Quasi metà del libro è occupato da un saggio di 200 pagine di Paolo Ranieri, ex membro del gruppo, che mescola ricordi personali con commenti allo stato attuale del mondo, offrendo informazioni preziose, ma anche alcuni deplorevoli scivoloni.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Pil: hanno tutti torto
Pil: hanno tutti torto
di Leonardo Mazzei
Se ne leggono di tutte: il Pil cala a causa della politica del governo; no, è colpa di quello precedente. E' per l'incertezza sui conti, sentenzia Visco; per i cantieri che sono chiusi, sproloquia Confindustria. Ma sarà solo per un altro semestre, tranquillizza Conte. No, sarà finché non ve andrete, dicono le opposizioni. (Nel grafico l'andamento del Pil dal 2006)
E' come un impazzimento generale dove tutti, ma proprio tutti, hanno torto. Ed hanno torto perché anziché vedere la trave che opprime l'economia italiana da un ventennio, preferiscono guardare la pagliuzza che più gli confà per il quotidiano teatrino della politica.
Ma che è successo di così strano al Pil? Come leggere il calo degli ultimi mesi del 2018 (-0,1% nel terzo, -0,2% nel quarto trimestre)? E' successo che il ciclo economico capitalistico volge verso il basso. E, come avviene da anni, il calo è più marcato in Europa. All'interno della quale l'Italia paga più degli altri la gabbia dell'euro. Insomma, la verità è che siamo nella norma. Quella norma da cui non si può uscire, altrimenti i "mercati" (cioè l'oligarchia finanziaria) ci puniscono con lo spread.
Ma davvero è così difficile da capire? Certo, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire, ma qui non c'è più alcun limite alle sciocchezze.
Leggi tutto
Roberto Romano: Austerità e ideologia
Austerità e ideologia
di Roberto Romano
Nel libro appena edito da Rizzoli “Austerità: quando funziona e quando no”, gli autori -A. Alesina, C. Favero e F. Giavazzi- assumono la stabilizzazione del debito come un valore in sé, che contrasta con la prassi del capitalismo che si fonda sul debito, consigliando di farlo via tagli della spesa pubblica
A. Alesina, C. Favero e F. Giavazzi hanno da poco pubblicato il libro “Austerità: quando funziona e quando no”, edito da Rizzoli, 31 gennaio 2019. Sebbene gli autori si affannino nel sostenere la loro analisi relativa alla necessità di contenere il debito per sostenere l’economia, non possono esimersi dal constatare che “L’austerità basata sulla riduzione della spesa pubblica costa meno in termini di crescita di quella fondata sull’aumento delle entrate”[1]. Quindi l’austerità produce comunque una contrazione della domanda. Infatti, sono costretti a dichiarare una manifesta contraddizione: “La comprensione di questi risultati richiede di andare oltre gli effetti della politica fiscale sulla domanda aggregata …”; infatti, più avanti ridimensionano non di poco l’esito della cosiddetta austerità espansiva quando, illustrando un grafico, pervengono a questo risultato: “… illustra una piccola (sottolineo piccola, mia aggiunta) probabilità di osservare effetti espansivi dell’austerità – mediante tagli di spesa – sulla crescita”.
Leggi tutto
Mario Giambelli Gallotti: Recessione: facce di tolla galattiche ed ingenui colossali
Recessione: facce di tolla galattiche ed ingenui colossali
di Mario Giambelli Gallotti
Riporto integralmente dall’edizione di venerdì 1° febbraio de “Il Dubbio”:
“…il rapporto Istat arrivato già nella serata di mercoledì, è di quelli che mettono paura. Secondo l’istituto di statistica, infatti, l’economia italiana è ufficialmente in recessione tecnica. Nel quarto trimestre del 2018 il Pil corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato è infatti diminuito dello 0,2% rispetto al trimestre precedente ed è aumentato dello 0,1% in termini tendenziali. Si tratta del secondo calo congiunturale consecutivo dopo il – 0,1% segnato nel terzo trimestre dell’anno scorso, primo segno negativo dal secondo trimestre 2014. E dopo la sentenza dell’Istat il premier Giuseppe Conte ha provato a gettare acqua sul fuoco: “I dati del Pil non ci preoccupano, a noi interessa concentrarci sul rilancio della nostra economia che avverrà nel 2019, in particolare nel secondo semestre”.
“È una contrazione – aggiunge il premier – che era nell’aria, gli analisti l’avevano prevista ed è collegata a fattori transitori esterni alla nostra economia. C’è una guerra di dazi che si sta componendo e deve comporsi. Non abbiamo ragione di perdere fiducia, c’è molto entusiasmo”. Quanto alla possibilità di riferire in Parlamento come chiesto dalle minoranze, “sono sempre disponibile con le opposizioni quando c’è da chiarire qualcosa”, assicura il premier.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: Il M5S deve separarsi dalla Lega
Il M5S deve separarsi dalla Lega
di Fabrizio Marchi
Le contraddizioni strutturali finiscono prima o poi inevitabilmente per prevalere sui tatticismi e sulla realpolitik. Sono proprio queste che stanno mettendo in crisi il patto di governo fra Lega e M5S, due forze completamente diverse, che solo la vulgata mediatica ha accomunato sotto la voce “populismo”.
Lega e M5S sono infatti divisi pressochè su tutto: politica estera, politica economica, grandi opere, nazionalizzazioni, NO/SI TAV ecc.
Si tratta di due forze che rappresentano, anche al di là della loro volontà, interessi e bisogni sociali diversi e in conflitto fra loro. Fino ad ora sono riusciti a mantenere un equilibrio, sia pur precario, perché si sono ritagliati il proprio spazio attorno a due questioni che hanno gestito autonomamente: l’immigrazione (di competenza della Lega) e il reddito di cittadinanza (cavallo di battaglia del M5S).
Ma è evidente come questa alleanza di governo stia premiando clamorosamente solo la Lega che, secondo i sondaggi, ha praticamente quasi raddoppiato i suoi consensi (dal 17% al 32%) al contrario del M5S che è dato in netto calo (intorno al 25% rispetto al 32% delle ultime elezioni).
Qualsiasi partito dotato di lucidità politica non potrebbe che trarne le necessarie conseguenze. L’accordo di governo ha premiato l’una e bocciato l’altro.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2101
Hits 1894
Hits 1798
Hits 1774
Hits 1768
Hits 1757
Hits 1725
Hits 1698
tonino

Marco Palazzotto: C’è vita su Marx
C’è vita su Marx
di Marco Palazzotto
Una carrellata delle pubblicazioni, uscite nel duecentenario dalla nascita di Marx, che analizzano il pensiero maturo del filosofo tedesco e ridanno centralità alla sua critica dell'economia politica
 L’anno
appena trascorso sarà ricordato per il bicentenario della
nascita di
Karl Marx. Sono stati pubblicati in tutto il mondo numerosi
scritti per ricordare le idee e la vita di uno dei più
importanti pensatori della
storia dell’umanità. Considerata la varietà e quantità degli
argomenti affrontati in questi testi, ho cercato un fil
rouge che li accomunasse, affinché se ne potessero
ricavare delle riflessioni utili per analizzare il presente.
Tale filo comune è
il pensiero maturo di Marx e pertanto l’urgenza di riprendere
la critica marxiana dell’economia, sorvolando, per ragioni di
spazio e
tempo, sulle pubblicazioni biografiche.
L’anno
appena trascorso sarà ricordato per il bicentenario della
nascita di
Karl Marx. Sono stati pubblicati in tutto il mondo numerosi
scritti per ricordare le idee e la vita di uno dei più
importanti pensatori della
storia dell’umanità. Considerata la varietà e quantità degli
argomenti affrontati in questi testi, ho cercato un fil
rouge che li accomunasse, affinché se ne potessero
ricavare delle riflessioni utili per analizzare il presente.
Tale filo comune è
il pensiero maturo di Marx e pertanto l’urgenza di riprendere
la critica marxiana dell’economia, sorvolando, per ragioni di
spazio e
tempo, sulle pubblicazioni biografiche.
Marx, come sappiamo, ha vissuto gli ultimi anni intento a scrivere e a studiare in vista dell’opera che considerava la più importante e più faticosa. Soltanto una minima parte del suo lavoro sarà completata, e ciò che restituirà ai posteri è il primo libro del Capitale. Secondo e terzo libro saranno pubblicati postumi (dopo un personale rimaneggiamento) dall’amico e compagno di una vita Friedrich Engels. Tale opera – con i suoi scritti preparatori (come i Lineamenti fondamentali della critica dell’economia politica, noti anche come Grundrisse, e Per la critica dell’economia politica) e i manoscritti successivi – rappresenta la testimonianza e l’eredità di un intellettuale che ha voluto disvelare le leggi che regolano il modo di produzione capitalistico.
Diversamente dall’approccio di un marxismo storicista, umanistico e progressista, che mette al centro la “politica”, come quello che ha caratterizzato buona parte del pensiero novecentesco italiano, è fondamentale agganciare l’analisi della società moderna ai rapporti di produzione. Lo sfruttamento capitalistico – e la conseguente estrazione del valore utile all’accumulazione – non risiede negli apparati politici e in genere “sovrastrutturali”, ma è connesso al comando del lavoro nei processi produttivi. Se vogliamo palesare questi rapporti di sfruttamento, per combatterli, occorre studiare e capire l’economia di mercato, riprendendo oggi la marxiana critica dell’economia politica e restaurando, di conseguenza, una scienza del nuovo capitale, senza d’altra parte cadere in interpretazioni prettamente economicistiche.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Lo sciopero generale in Francia, prime valutazioni
Lo sciopero generale in Francia, prime valutazioni
di Giacomo Marchetti
 Lo sciopero generale di 24ore proclamato da
CGT e Solidaires è stato un
primo passo importante di convergenza su tutto il territorio
dell’Esagono tra “la marea gialla” ed il mondo sindacale,
dopo che vi
erano stati importanti segnali unitari nei mesi precedenti a
Marsiglia, Tolosa e Bordeaux.
Lo sciopero generale di 24ore proclamato da
CGT e Solidaires è stato un
primo passo importante di convergenza su tutto il territorio
dell’Esagono tra “la marea gialla” ed il mondo sindacale,
dopo che vi
erano stati importanti segnali unitari nei mesi precedenti a
Marsiglia, Tolosa e Bordeaux.
Nel soddisfatto comunicato di bilancio della giornata – “5 Febbraio. Convergenza delle lotte riuscita” – la CGT afferma che hanno partecipato alle mobilitazioni, svoltesi in circa 200 città, 300.000 persone.
A Parigi sarebbero state 30.000 le persone che hanno partecipato secondo gli organizzatori, 18.000 per le forze dell’ordine.
La centrale sindacale francese afferma :
“Questa giornata ha permesso, attraverso gli scioperi nel pubblico e nel privato, di rinforzare e di rendere comuni le lotte sociali. In diversi dipartimenti; la CGT è attiva nella preparazione di riunioni intersindacali con il fine di prolungare la mobilitazione. Già da ora, la CGT è il vettore propositivo attraverso l’organizzazione dei martedì di “emergenza sociale”, i quaderni di espressione popolare, i dibattiti pubblici e l’8 marzo”.
***
Le manifestazioni svoltesi sul territorio nazionale organizzate da CGT e Solidaires, a cui si sono aggregati alcuni settori di FO – senza che ci fosse una adesione a livello confederale di questa sigla – e della FSU (il maggior sindacato degli insegnanti), hanno visto sfilare insieme “giacche gialle” e “giacche rosse”, di fatto rompendo quel muro di diffidenza reciproca che aveva caratterizzato precedentemente, almeno in parte, i rapporti tra i gilets Jaunes e militanti sindacali.
Leggi tutto
Angela Nagle: La tesi di sinistra contro i confini aperti
La tesi di sinistra contro i confini aperti
di Angela Nagle
 Com’è stato possibile che in
questi ultimi anni la sinistra sia diventata propugnatrice
delle
tesi open border, nate all’interno dei circoli
anarco-capitalisti e da sempre sostenute dai think tank
della destra economica radicale? Come
può non rendersi conto che la libertà di migrare, lungi
dall’essere un diritto inviolabile dell’uomo, non è altro
che
una delle quattro libertà fondamentali di circolazione alla
base della dottrina economica neoclassica – nello specifico
quella della
forza lavoro – e che come tale viene fortemente sostenuta
proprio dal grande business? Questo lungo articolo tratto da American
Affairs,
cerca di spiegare i sommovimenti storici e culturali – che
gettano come sempre le radici nella svolta reazionaria
neoliberale degli anni
’80, innescata dalle politiche di Reagan e della Tatcher –
che hanno prodotto questa mutazione antropologica della
sinistra, passata dalle
tradizionali posizione anti-immigrazioniste legate al
movimento operaio e sindacale all’accettazione
dogmaticamente moralistica dei confini
aperti.
Com’è stato possibile che in
questi ultimi anni la sinistra sia diventata propugnatrice
delle
tesi open border, nate all’interno dei circoli
anarco-capitalisti e da sempre sostenute dai think tank
della destra economica radicale? Come
può non rendersi conto che la libertà di migrare, lungi
dall’essere un diritto inviolabile dell’uomo, non è altro
che
una delle quattro libertà fondamentali di circolazione alla
base della dottrina economica neoclassica – nello specifico
quella della
forza lavoro – e che come tale viene fortemente sostenuta
proprio dal grande business? Questo lungo articolo tratto da American
Affairs,
cerca di spiegare i sommovimenti storici e culturali – che
gettano come sempre le radici nella svolta reazionaria
neoliberale degli anni
’80, innescata dalle politiche di Reagan e della Tatcher –
che hanno prodotto questa mutazione antropologica della
sinistra, passata dalle
tradizionali posizione anti-immigrazioniste legate al
movimento operaio e sindacale all’accettazione
dogmaticamente moralistica dei confini
aperti.
Il grande business e le lobby del libero mercato, per promuovere aggressivamente i propri interessi, hanno creato un culto fanatico a difesa delle tesi open border – un prodotto fatto proprio da una classe urbana creativa, tecnologica, dei media e della conoscenza, che fa i propri interessi oggettivi di classe per mantenere a buon mercato i propri effimeri stili di vita e salvaguardare le proprie carriere. La sinistra liberale ha rivenduto il prodotto aggiungendovi il ricatto morale e la pubblica vergogna nei confronti dei popoli, accusati di atti inumani verso i migranti. Eppure, una vera sinistra dovrebbe tornare a guardare alle proprie tradizioni e cercar di migliorare le prospettive dei poveri del mondo. La migrazione di massa in sé non ci riuscirà: crea impoverimento per i lavoratori nei paesi ricchi e una fuga di cervelli in quelli poveri. L’unica vera soluzione è correggere gli squilibri dell’economia globale e ristrutturare radicalmente un sistema progettato per aiutare i ricchi a scapito dei poveri, riprendendo il controllo degli stati, delle politiche commerciali e del sistema finanziario globale.
Leggi tutto
coniarerivolta: Le briciole di cittadinanza tra salari da fame e strepiti liberisti
Le briciole di cittadinanza tra salari da fame e strepiti liberisti
di coniarerivolta
Nel dibattito di questi giorni sul reddito di cittadinanza si è sottolineato, da più parti, che tale misura avrebbe come effetto collaterale indesiderato quello di scoraggiare i disoccupati dalla ricerca di un posto di lavoro.
L’accorato allarme è stato lanciato da diversi dei soggetti coinvolti nelle audizioni informali che si stanno tenendo al Senato. Tra i primi a suonare il campanello d’allarme troviamo Pierangelo Albini di Confindustria, a capo dell’area Lavoro e Welfare dell’organizzazione padronale. Ai senatori della Commissione Lavoro ha voluto sottolineare che “i 780 euro mensili potrebbero scoraggiare dal cercare un impiego considerando che in Italia lo stipendio mediano dei giovani under 30 si attesta a 830 netti al mese”. Analoghe preoccupazioni sono state espresse dall’onnipresente Fondo Monetario Internazionale, che nel consueto report sulla situazione del Paese ha affermato che il livello del reddito di cittadinanza è troppo alto, addirittura “fissato al 100% della linea di povertà relativa in confronto al 40-70% indicato nelle buone pratiche internazionali”. Inoltre, l’immancabile presidente dell’INPS Tito Boeri ha parlato di “rilevanti effetti di scoraggiamento”, in quanto quasi il 45% dei dipendenti privati del Sud ha “redditi da lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal reddito di cittadinanza a un individuo che dichiari di avere un reddito uguale a zero”. Infine, le ‘preoccupazioni’ di Confindustria e Boeri sono state prontamente fatte proprie dal PD, nella persona della senatrice Iori.
Leggi tutto
Mark Epstein: Introduzione a Totalitarian Trends Today
Introduzione a Totalitarian Trends Today
di Mark Epstein*
Siamo lieti di annunciare, come redazione di Marx21.it, l'avvio di una collaborazione con Mark Epstein, compagno marxista statunitense di ambito accademico. Ci informerà periodicamente sulle questioni di politica interna ed estera degli USA e sugli sviluppi culturali internazionali. Quella che segue è la sua introduzione al volume “Totalitarian Trends Today”, che offre uno spaccato misconosciuto al pubblico italiano delle ricerche portate avanti da alcuni settori del marxismo statunitense. Sono lieto di annunciare che Epstein ha annunciato di avviare come prossima lettura “Il Totalitarismo liberale. Le tecniche imperialiste per l'egemonia culturale”. Spero che potrà trovarvi quell'analisi marxista del fenomeno totalitario di cui lamenta in questo articolo la mancanza. Questo è stato uno dei miei scopi che credo di aver portato adeguatamente a termine [Alessandro Pascale]
Per scaricare il saggio (in lingua
inglese) oggetto della
presentazione premi
qui
Questo saggio è contenuto in un volume collettaneo, TotArt: The Visual Arts, Fascism(s) and Mass-society (Newcastle: Cambridge Scholars Press, 2017), dedito alle arti visive durante le varie forme di fascismo, interpretato come il vero totalitarismo, quello della destra, come prosecuzione del capitalismo “by other means”, ca. come forma di ‘emergenza’ quando confrontati da crisi sia economicamente, che politicamente che socialmente più serie.
Il saggio passa in rassegna una serie di contributi recenti che tutti notano, in diversi modi, l’emergere di fenomeni associati a forme di controllo e dominio totalitario, la maggior parte di area non-marxiana (F. William Engdahl, Mike Lofgren, e Sheldon Wolin) il cui interesse risiede in aspetti diversi.
Leggi tutto
comidad: La politica partigiana e il lobbismo super partes
La politica partigiana e il lobbismo super partes
di comidad
A distanza di poche settimane dal suo “trionfo” per la cattura del latitante Battisti, per una sorta di nemesi, Salvini ha dovuto assaggiare a sua volta gli esiti dell’incertezza delle categorie giuridiche. Se Battisti ha dovuto subire l’etichetta di “assassino” in base a quella dilatazione concettuale che è il “concorso morale”, la stessa dilatazione concettuale ha consentito ad una Procura di incriminare il ministro degli Interni per “sequestro di persona” nel caso della nave Diciotti.
In base alla ricostruzione dei fatti nel caso della nave della Guardia Costiera Diciotti, nel comportamento di Salvini potevano essere ravvisati gli estremi dell’omissione di soccorso, che è già di per sé un reato grave. I magistrati hanno invece optato per l’ipotesi di reato del sequestro di persona, come se i migranti raccolti dalla Diciotti fossero in possesso di un regolare passaporto con visto d’ingresso e fossero stati vittima di un atto di pirateria. In pratica un organo dello Stato ne ha delegittimato un altro.
Il “salvinismo” è una bolla che di per sé avrebbe i giorni contati. Il leader della Lega ha infatti preso per i fondelli il proprio elettorato, enfatizzando e spettacolarizzando la questione degli sbarchi, dimenticandosi che i migranti entrano anche e soprattutto per altre vie e che, a riprova di ciò, in Italia i clandestini sono già centinaia di migliaia; così tanti che non avrebbero potuto entrare solo con i barconi.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Il bisogno di metafisica
![]()
Il bisogno di metafisica
di Salvatore Bravo
Il secolo trascorso ed il presente sono secoli senza metafisica, ogni limite è stato ed è trasceso in assenza di una definizione di bene e di male. Tali paradigmi sono liquidati come cianfrusaglie del pensiero, oziosi rompicapo senza soluzione. Il problema metafisico è annichilito, espulso dalle accademie, spesso pronunciato con parole appena udibili anche dalla chiesa. Le forme di totalitarismo sono proliferate in assenza di metafisica, nella loro metamorfosi, come l’essere polivoco di Aristotele, hanno un fondamento comune non riconosciuto: l’astratto. Ogni totalitarismo ambisce alla perfezione, vuole eliminare ogni differenza, la fatica del molteplice da cui rielaborare il concetto, i totalitarismi esigono la perfezione, calano sul mondo della vita una cappa astratta a cui ci si deve adattare. La perfezione non vuole dialogo, nega ogni principio ontologico fondato sulla parola, al suo posto campeggia l’ideale della perfezione, il quale si pone oltre ogni distinzione dialettica tra bene e male, è sottratto dallo spazio e dal tempo, luoghi cognitivi dove si viene a determinare il senso del bene e del male, dove l’uno ha significato nella presenza dell’altro. La perfezione non conosce dialettica, si ripiega su se stessa, si presenta nella forma dell’ipostasi dinanzi alla quale non si può che accettare senza consenso, senza concetto. Ogni totalitarismo assimila per espellere le differenze e presentarsi con il suo radicale monismo.
Leggi tutto
Vladimiro Giacché: Fine di un’epoca
Fine di un’epoca
di Vladimiro Giacché*
La crisi del 2007 ha dimostrato che la crescita e i profitti nel capitalismo non possono più essere garantiti dalla speculazione finanziaria. È necessario un cambio di sistema
 Per capire la prossima
crisi, dovremmo guardare alle origini e all’evoluzione della
precedente: dal
2000 al 2005, a causa dei bassi tassi di interesse, negli
Stati Uniti emerse una consistente bolla finanziaria. Sul
mercato immobiliare locale, i
prezzi e il numero di contratti di mutuo raddoppiarono. A
partire dal 2006, i prezzi iniziarono a scendere. Iniziò a
sussistere un problema di
eccesso di offerta, ovvero un problema di sovrapproduzione nel
settore delle costruzioni. Nel 2007 si evidenziarono i primi
problemi con i prodotti
finanziari, che avevano a che fare con alcuni prestiti
ipotecari statunitensi rischiosi (i cosiddetti mutui subprime).
Per capire la prossima
crisi, dovremmo guardare alle origini e all’evoluzione della
precedente: dal
2000 al 2005, a causa dei bassi tassi di interesse, negli
Stati Uniti emerse una consistente bolla finanziaria. Sul
mercato immobiliare locale, i
prezzi e il numero di contratti di mutuo raddoppiarono. A
partire dal 2006, i prezzi iniziarono a scendere. Iniziò a
sussistere un problema di
eccesso di offerta, ovvero un problema di sovrapproduzione nel
settore delle costruzioni. Nel 2007 si evidenziarono i primi
problemi con i prodotti
finanziari, che avevano a che fare con alcuni prestiti
ipotecari statunitensi rischiosi (i cosiddetti mutui subprime).
Quello che segue è noto: massiccia insolvenza dei mutuatari, problemi nei mercati finanziari. Saltano alcuni fondi speculativi e banche specializzate. La crisi si diffonde in tutto il mondo, e sarà la peggiore dagli anni ’30.
Ma perché la crisi è stata così grave?
In primo luogo, i mutui subprime erano solo uno degli elementi costitutivi di un enorme edificio finanziario costruito in 30 anni. Nel 1980, la somma di tutte le attività finanziarie globali equivaleva approssimativamente al prodotto interno lordo (PIL) globale. Alla fine del 2007, il rapporto tra queste attività e il PIL (eufemisticamente chiamato anche “profondità finanziaria”) era del 356%.
In secondo luogo, questa ipertrofia finanziaria non era una malattia in sé, ma un “farmaco” (al tempo stesso) contro un’insufficiente valorizzazione del capitale e contro la massiccia sovrapproduzione di capitale e merci nel triangolo del capitalismo maturo (USA, UE e Giappone).
A questo punto dobbiamo fare un passo indietro. A partire dagli anni ’70, abbiamo registrato una crescita sempre più bassa e tassi di investimento in calo, in particolare in Giappone e nell’Europa occidentale. Ciò ha comportato un calo globale dei tassi di investimento rispetto al PIL mondiale, nonostante l’enorme aumento degli investimenti in molti paesi in via di sviluppo, specialmente in Cina. È interessante notare che l’ipertrofia della finanza e del credito, cioè del “capitale capitale produttivo d’interesse” (Karl Marx), si sviluppa parallelamente alla caduta degli investimenti.
Leggi tutto
Françoise Gollain: Una filosofia applicata e sensibile
Una filosofia applicata e sensibile
Introduzione a Gorz
di Françoise Gollain
Presentiamo qui la traduzione dell’intro al libro di Françoise Gollain sul pensiero e il percorso anche esistenziale di André Gorz. Il libro, dal titolo “André Gorz – Une philosophie de l’emancipation”, uscito recentemente in Francia per le edizioni Harmattan, investe 50 anni di storia sociale filtrata attraverso la ricca e variegata esperienza di André Gorz, pensatore anomalo della sinistra ma quanto mai stimolante e attuale, specie in un momento come questo dove sembra sia diventato impossibile elaborare una strategia capace di opporsi al dominio della merce e del capitale, e alla loro devastante crisi. Particolarmente importante, dal nostro punto di vista, l’interesse manifestato da Gorz, nella parte finale della sua vita, verso la Wertkritik (Critica del valore), cioè quella corrente di pensiero il cui esponente di punta è stato Robert Kurz e di cui noi, redattori dell’Anatra di Vaucanson, cerchiamo di farci portavoce.
Françoise Gollain è dottoressa in sociologia e specialista del pensiero di Gorz. Ha collaborato con la rivista Entropia. Insegna alla Open University di Cardiff. Vive tra la Francia e il Galles [redazione].
 Figura di punta dell’ecologia
politica e critico radicale del lavoro, Gérard Horst, alias
André Gorz, ha saputo
coniugare le qualità del giornalista (sotto lo pseudonimo di
Michel Bosquet) con quelle del saggista visionario. Voce
singolare durante mezzo
secolo di dibattito in seno ad una sinistra affrancata da un
marxismo sclerotizzato ma (al tempo stesso) non chiusa al
meglio
dell’eredità marxiana, raggiunse una sicura autorevolezza
anche come teorico.
Figura di punta dell’ecologia
politica e critico radicale del lavoro, Gérard Horst, alias
André Gorz, ha saputo
coniugare le qualità del giornalista (sotto lo pseudonimo di
Michel Bosquet) con quelle del saggista visionario. Voce
singolare durante mezzo
secolo di dibattito in seno ad una sinistra affrancata da un
marxismo sclerotizzato ma (al tempo stesso) non chiusa al
meglio
dell’eredità marxiana, raggiunse una sicura autorevolezza
anche come teorico.
Per questo, potrebbe a prima vista sembrare sorprendente tramandarlo alla posterità come filosofo, nella misura in cui il fondamento filosofico della sua riflessione non viene in primo piano nelle opere più conosciute al grande pubblico, fatta eccezione per Il traditore.1
Gorz inoltre rivendicava lui stesso la sua mancanza di professionalità e si riconosceva fra i “cani sciolti” della filosofia, che non trovano né pubblico né editori e che possono praticarla solo applicandola a questioni socio-economiche. Coltivando la “non-appartenenza” in ragione di una storia personale tormentata, si è concesso solo lo statuto di filosofo “naufragato”, mancato (verunglückt).2 Questo epiteto non riesce comunque a rendere conto del fatto che la sua extraterritorialità accademica rappresentava in realtà per lui non solo un punto nevralgico ma ancor più e forse soprattutto una risorsa , come testimonia questa affermazione: “La verità è che io sono un tuttofare, un maverick.3
Leggi tutto
Raffaele Cimmino: La secessione dei ricchi e la questione nazionale
La secessione dei ricchi e la questione nazionale
di Raffaele Cimmino
 Il 15
febbraio prossimo rappresenta la dead line oltre la
quale, se le cose
andassero come auspicano i governatori di tre regioni –
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – ci sarà il voto al
Senato, a favore o
contro ma senza possibilità di emendamenti, sul regionalismo
differenziato. Si tratta di un percorso iniziato
coi i referendum
consultivi sull’autonomia svoltisi in Lombardia e Veneto il 22
ottobre 2017. Le due consultazioni sull’attribuzione di
condizioni
particolari di autonomia con l’attribuzione delle risorse
necessarie hanno avuto esito positivo. L’Assemblea regionale
dell’Emilia
Romagina, il 3 ottobre 2017, ha invece approvato una
risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla
sottoscrizione dell’intesa
con il Governo richiesta dall’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione.
Il 15
febbraio prossimo rappresenta la dead line oltre la
quale, se le cose
andassero come auspicano i governatori di tre regioni –
Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – ci sarà il voto al
Senato, a favore o
contro ma senza possibilità di emendamenti, sul regionalismo
differenziato. Si tratta di un percorso iniziato
coi i referendum
consultivi sull’autonomia svoltisi in Lombardia e Veneto il 22
ottobre 2017. Le due consultazioni sull’attribuzione di
condizioni
particolari di autonomia con l’attribuzione delle risorse
necessarie hanno avuto esito positivo. L’Assemblea regionale
dell’Emilia
Romagina, il 3 ottobre 2017, ha invece approvato una
risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla
sottoscrizione dell’intesa
con il Governo richiesta dall’articolo 116, terzo comma, della
Costituzione.
Il regionalismo differenziato è arrivato al traguardo con il governo Conte ma è una pratica istruita dal governo Gentiloni, che, pochi giorni prima delle elezioni del 4 marzo, tramite il sottosegretario Gianclaudio Bressa, ha sottoscritto una preintesa con ognuna delle tre regioni. Largamente simili, questi accordi prevedono all’art. 2 una durata decennale. Saranno immodificabili per dieci anni se non vi sarà il consenso a modificarli della regione interessata.
La devoluzione alle regioni riguarda le 23 materie previste dal terzo comma dell’art. 117, tra cui: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente, rapporti internazionali e con l’Unione Europea.Le preintese stabiliscono all’articolo 4 che le relative risorse andranno determinate da un’apposita Commissione paritetica Stato-Regione sulla base “di fabbisogni standard superando la spesa storica, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi”. Stabiliscono anche, senza meglio specificare, che “Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d’imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese”.
Leggi tutto
Angelo d’Orsi: In nome della democrazia, ignorando le lezioni della storia
In nome della democrazia, ignorando le lezioni della storia
La questione Venezuela
di Angelo d’Orsi
Il Venezuela troneggia sulle prime pagine, ancora. Ed è diventato argomento da bar. Quanti nostri concittadini sapevano qualcosa di questo grande paese latinoamericano? Ora sono tutti pronti a dire la loro, imbeccati opportunamente dagli influencer, ma senza dedicare una mezzora a studiare la questione. L’insegnamento di Gramsci (“studiare approfonditamente le questioni prima di parlarne”) è completamente disatteso: del resto, i primi a non sapere nulla sono gli opinionisti, che infatti giganteggiano sui media, mentre gli esperti vengono tenuti alla larga. Quanti di coloro che stanno firmando un appello a Mattarella in queste ore perché il governo italiano riconosca il golpista Guaidó sanno che cosa è accaduto in Venezuela in questi anni? Quanti hanno cognizione delle leggi venezuelane, a cominciare dalla Costituzione Bolivariana? E così siamo davanti ai due partiti: Guaidó vs. Maduro, e viceversa, e spesso anche dalla parte del secondo gli argomenti appaiono generici e mere petizioni di principio, per giuste che siano. Le tifoserie occupano il campo, “a prescindere”.
Intanto, forte della infelice, scorretta esternazione del Presidente della Repubblica, che ha invitato l’Italia a “raccordarsi” con l’Unione Europea, ossia ad aderire alla mozione passata nel Parlamento dominato da una solida maggioranza di destra, il PD, addirittura sta per presentare una interpellanza parlamentare, pronto ad allearsi, come sul Tav, con l’altra destra (il PD è un partito che con la sinistra non ha più nulla a che fare): una mozione di sostegno al giovane autoproclamato presidente venezuelano. Siamo davvero a un passo dalla follia, il “cupio dissolvi” di quel partito ogni giorno ci riserva una bella sorpresa.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: I tedeschi scoprono che il loro modello è fallito
I tedeschi scoprono che il loro modello è fallito
di Pasquale Cicalese
Sta suscitando scalpore in tutta Europa il documento preparato dal ministro dell’economia tedesco Peter Altmaier – “Piano Industria 2030” – perché prevede l’intervento dello Stato nell’economia, sia come “arrocco” per difendere i campioni nazionali da scalate ostili (si pensa ai cinesi, ma non solo), sia per avviare un salto tecnologico nelle grandi e medie industrie tedesche.
In particolare si parla di formare una sorta di “nuova Iri” per entrare in colossi quali Deutsche Bank, Bosch, Daimler ecc.
Altmaier, nel suo documento. parla di investimenti pubblici nei settori dell’intelligenza artificiale, nelle piattaforme di connessione informatiche, nelle biotecnologie, nella guida autonoma e nell’aerospaziale. Tutti settori dove dominano colossi americani e cinesi. Inoltre ritiene che entro il 2030 l’apporto dell’industria rispetto al pil debba aumentare dal 22 al 25% in Germania e dal 16 al 20% in Europa, considerando un grave errore la deindustrializzazione di molte aree europee a cui bisogna porre rimedio.
Da che pulpito viene la predica, verrebbe da dire…
Solo accennando al Trattato di Lisbona, esso prevedeva che l’UE a 500 milioni di abitanti divenisse entro il 2020 l’area economica più innovativa del mondo. Dalle parole di Altmaier scopriamo invece che il cuore industriale europeo è dietro di almeno 20 anni rispetto ai grandi sommovimenti produttivi mondiali.
Leggi tutto
Riccardo Castellana: L'amica seriale
L'amica seriale
di Riccardo Castellana
Fino al 2011 Elena Ferrante era stata una scrittrice di nicchia. Un po’, certo, aveva giovato alla relativa popolarità de L’amore molesto l’intenso film di Martone; meno, a I giorni dell’abbandono, il brutto lungometraggio di Roberto Faenza. Ma un piccolo gioiello come La figlia oscura, forse il vero capolavoro della scrittrice napoletana, è stato letto e apprezzato esclusivamente grazie al passaparola, e a qualche recensione favorevole, tenendo l’autrice lontana dai riflettori dei mass media. Pochissimo, non a caso, si disquisiva a vanvera, come si fa ora, di chi si nascondesse dietro quello pseudonimo (uno sport che ha fatto vittime eccellenti), e ciò che contava davvero era la scrittura: una scrittura eccezionalmente densa e corposa, capace di risvegliare archetipi profondi intorno alla tematica, estremamente reale e concreta, del rapporto tra madre e figlia.
Dall’apparizione, nel 2011 appunto, del primo volume dell’Amica geniale le cose sono cambiate. A cominciare dalla dimensione del “caso” Ferrante, che ha oltrepassato non solo i confini socio-culturali d’origine, ma addirittura quelli nazionali: ci sono nel mondo serissimi professori di Letteratura rinascimentale inglese disposti a proclamare L’amica geniale un capolavoro della World Literature, e per nulla timorosi di sfidare, così facendo, il sussiego e l’aria di sufficienza dei loro interlocutori italiani; e ci sono state anche (in Italia) riviste di teoria materialista della letteratura che alla Ferrante hanno generosamente dedicato numeri monografici.
Leggi tutto
Francesco Piccioni: Dal reddito al salario. E’ ora di alzare la testa!
Dal reddito al salario. E’ ora di alzare la testa!
di Francesco Piccioni
Quando un sistema è davvero in crisi, succedono di queste cose. Un governo – o una parte di esso – decide di destinare un po’ di soldi pubblici (molto pochi) in un abbozzo di “reddito sociale” che fin qui non esisteva (in altri paesi dell’Unione Europea sì). L’intento, al pari degli “80 euro” di Matteo Renzi, era quello di guadagnarsi un po’ di consensi in vista delle elezioni europee – di qui la fretta di metterlo in campo, nonostante problemi burocratico-organizzativi di un certo rilievo – e dimostrare di aver almeno in parte mantenuta almeno una delle tante promesse elettorali.
Poca roba, ripetiamo, e in una logica di workfare che lambisce seriamente l’obbligo schiavistico al lavoro, deportazione compresa (basta vedere lo scontro tra Giorgio Cremaschi e il “sciur Brambilla” su La7 per averne la prova provata).
Bene, di fronte a questa robetta che fa il solletico alla povertà crescente, soprattutto delle nuove generazioni avviate al lavoro, Confindustria se n’è uscita con una critica che supera l’incredibile e diventa suicidio: “il reddito di cittadinanza è troppo alto, potrebbe scoraggiare i giovani dal cercare lavoro”. Parola di Pierangelo Albini, direttore dell’area Lavoro e Welfare di via dell’Astronomia. A suo supporto si schierano Pd, Berlusconiani, Lega, CgilCislUil, e minutaglia varia, chiarendo definitivamente qual’è il campo della destra antipopolare in questo paese.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2718
Hits 1924
Hits 1831
Hits 1818
Hits 1815
Hits 1801
Hits 1783
Hits 1764
Hits 1724
Hits 1716
tonino

Michael Löwy: La critica della democrazia borghese in Rosa Luxemburg
La critica della democrazia borghese in Rosa Luxemburg
di Michael Löwy
Come ha scritto Michael Löwy,i Freikorps che uccisero Rosa Luxemburg – la “fondatrice del Partito comunista tedesco (Lega Spartachista)” -, erano una “banda di ufficiali e militari controrivoluzionari” che rappresentava il “futuro vivaio del partito nazista”[1].
Furono inviati a Berlino dal ministro socialdemocratico Gustav Noske per stroncare la rivolta spartachista e sconfiggere il tentativo di una rivoluzione in Germania. Per ricordare la filosofa rivoluzionaria polacca, a cento anni dalla sua morte, Tysm pubblica un testo di Löwy che sottolinea la vitalità della sua lezione.
Ringraziamo Löwy per averci concesso di pubblicare questo testo, inedito in lingua italiana, apparso originariamente sul numero 59, 2016 della rivista francese Agone. Un’altra versione* è pubblicata in Löwy, Rosa Luxemburg. L’étincelle incendiaire, Montreuil, Le temps des cerises, 2018.
 L’approccio estremamente dialettico di Rosa
Luxemburg allo Stato
borghese e alle sue forme democratiche le permette di sfuggire
tanto agli approcci social-liberali (á laBernstein),
che negano il loro
carattere borghese, quanto a quelli di un certo marxismo
volgare, che non tengono in considerazione l’importanza della
democrazia. Fedele alla
teoria marxista dello Stato, Rosa Luxemburg insiste sul suo
carattere di “Stato di classe”. Ma aggiunge immediatamente:
“[questo]non dovrebbe essere
preso nel suo significato rigido, assoluto, bensì in un senso
dialettico”.Che cosa significa?
Da una parte, che “nell’interesse dell’evoluzione sociale [lo
Stato] assume diverse funzioni di interesse generale”; ma allo
stesso tempo che “lo fa esclusivamente perché e fintantoché
questi interessi e l’evoluzione sociale coincidono con gli
interessi della classe dominante”[1].
L’universalità dello Stato è quindi severamente limitata e, in
larga
misura, negata dal suo carattere di classe.
L’approccio estremamente dialettico di Rosa
Luxemburg allo Stato
borghese e alle sue forme democratiche le permette di sfuggire
tanto agli approcci social-liberali (á laBernstein),
che negano il loro
carattere borghese, quanto a quelli di un certo marxismo
volgare, che non tengono in considerazione l’importanza della
democrazia. Fedele alla
teoria marxista dello Stato, Rosa Luxemburg insiste sul suo
carattere di “Stato di classe”. Ma aggiunge immediatamente:
“[questo]non dovrebbe essere
preso nel suo significato rigido, assoluto, bensì in un senso
dialettico”.Che cosa significa?
Da una parte, che “nell’interesse dell’evoluzione sociale [lo
Stato] assume diverse funzioni di interesse generale”; ma allo
stesso tempo che “lo fa esclusivamente perché e fintantoché
questi interessi e l’evoluzione sociale coincidono con gli
interessi della classe dominante”[1].
L’universalità dello Stato è quindi severamente limitata e, in
larga
misura, negata dal suo carattere di classe.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Venezuela, 5S e quant’altro..... Non basta un clic
Venezuela, 5S e quant’altro..... Non basta un clic
di Fulvio Grimaldi
 Da anni
ricevo, sul blog, in Facebook e in posta, commenti, a volte di
consenso, a volte di
virulente dileggio, sulla mia posizione sul Movimento 5
Stelle. Che, come i meno strabici, hanno perfettamente capito,
è di frequentazione da
fuori (resto iscritto esclusivamente all’Ordine dei
Giornalisti), di condivisione in parola e immagine di molte
sue battaglie, di sostegno alle
cose che mi paiono buone (e a volte senza precedenti, le più
osteggiate dall’unanimismo globalista destra-sinistra) e di
critica a quelle
che considero meno buone, o del tutto sbagliate. Il lancio
della prima pietra, però, lo lascio ad altri. A quelli, dotati
di grande humour, che
si dicono senza peccato.
Da anni
ricevo, sul blog, in Facebook e in posta, commenti, a volte di
consenso, a volte di
virulente dileggio, sulla mia posizione sul Movimento 5
Stelle. Che, come i meno strabici, hanno perfettamente capito,
è di frequentazione da
fuori (resto iscritto esclusivamente all’Ordine dei
Giornalisti), di condivisione in parola e immagine di molte
sue battaglie, di sostegno alle
cose che mi paiono buone (e a volte senza precedenti, le più
osteggiate dall’unanimismo globalista destra-sinistra) e di
critica a quelle
che considero meno buone, o del tutto sbagliate. Il lancio
della prima pietra, però, lo lascio ad altri. A quelli, dotati
di grande humour, che
si dicono senza peccato.
Landini, molto rumore per nulla
Viene in mente, per la portata anche simbolica di tutta una sinistra terrorizzata dal minimo bagliore esterno al quadro delle compatibilità, tale Landini Maurizio. Lo ricorderete da mille comparsate tv, agitato fracassone in maglietta della salute, a testa bassa contro i padroni e una segretaria CGIL troppo remissiva. Ricorderete la sua “coalizione sociale”, fondata a Bologna in un mattino del 2015 e svaporata prima che calasse il sole e prima che potesse, come anticipato, spostare di 180 gradi a sinistra la barra del barcone Italia zeppo di naufraghi, che però non se li fila nessuno, non fanno parte di nessuna filiera di trafficanti. Poi le cose andarono nel verso giusto sindacato unitario e patto dei produttori con la Confindustria. Tarallucci e vino tra Landini e Camusso sulle spoglie di un ceto lavoratore cui erano passati sopra, mentre il sindacato assisteva dalla Tribuna, gli scarponi chiodati dei tempi che corrono: guerre, neoliberismo, austerity, i salari più bassi d’Europa, spazzati via tutti i diritti costati secoli, carcere. botte e morti.
Leggi tutto
Eros Barone: L’ideologia della casa in proprietà e le catene dorate del capitale
![]()
L’ideologia della casa in proprietà e le catene dorate del capitale
di Eros Barone
 I
poeti vivono in un mondo immaginario, e così anche il
signor Sax, il quale s'immagina che il padrone d'immobili
abbia "raggiunto il grado
supremo d'indipendenza economica" ed abbia "un ricovero
sicuro", "diverrebbe capitalista e sarebbe
assicurato contro i pericoli della disoccupazione o
dell'inabilità al lavoro dal credito
immobiliare, che sarebbe a sua disposizione" ad ogni
momento.
I
poeti vivono in un mondo immaginario, e così anche il
signor Sax, il quale s'immagina che il padrone d'immobili
abbia "raggiunto il grado
supremo d'indipendenza economica" ed abbia "un ricovero
sicuro", "diverrebbe capitalista e sarebbe
assicurato contro i pericoli della disoccupazione o
dell'inabilità al lavoro dal credito
immobiliare, che sarebbe a sua disposizione" ad ogni
momento.
Friedrich Engels, La questione delle abitazioni.
Non ho mai toccato un soldo. Ho posseduto solo una vecchia Ritmo e questo ai milanesi non dovrei dirlo visto che a Milano chi non ha neppure una casa in proprietà è considerato un poveraccio.
Armando Cossutta, Un storia comunista.
-
“Investire nel mattone”: miti e realtà di un mercato monopolistico
In Italia, dove a lungo la cultura marxista ha discusso intorno ai processi di formazione di un nuovo blocco storico, non solo è mancata quasi del tutto un’analisi del blocco storico dominante, ma continua a mancare un’analisi adeguata della complessiva questione delle abitazioni come essenziale cerniera del blocco di potere dominante. Fatta questa premessa, resta tuttavia da aggiungere che qui non si intende offrire al lettore un’analisi compiuta di quello che si potrebbe definire “il blocco edilizio”, ma solo alcune linee introduttive ad una siffatta analisi, cercando, sia pure in modo schematico, di individuare le stratificazioni economiche e sociali che ne fanno parte o sono in qualche modo subordinate a questo “blocco”, e i legami, anche di carattere sovrastrutturale, che sono condizione del suo radicamento e della sua conservazione.1
Orbene,la consistenza economica e le ramificazioni del blocco fondiario, industriale e finanziario dell’edilizia appaiono evidenti, sol che si consideri come, nonostante le profonde interrelazioni tra pubblico e privato, il segno di questo settore sia tuttavia nettamente privatistico. Dal punto di vista della produzione e della proprietà, il settore dell’edilizia è infatti tra i più privatizzati della nostra economia.
Leggi tutto
Lorenzo Vita: Di Battista “rompe” l’asse con Trump: “L’Europa si sganci dall’America”
Di Battista “rompe” l’asse con Trump: “L’Europa si sganci dall’America”
di Lorenzo Vita
Il governo italiano ha tre politiche estere: quella della Lega, quella del Movimento 5 Stelle e quella di Enzo Moavero Milanesi. E oggi, Alessandro Di Battista ha infranto un altro tabù: l’asse con gli Stati Uniti di Donald Trump. Una sinergia che sembrava essere l’unico vero architrave dell’agenda estera italiana del governo giallo-verde, insieme alle forti aperture nei confronti della Russia. E di cui il viaggio di Giuseppe Conte a Washington doveva essere la certificazione.
Ma quest’asse nato dall’insediamento di Conte non sembra essere così netto. E lo dimostrano le parole di uomo estremamente rilevante per il Movimento 5 Stelle, che resta il principale partito di maggioranza dell’esecutivo. Ai microfoni di Lucia Annunziata, Di Battista ha infatti calato una carta decisamente importante affermando senza mezzi termini che “l’Europa avrà un futuro se si sgancerà dagli americani”. Una frase importante che arriva in un momento già di forti tensioni in seno alla maggioranza e in ottica internazionale dopo la frattura con Parigi.
Di Battista non è un ministro, non rappresenta il governo, ma certamente non è un uomo che parla a titolo esclusivamente personale. Rappresenta un segmento fondamentale del Movimento 5 Stelle ed è lui che guida da qualche settimana il fronte “movimentista” dei pentastellati dopo una fase di rigido “governismo” in cui il partito aveva assunto una linea molto più filo-occidentale e legate agli Stati Uniti.
Leggi tutto
Giorgio Mascitelli: Una morale smart per il nuovo millennio
Una morale smart per il nuovo millennio
di Giorgio Mascitelli
Nei giorni scorsi si è diffusa sui giornali italiani la notizia infondata che il presidente della commissione europea Juncker avrebbe chiesto scusa per la politica di austerità condotta contro la Grecia, tant’è vero che alcuni esponenti del governo si sono affrettati a parlare di ‘lacrime di coccodrillo’ e di ipocrisia. Vorrei innanzi tutto rassicurarli: il presidente della commissione non si è macchiato di un simile comportamento riprovevole, si è limitato a chiedere scusa per l’avventata austerità, anche se le riforme strutturali restano essenziali e per gli insulti piovuti sui greci. Insomma, in Grecia è stata fatta la cosa giusta, anche se un po’ brutalmente (eppure mi ricordo che allora la questione della rapidità dei provvedimenti era considerata essenziale dalla troika). Ecco, si tratta di un peccato veniale forse dettato dall’eccessivo entusiasmo europeista.
In realtà, anche se le scuse fossero state più articolate e fondate, dal punto di vista pratico non sarebbe cambiato molto: non è certo un presidente a fine mandato che può cambiare le politiche che tuttora sussistono in Grecia o rinegoziare gli obblighi che graveranno su questo paese per tutto il secolo. Da un punto di vista pragmatico, il comportamento di Juncker e di Dijsselbloem, che lo aveva preceduto nell’ammissione che il prezzo pagato dal popolo greco era stato troppo pesante (senza scusarsi peraltro), è comprensibilissimo per vari motivi: è chiaro che il fantasma della Grecia è stato decisivo per l’affermazione elettorale di tante forze politiche sovraniste, che verosimilmente alle prossime elezioni europee modificheranno radicalmente la composizione del parlamento di Strasburgo.
Leggi tutto
Paola Ceretto: La tariffa dell’acqua è una truffa?
La tariffa dell’acqua è una truffa?
di Paola Ceretto
La tariffa dell’acqua è una truffa? Lo dice il Comitato provinciale Acqua Pubblica Torino nel dossier presentato il 22 gennaio scorso al Caffè Basaglia di Torino. La responsabilità risale al Governo Berlusconi IV che, per neutralizzare il referendum del 2011, nel complice silenzio dei Comuni italiani, ha privatizzato il sistema di governo del Servizio Idrico Integrato abolendo il Comitato Nazionale Vigilanza sulle Risorse Idriche (COVIRI), struttura di supporto del Ministero dell’ambiente, ed esternalizzandolo ad ARERA (Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente).
ARERA (=Bengodi) è finanziata con la tariffa dell’acqua riscossa dalle aziende che gestiscono il Servizio Idrico Integrato, nella misura dell’1‰ (uno per mille) dei ricavi. Al 31 dicembre 2017 aveva un deposito bancario attivo di € 80.744.896 e ha compiuto operazioni immobiliari milionarie che non hanno giustificazione.
Il Collegio di ARERA è composto dal presidente e quattro membri (nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e che durano in carica sette anni). Percepiscono 240.000 € annui cadauno, a cui vanno aggiunti, per il 2017, ulteriori € 148.555 complessivi di rimborsi spese.
Il compenso dei Revisori dei Conti è di € 35.000 annui per il Presidente e di € 31.500 ciascuno degli altri, quasi il doppio del limite massimo dei compensi dei Revisori dei Comuni con più di 500.000 abitanti e notevolmente più elevati dei compensi applicati nel settore privato. Godono inoltre di un rimborso spese complessivo di € 33.906.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Inclusione o emancipazione
![]()
Inclusione o emancipazione
di Salvatore Bravo
Lessico unidirezionale
I sistemi di potere proliferano, divengono capillari, strutturano i pensieri diffondendo parole, escludendone altre: censura linguistica-lessicale. La contrapposizione, il polemos (Πόλεμος) linguistico è la condizione della democrazia, della comunità viva che veicola con le parole il confronto concettuale. In assenza di polemos linguistico non vi è che lo scorrere delle parole lungo un asse unidirezionale. Le parole sono apprese, ripetute, formulano rappresentazioni finalizzate a puntellare la caverna dei nostri mondi. Il sole che illumina fuori della caverna, il bene, è la libertà di parlare con cognizione di sé, dei modi di produzioni, la parresia (dal greco παρρησία, composto di pan (tutto) e rhema, ciò che viene detto). Non vi è comunità che con la parola plurale, dialettica, in cui ci si confronta per capire, si studia la storia per evidenziare in modo contrastivo le differenze. Un mondo senza parole dialettiche è unidirezionale, convoglia verso uno spazio ed un tempo eguale per tutti. La forza del sistema è nel ridurre le differenze a simulacro, ad imitazione del loro essere essenziale, della loro natura. Il simulacro è l’immagine allo specchio svuotata di ogni suo contenuto formale, di ogni passaggio alla potenza all’atto. E’ possibile per tutti dichiarare la propria differenza, ostentarla fino al ridicolo, purché non intacchi la struttura dell’economia.
Leggi tutto
Sandro Moiso: Aprire gli occhi, leggere la crisi
Aprire gli occhi, leggere la crisi
di Sandro Moiso
Countdown. Studi sulla crisi. Vol.III, Asterios Abiblio Editore, Trieste Novembre 2018, pp.160, euro 15,00
 Secondo le stime dell’ufficio statistico
federale, a novembre, in
Germania la produzione di beni di consumo è diminuita di oltre
il 4%, i mezzi di produzione di quasi il 2% e i beni intermedi
dell’1%. Il
calo della produzione è stato avvertito anche nel settore
energetico e delle costruzioni e tutti questi problemi sono
associati alle
difficoltà incontrate dall’industria automobilistica del paese
governato da Angela Merkel.
Secondo le stime dell’ufficio statistico
federale, a novembre, in
Germania la produzione di beni di consumo è diminuita di oltre
il 4%, i mezzi di produzione di quasi il 2% e i beni intermedi
dell’1%. Il
calo della produzione è stato avvertito anche nel settore
energetico e delle costruzioni e tutti questi problemi sono
associati alle
difficoltà incontrate dall’industria automobilistica del paese
governato da Angela Merkel.
Se la cosiddetta locomotiva tedesca non si dimostra più così capace di trainare il trenino europeo, anche dall’altra parte del mondo l’economia cinese inizia a dare i primi segnali di cedimento, mentre la guerra dei dazi tra USA e Cina aggiunge ulteriori preoccupazioni sullo stato “reale” dell’economia mondiale e allo stesso tempo per i titoli azionari statunitensi, il mese di dicembre scorso è stato il peggiore dal 1931, ovvero dalla Grande Depressione!1 Inoltre “le principali detenzioni estere di debito statunitense a ottobre sono calate di altri 26 miliardi […] Sempre in base a dati ufficiali riferiti allo scorso ottobre, gli investitori esteri hanno venduto altri 22,2 miliardi di dollari di titoli azionari statunitensi, il sesto mese di vendite di fila”.2 Così che al World Economic Forum di Davos, tra il 22 e il 25 gennaio, in sostituzione di tre rappresentanti assenti di altrettanti pezzi da novanta dell’establishment economico occidentale (Macron impelagato tra gilets jaunes e affaire Benalla; Theresa May incastrata tra un Parlamento ribelle e una possibile hard Brexit e Trump e la delegazione americana che hanno colto l’occasione dello shutdown federale per non prendervi parte), ha preso posto un’unica autentica convitata di pietra: la recessione mondiale.
Leggi tutto
Luciano Vasapollo: Venezuela. “C’è una sinistra complice con il golpe contro Maduro”
Venezuela. “C’è una sinistra complice con il golpe contro Maduro”
Rino Condemi intervista Luciano Vasapollo
 Intervista a Luciano
Vasapollo. Economista e militante della Rete dei Comunisti,
da anni segue le vicende
politiche ed economiche dell’America Latina. Abbiamo chiesto
a Luciano Vasapollo di commentare una intervista sulla
situazione in Venezuela
comparsa su Il manifesto che ci ha colpito, in negativo.
Nelle argomentazioni e nei presupposti di quella intervista
al sociologo Emiliano Teran
Mantovani, abbiamo intravisto lo spettro della subalternità
della sinistra in Europa alla campagna di legittimazione del
golpe e di
delegittimazione del governo bolivariano di Maduro. Un
brutto segnale che merita una replica a tutto tondo.
Intervista a Luciano
Vasapollo. Economista e militante della Rete dei Comunisti,
da anni segue le vicende
politiche ed economiche dell’America Latina. Abbiamo chiesto
a Luciano Vasapollo di commentare una intervista sulla
situazione in Venezuela
comparsa su Il manifesto che ci ha colpito, in negativo.
Nelle argomentazioni e nei presupposti di quella intervista
al sociologo Emiliano Teran
Mantovani, abbiamo intravisto lo spettro della subalternità
della sinistra in Europa alla campagna di legittimazione del
golpe e di
delegittimazione del governo bolivariano di Maduro. Un
brutto segnale che merita una replica a tutto tondo.
* * * *
Puntuale come un temporale in autunno, anche il Manifesto non si è tirato indietro dal coro “a sinistra contro Maduro”. Sabato 2 febbraio ha pubblicato una intervista sul Venezuela a Emiliano Teran Mantovani, dell’università di Barcellona e sociologo dell’università venezuelana, esponente di una sinistra ecologista e indigenista molto europea . In questa intervista ci sono valutazioni pesanti contro il governo Maduro. Cosa indica questo atteggiamento?
Sul ruolo e sulle responsabilità della “sinistra italiana”, dai partiti ai media, Manifesto compreso, non ho dubbi nel vedere nuovamente subalternità alla preparazione di una nuova “guerra umanitaria” al servizio di un sempre più cinico e inumano capitalismo.
Alla sinistra eurocentrica e colonizzatrice non interessano più gli investimenti sociali, nella sanità, nell’istruzione, sulle abitazioni e nelle politiche pubbliche sulle risorse che hanno caratterizzato Maduro e il Venezuela o le rivoluzioni e i processi progressisti in America Latina, ma si piega alla logica delle democrazie occidentali. In queste prevalgono la ricerca dei profitti e la proprietà privata, gli unici investimenti sui quali non si alza mai veramente la voce sono quelli a carattere militare. Vedo, sempre più una sinistra eurocentrica e sempre più filo imperialista, con partiti e stampa schierati per l’ennesima guerra umanitaria, l’ossimoro e l’ambiguità che abbiamo vista all’opera in questi venti anni.
Leggi tutto
Andrea Pannone: Blockchain per il bene comune?
Blockchain per il bene comune?
Come utilizzare Blockchain per evitare la tragedia dei commons
di Andrea Pannone
La Blockchain è nata per lo scambio di criptovalute come Bitcoin, ma può essere molto utile anche per affrontare il problema della scarsità dei beni comuni
 1. La ‘novità’ di
blockchain
1. La ‘novità’ di
blockchain
Negli ultimi mesi è cresciuta esponenzialmente tra studiosi e politici l’attenzione su blockchain – la tecnologia nata per facilitare lo scambio online di criptovalute come Bitcoin[1] – quale strumento per coordinare e rendere efficienti un’ampia varietà di transazioni decentralizzate non intermediate da soggetti terzi. In termini estremamente semplificati una blockchain è un libro mastro, ovvero la base fondamentale della contabilità, condiviso da una rete decentralizzata di computer per l’archiviazione digitale e il tracciamento dei dati associati a un prodotto o servizio lungo tutta la catena del valore (ossia dalla fase di produzione fino al consumatore/utilizzatore).
La blockchain può essere considerata una tecnologia che appartiene alla categoria delle tecnologie Distributed Ledger, ossia un insieme di sistemi concettualmente caratterizzati dal fatto di fare riferimento a un registro distribuito, governato in modo da consentire l’accesso e la possibilità di effettuare modifiche da parte di più nodi di una rete (vedi figura sotto).
Come suggerisce il nome una blockchain è organizzata in una sequenza lineare di piccoli insiemi di dati crittografati chiamati “blocchi”, che contengono gruppi di transazioni con data e ora (timestamp). Ogni blocco contiene un riferimento al suo blocco precedente e una risposta a un puzzle matematico complesso, che serve a convalidare le transazioni che contiene[2]. Nella sua forma più elementare la blockchain serve come mezzo per registrare, in modo sicuro e verificabile, un particolare stato di cose che è stato concordato dalla rete (Wright & De Filippi 2015). Come tale, la blockchain può essere utilizzata in qualsiasi sistema che comprende informazioni preziose, inclusi denaro, titoli, azioni, diritti di proprietà intellettuale e persino voti o dati di registro di identità (Davidson et al., 2016; Tapscott & Tapscott, 2016)[3]. Osserviamo che la necessità di crittare i dati deriva proprio dal fatto che tutto quello che viene registrato su una blockchain è visibile a tutti i nodi della rete e quindi se si registrassero informazioni sensibili senza essere critptate esse diventerebbero pubbliche.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Lalaland -INI
Lalaland -INI
di Ugo Boghetta
A proposito dell’ineffabile manifestazione dei sindacati del 9 febbraio.
E così Cgil Cisl Uil sono scesi in piazza, ma le ragioni di questa mobilitazione sfuggono.
Criticano questo o quel taglio ma non una parola sui motivi ed i colpevoli di questi tagli: i tecnocrati di Bruxelles. In effetti, se volevano contare sulla manovra avrebbero dovuto manifestare in autunno, ma in quel tempo sarebbe stato impossibile non criticare anche l’Unione Europea. Ma questo non si può fare. E’ proibito. Anche sindacati cosiddetti radicali si allineano. Ho letto volantini che criticano questa o quella riduzione di stanziamenti, ma non una riga su chi li ha pretesi!
E così tutti, volenti o nolenti, partecipano al ballo contro il governo gialloverde. Non è un buon inizio Landini!
Questo fa perdere ai sindacati ulteriore credibilità e già è scarsa. Manifestano contro quota 100 quando sono stati silenziosi sulla Fornero ma qualche migliaia di lavoratori potranno andare a casa.
Criticano il reddito di cittadinanza quando la povertà è raddoppiata: qualche milione di persone avranno un reddito. Certo sono provvedimenti che hanno problematiche, non hanno un senso strategico, ma per la prima volta c’è un po’ di redistribuzione e risarcimento sociale. E, alle porte, non c’è un governo migliore.
Leggi tutto
Fabio Mini: Robot e super-armi: la guerra del futuro sarà sempre più sporca
Robot e super-armi: la guerra del futuro sarà sempre più sporca
Marco Cedolin intervista il generale Fabio Mini
Le guerre del passato e le guerre del futuro rappresentano due elementi radicalmente differenti fra loro, oppure in fondo a prescindere dall’evoluzione tecnologica si tratta sempre della solita “sporca guerra” che purtroppo ben conosciamo? E la pace che ci viene “venduta” come tale nel corso degli ultimi decenni lo è davvero o si tratta semplicemente di una guerra combattuta in forme differenti?
Ne parliamo con il generale Fabio Mini, esperto conoscitore di questioni geopolitiche e strategia militare e oggi autore di svariate pubblicazioni su questi argomenti, dopo essere stato capo di Stato maggiore del comando Nato per il Sud Europa, comandante della missione di pace interforze in Kosovo nel 2003, oltre ad avere svolto molti altri incarichi di primaria importanza.
* * * *
Le guerre del XXI secolo saranno un’evoluzione di quelle del passato o si svolgeranno su un piano inclinato radicalmente differente?
È già passato il primo ventennio del XXI secolo e la guerra non è cambiata. Anzi i potenziali cambiamenti offerti dall’evoluzione tecnologica devono fare i conti con l’involuzione dei conflitti sempre più caratterizzati dal ricorso a metodi a dir poco barbarici. Abbiamo fatto passi indietro nella regolamentazione degli usi e costumi di guerra, i potenti hanno fatto ricorso all’eccesso di potenza cercando di ridurre i rischi e i deboli hanno fatto ricorso all’eccesso della violenza irrazionale e immotivata.
Leggi tutto
Michele Mezza: Per non diventare sudditi del Re digitale dobbiamo sviluppare algoritmi di libertà
Per non diventare sudditi del Re digitale dobbiamo sviluppare algoritmi di libertà
di Michele Mezza
La scala del calore che fino a oggi ha governato le economie del mondo, con vapore prima e petrolio poi, come fonti di energia che determinavano le gerarchie degli Stati, ora è gradualmente sostituita dalla scala del calcolo, in cui sono le agenzie globali, come appunto google e Ibm, che partecipano alla corsa quantica, a determinare le relazioni di comando nel pianeta. In questa spirale irrompono ora i nuovi algoritmi quantici che per potenza di calcolo promettono di sbriciolare già l’insuperabile complessità della blockchain.
Sembra un gioco di società, in realtà è una terribile e permanente prova di forza, che si sottrae a ogni controllo sociale e democratico, rinchiudendo in ambiti elitari le fasi di un potere che si vuole supremo.
Più calcolo, più automazione, più autonomia dei sistemi digitali, meno esseri umani che possono incidere sul futuro.
L’automatizzazione della documentazione, come la blockchain delle criptomonete ci indica, porta all’automatizzazione della governance finanziaria, come le banche centrali stanno studiando, che alla fine ci proietterà come soluzione inevitabile, anzi auspicata, a quella democrazia automatica di cui parlava Virilio già a metà degli anni novanta, e che Parag Khanna già vede realizzata a Singapore.
Leggi tutto
Luca Picotti: “Il lavoro del futuro” di Luca De Biase
“Il lavoro del futuro” di Luca De Biase
di Luca Picotti
Recensione a: Luca De Biase, Il lavoro del futuro, Codice Edizioni, Torino 2018, pp. 178, 15 euro, (scheda libro)
Le grandi trasformazioni tecnologiche ed economiche che stiamo vivendo pongono problemi, sfide e punti interrogativi del tutto inediti. Dinanzi a questa realtà in continuo divenire, la ricerca di nuovi linguaggi e schemi concettuali risulta necessaria se si vuole comprendere il presente e immaginare il futuro.
Il lavoro, inteso come identità sociale, espressione di sé e percorso di realizzazione delle proprie aspirazioni, rappresenta un campo di indagine particolarmente soggetto alle trasformazioni tecnologiche e sul quale si addensano, volgendo lo sguardo all’orizzonte dei prossimi decenni, numerose incognite. Quali mestieri verranno spazzati via dalle nuove tecnologie? E quali altri compariranno sulla scena? Verso quali studi converrà indirizzare le generazioni a venire? Quali competenze saranno necessarie?
Luca De Biase, giornalista e saggista, nel libro Il lavoro del futuro, edito da Codice Edizioni, rilancia e approfondisce un’inchiesta sviluppata per Il Sole 24 ore sul mondo del lavoro. Attraverso dati, interviste, testimonianze e lucide osservazioni, De Biase indaga attorno agli sviluppi dell’automazione, della gig economy e più in generale di un mercato del lavoro in costante mutamento.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2778
Hits 1963
Hits 1884
Hits 1843
Hits 1833
Hits 1817
Hits 1813
Hits 1796
Hits 1755
Hits 1734
tonino

Michael Roberts: La moderna teoria della moneta
La moderna teoria della moneta
di Michael Roberts
 I.
Cartalismo e
marxismo
I.
Cartalismo e
marxismo
La modern monetary theory giustifica la spesa pubblica senza restrizioni per ripristinare e sostenere la piena occupazione. Ma questa apparente virtù nasconde il suo vizio, un ostacolo molto più grande per un vero cambiamento
La teoria della moneta moderna (modern monetary theory - MMT) è diventata di moda tra molti economisti di sinistra negli ultimi anni. La nuova democratica di sinistra Alexandria Ocasio-Cortez è sembra esserne una sostenitrice; e uno dei principali esponenti della MMT ha recentemente discusso la teoria e le sue implicazioni politiche con John McDonnell, cancelliere dello scacchiere ombra per il partito laburista britannico.
La MMT ha una certa trazione nella sinistra in quanto sembra offrire un supporto teorico per le politiche di spesa fiscale finanziate dall’emissione di moneta da parte della banca centrale e per far fronte ai deficit di bilancio e al debito pubblico senza timore di crisi; e quindi sostenere politiche di spesa pubblica per progetti infrastrutturali, creazione di posti di lavoro e l'industria, in diretto contrasto con le politiche mainstream neoliberali di austerità e intervento governativo minimo.
Quindi, in questo post e in altri post a seguire, offrirò la mia opinione sul valore della MMT e le sue implicazioni politiche per il movimento operaio. In questo articolo cercherò di dare una visione generale per far emergere le somiglianze e le differenze con la teoria monetaria di Marx.
La MMT si fonda sulle idee di ciò che è chiamato cartalismo [chartalism, da non confondere col cartismo, il movimento politico-sociale inglese della prima metà del sec. XIX, ndt]. Georg Friedrich Knapp, un economista tedesco, coniò il termine cartalismo nella sua Teoria statale della moneta, che fu pubblicata in tedesco nel 1905 e tradotta in inglese nel 1924. Il nome deriva dal latino charta, nel senso di un simbolo (token) o biglietto. Il cartalismo sostiene che il denaro ha avuto origine dai tentativi statali di dirigere l'attività economica piuttosto che rappresentare una soluzione spontanea ai problemi del baratto o come mezzo per simbolizzare il debito.
Leggi tutto
Dino Erba: Dall’aristocrazia operaia al sottoproletariato
![]()
Dall’aristocrazia operaia al sottoproletariato
di Dino Erba
Per nascondere la propria miseria politica e intellettuale
 Quand’ero
giovane, negli anni Settanta del Novecento, un tema
ricorrente era
il ruolo della cosiddetta aristocrazia operaia
nel frenare e ostacolare il presunto processo rivoluzionario.
A distanza di mezzo
secolo, molte cose sono mutate sotto il cielo del capitale, e
il ruolo di freno e ostacolo è passato al cosiddetto
sottoproletariato. Occorre sempre un capro
espiatorio sociale, per giustificare la propria
(nostra) miseria politica
e intellettuale.
Quand’ero
giovane, negli anni Settanta del Novecento, un tema
ricorrente era
il ruolo della cosiddetta aristocrazia operaia
nel frenare e ostacolare il presunto processo rivoluzionario.
A distanza di mezzo
secolo, molte cose sono mutate sotto il cielo del capitale, e
il ruolo di freno e ostacolo è passato al cosiddetto
sottoproletariato. Occorre sempre un capro
espiatorio sociale, per giustificare la propria
(nostra) miseria politica
e intellettuale.
In entrambi i casi, c’era e c’è molta confusione teorica sotto il mutevole cielo del capitale.
E, in entrambi i casi, gioca il peso del passato, nel bene e nel male.
Le due categorie sociali – aristocrazia operaia e sottoproletariato – sono strettamente connesse, sono due facce della medesima medaglia economico-sociale del capitale. Solo per facilitare l’esposizione le separo, per poi ricomporne la contraddittoria unità. Per farla breve, non ci vuol molto a capire che il sottoproletariato rappresenta gli strati bassi dei lavoratori salariati (i più sfigati), mentre l’aristocrazia rappresenta gli strati alti (i più viziati). I rispettivi orientamenti ideologici e politici dipendono dalla fase storica, e non dalle loro caratteristiche congenite (dal loro Dna, si dice oggi...).
Seguendo questo filo conduttore, cercherò di proporre una linea interpretativa.
Sottoproletariato
Che cosa sia il sottoproletariato, ce lo spiega Marx, nel capitolo 24, del Primo libro del Capitale: La cosiddetta accumulazione originaria. In breve.
In italiano, il termine è tradotto impropriamente dal tedesco Lumpenproletariat che significa proletariato straccione. La sua comparsa avvenne durante la Rivoluzione industriale, che ebbe il suo epicentro nell’Inghilterra del XVIII secolo, ma ebbe una lunga gestazione nei secoli precedenti: in Italia, Fiandre, Spagna, Francia, Germania.
Leggi tutto
Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione: Una stima degli effetti della manovra e delle alternative possibili
Una stima degli effetti della manovra e delle alternative possibili
Stima degli effetti della manovra economica e simulazione di manovre alternative
di Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione
Stima Manovra Economica. Con diverse tecniche di stima dei moltiplicatori degli stimoli fiscali mostriamo che la manovra economica del governo per il 2019 ha un impatto molto modesto sulla crescita perché trascura gli investimenti, non presenta un disegno di politica industriale e non muta le condizioni del lavoro. Al contrario, una diversa composizione della manovra, anche a saldi invariati ma con risorse dimezzate sulle misure-simbolo e corrispondenti maggiori investimenti, avrebbe raddoppiato l’impatto positivo sulla crescita. Inoltre, portando il deficit al 2,4% e spostando le risorse aggiuntive sugli investimenti, tutte le stime mostrano che l’impatto espansivo sarebbe addirittura triplicato
 La necessità di una manovra
espansiva
La necessità di una manovra
espansiva
Nella seconda metà del 2018, le medesime tensioni internazionali che hanno determinato un rallentamento della crescita in Germania e Francia hanno spinto l’Italia nella recessione, complici i gravi deficit di competitività dell’apparato produttivo e infrastrutturale del Paese, il cronico sottofinanziamento degli investimenti pubblici e privati nonché la crescente precarizzazione del lavoro che contribuisce al ristagno dei consumi. In questo scenario, monta la preoccupazione che la manovra economica del governo possa avere un profilo espansivo insufficiente. Per cominciare, la manovra economica non ha impresso un cambiamento di direzione significativo alla politica delle finanze pubbliche rispetto agli anni dell’austerità. A riguardo, il governo sembra avere scontato un deficit di capacità politica in Europa e in particolare nel confronto con la Commissione Europea. Infatti, anziché proporre una manovra incentrata sul rilancio degli investimenti pubblici e sulle politiche industriali, che avrebbe potuto riscuotere consensi in altri Paesi e registrato minori resistenze presso la Commissione Europea, il governo ha presentato una manovra caratterizzata da un deficit incrementato al 2,4% del pil e finalizzato a un aumento della spesa corrente e dei trasferimenti. Successivamente, per evitare la procedura sanzionatoria, il governo ha dovuto ridurre il deficit al 2,04% del pil, riportando i valori della finanza pubblica pressoché in linea con quelli registrati nel 2018.
Leggi tutto
CityStrike: Il pilota automatico e la lotta di classe
Il pilota automatico e la lotta di classe
di CityStrike
Qualche mese fa proponevamo una riflessione sul concetto di sovranità a partire da un allora recente fatto politico, ovvero il diniego da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a nominare l'economista Paolo Savona alla carica di Ministro dell'economia. La questione era molto semplice, Savona rischiava di assumere una linea nei confronti dell'Ue non tollerabile dall'establishment economico-finanziario. Il tutto a prescindere dalla reale validità delle posizioni economiche di Paolo Savona che ritenevamo e riteniamo ancora molto discutibili.
La storia oggi si ripete tale e quale con la questione venezuelana, laddove Mattarella interviene per riportare il nostro paese nel solco delle posizioni espresse dagli stati europei, e per ribadire la fedele subalternità dello Stato italiano ai partner statunitensi, ovvero a fianco del golpista Juan Guaidò scelto dagli USA, dopo che i 5 Stelle avevano assunto una posizione intelligente, utile perlomeno a scongiurare una carneficina alla quale, invece, evidentemente aspirano i sostenitori del golpe.
Si tratta di un fatto molto grave: il Presidente della Repubblica interviene a gamba tesa contro le cautele governative indicando la necessità di sostenere un golpe totalmente antidemocratico e ingiustificabile a norma del diritto internazionale. Il tutto amplificato dalle posizioni della Lega Nord che, a stretto giro, fa sapere di essere d’accordo con il Presidente della Repubblica unendosi a un ampio fronte costituito dalla destra estrema, dal PD e dai media.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Cosa ci dice l'Abruzzo?
Cosa ci dice l'Abruzzo?
di Leonardo Mazzei
Cosa ci dicono le elezioni abruzzesi? Tre cose sono evidenti: la vittoria della destra a trazione leghista, il significativo arretramento dei Cinque Stelle, la relativa ripresa del centrosinistra ma non del Pd.
Se questi sono i fatti, è però opportuno andare un po' più in profondità.
La tentazione di ricavare scenari nazionali dal voto amministrativo è forte, ma spesso fuorviante. Bisogna infatti ricordarsi sempre tre banalità: che le regionali non sono le politiche, che la differenza della partecipazione al voto tra queste due elezioni è abissale, che forti oscillazioni elettorali - spesso anche in tempi ravvicinati - sono ormai la norma.
Che le regionali non siano le politiche dovrebbe essere cosa ovvia. Diverso il sistema elettorale, più forte il peso del notabilato e del sistema delle preferenze. Rimanendo all'Abruzzo, come si spiegherebbe altrimenti l'enormità di cinque liste della coalizione di destra ed addirittura otto di quella di centrosinistra? E' chiaro che si tratta di trucchetti acchiappavoti che penalizzano fortemente la solitaria corsa di M5S.
Leggi tutto
Chris Hedges: Goodbye al dollaro
Goodbye al dollaro
di Chris Hedges*
L’inetta e corrotta presidenza Trump ha dato involontariamente il colpo fatale all’Impero Americano con l’abbandono del dollaro come principale valuta di riserva del mondo. Sempre più nazioni in tutto il pianeta, specialmente in Europa, hanno perso la fiducia che gli Stati Uniti possano agire in maniera razionale e che, anche meno, possano fungere da guida nelle problematiche che riguardano la finanza internazionale, il commercio, la diplomazia e la guerra. Queste nazioni stanno silenziosamente smantellando un’alleanza con gli Stati Uniti vecchia di settant’anni e stanno mettendo a punto sistemi alternativi per gli scambi bilaterali. Questa riconfigurazione del sistema finanziario mondiale sarà fatale all’Impero Americano, come affermano da molto tempo lo storico Alfred McCoy e l’economista Michael Hudson. Attiverà una spirale di morte economica, con un’inflazione alle stelle che causerà una massiccia contrazione della presenza militare d’oltreoceano e farà precipitare gli Stati Uniti in una depressione prolungata. Trump, invece di rendere nuovamente grande l’America, si è involontariamente dimostrato il più spietato becchino dell’impero.
L’amministrazione Trump ha capricciosamente sabotato le istituzioni globali, fra cui la NATO, l’Unione Europea, le Nazioni Unite, la Banca Mondiale e il Fondo Monetario Internazionale, che forniscono copertura e legittimità all’imperialismo americano e alla sua egemonia economica planetaria. L’Impero Americano, come fa notare McCoy, è sempre stato un ibrido degli imperi del passato. Aveva sviluppato, scrive,
Leggi tutto
Carlo Bertani: Abruzzo: Due scenari
Abruzzo: Due scenari
di Carlo Bertani
Le elezioni in Abruzzo non hanno raccontato molto sulla politica nazionale, perché ci sono di mezzo antiche questioni clientelari, molte legate al terremoto dell’Aquila del 2009. Rispetto alle precedenti elezioni regionali del 2014, il M5S ha preso circa la stessa percentuale, intorno al 20%: la differenza è che il centro-destra, mediante il “traino” di Salvini, ha spodestato il precedente presidente di centro-sinistra. Capisco che, per chi segue ancora queste vittorie/sconfitte sempre nell’ambito della dicotomia destra/sinistra, possa interessare. Personalmente, non lo ritengo così importante, però un’analisi più approfondita è necessaria.
La vicenda elettorale toccherà probabilmente gli equilibri nella gestione degli appalti, che “vireranno” verso il centro destra. Il tandem Giorgetti-Berlusconi gioisce, anche se il Cavaliere non tocca nemmeno quota 10%, perché l’obiettivo dei due è far saltare l’alleanza “impuria” con i 5S e restaurare un bel governo di destra a livello nazionale. Per Salvini la questione è più seria poiché, senza quel 10% di Berlusconi, il governo di destra non si farà mai e, dunque, si ripiomberebbe in un dejà vu che vedrebbe la Lega appoggiare sì i grandi appalti – come una parte del suo elettorato desidera (tutti quelli di Berlusconi) – mentre sul fronte europeo l’Italia finirebbe sotto il tallone di Bruxelles. Il cavaliere, oggi, per Bruxelles è una garanzia. E Salvini, unito a Berlusconi, perderebbe senz’altro molti voti da parte delle persone che oggi lo voterebbero, ma senza l’ingombrante Cavaliere.
Leggi tutto
Carlo Formenti: La guerra fra metropoli e periferie
La guerra fra metropoli e periferie
La Francia, i gilet gialli e la crisi della sinistra
di Carlo Formenti
 Fra le tesi che ho sostenuto ne
“La variante populista” – e rilanciato nel mio nuovo libro,
“il socialismo è morto. Viva il socialismo” (Meltemi) – ve n’è
una che ha suscitato critiche particolarmente
aspre: mi riferisco all’affermazione secondo cui il conflitto
di classe, nell’attuale fase di sviluppo capitalistico, si
manifesta
soprattutto come antagonismo fra flussi e luoghi. L’idea di
fondo è che il capitalismo globalizzato e finanziarizzato –
fatto di
flussi sempre più veloci di merci, servizi, capitali e persone
che ignorano i confini politici e geografici – opprime e
sfrutta i
territori – laddove resta confinata la stragrande maggioranza
dell’umanità che non gode delle chance di mobilità fisica e
sociale riservate alle élite – dai quali estrae risorse senza
restituire nulla in cambio.
Fra le tesi che ho sostenuto ne
“La variante populista” – e rilanciato nel mio nuovo libro,
“il socialismo è morto. Viva il socialismo” (Meltemi) – ve n’è
una che ha suscitato critiche particolarmente
aspre: mi riferisco all’affermazione secondo cui il conflitto
di classe, nell’attuale fase di sviluppo capitalistico, si
manifesta
soprattutto come antagonismo fra flussi e luoghi. L’idea di
fondo è che il capitalismo globalizzato e finanziarizzato –
fatto di
flussi sempre più veloci di merci, servizi, capitali e persone
che ignorano i confini politici e geografici – opprime e
sfrutta i
territori – laddove resta confinata la stragrande maggioranza
dell’umanità che non gode delle chance di mobilità fisica e
sociale riservate alle élite – dai quali estrae risorse senza
restituire nulla in cambio.
Constato ora che questa tesi trova conforto nei lavori di un geografo francese, Christophe Guilluy, di cui ho recentemente letto due importanti lavori: “La France périphérique” e “No society. La fin de la classe moyenne occidentale” (entrambi pubblicati da Flammarion). Queste due opere, segnalatemi da un amico di Podemos, aiutano più di tutte le idiozie proferite da media, politici ed “esperti” a comprendere il fenomeno dei gilet gialli (ma anche il voto americano per Trump, l’esito del referendum inglese sulla Brexit e il trionfo elettorale dei “populisti” italiani). Nelle pagine seguenti descriverò sinteticamente le argomentazioni dell’autore, riservandomi di commentarle nelle righe conclusive.
In primo luogo, Guilluy critica la rappresentazione dei conflitti che da qualche anno dilaniano le maggiori società occidentali in termini di antagonismo fra popolo ed élite, alto e basso, super ricchi e gente comune (l’1% contro il 99%, secondo lo slogan lanciato da Occupy Wall Street e ampiamente ripreso da populismi di destra e di sinistra). Se le cose stessero davvero così, argomenta Guilluy, le élite sarebbero già state spazzate via, la verità è che, se sono ancora al potere, non è solo perché possono contare sulla loro tradizionale egemonia culturale, ma perché i loro interessi coincidono con quelli di un buon terzo della popolazione.
Leggi tutto
Massimiliano Tomba: La bestia è l’azienda, non il fatto che abbia un padrone
‘La bestia è l’azienda, non il fatto che abbia un padrone’*
Commento al quinto capitolo del Capitale
di Massimiliano Tomba**
Abstract: The first chapter of the third section of Capital, Volume 1, constitutes in many ways an Archimedean point of the entire work. In this chapter the many theoretical questions investigated in the first section are reconfigured from the perspective of the labor-process and valorization-process, acquiring a new political color. In my reconstruction, by putting the use-value at the center, I explore the diverse theoretical layers of this chapter in light of their political implication
 È opportuno partire dall’inizio. E quindi,
ancora una volta, dalla
merce e dal valore. Non però nella formulazione che troviamo
nell’incipit del Capitale, ma dalle Glosse
a
Wagner del 1882, dove incontriamo un Marx maturo, che
ha attraversato per intero il suo personale work in
progress sulla nozione di
«valore». In queste glosse, Marx afferma, contro Wagner, che
nel Capitale non è partito da concetti e neppure dal
concetto
di «valore», e che non procede deduttivamente da un concetto
all’altro, ma è partito dalla merce nella sua concretezza
(Konkretum der Ware)[1]. Purtroppo
questa pagina non è stata tradotta nell’edizione degli scritti
inediti di Marx curata da Tronti,
perché Tronti nelle Glosse fa un po’ di selezione e
la salta. Ma qui Marx afferma una cosa importante: «Io non ho
preso le
mosse da concetti ma dalla merce nella sua concretezza». Credo
che questa affermazione permetta alcune riflessione sulla sua
natura non
hegeliana e sul modo di argomentazione e di esposizione di
Marx nel Capitale. Cosa significhi l’espressione
«merce nella sua
concretezza»? Significa un’accentuazione del valore d’uso
della merce, un modo di procedere nettamente diverso da quello
hegeliano,
nonostante gli svariati tentativi di leggere i primi capitoli
del Capitale assieme alla Scienza della Logica
di Hegel. Si potrebbe
dire, per usare un termine di Adorno, che Marx privilegia il
«rudimento metalogico» del concetto o, in altre parole, invece
di prendere le
mosse dall’‘essere’, come fa Hegel per mettere in moto la
prima triade di essere-nulla-divenire, Marx parte dal qualcosa
(etwas) nella sua concretezza. In questo «rudimento
metalogico» c’è un’insistenza sul non identico come
ciò che eccede la concettualizzazione e la sua sussunzione
all’identico, nel caso della merce, il valore. La differenza,
per dirla in
gergo filosofico, è che se nella Scienza della Logica
Hegel parte dall’immediatamente indeterminato, da ciò che è
privo di ogni determinazione, e questo permette ad Hegel di
dare inizio alla catena deduttiva, Marx ha un incipit
contrario: prende le mosse
dalla concretezza della merce, da ciò che, nella sua non
identità, si presenta come eccedenza rispetto al concetto.
È opportuno partire dall’inizio. E quindi,
ancora una volta, dalla
merce e dal valore. Non però nella formulazione che troviamo
nell’incipit del Capitale, ma dalle Glosse
a
Wagner del 1882, dove incontriamo un Marx maturo, che
ha attraversato per intero il suo personale work in
progress sulla nozione di
«valore». In queste glosse, Marx afferma, contro Wagner, che
nel Capitale non è partito da concetti e neppure dal
concetto
di «valore», e che non procede deduttivamente da un concetto
all’altro, ma è partito dalla merce nella sua concretezza
(Konkretum der Ware)[1]. Purtroppo
questa pagina non è stata tradotta nell’edizione degli scritti
inediti di Marx curata da Tronti,
perché Tronti nelle Glosse fa un po’ di selezione e
la salta. Ma qui Marx afferma una cosa importante: «Io non ho
preso le
mosse da concetti ma dalla merce nella sua concretezza». Credo
che questa affermazione permetta alcune riflessione sulla sua
natura non
hegeliana e sul modo di argomentazione e di esposizione di
Marx nel Capitale. Cosa significhi l’espressione
«merce nella sua
concretezza»? Significa un’accentuazione del valore d’uso
della merce, un modo di procedere nettamente diverso da quello
hegeliano,
nonostante gli svariati tentativi di leggere i primi capitoli
del Capitale assieme alla Scienza della Logica
di Hegel. Si potrebbe
dire, per usare un termine di Adorno, che Marx privilegia il
«rudimento metalogico» del concetto o, in altre parole, invece
di prendere le
mosse dall’‘essere’, come fa Hegel per mettere in moto la
prima triade di essere-nulla-divenire, Marx parte dal qualcosa
(etwas) nella sua concretezza. In questo «rudimento
metalogico» c’è un’insistenza sul non identico come
ciò che eccede la concettualizzazione e la sua sussunzione
all’identico, nel caso della merce, il valore. La differenza,
per dirla in
gergo filosofico, è che se nella Scienza della Logica
Hegel parte dall’immediatamente indeterminato, da ciò che è
privo di ogni determinazione, e questo permette ad Hegel di
dare inizio alla catena deduttiva, Marx ha un incipit
contrario: prende le mosse
dalla concretezza della merce, da ciò che, nella sua non
identità, si presenta come eccedenza rispetto al concetto.
Leggi tutto
Manolo Monereo: La grande crisi di Podemos
La grande crisi di Podemos
Cuarto Poder intervista Manolo Monereo
In questa intervista del 4 febbraio a Cuarto Poder Manolo Monereo — di recente dimessosi dalla direzione nazionale di PODEMOS — ci parla della crisi profonda che viveil movimento. La recente sconfitta elettorale in Andalusia, la mossa scissionista di Íñigo Errejón, lo scollamento tra base e vertice, la debolezza organizzativa e un certo burocratismo nel regime interno... Tutti fattori che per Monereo spiegano questa crisi, non senza dimenticare, aggiungiamo noi, l'appoggio esterno che UNIDOS PODEMOS (la coalizione tra Podemos e Izquierda Unida) continua a fornire al governo Sanchez, malgrado questo sia ligio non solo alle direttive europee ma pure a quelle di Trump
 D. La scorsa settimana non hai partecipato al
Consiglio Cittadino di Statale (CCE)
[la direzione politica nazionale di PODEMOS, ndt] che
si è svolto per risolvere il problema della crisi aperta a
Podemos nella
Comunità di Madrid. [In vista delle elezioni
amministrative della capitale del prossimo maggio Íñigo
Errejón, in
dissenso con Pablo Iglesias e rompendo de facto con
PODEMOS, ha dichiarato di sostenere la lista "Más Madrid"
dell'attuale
sindaca Manuela Carmena, ndt].
D. La scorsa settimana non hai partecipato al
Consiglio Cittadino di Statale (CCE)
[la direzione politica nazionale di PODEMOS, ndt] che
si è svolto per risolvere il problema della crisi aperta a
Podemos nella
Comunità di Madrid. [In vista delle elezioni
amministrative della capitale del prossimo maggio Íñigo
Errejón, in
dissenso con Pablo Iglesias e rompendo de facto con
PODEMOS, ha dichiarato di sostenere la lista "Más Madrid"
dell'attuale
sindaca Manuela Carmena, ndt].
R. Non ho partecipato perché mi sono dimesso mesi fa. Mi sono dimesso perché sapevo che i metodi sbagliati e le modalità di organizzazione dei dibattiti hanno sempre serie conseguenze. Nella mia vita politica ho imparato una cosa, le crisi reali sono causate, più che da fattori ideologici o di programma, dai metodi e dagli stili del lavoro di partito. PODEMOS ha uno stile di lavoro che non è all'altezza delle sue sfide. Per dirla senza mezzi termini, a Vistalegre II [il secondo congresso di PODEMOS, del febbraio 2017, ndt] abbiamo posto fine alle frazioni, non che una di esse si mangiasse tutte le altre. Ciò si ottiene generando organicità, creando organismi di dibattito politico, adottando regole chiare affinché questo possa svolgersi, approfondendo il dibattito. Questo non è il metodoche viene utilizzato in PODEMOS e ciò ha delle conseguenze.
Faccio un esempio. In generale, il CCE si riunisce e il segretario generale compie una brillante analisi politica, parla per tutto il tempo che ritiene necessario e poi ci concede tre minuti per intervenire. Nessuno sa cosa sia stato approvato, è come se fossimo una ONG in cui il direttore fa una buona analisi di ciò che accade, ma poi non ci sono verbali, documenti o risoluzioni politiche. È un dibattito che non genera impegni. Il funzionamento dell'organismo è pregiudicato e non vi è alcun dibattito politico.
La politica è dibattuta nelle frazioni e nei media. Non esiste una deliberazione democratica da cui emergano consenso e dissenso, maggioranze e minoranze. Non si vota.
Leggi tutto
Michele Castaldo: I comunisti e il colonialismo di ritorno
![]()
I comunisti e il colonialismo di ritorno
di Michele Castaldo
Uno degli aspetti più complicati di questa fase storica è costituito dal passaggio difase del moto- modo di produzione capitalistico.
La questione posta all’ordine del giorno riguarda il Venezuela e le mire fameliche dei paesi occidentali in crisi. Questi minacciano un intervento dall’esterno per aiutare la formazione di un governo che dovrebbe favorire i padroni del mondo (così essi si ritengono) nella gestione delle materie prime a prezzi a lor signori convenienti. In nome della rapina petrolifera? No, in nome – manco a dirlo – della democrazia.
La differenza tra il vecchio colonialismo e quello odierno è piuttosto consistente, perché il vecchio si collocava in una fase espansiva e “radiosa” del modo di produzione capitalistico, mentre quello odierno è espressione di una crisi di sistema di tutto il movimento storico del modo di produzione capitalistico. Famelici e briganti furono prima, famelici, briganti e guerrafondai sono quelli moderni. Non cogliere però la differenza ci aliena la possibilità di una riflessione nei confronti delle nuove generazioni.
Per il caso in questione ci vorrebbe ben altro che poche note, ma se si vuole capire potrebbero anche bastare. Veniamo perciò al dunque senza troppi giri di parole.
Leggi tutto
Francesco Ciafaloni: Il mutualismo e lo stato
![]()
Il mutualismo e lo stato
di Francesco Ciafaloni
Il mutualismo e i servizi forniti dallo stato come diritti non sono in conflitto tra loro ma complementari. Anzi l’iniziativa personale e l’aiuto reciproco sono indispensabili al funzionamento di uno stato sociale universalistico. Lo dicono la Costituzione e le leggi; ed accade nella realtà. Si tratta di una realtà faticosamente costruita, ora sotto attacco, in pericolo, ma non di utopie o formalismi giuridici. Gli abusi, le disfunzioni frequenti, l’uso dello stato come mangiatoia, non possono cancellare la necessità e la realtà dei servizi pubblici.
La Repubblica si fonda, prima che sulle strutture sociali elementari, sul lavoro dei cittadini (art.1 Cost.). Non è solo un principio: è la realtà di fatto. Una società non solo deve reggersi, ma di fatto si regge, sul lavoro, sull’impegno che mettiamo nel guadagnarci da vivere, nell’affrontare i problemi, nel riparare ciò che si rompe. Ci sono eccezioni: i ricchi, che possono non lavorare e pagare altri che lavorino per loro; ci sono gli invalidi, in tutti i sensi; ci sono i disoccupati involontari; ci sono i criminali, che tolgono ad altri invece di lavorare, ma di norma tutti cerchiamo di badare a noi stessi.
Subito dopo, all’articolo due, la Costituzione prevede il dovere di “solidarietà politica, economica e sociale”. Forme di solidarietà elementare tra compaesani, tra compagni, di mutuo aiuto, sono state e rimangono la base della convivenza.
Leggi tutto
Cinzia Arruzza: Il femminismo del 99% è l’alternativa anticapitalista al femminismo liberale
Il femminismo del 99% è l’alternativa anticapitalista al femminismo liberale
intervista a Cinzia Arruzza
La femminista italiana Cinzia Arruzza è professoressa presso la New School of Social Research di New York e autrice del libro “Le relazioni pericolose: matrimoni e divorzi tra marxismo e femminismo”. Ha sostenuto lo sciopero internazionale delle donne negli Stati Uniti ed ha appena terminato di scrivere un Manifesto per un femminismo del 99% insieme a Nancy Fraser e Tithi Bhattacharya, che verrà pubblicato in autunno. In questa intervista le abbiano rivolto domande sulla relazione tra capitalismo e patriarcato e tra genere e classe, alla luce della nuova onda femminista su scala internazionale.
Qual è l’obiettivo e qual'è la tesi principale contenuta nel Manifesto per un femminismo del 99%?
Il femminismo del 99% è l’alternativa anticapitalista al femminismo liberale che negli ultimi decenni, viste le scarse mobilitazioni ed il basso livello di lotte in tutto il mondo, era diventato egemonico. Con l’espressione femminismo liberale ci riferiamo ad un femminismo incentrato sulle libertà e sull’uguaglianza formale, che ricerca appunto l’eliminazione delle diseguaglianze di genere, ma con strumenti che sono accessibili solo alle donne che appartengono all’elite. Pensiamo ad esempio al tipo di femminismo incarnato da donne come Hillary Clinton o al femminismo che in Europa sta diventando un alleato di molti governi in tema di politiche islamofobe “in nome dei diritti delle donne”, come spiega Sara Farris in un suo recente libro (In the Name of Women′s Rights: The Rise of Femonationalism).
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Vi scrivo come nuovo presidente del Venezuela
Vi scrivo come nuovo presidente del Venezuela
di ilsimplicissimus
Oggi ho intenzione di buttarmi nell’arena: mi dichiaro ufficialmente legittimo presidente del Venezuela. Nessuno mi ha eletto a tale carica? Chissenefrega nemmeno Guaidò se è per quello. Nessuno mi conosce? Bé prima del golpe morbido dell’insignificante ometto al servizio del King Kong ossigenato della Casa Bianca, l’80 e passa per cento dei venezuelani non sapeva chi fosse questo Guaidò. E badate che le statistiche diffuse dai media provengono da rami locali di società americane, quindi ritoccati più che si può in favore di Washington. Con tali presupposti chiunque sul pianeta ad eccezione di Maduro, l’unico ad essere stato eletto a questa carica, può dichiararsi presidente ed essere “investito” della carica da Washington e dai sui servi europei: a un patto però, che in veste di presidente riconosciuto da tutti salvo che dal popolo che dovrebbe governare, autorizzi interventi militari stranieri o in seconda istanza faccia cadere davanti all’Onu la secolare questione dei confini della Guyana. Ci sarebbe da divertirsi se milioni di persone si dichiarassero presidenti del Venezuela, se non altro farebbero vergognare gli autori di questa drammatica farsa che tuttavia è perfettamente in linea con la spogliazione di sovranità dei popoli e l’autoritarismo delle decisioni calate dall’alto Siamo ormai un po’ tutti venezuelani.
D’altra parte gli americani hanno sempre più fretta di chiudere la partita col governo venezuelano e mettere un loro burattino a Caracas: ne va di 5 miliardi barili di petrolio e di alcuni triliardi di metri cubi di gas, tanto per cominciare.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2827
Hits 2011
Hits 1921
Hits 1915
Hits 1848
Hits 1841
Hits 1832
Hits 1817
Hits 1807
Hits 1707
tonino

Collettivo di fabbricato: Ritornare a Marx
Ritornare a Marx
di Collettivo di fabbricato
 Lo scritto che pubblichiamo qui
di seguito è intitolato Ritornare a Marx. È stato
recuperato scartabellando tra documenti, carte e libri
conservati alla
rinfusa e di cui avevamo quasi perso traccia. Strano destino
quello di questo testo, destinato più volte all’oblio, e che
invece continua
periodicamente a circolare. Vale la pena allora
ripercorrerne la genesi, visto che esso è il frutto
singolare di un’elaborazione
collettiva che, pur risalendo oramai a più di quindici anni
fa, mantiene intatta una certa originalità e una
significativa
attualità.
Lo scritto che pubblichiamo qui
di seguito è intitolato Ritornare a Marx. È stato
recuperato scartabellando tra documenti, carte e libri
conservati alla
rinfusa e di cui avevamo quasi perso traccia. Strano destino
quello di questo testo, destinato più volte all’oblio, e che
invece continua
periodicamente a circolare. Vale la pena allora
ripercorrerne la genesi, visto che esso è il frutto
singolare di un’elaborazione
collettiva che, pur risalendo oramai a più di quindici anni
fa, mantiene intatta una certa originalità e una
significativa
attualità.
Tra il 2001 e il 2003 un piccolo gruppo di attivisti e attiviste decide a Palermo di dedicarsi alla lettura e allo studio del primo libro de Il Capitale. Si dà pure un nome, Collettivo di fabbricato, evocando ironicamente la pellicola di Wolfgang Becker Good Bye Lenin: forse perché in quel gruppo c’era qualcuno particolarmente affezionato alla Berlino dei tempi andati, o forse perché già allora la vittoria del capitalismo suscitava quel sentimento, un misto di rabbia e rassegnazione che, dopo l’annessione della DDR, l’Anschluss, è stato definito Ostalgie.
Il Collettivo di fabbricato si proponeva di affiancare lo studio e l’elaborazione teorica all’impegno militante, coniugando, per così dire, teoria e prassi. Al contempo costituiva uno spazio di elaborazione teorica al di fuori dei tradizionali circuiti culturali accademici e dell’establishment, anche quello di sinistra.Anzi, la sua stessa esistenza si configurava implicitamente come una critica, radicale e spietata, a quei luoghi dell’elaborazione del sapere, in primis l’università, che già allora manifestavano quei segni di imbalsamata sclerosi e mummificata inutilità e immobilismo oggigiorno diventati scandalosamente evidenti.
Il collettivo si riuniva ogni due settimane nelle case dei vari componenti, si discuteva un capitolo alla volta, periodicamente ci si dedicava alla lettura di testi critici, e di volta in volta si decideva come proseguire. Quella dei seminari autogestiti era una pratica che era già stata abbondantemente sperimentata negli anni ’90 nella Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo, a partire dal movimento della Pantera.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Dardot e Laval, “La nuova ragione del mondo”
Dardot e Laval, “La nuova ragione del mondo”
di Alessandro Visalli
 Il libro del 2009 di Pierre Dardot e
Christian
Laval reca come sottotitolo “Critica della razionalità
neoliberista”, e svolge in quasi cinquecento pagine una
lunga e
meditata ricostruzione della genealogia dello sviluppo del
neoliberismo nelle sue varie e diverse correnti. Si tratta di
un libro che utilizza e
riprende espressamente la lettura che Michel Foucault fece,
nei suoi ultimi, anni del neoliberismo[1] e della sua
forma di ragione[2].
Il libro del 2009 di Pierre Dardot e
Christian
Laval reca come sottotitolo “Critica della razionalità
neoliberista”, e svolge in quasi cinquecento pagine una
lunga e
meditata ricostruzione della genealogia dello sviluppo del
neoliberismo nelle sue varie e diverse correnti. Si tratta di
un libro che utilizza e
riprende espressamente la lettura che Michel Foucault fece,
nei suoi ultimi, anni del neoliberismo[1] e della sua
forma di ragione[2].
Il neoliberismo riletto da Dardot e Laval è un pensiero dell’adattamento, sottilmente invertebrato, capace di pervadere ogni cosa e soprattutto produttore di nuove soggettività. Al contrario di quanto normalmente si pensa per gli autori esso non è, come il liberalismo classico, ostile alle regolamentazioni, ma è il creatore di vere e proprie strutture nelle quali l’uomo diventa una particolare (ed ‘inumana’) macchina per la competizione e per il desiderio. L’uomo neoliberale esiste solo in un universo di competizione, e si pensa come auto-governato, e quindi integralmente autonomo. Il tentativo che compie la pratica neoliberale è, in altre parole, di governare l’uomo attraverso se stesso, non contro la sua libertà, ma per mezzo di essa; di convincerlo a conformarsi autonomamente al sistema di norme idoneo alla competizione che esso stesso determina.
Ma tutto questo, bisogna notare, per gli autori, come per il loro maestro, non è un progetto di qualche macrosoggetto, sia esso una classe o un gruppo; non è disceso da un corpo dottrinario pronto, anche se molti vi hanno lavorato per anni. Esso “si è costituito lungo il filo di battaglie incerte e politiche claudicanti” (p.15). Dunque la società neoliberista, non è neppure il risultato della logica del capitale, o di uno o più rapporti di produzione, Dardot e Laval, che non sono marxisti, pensano che tutto ciò derivi sì dagli effetti della crisi degli anni settanta, ma che questa non sia principalmente economica. Pensano che, cioè, non sia questione di difficoltà di accumulazione, come ad esempio sostiene David Harvey contro il quale polemizzano, bensì sia una questione dell’emergere di un deficit di governamentalità[3].
Leggi tutto
Johnathan Cook: Un'élite liberale europea ci attira ancora verso l'abisso
Un'élite liberale europea ci attira ancora verso l'abisso
di Johnathan Cook [globalresearch.ca]
 Un gruppo
di 30 rispettati intellettuali, scrittori e storici ha
pubblicato un manifesto
lamentando l'imminente collasso dell'Europa e dei suoi
presunti valori illuministici di liberalismo e razionalismo.
L'idea di Europa, avvertono, "sta
cadendo a pezzi davanti ai nostri occhi", mentre la Gran
Bretagna si prepara alla Brexit e i partiti "populisti e
nazionalisti" sembrano pronti a
incassare ampi successi nelle elezioni in tutto il continente.
Un gruppo
di 30 rispettati intellettuali, scrittori e storici ha
pubblicato un manifesto
lamentando l'imminente collasso dell'Europa e dei suoi
presunti valori illuministici di liberalismo e razionalismo.
L'idea di Europa, avvertono, "sta
cadendo a pezzi davanti ai nostri occhi", mentre la Gran
Bretagna si prepara alla Brexit e i partiti "populisti e
nazionalisti" sembrano pronti a
incassare ampi successi nelle elezioni in tutto il continente.
Il breve manifesto è stato pubblicato nelle riviste europee dell'élite liberale, in giornali come The Guardian.
"Dobbiamo ora combattere per l'idea di Europa o perire sotto le ondate del populismo", si legge nel documento. Fallire significa che "il risentimento, l'odio e una pletora di infelici passioni ci circonderanno e sommergeranno".
A meno che non si possa cambiare la situazione, le elezioni in tutta l'Unione europea saranno "le più calamitose che abbiamo mai conosciuto: una vittoria per i sabotatori, la disgrazia per coloro che credono ancora nell'eredità di Erasmo, Dante, Goethe e Comenius; il disprezzo per l'intelligenza e la cultura; esplosioni di xenofobia e antisemitismo ovunque; il disastro".
Il manifesto è stato scritto da Bernard-Henri Levy, il filosofo francese devoto ad Alexis de Tocqueville, un teorico del liberalismo classico. Tra i firmatari figurano i romanzieri Ian McEwan, Milan Kundera e Salman Rushdie, lo storico Simon Shama e i premi Nobel come Svetlana Alexievitch, Herta Müller, Orhan Pamuk e Elfriede Jelinek.
Sebbene non nominati, i loro eroi politici europei sembrano essere l'Emmanuel Macron di Francia, attualmente impegnato nel tentativo di schiacciare le proteste popolari contro l'austerità dei Gilet gialli e la cancelliera tedesca Angela Merkel, a presidio delle barricate per l'élite liberale contro una rinascita dei nazionalisti in Germania.
Leggi tutto
Angelo d’Orsi: La questione foibe e la verità di Stato
La questione foibe e la verità di Stato
di Angelo d’Orsi
Ho voluto attendere che il 10 febbraio fosse alle nostre spalle, prima di scriverne. Sapevo ovviamente che la “questione foibe” sarebbe ritornata puntualmente, come ogni anno, all’onore (o meglio al disonore) delle cronache. Sapevo che come per il Venezuela, come per il Tav (solo per fare due esempi), si sarebbe verificato il bombardamento mediatico-politico, e le tifoserie si sarebbero eccitate, scendendo in campo, ma a differenza di questi due esempi, in cui comunque i due campi hanno la possibilità di esprimersi, sia pure con uno dei due svantaggiato dalla schiacciante forza del mainstream, per “le foibe” la sproporzione è immensa: si tratta di un’autentica “guerra ineguale”.
La narrazione delle foibe, mendace e infondata, anticomunista “a prescindere”, è divenuta, in quest’anno di grazia 2019, verità di Stato, con tanto di sanzioni per coloro che se ne distacchino. La situazione è stata aggravata dalla convergenza tra opinionisti (che di regola non sanno nulla di ciò su cui opinano) e politici (i quali prescindono completamente dalla verità). E a dispetto dei risultati della ricerca storica seria, che ha certificato qualche centinaio di infoibati, spesso semplicemente cadaveri (vittime “naturali” della guerra, ma anche persone giustiziate) che sono stati gettati in quelle cavità per ragioni di “praticità” in tempi difficili, dove non c’era spesso modo né tempo di dare degna sepoltura ai morti.
Leggi tutto
Francesco Raparelli: Avicenna e la sinistra aristotelica di Ernst Bloch
Avicenna e la sinistra aristotelica di Ernst Bloch
recensione di Francesco Raparelli
La materia e la forma. Che poi è un altro modo per dire corpo e anima. Con l’anima, la parte attiva, dinamica, e il corpo che passivamente subisce la volontà dell’anima. In questo dualismo, così classico da sembrare intoccabile, c’è una civiltà, un rapporto tra i sessi, lo sfruttamento di chi lavora, la distruzione della natura. Contro questo dualismo, che è anche e soprattutto religioso, da sempre si batte il materialismo, secondo cui la materia è eterna, le cose singole sono solo modificazioni di questa materia, corpo e mente non sono distinti e di certo la mente (attiva) non comanda il corpo (semplicemente passivo). Conosciamo i grandi riferimenti dell’antichità di questa corrente, con i loro libri bruciati dai cristiani o scomparsi: Democrito, Epicuro, ovviamente Lucrezio e il De rerum natura. Ernst Bloch, nel suo lavoro in generale e più in particolare nel suo Avicenna e la sinistra aristotelica (Mimesis edizioni, 2018), propone un’altra genealogia: quella araba.
Nel mezzo del medioevo orientale, Bloch individua un “Illuminismo” giunto assai prima di quello francese ed europeo. I filosofi che lo animano, in testa Avicenna (Ibn Sīnā, ca. 980-1037), sono “medici prima che monaci, naturalisti prima che teologi”. Tra loro splende Averroè (Ibn Rushd, 1126-1198), e a loro dobbiamo la traduzione e il commento delle grandi opere aristoteliche – che altrimenti, in buona parte, sarebbero andate perdute.
Leggi tutto
Luca Picotti: “Tornare alla crescita” di Pierluigi Ciocca
“Tornare alla crescita” di Pierluigi Ciocca
di Luca Picotti
Recensione a: Pierluigi Ciocca, Tornare alla crescita. Perché l’economia italiana è in crisi e cosa fare per rifondarla, Donzelli Editore, Roma 2018, pagine 224, 19 euro (scheda libro)
I presupposti, geografici e politici, che stanno alla base della struttura economica italiana sono la carenza di risorse naturali, l’alta densità della popolazione e la frammentazione sia orografica che politica, con mercati spesso segmentati e poco interconnessi a causa del deficit infrastrutturale.
Nonostante questi limiti intrinseci di ordine sistemico, la storia economica dell’Italia unita presenta successi di enorme rilievo: nei 150 anni dall’Unità il PIL pro capite è aumentato di 13 volte, contro una media dell’Europa occidentale di 10; nel 1861 la speranza di vita alla nascita era di 30 anni, oggi gli italiani sono tra i più longevi al mondo con una speranza di vita che va ben oltre gli 80 anni; lo Human Development Index, un indice compreso tra lo 0 e l’1 che comprende reddito, salute e istruzione, è passato dallo 0,19 del 1870 allo 0,94 di oggi.
In particolare, vi sono stati due periodi di grande accelerazione e sviluppo, caratterizzati da dinamismo imprenditoriale, apertura internazionale, incrementi di produttività e da salari in ascesa: l’età giolittiana (1900-1913) e gli anni del cosiddetto miracolo economico (1950-1969). L’opposto è accaduto in tre fasi, l’età di Crispi, quella di Mussolini e gli ultimi venticinque anni.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Corrotti, corruttori e corruttibili
![]()
Corrotti, corruttori e corruttibili
Resistenze di sabbia
di Mauro Armanino
Niamey, 9 febbraio 2019. Ci risiamo. Nell’indice sulla percezione della corruzione del 2018, pubblicato qualche giorno fa da Transparency International, ci troviamo al numero 114 su 180 iscritti. Due punti persi rispetto all’anno precedente quando abitavamo la casella numero 112. Inezie se paragonati alla Somalia, prima in ordine inverso, o altri Paesi in via di corruzione. Quanto all’Italia, pur facendo parte del continente ‘meno corrotto’ secondo la stessa agenzia, è classificata comunque tra i 13 Paei più corrotti dell’Europa. Ad ognuno le sue corruzioni. Qui da noi anch’esse sono di sabbia, si spostano a piacimento dalla polizia alla dogana e hanno tendenza ad accumularsi nella politica. Nulla di nuovo insomma, sotto il sole del Sahel e di quello che splende altrove. I grandi corrotti non cercateli qui. La stessa Transparency è figlia del sistema che la genera. Cercateli invece tra gli azionisti delle banche, nelle direzioni delle multinazionali e in coloro che, in tutta impunità, orientano le grandi scelte politiche del sistema-mondo. Sono ben vestiti, hanno uno stile di vita incompatibile con gli altri umani e per certo hanno le mani pulite. Sono loro i grandi corruttori che viaggiano in tutta impunità.
Quelli di cui si parla nei rapporti sulla Trasparenza sono i piccoli corrotti, quelli che, per intenderci, usano le carriole o alle dogane fanno la cresta sui documenti e le merci. Pesci piccoli che poi nelle foto di propaganda appaiono con soldi da mano a mano, Euro o franchi CFA come va di moda da queste parti.
Leggi tutto
Costas Lapavitsas: Il Socialismo comincia a casa propria
Il Socialismo comincia a casa propria
Intervista a Costas Lapavitsas
 Costas
Lapavitsas – Il libro è ovviamente una critica all’UE così
com’è. È una valutazione di dove si trova l’Unione, di ciò
che è diventata e della sua probabile direzione.
È un tentativo di affermare che la sinistra non dovrebbe
avere nulla a che fare con la difesa di questo insieme di
istituzioni. Dovrebbe
assumere una posizione critica e respingente. Sto affermando
che questo è l’unico modo per sviluppare una politica
radicale in Europa, un
programma economico e sociale radicale e internazionalista.
Costas
Lapavitsas – Il libro è ovviamente una critica all’UE così
com’è. È una valutazione di dove si trova l’Unione, di ciò
che è diventata e della sua probabile direzione.
È un tentativo di affermare che la sinistra non dovrebbe
avere nulla a che fare con la difesa di questo insieme di
istituzioni. Dovrebbe
assumere una posizione critica e respingente. Sto affermando
che questo è l’unico modo per sviluppare una politica
radicale in Europa, un
programma economico e sociale radicale e internazionalista.
* * * *
Michael Calderbank – Il ritorno più ovvio sarebbe che le forze che minacciano di fare a pezzi l’UE – i populisti in Italia, o l’AfD in Germania – che sono anti-immigrati, di destra, se l’UE si disintegra, saranno quelle che ne trarranno benefici. Come risponderesti a questo?
Lasciatemi dire sin dall’inizio che, naturalmente, non dovremmo avere nulla a che fare con queste forze reazionarie e razziste. Dovremmo opporci a tutti loro. Ma per capire perché sono diventati così potenti e per capire cosa dovremmo fare, dobbiamo iniziare con la stessa UE. L’emergere di queste forze non è casuale. Ha a che fare con ciò che l’UE è diventata. Solo partendo da questa prospettiva possiamo capire cosa dovrebbe fare la sinistra.
Allora perché l’estrema destra è così potente e l’UE in questo stato? La prima cosa da osservare è che l’UE affronta una crisi esistenziale diversa da qualsiasi altra nel passato. Ha a che fare con ciò che è, cosa fa e quali interessi serve. È una crisi che è il risultato della profonda trasformazione da Maastricht in poi.
Maastricht è stato un momento chiave. Quello che è successo è che l’UE è emersa come un difensore intransigente del capitale contro il lavoro, un promotore del neoliberismo, con una serie molto rigida di meccanismi che si fa strada come bulldozer spianando ogni tipo di opposizione.
Leggi tutto
Simone Fana e Lorenzo Zamponi: Pietro Ichino e l’idea corporativa del sindacato
Pietro Ichino e l’idea corporativa del sindacato
di Simone Fana e Lorenzo Zamponi
In una lettera al nuovo segretario della Cgil, l'ex senatore del Pd propone un'unità nazionale corporativa per la competitività globale. Una faccia nazionalista del neoliberismo che nega l'antagonismo tra lavoratori e imprenditori
 Pochi
giorni dopo l’elezione di Maurizio Landini a segretario
generale della
Cgil, l’ex senatore del Partito Democratico Pietro Ichino gli
ha rivolto una lettera aperta, sul sito
economico
LaVoce.info. Il tema evocato da Ichino è quello dell’unità
sindacale, citata da Landini nelle conclusioni al
congresso. Ma si
tratta di un pretesto per chiarire al nuovo segretario
generale che l’establishment liberal italiano non
gli perdona il recente passato
battagliero, e lo aspetta al varco, invitandolo pacatamente e
serenamente a omologarsi a un’idea di sindacato pacificato e
addomesticato.
Secondo l’ex senatore, «la Cgil ha bisogno di una correzione»
e la lettera ne indica la direzione: un nuovo corporativismo
aggiornato all’epoca della globalizzazione, in cui qualsiasi
conflitto tra capitale e lavoro è rimosso in nome della
competitività
dell’Italia nel mercato internazionale, e l’interesse dei
lavoratori dev’essere sacrificato all’interesse nazionale, che
coincide con quello delle imprese. Un corto circuito solo
apparentemente paradossale, quello tra neoliberismo globale e
corporativismo nazionalista:
la logica della competitività serve proprio a questo, a
schiacciare gli interessi di classe in nome del supremo
interesse nazionale ad attrarre
capitali livellando verso il basso i diritti dei lavoratori.
Pochi
giorni dopo l’elezione di Maurizio Landini a segretario
generale della
Cgil, l’ex senatore del Partito Democratico Pietro Ichino gli
ha rivolto una lettera aperta, sul sito
economico
LaVoce.info. Il tema evocato da Ichino è quello dell’unità
sindacale, citata da Landini nelle conclusioni al
congresso. Ma si
tratta di un pretesto per chiarire al nuovo segretario
generale che l’establishment liberal italiano non
gli perdona il recente passato
battagliero, e lo aspetta al varco, invitandolo pacatamente e
serenamente a omologarsi a un’idea di sindacato pacificato e
addomesticato.
Secondo l’ex senatore, «la Cgil ha bisogno di una correzione»
e la lettera ne indica la direzione: un nuovo corporativismo
aggiornato all’epoca della globalizzazione, in cui qualsiasi
conflitto tra capitale e lavoro è rimosso in nome della
competitività
dell’Italia nel mercato internazionale, e l’interesse dei
lavoratori dev’essere sacrificato all’interesse nazionale, che
coincide con quello delle imprese. Un corto circuito solo
apparentemente paradossale, quello tra neoliberismo globale e
corporativismo nazionalista:
la logica della competitività serve proprio a questo, a
schiacciare gli interessi di classe in nome del supremo
interesse nazionale ad attrarre
capitali livellando verso il basso i diritti dei lavoratori.
Un sindacato da “correggere”
La lettera di Ichino inizia fondamentalmente chiedendo a Landini di cospargersi il capo di cenere per le battaglie portate avanti negli 8 anni passati alla guida della Fiom. Il primo consiglio è quello di lasciar perdere qualsiasi velleità di confronto con la politica, dedicandosi solo alla contrattazione in senso stretto.
Leggi tutto
Lars T. Lih: ‘Tutto il potere ai Soviet!’, parte quinta
‘Tutto il potere ai Soviet!’, parte quinta
‘Una questione fondamentale’: le glosse di Lenin alle Tesi di aprile
di Lars T. Lih
Si veda anche, in calce a questo stesso post, l’appendice ‘Lenin respinge un travisamento delle Tesi di aprile’
 Nell’aprile del 1917 Lenin
sfornava articoli per la Pravda con una cadenza
sbalorditiva. Uno di questi
articoli, “Una questione fondamentale”, venne scritto il 20
aprile e pubblicato il giorno seguente. Un testo che
successivamente avrebbe
trovato il proprio posto nelle Opere complete di Lenin, dov’è
oggi facilmente reperibile. Non si tratta in alcun modo di un
documento
misconosciuto o da riportare alla luce – e tuttavia, nel
contesto di un nuovo sguardo agli eventi della primavera 1917,
“Una questione
fondamentale” appare come un documento notevole e rivelatore.
Pertanto, l’ho ritradotto di recente e ho provveduto a
fornirne un
commento.
Nell’aprile del 1917 Lenin
sfornava articoli per la Pravda con una cadenza
sbalorditiva. Uno di questi
articoli, “Una questione fondamentale”, venne scritto il 20
aprile e pubblicato il giorno seguente. Un testo che
successivamente avrebbe
trovato il proprio posto nelle Opere complete di Lenin, dov’è
oggi facilmente reperibile. Non si tratta in alcun modo di un
documento
misconosciuto o da riportare alla luce – e tuttavia, nel
contesto di un nuovo sguardo agli eventi della primavera 1917,
“Una questione
fondamentale” appare come un documento notevole e rivelatore.
Pertanto, l’ho ritradotto di recente e ho provveduto a
fornirne un
commento.
Ufficialmente, questo articolo costituiva una controreplica a una critica delle Tesi di aprile, ad opera di Georgy Plekhanov, pubblicata il 20 aprile (una traduzione dell’articolo di Plekhanov si può trovare in appendice). In realtà, Lenin era meno interessato a confutare Plekhanov che a rassicurare i praktiki bolscevichi (gli attivisti di medio livello che compivano il lavoro pratico del partito). Sergei Bagdatev era appunto un praktik bolscevico, nonché un ardente sostenitore del potere al soviet; nella parte quarta di questa serie di post, abbiamo visto come egli esprimesse il timore che alcuni aspetti delle Tesi di Lenin potessero ostacolare la via all’instaurazione del potere del soviet. La sua preoccupazione di fondo riguardava le basi di classe della rivoluzione in corso: Lenin stava davvero affermando che non erano necessari i contadini come alleati, come sottinteso dalle Tesi di aprile e da svariati altri commenti? In “Una questione fondamentale”, Lenin rispondeva con enfasi a tale preoccupazione: no, non era ciò che intendeva, non lo era nel modo più assoluto.
Plekhanov sui ‘deliri’ di Lenin
Negli anni Ottanta dell’Ottocento, Plekhanov fu un pioniere nella divulgazione del messaggio di Marx, nonché nella sua applicazione alle condizioni della Russia, guadagnandosi in tal modo l’appellativo di “padre del marxismo russo”. Da allora, giocò sempre un ruolo significativo nella socialdemocrazia russa, sebbene spesso ben lontano dall’essere costruttivo.
Leggi tutto
Marco Cedolin: Una pietra tombale sul TAV
Una pietra tombale sul TAV
di Marco Cedolin
Finalmente dopo oltre 20 anni di slogan da bar dello sport, parole esperite a vanvera, menzogne senza ritegno vendute un tanto al chilo al mercato delle marchette da giornalista chic, per la prima volta si parla con serietà del TAV Torino – Lione e lo si fa sulla base della prima seria analisi costi – benefici riguardante l'opera, portata avanti da una commissione di esperti indipendenti e non di qualche grottesca analisi pilotata, costruita ad arte (neppure troppo bene) da un gruppo di dipendenti della consorteria che il TAV lo voleva costruire ad ogni costo, perché portava miliardi nelle loro tasche....
Come avrebbe potuto facilmente immaginare chiunque avesse studiato anche solo superficialmente la questione, l'analisi resa pubblica oggi dal Mit ad opera di una commissione capitanata dall'architetto Marco Ponti (non certo un NO TAV ma un esperto di trasporti di fama mondiale che ha un curriculum da fare impallidire la maggior parte dei suoi colleghi e si è sempre dichiarato un liberista convinto) ha bocciato impietosamente l'opera dichiarando che i costi supererebbero i benefici per una cifra contabilizzata orientativamente fra i 5,7 e gli 8 miliardi di euro.
In parole povere il TAV (come in tanti abbiamo scritto per decine di anni in libri ed articoli) viene certificato come un'opera priva di senso, in grado di sperperare miliardi di denaro provenienti dalle tasche dei contribuenti, senza alcuna prospettiva di ottenere un ritorno economico dell'investimento.
Leggi tutto
Strategic Culture: L'Italia salva la dignità dell'Europa rispetto al bullismo USA sul Venezuela
L'Italia salva la dignità dell'Europa rispetto al bullismo USA sul Venezuela
di Strategic Culture
È comicamente ironico. La Francia ha richiamato il suo ambasciatore da Roma con una dichiarazione di presunta "ingerenza" dell'Italia negli affari politici interni francesi. Questo avviene mentre la Francia e altri stati europei si uniscono alla sfacciata campagna degli Stati Uniti per rovesciare il presidente eletto del Venezuela, Nicolas Maduro. L'ironia non può andare oltre.
La querelle tra Francia e Italia non è che l'ultima di una lunga sfida tra il presidente francese Emmanuel Macron e il neoeletto governo di coalizione a Roma. Il governo italiano è un'improbabile coalizione tra il movimento a cinque stelle - di sinistra – Movimento 5 stelle - e un partito di destra, La Lega.
Entrambe le parti sono molto critiche nei confronti della creazione dell'Unione europea e delle politiche capitaliste neoliberiste che l'ex banchiere Rothschild della Francia, diventato presidente Macron, incarna.
Roma ha anche criticato la Francia per le sue responsabilità nel fomentare enormi problemi di immigrazione per l'Europa e l'Italia, in particolare attraverso gli interventi militari criminali di Parigi, insieme con gli Stati Uniti e altre potenze della NATO, nel Medio Oriente e nel Nord Africa.
Leggi tutto
∫connessioni precarie: Il reddito che abbiamo e quello che ci manca: poche certezze e alcune domande
Il reddito che abbiamo e quello che ci manca: poche certezze e alcune domande
di ∫connessioni precarie
Il governo gialloverde ci ha dato il suo reddito e probabilmente è anche l’unico che poteva darci. Chi, anche in mezzo allo scontento del nostro movimento, ha coltivato aspettative diverse ha semplicemente dimenticato un vecchio suggerimento utile a chi voglia varcare senza problemi una porta aperta: tenere presente che gli stipiti sono duri. Lavoro comandato più tintinnio di manette e qualche centinaio di euro: ecco in breve la formula del reddito di cittadinanza italico. A parte le perversioni manettare di alcuni esponenti di questo governo, si tratta di una versione del reddito minimo in linea con la logica di fondo dell’Hartz IV tedesco, dell’RSA francese o del JSA britannico: «sostenere e pretendere», affinché il divano sia sempre troppo scomodo per restarci seduti. Il sostegno infatti è minimo, mentre le pretese sono tante e il reddito si rivela per quello che è: la forma neoliberale del governo di poveri e precari sulla soglia dell’indigenza, della loro mobilità e occupabilità. Che il reddito di cittadinanza concesso dal governo ne sia un’espressione particolarmente feroce lo hanno detto in molti e con valide argomentazioni. Non ci dilungheremo dunque in un’analisi delle singole misure coattive, disciplinanti, poliziesche o sull’impianto moralistico che sottende il decreto, per altro coerente con il rigurgito di sani valori «borghesi» che appesta l’aria di questo paese e non solo.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Integralismo economico e culto dell’astratto
![]()
Integralismo economico e culto dell’astratto
di Salvatore Bravo
Domenico Losurdo nel 1991 pubblica il testo La comunità la morte l’occidente Heidegger e l’«ideologia della guerra», è l’anno della fine dell’Unione sovietica, è il trionfo del liberismo, la storia da quel momento cambia ad oriente ed a occidente, si accelerano i processi di economicizzazione delle comunità. L’Unione sovietica con la sua presenza legittimava un mondo di valori altri rispetto all’americanismo mercatile e specialmente nell’occidente limitava, con la sua esistenza politica ed ideologica, l’esiziale avanzata del liberismo. Il testo del 1991 è profetico nelle sue intenzioni, con la fine dell’Unione sovietica ogni ideale internazionale politico ed antropologico scompare dall’orizzonte culturale. L’economicizzazione livellatrice avanza, i trattati europei si avvicendano, si viaggia in direzione euro, tutto avviene per opera di plutocrati, mentre i popoli senza punti di riferimento partitici ed ideologici assistono alle trasformazioni, spesso senza consapevolezza. L’integralismo economico è vincente, la globalizzazione inaugura un nuovo tipo di umanità dedita al valore di scambio a livello planetario, umanità astratta in quanto sradicata da ogni tradizione, da ogni storia, un essere umano senza volto con l’unico intento prometeico di dominare sui mercati. L’onnipotenza mercantile trascorso l’ottundimento iniziale, dei primi anni, comincia a mostrare le proprie contraddizioni.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2871
Hits 2084
Hits 2016
Hits 1976
Hits 1870
Hits 1863
Hits 1845
Hits 1840
Hits 1786
Hits 1742
tonino

Alessandro Barile: Sinistra e critica alla Ue: a che punto è la notte?
Sinistra e critica alla Ue: a che punto è la notte?
di Alessandro Barile
 «Senza teoria rivoluzionaria non può
esservi movimento rivoluzionario» Lenin
«Senza teoria rivoluzionaria non può
esservi movimento rivoluzionario» Lenin
«Un’oncia di azione vale quanto una tonnellata di teoria» Engels
Ormai giunti al 2019 possiamo trarre un parziale ma significativo bilancio sul rapporto tra la sinistra[1] e l’Unione europea. O meglio: tra la sinistra e la critica alla Ue. Una posizione, questa, che ha segnato una novità e una discontinuità nel discorso medio della sinistra italiana ed europea di questo decennio. Forse l’unica vera discontinuità concettuale che ha investito le posizioni politiche della sinistra da molti anni a questa parte. Nei fatti, il dibattito pubblico veicolato dal sistema politico-mediatico si concentra nei pressi proprio dell’Unione europea: sovranità politica o popolare, sovranismo, populismo, questione nazionale, lotta alla globalizzazione, crisi economica et similia. L’Unione europea è al centro di ogni frame discorsivo massmediatico che ci investe quotidianamente. Va però riconosciuto che siamo entrati in una fase diversa. Se negli anni attorno allo scoppio della crisi economica, e soprattutto – in Italia – nel periodo tra il 2009 e il 2012, andava introdotto a forza un pensiero critico che ponesse la Ue al centro delle riflessioni sistemiche, oggi questa critica si è assestata. Procede affinandosi, ovviamente, ma si è resa in qualche modo inaggirabile, al di là di come la si pensi sulla rottura o meno della costruzione europeista. Per essere più precisi: la critica alla Ue è andata sedimentando tre posizioni, espressioni di altrettante sinistre: da una parte la sinistra anti-Ue, che orienta la sua proposta politica attorno al tema della rottura coi vincoli europeisti; dall’altra, quella sinistra che, nonostante il posizionamento critico, persiste nel dichiararsi europeista, proponendosi al più di «cambiare dall’interno» il rigido regime liberista di Maastricht; c’è poi una sinistra che decide di posizionarsi fuori da questo schematismo, lasciando decisioni e ragionamenti in sospeso, evitando il confronto diretto con la questione europeista.
Leggi tutto
Alessandro Pascale: La guerra culturale in corso in Italia
La guerra culturale in corso in Italia
di Alessandro Pascale
 La guerra di cui si parla avviene
nel campo della riscrittura ufficiale della Storia. Quello che
Orwell aveva teorizzato in
1984 sta avvenendo in questo periodo storico in Italia.
La guerra di cui si parla avviene
nel campo della riscrittura ufficiale della Storia. Quello che
Orwell aveva teorizzato in
1984 sta avvenendo in questo periodo storico in Italia.
Mattarella non è il nostro presidente
Poco più di un mese fa Mattarella era osannato da tutti per il suo discorso democristiano di Capodanno. Nel giro di pochi giorni ha ricordato a tutti la sua vera natura, quella di un furbo squalo, servo della borghesia e dell'imperialismo.
“Bisogna difendere e preservare l'amicizia con la Francia”, dice Sergio Mattarella. Ed esprime tutta la sua inquietudine sulle tensioni diplomatiche in corso con Parigi, parlando di “grande preoccupazione per la situazione” e chiedendo di “ristabilire subito il clima di fiducia”. [1] Mattarella non ha alcun interesse a sostenere la polemica sul franco CFA, né si esprime sulle rivolte popolari dei gilets jaunes che mettono a ferro e fuoco il Paese da oltre due mesi. Per lui l'UE e i suoi equilibri vengono prima degli interessi dell'Italia. Lo ha mostrato peraltro in maniera molto chiara nel piccolo “golpe” del 27 maggio 2018, quando disse che gli interessi dei “risparmiatori” e degli “investitori internazionali” venivano prima dell'intero popolo italiano. [2]
Cosa ha detto invece sul Venezuela e su quel Guaidò autoproclamatosi presidente con l'appoggio di Washington e di Bruxelles? Sempre in polemica con la giusta linea “neutralista” del Governo (cosa di cui bisogna rendere merito al M5S), ha chiesto che l'Italia assumesse, con “senso di responsabilità e chiarezza”, una “linea condivisa con tutti gli alleati e i partner europei”. D'altronde ci tiene a ribadire che “non ci può essere incertezza né esitazione nella scelta tra la volontà popolare e la richiesta di autentica democrazia da un lato, e dall'altro la violenza della forza”. [3]
Certo: Caracas non è mica Parigi...
Leggi tutto
Claudio Conti: Il grandioso crollo dell’austerità europea
Il grandioso crollo dell’austerità europea
di Claudio Conti
A seguire un articolo di Guido Salerno Aletta da Milano Finanza
 Piovono conferme, non
avevamo capito male. Il “documento Altmaier” è la
dichiarazione di fallimento del modello economico che è
stato imposto con la forza alla Germania e a tutta l’Unione
Europea negli ultimi
venti anni. E l’annuncio, ancora imbarazzato e senza una
chiara strategia, di una inversione di rotta.
Piovono conferme, non
avevamo capito male. Il “documento Altmaier” è la
dichiarazione di fallimento del modello economico che è
stato imposto con la forza alla Germania e a tutta l’Unione
Europea negli ultimi
venti anni. E l’annuncio, ancora imbarazzato e senza una
chiara strategia, di una inversione di rotta.
Non basta infatti rendersi conto di aver sbagliato tutto, se l’universo concettuale con cui si ragiona è ancora quello che ha prodotto il disastro. Ne abbiamo una dimostrazione nel demenziale “dibattito politico” italiano, dominato da “esperti” che ripetono le antiche sciocchezze sull’austerità necessaria e i “soldi che non ci sono”, incaricati di combattere degli autentici idioti che sentono suonare le campane ma non sanno da dove (Lega e Cinque Stelle).
L’errore, infatti, non è dipeso da un cattivo uso della ragione, ma dalla assoluta prevalenza di interessi materiali: in specifico quella delle multinazionali dell’industria manifatturiera classica e della finanza speculativa. Un’accoppiata che ha impedito di affrontare sul serio le sfide dell’innovazione tecnologica (pur riempiendosene la bocca ad ogni cerimonia ufficiale), ha depresso violentemente il mercato interno europeo (il primo del mondo, quando ancora i salari non erano stati violentemente compressi), e soprattutto distrutto il sistema dell’istruzione (in Italia siamo arrivati addiritura a sentire ministri dire “con la cultura non si mangia”…).
La borghesia multinazionale europea, grazie al dominio della Germania, si è crogiolata nel vantaggio accumulato nei decenni precedenti (grazie a quel “modello sociale europeo” imposto dal conflitto sociale e dalla presenza dell’Urss), mentre gli Stati Uniti delocalizzavano la produzione e i giganti asiatici cominciavano appena a tirarsi fuori dal sottosviluppo.
Leggi tutto
Sergio Bologna: Von Banditen erschossen (su Mattarella e le foibe)
Von Banditen erschossen (su Mattarella e le foibe)
di Sergio Bologna
Come cittadino, come storico del nazismo e soprattutto come triestino sono rimasto sconcertato, amareggiato e disgustato dalle dichiarazioni del Presidente Mattarella sulla questione delle foibe.
Avevo otto anni quando i partigiani di Tito, il 1 maggio del 1945, proprio sotto casa mia fermarono la loro avanzata per non esporsi al tiro della guarnigione tedesca, asseragliata nel Castello di San Giusto. Erano scesi dall’altipiano del Carso in due colonne, una si era diretta all’edificio del Tribunale dove i tedeschi avevano installato il Comando e l’altra al Castello di San Giusto, dove il vescovo Santin svolgeva il ruolo di mediatore tirando le trattative per le lunghe in modo da dare il tempo ai neozelandesi, avanguardia dell’esercito alleato, di arrivare ed evitare in tal modo che la resa venisse consegnata nelle sole mani dell’esercito di liberazione yugoslavo. Così la guarnigione tedesca si arrese il 2 maggio, presenti anche gli anglo-americani, giunti a marce forzate dalla litoranea. Ma sul Carso, a vista d’occhio dalla città, si combatteva ancora. La cosiddetta “battaglia di Opicina” è costata molti morti, in gran maggioranza tedeschi, e si sarebbe conclusa solo il 3 maggio.
Secondo certe ricostruzioni (Leone Veronese, 1945. La battaglia di Opicina, Luglio Editore, 2015) i primi a essere gettati nelle cavità carsiche furono soldati dell’esercito tedesco, fucilati dopo la resa. La versione secondo cui gli infoibati sarebbero stati in maggioranza cittadini inermi che avevano il solo torto di essere italiani è falsa.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Tre cartoline di guerra dall’impero
Tre cartoline di guerra dall’impero
di ilsimplicissimus
Bastano tre o quattro notizie di questi giorni per restituire il senso dell’incubo contemporaneo, dei fantasmi che si agitano dietro le quinte senza che lo stridio di catene giunga al grande pubblico e di un potere ormai senza freni deciso a pervadere le vite e l’immaginario fino agli estremi. Mi limito ad elencare alcuni divisi per capitoli.
Iran – Israele e la guerra
Un tweet, successivamente cancellato e aggiustato, del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha acceso nuovi timori sulla sua posizione sull’Iran. Il messaggio originariamente in ebraico è stato poi tradotto in inglese, sempre sull’account twitter del primo ministro e riguarda le alcune sue osservazioni di ieri mentre partecipava a un vertice sul Medio Oriente a guida americana, anzi a guida Mike Pompeo tenutosi a Varsavia. Nel tweet iniziale, tradotto dall’ebraico, Netanyahu scriveva: “Ciò che è importante di questo incontro, non è segreto, questo è un incontro aperto con i rappresentanti dei principali paesi arabi che stanno sedendo insieme a Israele per promuovere l’interesse comune della guerra con l’Iran.” Una traduzione modificata ha successivamente sostituito “guerra” con combattere “. Sotto un’immagine con i due tweet.
Leggi tutto
Mauro Luongo: Disuguaglianze, territori, capitale. Le metropoli nella competizione globale
Disuguaglianze, territori, capitale. Le metropoli nella competizione globale
di Mauro Luongo*
Il lavoro d’inchiesta della Rete dei Comunisti sulle trasformazioni metropolitane iniziato con il volume su “La metropoli come merce”, ha aggiunto un nuovo capitolo con la pubblicazione de “Le metropoli nella competizione globale”. Un lavoro collettivo e a più voci che prova ad affondare l’analisi nelle molteplici relazioni tra la condizione delle aree territoriali e metropolitane e la cosiddetta globalizzazione. Un processo che alla nostra latitudine ha assunto la fisionomia del processo di costruzione di un’area strettamente integrata come Unione Europea, misurandosi con la funzione strategica assunta dal territorio nei processi di competizione/valorizzazione capitalistica.
Questo lavoro tenta di “ricostruire” i riferimenti della relazione centro-periferia nelle dinamiche delle filiere del valore a livello continentale e nazionale (vedi la “magnetizzazione” di risorse verso Milano a discapito della Capitale o il processo avviato con l’autonomia regionale differenziata), in un contesto in cui il territorio, inteso come insieme socio-produttivo, da terminale dei flussi di capitale a prevalente composizione transnazionale, interagisce non solo con la costruzione politica delle condizioni di ricettività, ma con una proiezione nelle dinamiche competitive, e diventa così parte attiva del circuito competitivo, che su scala globale assume sempre più evidentemente i caratteri dello scontro inter-imperialista.
Leggi tutto
Alberto Negri: Dal M5S alla Siria: gli intellettuali italiani non ne azzeccano una
Dal M5S alla Siria: gli intellettuali italiani non ne azzeccano una
di Alberto Negri
Parafrasando Longanesi, i nostri intellettuali sono come gli italiani, vogliono fare la rivoluzione ma con il permesso dei carabinieri. In fondo ce li meritiamo
Gli intellettuali italiani, che sciorinano da anni editoriali su Corsera, Repubblica e Stampa si pentono di avere votato i grillini e si accorgono che il Pd ha spianato loro la strada. Ora si svegliano improvvisamente e spalancano gli occhioni come sonnambuli. Ma loro in questi anni dov’erano?
Diciamo che per quanto riguarda la politica estera sono degli incompetenti: hanno appoggiato tutte le più devastanti imprese degli americani, compresa la guerra in Iraq nel 2003, e i raid in Libia nel 2011. Sono dei sonnambuli veri e propri, con movimenti e gestualità complesse ma senza averne assolutamente coscienza.
I nostri intellettuali, affetti da questo benigno e innocente disturbo, hanno una caratteristica fondamentale: non ci beccano mai.
Pur non sapendo nulla di Siria, in cui mai hanno messo piede, si sono accodati per anni alla cantilena occidentale e delle monarchie assolutistiche del Golfo: “Bashar Assad se ne deve andare”. Salvo poi ammettere che la Russia di Putin era diventata un attore di primo piano in Medio Oriente e accettare che Assad resti dov’è.
Leggi tutto
coniarerivolta: Il lavoro manca ma De Bortoli (purtroppo) c’è: se sei disoccupato la colpa è tua
Il lavoro manca ma De Bortoli (purtroppo) c’è: se sei disoccupato la colpa è tua
di coniarerivolta
 Tornano a squillare, se mai se ne
fosse sentita la mancanza, le trombe del padronato. Il tema è
sempre lo stesso: il
lavoro c’è ma i lavoratori, in particolare i giovani, lo
scanserebbero mossi da inspiegabile snobismo. Non la
drammatica carenza di
domanda di lavoro da parte delle imprese, non la più che
decennale stagnazione, ma i giovani choosy, ve li
ricorderete, che viziati e pigri preferiscono poltrire o
dedicarsi agli studi più effimeri, invece che
guadagnarsi da vivere. Sul Corriere della Sera, la scorsa
settimana, è apparso un articolo di Ferruccio De
Bortoli (personaggio ha già fatto capolino sulle nostre onde, e non
certo per prendersi applausi) con l’eloquente titolo
“Il lavoro c’è. Ma ci interessa?” L’articolo
è particolarmente interessante perché
condensa in modo sintetico e
significativo la visione dominante sul funzionamento del
mercato del lavoro e sulle cause della disoccupazione.
L’argomentazione è chiara: di lavoro non ne manca,
sono i lavoratori che non hanno voglia di lavorare.
Tornano a squillare, se mai se ne
fosse sentita la mancanza, le trombe del padronato. Il tema è
sempre lo stesso: il
lavoro c’è ma i lavoratori, in particolare i giovani, lo
scanserebbero mossi da inspiegabile snobismo. Non la
drammatica carenza di
domanda di lavoro da parte delle imprese, non la più che
decennale stagnazione, ma i giovani choosy, ve li
ricorderete, che viziati e pigri preferiscono poltrire o
dedicarsi agli studi più effimeri, invece che
guadagnarsi da vivere. Sul Corriere della Sera, la scorsa
settimana, è apparso un articolo di Ferruccio De
Bortoli (personaggio ha già fatto capolino sulle nostre onde, e non
certo per prendersi applausi) con l’eloquente titolo
“Il lavoro c’è. Ma ci interessa?” L’articolo
è particolarmente interessante perché
condensa in modo sintetico e
significativo la visione dominante sul funzionamento del
mercato del lavoro e sulle cause della disoccupazione.
L’argomentazione è chiara: di lavoro non ne manca,
sono i lavoratori che non hanno voglia di lavorare.
Da anni, decine di economisti di ispirazione liberista cercano di convincerci che la cronica disoccupazione europea, che in molti Paesi eccede abbondantemente il 10%, sarebbe da attribuire proprio ai disoccupati che, o non hanno le competenze adeguate a rivestire ruoli e mansioni fortemente richiesti dalle imprese, o mostrano una vera e propria inettitudine, pigrizia e mancanza di volontà ad adeguarsi al salario corrente e alla tipologia di lavori richiesti. La crisi? Il crollo degli investimenti pubblici e privati? Anni di austerità che, facendo sprofondare la domanda aggregata, hanno distrutto la capacità produttiva del Paese? Dettagli! La disoccupazione è, in buona sostanza, colpa di chi per scarsa intraprendenza, non adeguata preparazione o incomprensibile scelta, non lavora.
L’articolo di De Bortoli, nel portare avanti queste tesi, sciorina tutte le convinzioni del pensiero ortodosso in termini di occupazione. Se i lavoratori sono pigri, sarà necessario disincentivare questo loro comportamento: De Bortoli fa riferimento proprio a questa visione richiamando la ormai nota retorica contro le cosiddette politiche passive del lavoro, vale a dire, i sussidi di disoccupazione, gli ammortizzatori sociali e qualsiasi altra forma di trasferimento ai disoccupati.
Leggi tutto
Gianfranco Viesti: La secessione dei ricchi
La secessione dei ricchi
Stefano Poggi* intervista Gianfranco Viesti
 Nel silenzio e nella sostanziale indifferenza
dell’opinione pubblica nazionale,
il governo gialloverde si prepara a varare il frutto della
trattativa condotta per attivare la cosiddetta “autonomia
regionale
differenziata” per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: il
passaggio di massimo 23 competenze dallo stato alle regioni
secondo l’articolo
116 della Costituzione. Si corona così la strategia politica
della “nuova” Lega di Matteo Salvini: mantenere il
tradizionale
radicamento al nord con il tema delle autonomie regionali,
conquistando al tempo stesso nuovo consenso al centro e al
sud grazie a un inedito
nazionalismo italiano.
Nel silenzio e nella sostanziale indifferenza
dell’opinione pubblica nazionale,
il governo gialloverde si prepara a varare il frutto della
trattativa condotta per attivare la cosiddetta “autonomia
regionale
differenziata” per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: il
passaggio di massimo 23 competenze dallo stato alle regioni
secondo l’articolo
116 della Costituzione. Si corona così la strategia politica
della “nuova” Lega di Matteo Salvini: mantenere il
tradizionale
radicamento al nord con il tema delle autonomie regionali,
conquistando al tempo stesso nuovo consenso al centro e al
sud grazie a un inedito
nazionalismo italiano.
Ne abbiamo parlato con Gianfranco Viesti, docente di economia all’Università di Bari) che nel gennaio 2019 ha pubblicato per Laterza un e-book scaricabile gratuitamente (“Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale”) in cui denuncia gli aspetti più preoccupanti di una riforma che sconvolgerebbe l’assetto istituzionale italiano, delegando nuovi poteri e risorse a tre regioni che esprimono quasi un terzo della popolazione italiana e il 40% del Pil.
* * * *
Perché ha scelto un’espressione forte come «secessione dei ricchi» per descrivere il processo di autonomia differenziata di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto?
Bisogna intanto premettere che le carte attualmente in discussione fra regioni e governo sono segrete. Io mi rifaccio quindi al contenuto della pre-intesa siglata dalle regioni e dal governo Gentiloni il 28 febbraio 2018. All’articolo 4 di quell’intesa si trova il punto che fa pensare a una «secessione dei ricchi»: un meccanismo finanziario che prevede che – dopo un anno di transizione – si abbandoni progressivamente il criterio della spesa storica e si inizi a riferirsi a fabbisogni standard parametrati sul gettito fiscale regionale.
Leggi tutto
Transnational Social Strike Platform: L’ordine non regna in Europa
L’ordine non regna in Europa
L’insurrezione dei gilet gialli e la sfida transnazionale
di Transnational Social Strike Platform
 L’ordine non regna in Europa. La
scena politica già occupata dagli scontri tra i governi
nazionali è ora scossa da
segnali di rivolta da Est a Ovest. Il rischio di
disintegrazione dell’UE, paventato dalle istituzioni europee
dopo la crisi greca per frenare
qualsiasi tentativo di messa in discussione delle politiche di
austerity, si è ora trasformato nella paura concreta
dei governi del
diffondersi di atti d’insubordinazione. La
sollevazione in Ungheria contro la ‘slave law’ di Orbàn, le
manifestazioni in Serbia e Albania contro la violenza del
governo, la ribellione delle donne all’ordine sociale
patriarcale, gli scioperi che
attraversano tutti i settori del lavoro, dai centri logistici
agli ospedali, dagli uffici postali alle fabbriche,
l’ingovernabile movimento dei
migranti che sfida ogni giorno i confini e il razzismo
istituzionale. Sono tutte espressioni differenti, per quanto
spesso sconnesse tra di loro, di
una crescente rivolta contro lo stato di cose presente. Il
segno del rifiuto di un sistema che, in maniere diverse e con
attori politici differenti,
mira a ottenere donne e uomini ubbidienti e sfruttabili
attraverso l’impoverimento e la precarizzazione. Se in Europa
dell’Est il
tentativo di disciplinare il malcontento sociale attraverso
l’uso di una retorica nazionalista sta dando segni di
cedimento, a Ovest
l’idea che le istituzioni neoliberali possano conservare
l’ordine sociale si sta frantumando. Che ricorrano a un
comando autoritario
o facciano appello alle possibilità del mercato, i sistemi
politici sembrano incapaci di rispondere alle pretese avanzate
dai lavoratori e dai
movimenti sociali. Con il sopraggiungere delle elezioni
europee che costringono i leader politici a cercare modi per
farsi notare, cresce
l’incertezza e il transnazionale riemerge nuovamente quale
terreno di lotta cruciale. È all’interno di questo quadro che
da
novembre, la Francia (e le sue regioni e dipartimenti
oltremare) è attraversata da ondate di proteste e scioperi
ingovernabili, diffusi e
sostenuti da manifestanti con il gilet giallo (Gilets Jaunes).
L’ordine non regna in Europa. La
scena politica già occupata dagli scontri tra i governi
nazionali è ora scossa da
segnali di rivolta da Est a Ovest. Il rischio di
disintegrazione dell’UE, paventato dalle istituzioni europee
dopo la crisi greca per frenare
qualsiasi tentativo di messa in discussione delle politiche di
austerity, si è ora trasformato nella paura concreta
dei governi del
diffondersi di atti d’insubordinazione. La
sollevazione in Ungheria contro la ‘slave law’ di Orbàn, le
manifestazioni in Serbia e Albania contro la violenza del
governo, la ribellione delle donne all’ordine sociale
patriarcale, gli scioperi che
attraversano tutti i settori del lavoro, dai centri logistici
agli ospedali, dagli uffici postali alle fabbriche,
l’ingovernabile movimento dei
migranti che sfida ogni giorno i confini e il razzismo
istituzionale. Sono tutte espressioni differenti, per quanto
spesso sconnesse tra di loro, di
una crescente rivolta contro lo stato di cose presente. Il
segno del rifiuto di un sistema che, in maniere diverse e con
attori politici differenti,
mira a ottenere donne e uomini ubbidienti e sfruttabili
attraverso l’impoverimento e la precarizzazione. Se in Europa
dell’Est il
tentativo di disciplinare il malcontento sociale attraverso
l’uso di una retorica nazionalista sta dando segni di
cedimento, a Ovest
l’idea che le istituzioni neoliberali possano conservare
l’ordine sociale si sta frantumando. Che ricorrano a un
comando autoritario
o facciano appello alle possibilità del mercato, i sistemi
politici sembrano incapaci di rispondere alle pretese avanzate
dai lavoratori e dai
movimenti sociali. Con il sopraggiungere delle elezioni
europee che costringono i leader politici a cercare modi per
farsi notare, cresce
l’incertezza e il transnazionale riemerge nuovamente quale
terreno di lotta cruciale. È all’interno di questo quadro che
da
novembre, la Francia (e le sue regioni e dipartimenti
oltremare) è attraversata da ondate di proteste e scioperi
ingovernabili, diffusi e
sostenuti da manifestanti con il gilet giallo (Gilets Jaunes).
Leggi tutto
Peppe Liberti: Guida ragionevole alla mente quantistica
Guida ragionevole alla mente quantistica
di Peppe Liberti*
Le strane proprietà del mondo quantistico possono essere utili per descrivere e simulare i processi cerebrali?
 Una delle
cose che più fanno saltare la mosca al naso ai fisici è aver a
che fare
con chi sostiene che la meccanica quantistica, la migliore
teoria che abbiamo a disposizione per descrivere le proprietà
delle particelle,
degli atomi e delle molecole, possa spiegare anche la nostra
mente. Quest’idea ha la sua origine nelle riflessioni e nelle
indimostrate ipotesi
di alcuni tra i più grandi scienziati del secolo passato
(Wigner, Von Neumann, Bohm e così via) ma è stata amplificata
ogni
giorno di più dal numero immane di sciocchezze veicolate da
strampalati guru dei nostri tempi, da gente come
Deepak Chopra per esempio,
il celeberrimo neuroendocrinologo indiano, esperto di medicina
ayurvedica e terapie alternative, e in genere da tutti quelli
che provano a
giustificare le loro credenze irrazionali facendo largo e
ingiustificato uso della parola “quantistico”.
Una delle
cose che più fanno saltare la mosca al naso ai fisici è aver a
che fare
con chi sostiene che la meccanica quantistica, la migliore
teoria che abbiamo a disposizione per descrivere le proprietà
delle particelle,
degli atomi e delle molecole, possa spiegare anche la nostra
mente. Quest’idea ha la sua origine nelle riflessioni e nelle
indimostrate ipotesi
di alcuni tra i più grandi scienziati del secolo passato
(Wigner, Von Neumann, Bohm e così via) ma è stata amplificata
ogni
giorno di più dal numero immane di sciocchezze veicolate da
strampalati guru dei nostri tempi, da gente come
Deepak Chopra per esempio,
il celeberrimo neuroendocrinologo indiano, esperto di medicina
ayurvedica e terapie alternative, e in genere da tutti quelli
che provano a
giustificare le loro credenze irrazionali facendo largo e
ingiustificato uso della parola “quantistico”.
La meccanica quantistica, del resto, è una teoria strana e per molti aspetti paradossale, e fornisce una descrizione delle cose assai diversa dalla realtà a cui siamo abituati. Per esempio nel mondo degli “oggetti quantistici” non si può misurare nulla senza influenzare l’esito della misura: chi osserva – lo sperimentatore – dà sempre noia all’osservato e diventa così parte integrante dell’esperimento. Per alcuni, Eugene Wigner in particolare, ciò rappresenterebbe la prova che è la stessa mente di chi osserva che influenza, in qualche indecifrabile maniera, l’esito dell’osservazione.
A invertire il collegamento tra mente e meccanica quantistica ci ha pensato più di recente Roger Penrose, matematico e fisico britannico, che è arrivato ad affermare che la mente è quantistica e che è proprio questa la ragione per cui gli esseri umani possono fare cose che nessun computer classico sarà mai in grado di fare. Gli argomenti che ha portato a sostegno della sua tesi non hanno persuaso la stragrande maggioranza dei ricercatori.
Leggi tutto
Piotr: La batosta abruzzese e il resto del mondo
La batosta abruzzese e il resto del mondo
di Piotr
In Abruzzo ha vinto il Centrodestra. Attenzione! Non la Lega in quanto partito al governo col M5Stelle, ma la Lega in quanto ormai partito leader del Centrodestra. Il nuovo presidente della Regione Abruzzo sarà infatti il fratello d’Italia Marco Marsilio.
Ecco i risultati di questo raggruppamento: Forza Italia 9,1%, FdI 6,44%, Lega 27,54.
Sia Lega che FdI hanno raddoppiato i consensi.
Il Carroccio guadagna cinquantamila voti assoluti rispetto alle politiche del marzo scorso mentre i 5Stelle ne perdono duecentomila fermandosi al 20,2% dei voti validi contro il 39,9 per cento ottenuto alle politiche.
Ora, possiamo sbizzarrirci sulla debolezza dei 5Stelle nelle amministrative rispetto alle politiche o sul fatto che, per l’appunto, queste sono amministrative e non politiche, ma perderemmo di vista il dato saliente, ovvero le contraddizioni intrinseche di questo governo e il fatto che finora hanno penalizzato il Movimento 5 Stelle e premiato la Lega.
Avevo cercato di analizzarle, subito dopo il varo del governo, e mi sono così preso molte sgridate sia da chi riponeva in esso fiducia sia da chi lo osteggiava. Un en plein, insomma.
In sintesi giudicavo il governo Conte come il risultato di una manovra diretta dal presidente Mattarella per – passatemi l’espressione – “normalizzare l’esito del voto populista”.
Leggi tutto
Felice Roberto Pizzuti, Roberto Romano: La Commissione scarica sull’Italia i suoi fallimenti
La Commissione scarica sull’Italia i suoi fallimenti
di Felice Roberto Pizzuti, Roberto Romano
La Commissione europea taglia le stime della crescita italiana per il 2019 dall’1,2% allo 0,2%; il Fondo Monetario la riduce allo 0,6%. La tempistica delle differenti proiezioni è significativa: le prime erano del novembre 2018, mentre le ultime sono di fine gennaio. L’aspetto su cui riflettere è che il modello europeo di previsione della crescita, in meno di due-tre mesi, cambia il risultato di un punto di Pil, cioè di 17 mld (l’errore del Fmi è più contenuto).
Se in meno di due-tre mesi l’Italia e l’Europa registrano un crollo così evidente della crescita, forse c’è qualcosa di più grave e profondo che l’Europa prima e l’Italia dopo devono affrontare. Altro che misure correttive, semmai sarebbe necessaria un’azione urgente di spesa da parte delle istituzioni europee per tenere in tensione la domanda (effettiva), a cui dovrebbe seguire un intervento coordinato degli stati dell’area euro per rispondere al crescente disagio sociale.
L’evidenza suggerisce anche un altro e non banale quesito: l’Europa e in particolare l’Italia sono mai uscite dalla crisi del 2008? L’Europa ha castigato la crescita con delle politiche restrittive e non è sorprendente che gli effetti prima o poi si manifestino. Mentre gli Usa crescevano di 17 punti di Pil, l’Europa ha realizzato una crescita di soli 8 punti, mentre l’Italia ha fatto molto peggio. In altri termini, il tema centrale non è se e come il governo debba correggere i conti pubblici, piuttosto come affrontare una crisi i cui contenuti travalicano la congiuntura economica (non solo nazionale).
Leggi tutto
Gustavo Piga: Salviamo l’Europa con una nuova Costituzione fiscale
Salviamo l’Europa con una nuova Costituzione fiscale
Il mio articolo oggi sul Sole 24 Ore
di Gustavo Piga
Nella nota congiunturale dell’Ufficio Parlamentare di Bilancio spicca una tabella che riassume le condizioni attuali al ribasso della congiuntura mondiale. A fronte di una crescita 2019 del 3,5%, sempre trainata dai paesi emergenti (+ 4,5%), sono i paesi avanzati a segnare come da decenni a questa parte il passo, con una crescita minore al 2%. Eppure all’interno del mondo sviluppato la condizione del convalescente è variegata: si passa dal 2,5% statunitense al solito 1% in meno dell’area euro, al solito 1% in meno addizionale dell’Italia.
Non si pensasse tuttavia che questa particolare congiuntura europea al rischio di ribasso, la terza nel giro di 10 anni, non abbia una sua caratura speciale e diversa. Non è sfuggita agli occhi più attenti il curioso parallelismo continentale tra Francia e Italia, in cui la prima, secondo la Corte dei Conti transalpina, fronteggia significativi rischi di finanza pubblica con un deficit vicino al 3%, un debito alto e poco spazio di ulteriore manovra a seguito degli 11 miliardi stanziati per venire incontro alle richieste di pensionati e lavoratori a basso reddito. Come non dedurne che in Europa è lo stato dell’economia con le sue prorompenti esigenze di maggiore equità a dettare la linea delle politiche di bilancio? In fondo, lo stesso avviene negli Stati Uniti, con la differenza che Trump si permette deficit pubblici ben più alti di quelli del Vecchio Continente e per il tramite della politica fiscale espansiva sorregge la sua economia ed il suo consenso elettorale, equilibrismo ben più instabile dall’altra sponda dell’Atlantico.
Leggi tutto
James Petras: Peculiarità dell'imperialismo nel Sud America
Peculiarità dell'imperialismo nel Sud America
di James Petras
Comprendere l'imperialismo come fenomeno generale fa perdere di vista il suo modus operandi in ogni contesto specifico e significativo. Mentre l'esercizio del potere imperialista è una strategia comune, le sue motivazioni, strumenti, obiettivi e impegno variano a seconda della natura del sovrano imperiale e del paese bersaglio.
Il Venezuela, l'attuale bersaglio del Presidente degli USA Donald Trump, è un caso che illustra le "peculiarità" della politica imperialista. Procederemo a delineare il contesto, le tecniche e l'impatto della manovra di potere imperiale.
Contesto storico
Gli Stati Uniti hanno una lunga storia di interventi in Venezuela principalmente per ottenere il controllo della sua ricchezza petrolifera. Durante gli anni '50, Washington appoggiò una dittatura militare lanciata da Perez Jimenez, fino a quando fu rovesciata da un'alleanza di massa dei partiti socialisti, nazionalisti e socialdemocratici rivoluzionari. Washington non poteva intervenire e non intervenne; si schierò invece con i partiti democratici di centro-sinistra (AD) e del centro-destra della COPEI, che hanno proceduto a dichiarare guerra alla sinistra radicale. Nel corso degli anni, gli Stati Uniti hanno riguadagnato l'egemonia fino a quando l'economia non è entrata in crisi negli anni '90, portando a sollevazioni popolari e massacri di stato.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2909
Hits 2158
Hits 2083
Hits 2009
Hits 1890
Hits 1877
Hits 1861
Hits 1858
Hits 1757
Hits 1724
tonino

coniarerivolta: La pericolosa deriva dei sindacati confederali: negano il conflitto e sposano il liberismo
La pericolosa deriva dei sindacati confederali: negano il conflitto e sposano il liberismo
di coniarerivolta
 Nel 1927 il Gran Consiglio del
Fascismo deliberava la ‘Carta del Lavoro’, il documento
simbolo della nascita
dello stato corporativo e dell’indirizzo di politica economica
che il regime avrebbe condotto di lì in avanti, almeno fino
allo scoppio
del secondo conflitto mondiale. Un indirizzo politico volto
all’esplicita negazione del conflitto di classe
e, di conseguenza,
alla completa sottomissione dei lavoratori agli
interessi padronali. Espressioni quali
“collaborazione tra le forze
produttive”, “solidarietà tra i vari fattori della
produzione”, “uguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori”,
rinvenibili nell’articolato della Carta del Lavoro, trovarono
la loro compiuta sintesi nel riconoscimento, da parte del
fascismo,
dell’organizzazione privata della produzione come “funzione di
interesse nazionale” e dell’iniziativa economica privata come
motore dell’economia. Una perfetta espressione della visione
liberista (con i dovuti e gli opportuni distinguo – si pensi,
ad esempio,
alla coniugazione del lavoro, presente nella Carta fascista,
come “dovere sociale”, in contrapposizione all’ideale liberale
del
lavoro come “diritto”), che prevede il superamento della lotta
di classe in nome di un “armonico” asservimento del lavoro al
capitale, ai fini dello “sviluppo della potenza nazionale”.
Nel 1927 il Gran Consiglio del
Fascismo deliberava la ‘Carta del Lavoro’, il documento
simbolo della nascita
dello stato corporativo e dell’indirizzo di politica economica
che il regime avrebbe condotto di lì in avanti, almeno fino
allo scoppio
del secondo conflitto mondiale. Un indirizzo politico volto
all’esplicita negazione del conflitto di classe
e, di conseguenza,
alla completa sottomissione dei lavoratori agli
interessi padronali. Espressioni quali
“collaborazione tra le forze
produttive”, “solidarietà tra i vari fattori della
produzione”, “uguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori”,
rinvenibili nell’articolato della Carta del Lavoro, trovarono
la loro compiuta sintesi nel riconoscimento, da parte del
fascismo,
dell’organizzazione privata della produzione come “funzione di
interesse nazionale” e dell’iniziativa economica privata come
motore dell’economia. Una perfetta espressione della visione
liberista (con i dovuti e gli opportuni distinguo – si pensi,
ad esempio,
alla coniugazione del lavoro, presente nella Carta fascista,
come “dovere sociale”, in contrapposizione all’ideale liberale
del
lavoro come “diritto”), che prevede il superamento della lotta
di classe in nome di un “armonico” asservimento del lavoro al
capitale, ai fini dello “sviluppo della potenza nazionale”.
La caduta del regime fascista non ha comportato, come ben sappiamo, la morte dell’ideale liberal-corporativista di unità tra le forze produttive. Esso appare infatti rintracciabile negli indirizzi di politica economica promossi dai governi italiani dal secondo dopoguerra in poi. Neanche l’alternanza tra governi di centro-sinistra e centro-destra degli ultimi decenni ha minimamente scalfito questa visione. Senza addentrarci in una complessa disamina storica, venendo ai giorni nostri, si può ritenere che quel concetto, pur rimanendo immutato nella sostanza, abbia fatto registrare dei cambiamenti nelle modalità tramite le quali esso viene declinato nel discorso pubblico.
Leggi tutto
Il Pedante: Il silenzio dei senzienti
Il silenzio dei senzienti
di Il Pedante
 Ricevo e
pubblico con gratitudine un contributo
sottoscritto da numerose associazioni per la libertà di
scelta sanitaria. Il documento, scaricabile
qui
nella versione completa di allegati e approfondimenti,
contiene il lavoro svolto dalle associazioni in preparazione
delle loro audizioni presso la
Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica,
nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 770 in
materia di
vaccinazioni.
Ricevo e
pubblico con gratitudine un contributo
sottoscritto da numerose associazioni per la libertà di
scelta sanitaria. Il documento, scaricabile
qui
nella versione completa di allegati e approfondimenti,
contiene il lavoro svolto dalle associazioni in preparazione
delle loro audizioni presso la
Commissione igiene e sanità del Senato della Repubblica,
nell'ambito della discussione sul disegno di legge n. 770 in
materia di
vaccinazioni.
Quelle audizioni non hanno avuto luogo né mai lo avranno, nonostante le pubbliche rassicurazioni del presidente di Commissione. Qualcuno ha infatti stabilito che il testo dovrà tradursi in legge nel più breve tempo possibile. Chi ha dettato questa accelerazione? Chi ha deciso di escludere le associazioni? E perché? Non si sa né, come già in passato, ci si degnerà di spiegarlo. La vicenda, ostinatamente derubricata dai più intelligenti, da quelli che badano alle cose serie, all'ordinaria amministrazione di cose tecniche e grige da lasciare al grigiore dei tecnici, continua a svolgersi in un silenzio equivoco da segreto di Stato e sotto l'assedio del mainstream anglosassone, scientifico e non, mentre persino il vicepremier e ministro degli Interni deve suggerire in pubblico la propria impotenza malgrado gli impegni presi con gli elettori. Sembra che nessuno possa affrontare il tema senza fulminarsi: una dinamica tipica, ci spiegano gli intelligenti, delle cose di poca importanza.
Sul disegno di legge in parola ho già speso molte pagine su questo blog (qui e qui, inter alia). Nel testo che segue se ne affrontano le criticità in modo più sistematico, nell'ambito di una battaglia ferma ed equilibrata per affermare il diritto del popolo italiano di autodeterminarsi secondo Costituzione, attraverso il voto e le altre forme di partecipazione previste dalla Carta. La ripetuta violazione di questo diritto, con questa ennesima promessa mancata, dovrebbe aprire gli occhi di tutti su un metodo che, già da solo, lascia intuire l'abnormità del merito in gioco.
Leggi tutto
Maurizia Russo Spena, Vincenzo Carbone: La società dei performanti
La società dei performanti
di Maurizia Russo Spena, Vincenzo Carbone
 Interroghiamo oggi, in questa
sede, il libro di Roberto Ciccarelli
Capitale
disumano. La vita in alternanza scuola lavoro (Manifestolibri,
2018), che è meraviglioso soprattutto nella sua sezione più
filosofico-politica (dove vi è un recupero ed una
riappropriazione della nozione di forza lavoro intesa come
produttrice di legame sociale e
valori), a partire dall’osservazione di alcune categorie
rilette sulla base delle nostre esperienze professionali di
ricercatori in ambito
socio-educativo e di genitori di figli che subiscono
costantemente le ingiunzioni performative della «scuola delle
competenze».
Interpelleremo del testo, pertanto, la parte più empirica
delle transizioni intese come misura di politica attiva
dell’alternanza scuola
lavoro (ASL), che definiremmo piuttosto come intreccio non
lineare tra formazioni e lavori, e, dunque, non l’analisi
delle transizioni quale
paradigma che concerne l’intero corso di vita.
Interroghiamo oggi, in questa
sede, il libro di Roberto Ciccarelli
Capitale
disumano. La vita in alternanza scuola lavoro (Manifestolibri,
2018), che è meraviglioso soprattutto nella sua sezione più
filosofico-politica (dove vi è un recupero ed una
riappropriazione della nozione di forza lavoro intesa come
produttrice di legame sociale e
valori), a partire dall’osservazione di alcune categorie
rilette sulla base delle nostre esperienze professionali di
ricercatori in ambito
socio-educativo e di genitori di figli che subiscono
costantemente le ingiunzioni performative della «scuola delle
competenze».
Interpelleremo del testo, pertanto, la parte più empirica
delle transizioni intese come misura di politica attiva
dell’alternanza scuola
lavoro (ASL), che definiremmo piuttosto come intreccio non
lineare tra formazioni e lavori, e, dunque, non l’analisi
delle transizioni quale
paradigma che concerne l’intero corso di vita.
Ci soffermeremo, in particolare, sulla violenza delle retoriche delle competenze, del loro carattere performativo, delle conseguenze che producono sulla vita dei soggetti in carne ed ossa, soprattutto a partire dal mondo della scuola. La costruzione di questa narrazione, secondo la quale gli studenti all’interno del principio della formazione continua, degli apprendimenti ricorsivi e della certificazione delle capacità (sapere, fare, dover-essere, imparare ad apprendere), devono essere i promotori del proprio capitale umano, è avvenuta in un quarto di secolo, a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale ed europeo.
1. La nozione di competenza/e va aggredita non solamente in quanto dispositivo di controllo, valutazione ed asservimento, ma soprattutto perché le logiche e le metriche (adottate verso «comportamenti oggettivabili») ad essa sottese costituiscono e delimitano l’unico orizzonte di pensabilità del soggetto neoliberale.
Leggi tutto
Sergio Scorza: Prima gli italiani? No, prima i ricchi!
Prima gli italiani? No, prima i ricchi!
di Sergio Scorza
Contro il governo della carota e del bastone…
In Italia, negli ultimi 20 anni, la ricchezza si è spostata, con un andamento costante, dai salari ai profitti e lo stato sociale è stato ridotto in braghe di tela in nome dell’assioma teologico “meno stato, più mercato” . Quell’assioma è stato adottato di peso da tutti i governi che si sono succeduti alla guida del paese i quali hanno invariabilmente alimentato questa tendenza fino a raggiungere lo splendido risultato di spingere nella povertà assoluta più di 5 milioni di persone ed altre 10 milioni di persone in quella relativa(a ridosso della “linea di povertà”) mentre il 5% di italiani si è impossessato dello stesso patrimonio dell’80% dei restanti.
Insomma, la coperta della quota che prima finiva in redistribuzione sotto forma di salario e servizi nelle così dette ” fasi espansive” si è ristretta ferocemente a causa della atavica avidità del padronato italiano che ha trovato in politici e sindacati docili sponde ai suoi desiderata ma anche per effetto dei folli diktat europei e del ricatto del debito infinito che hanno prodotto il mostro del “pareggio di bilancio” in Costituzione e dei tagli selvaggi alla spesa sociale. Ora il problema per milioni di famiglie già esistenti o per chi se ne volesse fare una è il seguente: con un salario medio di 900, 1000 euro al mese(se fai parte dei più fortunati) in cambio di un lavoro quasi sempre precario, come faccio vivere se solo per l’affitto di un modestissimo bilocale di in quartiere periferico mi chiedono almeno 700, 800 euro?
Leggi tutto
Stefano G. Azzarà: Contro la secessione dei ricchi e l'autonomia regionale differenziata
Contro la secessione dei ricchi e l'autonomia regionale differenziata
Un comitato in difesa dell’unità nazionale
di Stefano G. Azzarà
L'unico "sovranismo" che ci piace: difendere l'unità nazionale - definita dalla Costituzione repubblicana nata dalla Resistenza antifascista e dall'impegno dei comunisti - dalla secessione dei ricchi promossa da Lega e 5Stelle.
Mi sembra un'ottima iniziativa. Forse la prima che la sinistra azzecca dal 2005.
A fronte di tanto patriottismo socialsciovinista eurofobo e subalterno agli USA che si è diffuso anche a sinistra, questo è finalmente il modo di smascherare il sedicente "sovranismo" sui problemi concreti. E di porre all'ordine del giorno la vera questione nazionale, che - a partire dal divario Nord-Sud - è sempre anche una questione di classe.
Se la sinistra lo avesse fatto in tempo utile, oggi non assisteremmo a tanti episodi di slittamento patriottardo a destra, come nel caso di rinascita, patria e costituzione, Senso comune e via di rozzobrunismo.
E' un'occasione da non perdere e soprattutto una questione da non lasciare ai grillini, che se saranno messi all'angolo cercheranno disperatamente di intestarsela declinandola in chiave "sudista".
Invito tutti ad aderire. Domenico Losurdo, che temeva la Lega più di ogni altra cosa, approverebbe [SGA].
Leggi tutto
Salvatore Palidda: Critica della demo-politica
Critica della demo-politica
No al natalismo e ai pro-migranti per la crescita neoliberista
di Salvatore Palidda
Da qualche tempo diversi esperti oltre che alcuni media veicolano dei paradossi demo-politici: da un lato si alimenta l’angoscia per il cosiddetto aumento costante della popolazione mondiale (e spesso si alimenta l’incitamento alla guerra alle migrazioni) e dall’altro si ha paura del calo della popolazione in Europa e in particolare in Italia.
In un recente articolo pubblicato dal prestigioso sito Neodemos.info a proposito del bilancio del 2018 dell’Istat, si “ribadisce che la demografia italiana rimane “sdraiata sul fondo”, come un sottomarino in avaria che non riesce ad emergere: le nascite sono in ulteriore declino e per il quarto anno consecutivo la popolazione è in diminuzione … Per il quarto anno consecutivo la popolazione residente è diminuita: 60,4 milioni di residenti al primo gennaio del 2019, 400.000 in meno di quattro anni prima…. Questo bilancio negativo non è frutto di una situazione congiunturale, ma è il risultato di tendenze profondamente iscritte nella struttura demografica del paese”. Neodemos “afferma con forza che esiste una “questione demografica” che lentamente ma con continuità, anno dopo anno, frena lo sviluppo, appesantisce i conti pubblici, rallenta la produttività, pone in tensione la coesione sociale del paese”. A partire da ciò gli esperti di Neodemos si allarmano: “ogni anno che passa diventa più urgente l’avvio di una politica sociale integrata ed efficace … si fa altrettanto urgente l’avvio di una saggia programmazione dei flussi d’immigrazione, l’unica efficiente medicina di contrasto al declino”.
Leggi tutto
Nicole Janigro: Quando l’economico è psichico
Quando l’economico è psichico
di Nicole Janigro
Anna è giovane, e sempre bella, già sulla soglia intravedo una faccia tirata, pare rattristata, penso a un problema sentimentale, invece è patrimoniale. Anna è una collega, suo marito un libero professionista dagli introiti alternati, dai pagamenti sempre spostati, il mutuo è grande, il figlio piccolo, in banca non accettano dilazioni, a fine mese non si arriva, piange per la mortificazione, l’umiliazione di dover continuare a chiedere qualcosa che ogni giorno sudatamente guadagna.
Riccardo è uno stagista, ma non è di Milano, dopo due mesi di lavoro ovviamente gratuito e con orari prolungati, chiede i buoni pasto, il capo alza il telefono e chiama un altro, da domani lui se ne può andare.
L’ospedale gode di buona fama, ma le infermiere protestano perché i turni notturni sono seguiti da quelli diurni, il che è illegale, ma soprattutto mette in ansia chi lavora in un reparto neonatale.
Il budget non è stato raggiunto, la direttrice raduna tutti, fustiga e maltratta, e dato che questa è la sua guerra, le parole sono insulti da lanciare come pallottole.
Carlo scaraventa il computer in aria e abbandona la postazione, dopo l’ennesima richiesta di reperibilità.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Invito a ragionare
Invito a ragionare
di Pierluigi Fagan
 Dopo il festival di
Sanremo ma prima del festival di Cannes, si terrà a Roma,
nel secondo week end di
maggio, l’inaugurazione della decima edizione del Festival
della complessità. Gli amici del comitato promotore a cui
quest’anno do
una mano, mi hanno chiesto di tenere per un mesetto il blog
collegato all’iniziativa che durerà poi tutta l’estate con
molti
incontri organizzati in tutta Italia.
Dopo il festival di
Sanremo ma prima del festival di Cannes, si terrà a Roma,
nel secondo week end di
maggio, l’inaugurazione della decima edizione del Festival
della complessità. Gli amici del comitato promotore a cui
quest’anno do
una mano, mi hanno chiesto di tenere per un mesetto il blog
collegato all’iniziativa che durerà poi tutta l’estate con
molti
incontri organizzati in tutta Italia.
Apriamo quindi il percorso di avvicinamento a quel primo incontro con questo post che verte su una cruciale questione relativa non a questo o quel pensiero o sistema di pensiero, ma su come componiamo i pensieri in genere. Pensare è sempre pensare a qualcosa ed è attività talmente istintiva che pensiamo tutti di poterlo e saperlo fare, siamo tutti esperti nel pensare ricevendo in eredità la funzione dalla lunga storia del nostro genere Homo, viepiù se sapiens.
Pensare a come pensiamo è una di quelle situazioni riflessive (la cosa applicata a se stessa che comincia dalla coscienza di avere coscienza) che apre un mondo diverso, non quello che vede noi alle prese con le cose del mondo, ma noi alle prese con noi stessi. E’ attività poco divertente o meno divertente che non pensare a questo o quello e poi buttarsi a capofitto nella polemica con chi la pensa diversamente, un po’ come la scuola guida rispetto al viaggiare verso una meta.
Alle volte però è necessario perché non sempre come facciamo le cose produce di per sé la miglior soluzione. Apriamo dunque con l’invito a pensare le cose “nel loro complesso”. Ma cosa significa pensar la cosa nel suo complesso?
Eccovi l’articolo sul sito del festival: qui.
Leggi tutto
Luca Michelini: La CGIL di Landini, il ruolo del sindacato e la politica economica
![]()
La CGIL di Landini, il ruolo del sindacato e la politica economica
di Luca Michelini*
 1. Pur
con i limiti di chi non conosce dall’interno le logiche
odierne di una grande
organizzazione come la CGIL, che pure ho studiato nella sua
evoluzione storica ed ho avuto modo di conoscere
direttamente, seguire l’azione
politico-sindacale di Landini ritengo sia molto importante
per cercare di cogliere qualche segnale di risveglio del cd.
movimento dei lavoratori.
1. Pur
con i limiti di chi non conosce dall’interno le logiche
odierne di una grande
organizzazione come la CGIL, che pure ho studiato nella sua
evoluzione storica ed ho avuto modo di conoscere
direttamente, seguire l’azione
politico-sindacale di Landini ritengo sia molto importante
per cercare di cogliere qualche segnale di risveglio del cd.
movimento dei lavoratori.
La notizia importante è stata che Camusso ha appoggiato la candidatura di Landini alla segreteria.
La preparazione di Landini a questo appuntamento è stata notevole, perché per anni ha costruito la propria candidatura, seguendo una triplice strategia.
In primo luogo Landini è sempre stato al fianco dei lavoratori, acquisendo una credibilità sindacale, morale e politica innegabile. La credibilità in politica è fondamentale, soprattutto ora che sono venute definitivamente a mancare solide fondamenta culturali alla politica della sinistra. Certo, sono importanti anche gli esiti delle lotte; ma ancora più importante è che chi dirige le manovre, anche in caso di sconfitta, rimanga leale al proprio schieramento. Landini, d’altra parte, ha girato l’Italia rinsaldando l’organizzazione e lo spirito di tanti lavoratori e di tanti cittadini orfani di una rappresentanza politica capace di difenderli. Né Rifondazione e discendenti, né i partiti che hanno dato vita al PD, né il PD sono stati in grado di farlo, infatti. In fondo, Landini ha dato voce e speranza ai tanti cittadini italiani orfani del PCI. Ha cioè avuto cura di rinsaldare i tanti legami che il movimento operaio, in ogni sua componente (politica, sociale, sindacale) ha costruito in decenni e decenni di vita associativa. Ha fatto cioè l’esatto contrario di quanto si è proposta la dirigenza politica ex-comunista, come notò in un celebre editoriale dedicato a D’Alema il compianto direttore del “Manifesto” Luigi Pintor.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Losurdo, Controstoria del liberalismo
![]()
Losurdo, Controstoria del liberalismo
di Salvatore Bravo
 Il
binomio democrazia-liberalismo è parte dell’apparato
ideologico che col suo
manicheismo manipolativo esemplifica i messaggi e traccia
linee di confine tra il bene ed il male. L’ordoliberalismo
europeo trae la sua
legittimità dal giudizio sbrigativo e sempre negativo su
ogni alterità politica esistita. L’Unione sovietica, il
comunismo ed ogni
dialettica del possibile continuano ad essere “il male
impronunciabile”. Il male è ontologico ed inemendabile e
dunque
inspiegabile, per cui ogni mediazione razionale che possa
spiegare genesi, ascesa e caduta di un sistema politico
altro, è ridotta a poche
parole astoricizzate e che tendono solo, a far cogliere la
malvagità del sistema altro. Dall’altra parte della linea di
confine
c’è il bene, il regno irenico dove le contraddizioni sono
sublimate nella verità del mercato. Il liberal liberismo si
propone
quale verità della storia intrasmutabile oltre la quale vi è
se stessa, con i suoi naturali sommovimenti. Domenico
Losurdo in
Controstoria del liberalismo, mette in atto mediante
il metodo induttivo, la coerenza e le contraddizioni degli
autori liberali e del loro
contesto politico sociale. Si tratta di un’opera preziosa
per uscire dalla spelonca buia della rappresentazione
conformistica ed ideologica del
liberalismo, il quale è automaticamente associato alla
democrazia, ai diritti, all’emancipazione. La controstoria
non solo elimina i
pregiudizi positivi contro il liberalismo, riportandolo alla
sua verità storica, ma lungo il testo emerge la verità della
cultura
liberale, a cui pur riconoscendo indubitabili meriti, ovvero
la difesa dei soggetti dall’assolutismo, essa ha il fine di
difendere la
proprietà, laicizza la ricchezza, la mette in circolo e ne
fa il fondamento conflittuale ed individualistico delle
comunità che vorrebbe
liberare. La lettura della storia del liberalismo di
Domenico Losurdo ci permette di comprendere meglio l’Europa
dell’euro, della finanza
competitiva e nel contempo ci fa scorgere il nostro
probabile futuro, qualora nuovi accadimenti, nuove
consapevolezze comunitarie non intervengano a
deviare gli automatismi attuali.
Il
binomio democrazia-liberalismo è parte dell’apparato
ideologico che col suo
manicheismo manipolativo esemplifica i messaggi e traccia
linee di confine tra il bene ed il male. L’ordoliberalismo
europeo trae la sua
legittimità dal giudizio sbrigativo e sempre negativo su
ogni alterità politica esistita. L’Unione sovietica, il
comunismo ed ogni
dialettica del possibile continuano ad essere “il male
impronunciabile”. Il male è ontologico ed inemendabile e
dunque
inspiegabile, per cui ogni mediazione razionale che possa
spiegare genesi, ascesa e caduta di un sistema politico
altro, è ridotta a poche
parole astoricizzate e che tendono solo, a far cogliere la
malvagità del sistema altro. Dall’altra parte della linea di
confine
c’è il bene, il regno irenico dove le contraddizioni sono
sublimate nella verità del mercato. Il liberal liberismo si
propone
quale verità della storia intrasmutabile oltre la quale vi è
se stessa, con i suoi naturali sommovimenti. Domenico
Losurdo in
Controstoria del liberalismo, mette in atto mediante
il metodo induttivo, la coerenza e le contraddizioni degli
autori liberali e del loro
contesto politico sociale. Si tratta di un’opera preziosa
per uscire dalla spelonca buia della rappresentazione
conformistica ed ideologica del
liberalismo, il quale è automaticamente associato alla
democrazia, ai diritti, all’emancipazione. La controstoria
non solo elimina i
pregiudizi positivi contro il liberalismo, riportandolo alla
sua verità storica, ma lungo il testo emerge la verità della
cultura
liberale, a cui pur riconoscendo indubitabili meriti, ovvero
la difesa dei soggetti dall’assolutismo, essa ha il fine di
difendere la
proprietà, laicizza la ricchezza, la mette in circolo e ne
fa il fondamento conflittuale ed individualistico delle
comunità che vorrebbe
liberare. La lettura della storia del liberalismo di
Domenico Losurdo ci permette di comprendere meglio l’Europa
dell’euro, della finanza
competitiva e nel contempo ci fa scorgere il nostro
probabile futuro, qualora nuovi accadimenti, nuove
consapevolezze comunitarie non intervengano a
deviare gli automatismi attuali.
Leggi tutto
Eros Barone: Le prestazioni di un clown
![]()
Le prestazioni di un clown
di Eros Barone
Gli imbecilli dissacrino, è il loro mestiere. Capire che il riso comporta un grado elevato di complicità con il potere e l’ideologia dominanti, non è facile da concedere, ne convengo. Che il riso non castighi i costumi ma li confermi, è duro da ammettere. Ma è così. Il riso vale come critica solo se si aggiunge a una critica che non ride. Non può sostituirla. Debbo sapere che la tirannide è tragica. Solo quando ciò è ben chiaro, come in Shakespeare o in Beckett, allora posso permettermi di fare entrare i clowns.
F. Fortini, da L'ospite ingrato. Primo e secondo.
Che Fausto Bertinotti arrivi a celebrare Giovanni Guareschi, mimando Peppone in compagnia di un prelato che mima don Camillo, i due deuterantagonisti di quel ciarpame reazionario nel cui spaccio l’imbrattacarte emiliano si era specializzato durante il secondo dopoguerra, non può stupire, ma solo disgustare, chiunque conosca il camaleontismo politico-culturale di questo personaggio emblematico della degenerazione opportunista della sinistra e, soprattutto, chiunque non dimentichi che l’ex presidente della Camera arrivò a sentenziare qualche tempo fa, in un’intervista al “Corriere della Sera”, la fine del movimento operaio, esprimendo la sua ammirazione per il movimento integralista di Comunione e Liberazione.
Leggi tutto
Sergio Cararo: La secessione reale e il “Cigno nero”
La secessione reale e il “Cigno nero”
di Sergio Cararo
La politica si è svegliata come al solito troppo tardi. Il processo che può portare alla secessione reale del nostro paese ha macinato già parecchi chilometri e consensi, soprattutto nel Nord. Fermarlo non sarà un pranzo di gala, ma non ci si può in alcun modo sottrarre alla necessità di provarci, con ogni mezzo necessario.
“Non c’è nessuno slittamento. I testi sono pronti e li porto in Consiglio dei Ministri. Restano dei nodi politici sui quali discutere”. La conferma è venuta dal ministro per gli Affari Regionali Erika Stefani (Lega, ndr) relativamente al testo per l’autonomia rafforzata del Veneto, Lombardia e Emilia Romagna. Per il ministro “ il regionalismo differenziato è la chiave di volta per le regioni. È un’occasione da cogliere e non – conclude – un pericolo da scampare”.
Le fa eco uno dei caterpillar della secessione reale: “C’è finalmente un documento finale sulla autonomia che, se fosse confermato avere i contenuti proposti dal Veneto, per noi è immediatamente sottoscrivibile”, ha detto il presidente del Veneto, Luca Zaia, dopo l’annuncio dato dal ministro.
L’onda nefasta dei danni provocati dal governi di centro-sinistra che misero mano al Titolo V della Costituzione e dei governi di centro-destra intrisi dalla Devolution leghista, potrebbe arrivare a sintesi con un governo diverso da quelli che lo hanno preceduto.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Se sette guerre vi sembran poche, ne facciamo altre due
Se sette guerre vi sembran poche, ne facciamo altre due
Secondo gli scienziati atomici siamo a 2 minuti dall’apocalisse
di Fulvio Grimaldi
Qui si parla dell’Iran.
L’abbiamo girato in lungo e in
largo, ne abbiamo conosciuto i giovani, gli operai, le
donne, gli artisti, gli storici, i politici. Ne abbiamo
visitato le bellissime città
antiche, i siti archeologici. Ne abbiamo incontrato la
sofferenza per le atrocità del terrorismo che colpisce
alla cieca e delle sanzioni che
puntano ad affamare per sottomettere. E’ un Iran civile e
ospitale, il rovescio di quello che ci viene raccontato.
Un paese che non ha mai
aggredito nessuno. Ora lo vorrebbero annientare. Conviene
conoscerlo per sostenerlo. Il mio docufilm “TARGET IRAN”
ve ne offre
l’occasione. Per sapere come riceverlo scrivete a visio...@virgilio.it. Il
trailer qui.
Da discorsi dell’odio a fatti dell’odio
Quelli che, da quando li ha inventati Hillary Clinton e da noi li ha rilanciati Renzi, per poi passarli a Boldrini, onde ne coprisse paginate su “Repubblica” “Foglio” e “manifesto”, ci scassano le gonadi con la campagna contro i “discorsi dell’odio”, gli hate speeches, se fossero onesti dovrebbero gettare un’occhiata su quanto è successo a Varsavia e ritirarsene con orrore. Dopo l’abbandono USA del Trattato ABM già nel 2002, e ora di quello sui missili a corto e medio raggio (INF) che coinvolgono l’Europa e in vista dell’abbandono anche del trattato New START che scade nel 2021, siamo alla più demenziale corsa al riarmo nucleare dai tempi di Eisenhower. Una corsa che ha fatto spostare l’orologio degli scienziati atomici a 2 minuti da mezzanotte, dove era stato solo temporaneamente nel 1953 e nel 1960, nei momenti più acuti della guerra fredda.
Leggi tutto
Piergiovanni Pelfer: Le travail c’est la santé, rien faire c’est la conserver
Le travail c’est la santé, rien faire c’est la conserver
di Piergiovanni Pelfer
Il lavoro è una dannazione divina, dice la Bibbia. L’uomo era stato creato per vivere nell’Eden senza far nulla, tutto il necessario era disponibile e a portata di mano. Mark Twain definisce bene il lavoro nel suo romanzo Le avventure di Tom Sawyer: «Tom disse a se stesso che il mondo non era poi così desolato, in fin dei conti. Senza rendersene conto, aveva scoperto una grande legge delle azioni umane, vale a dire che per indurre un uomo o un ragazzo a bramare qualcosa, è necessario soltanto far sì che quella cosa sia difficile da ottenere. Se fosse stato un grande e savio filosofo, come l’autore del presente libro, si sarebbe reso conto, a questo punto, che il lavoro consiste in qualsiasi cosa una persona è costretta a fare, mentre il divertimento consiste in qualsiasi cosa una persona non è costretta a fare. E ciò lo aiuterebbe a capire perché fare fiori artificiali o sorvegliare un mulino è un lavoro mentre lanciare grosse palle contro birilli o scalare il Monte Bianco è soltanto divertimento. Vi sono ricchi gentiluomini, in Inghilterra, che guidano carrozze con tiri a quattro, per trenta o quaranta chilometri al giorno, in estate, perché un simile privilegio costa loro parecchi quattrini; ma, se venisse offerto loro un compenso per questa fatica, ciò la tramuterebbe in lavoro, e in tal caso darebbero le dimissioni».
Leggi tutto
comidad: Le specificità della menzogna europea
Le specificità della menzogna europea
di comidad
I dati sulla caduta della crescita e della produzione industriale in Italia nella seconda metà del 2018, sono stati accolti con un compiacimento eccessivo, che va oltre la scontata polemica con l’attuale governo. Le stesse notizie sul rallentamento economico della Germania e della Cina hanno suscitato nei media una sorta di euforia, come a confermare che la “crescita” non è affatto un obbiettivo comune e condiviso, al di là dei mezzi ritenuti idonei per raggiungerlo.
La lobby della deflazione è la grande innominata e innominabile dell’attuale contesto economico globale, così come viene totalmente rimossa l’ovvia osservazione per cui i processi di finanziarizzazione richiedono necessariamente un quadro di stagnazione economica. Lo sviluppo economico, con il conseguente aumento delle entrate fiscali, renderebbe gli Stati meno dipendenti dai prestiti dei grandi “investitori istituzionali”, cioè le multinazionali del credito, colossi bancari e fondi di investimento. Lo sviluppo determinerebbe inflazione e quindi erosione del valore dei crediti. Lo sviluppo determinerebbe anche aumenti salariali e quindi una minore dipendenza delle masse dal credito ai consumi. Insomma, lo sviluppo economico per la grande finanza sarebbe una iattura, quindi non c’è nulla di strano nel fatto che la centrale della lobby della deflazione, il Fondo Monetario Internazionale, delinei per il futuro scenari catastrofici in modo da scoraggiare gli investimenti e i consumi.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2958
Hits 2190
Hits 2101
Hits 2018
Hits 1943
Hits 1899
Hits 1878
Hits 1864
Hits 1774
Hits 1727
tonino

Ugo Boghetta: Regioni, aboliamole!
Regioni, aboliamole!
Il regionalismo differenziato è secessione
di Ugo Boghetta
 Puntuale come la cometa di Halley torna la
discussione sul
passaggio alle Regioni di soldi e competenze. Ma l’arrivo
delle comete era foriero di sventure.
Puntuale come la cometa di Halley torna la
discussione sul
passaggio alle Regioni di soldi e competenze. Ma l’arrivo
delle comete era foriero di sventure.
Con Bossi si chiamava devolution. Poi sono seguiti: sussidiarietà, federalismo fiscale, regionalismo rafforzato. Ora l’appellativo è quello di regionalismo differenziato.
Lombardia e Veneto, le due regioni a trazione leghista, per spingere in questo senso hanno anche svolto un referendum consultivo, La Regione Emilia Romagna ha invece avanzato una proposta parzialmente diversa ma a livello istituzionale.
La faccenda, è grave e pesante: ne va dell’unità del paese e di uguali diritti per gli italiani. Ma produce anche un indebolimento generale dell’Italia in un contesto internazionale complicato ed in transizione conflittuale anche nell’eurozona e nel Mediterraneo.
La questione è tecnicamente complicata per cui cercheremo di ridurla all’osso, o meglio, alla polpa. E la polpa sono i soldi e il potere.
Lombardia e Veneto pretendono risorse in una qualche proporzione di uno o più tributi versati nei loro territori, mentre la Regione Emilia-Romagna chiede le risorse in funzione del trasferimento di competenze. La zuppa è sempre la stessa. Ovviamente pretendono le risorse che lo Stato redistribuisce ma non gli interessi che paga.
I legaioli del nord chiedono 23 competenze, l’Emilia 15, ma le funzioni amministrative in ballo sono circa 200.
Le materie sono le più varie: salute, istruzione, mobilità ma anche protezione civile, cultura, infrastrutture quali ferrovie, autostrade, aeroporti, ma anche le prestazioni sanitarie, il numero dei medici nelle università, le assunzioni, la stessa ammissibilità dei farmaci!
Il passaggio del personale, che in alcuni casi copre tutta la spesa, tira in ballo anche questioni contrattuali. Mentre l’assunzione in altra regione dovrà essere consentita.
Leggi tutto
Moreno Pasquinelli: Le emigrazioni e il dilemma etico-politico
Le emigrazioni e il dilemma etico-politico
di Moreno Pasquinelli
 Catto-comunismo o comunismo
d’accatto?
Catto-comunismo o comunismo
d’accatto?
Parafrasando Carl Schmitt sovrano è chi decide l’ordine del giorno. E’ sotto gli occhi di tutti come l’élite neoliberista, forte della sua formidabile potenza di fuoco mediatica, sia riuscita a fare del fenomeno emigratorio la questione fondamentale dell’agenda politica.
Una colossale operazione ideologica di distrazione di massa. Tutti hanno abboccato, sinistre comprese, le quali hanno anzi deciso di occupare la prima linea del fronte immigrazionista, pur restando, lo Stato maggiore, ben saldo nelle mani dei dominanti. Sarebbe sbagliato pensare che questo obbligare la pubblica opinione a considerare l’immigrazione come questione delle questioni sia solo strumentale all’evidente obbiettivo di rovesciare il governo giallo-verde. Dietro c’è molto di più, c’è una visione del mondo, la necessità di imporla come destino.
Infatti, sul fenomeno emigratorio, l’élite dominante vorrebbe tracciare la linea che divide il bene dal male, lo spartiacque tra buoni e cattivi. Cattivo è chiunque non accetti come sacro il principio morale della cosiddetta “accoglienza”, dalla parte del male starebbe chiunque respinga come eticamente superiore l’ordine cosmopolitico fondato sul melting pot multietnico. Ancora una volta ricorrendo a Schmitt siamo in presenza di “concetti teologici secolarizzati”. Rovesciare l’ordine del giorno dei dominanti dovrebbe essere il primo atto politico di chi si considera antagonista, e non solo per evitare di essere ad essi funzionali.
Come mai questo non avviene? Non è solo per insipienza tattica, accade perché gli stessi “antagonisti” hanno introiettato e fatta propria sia la visione teologica dell’élite — compresi i suoi esorcismi per combattere e circoscrivere il “male” e non esserne contaminati — solo camuffandola con la maschera di quello che un tempo sarebbe stato chiamato “catto-comunismo” o meglio comunismo d’accatto.
Leggi tutto
André Chamy: Gli USA: uno Stato-canaglia al servizio della propria economia
Gli USA: uno Stato-canaglia al servizio della propria economia
di André Chamy*
 Improvvisamente, la classe
possidente francese diventa consapevole dell’uso economico che
gli Stati Uniti fanno del
sistema giudiziario. Dal 1993 il Dipartimento per il Commercio
ha creato un Trade Promotion Coordinating Committee e
un Advocy Center,
direttamente collegato alle agenzie d’intelligence. Più di
recente, il Dipartimento di Giustizia ha interpretato le leggi
statunitensi in
modo da estendere il proprio potere all’estero ed esercitarlo,
insieme alle altre amministrazioni, nell’interesse delle
grandi aziende
USA. Di fatto, i processi intentati contro le imprese europee
non sono in relazione con le violazioni di cui vengono
accusate. Sono processi concepiti
per portarle al fallimento o consentirne l’acquisizione da
parte di società USA
Improvvisamente, la classe
possidente francese diventa consapevole dell’uso economico che
gli Stati Uniti fanno del
sistema giudiziario. Dal 1993 il Dipartimento per il Commercio
ha creato un Trade Promotion Coordinating Committee e
un Advocy Center,
direttamente collegato alle agenzie d’intelligence. Più di
recente, il Dipartimento di Giustizia ha interpretato le leggi
statunitensi in
modo da estendere il proprio potere all’estero ed esercitarlo,
insieme alle altre amministrazioni, nell’interesse delle
grandi aziende
USA. Di fatto, i processi intentati contro le imprese europee
non sono in relazione con le violazioni di cui vengono
accusate. Sono processi concepiti
per portarle al fallimento o consentirne l’acquisizione da
parte di società USA
In pochi mesi, Frédéric Pierucci è passato brutalmente dallo status di presidente della filiale “calderone” di Alstom a quello di detenuto sottoposto alle drastiche condizioni della vita carceraria statunitense…
Ecco riassunto in poche parole il percorso di un dirigente francese in balìa della giustizia USA… Il caso Pierucci consente di fare diverse considerazioni sul piano economico e strategico.
In un libro-testimonianza, intitolato Le piège américain. Otage de la plus grande entreprise de déstabilisation (La trappola americana. Ostaggio della più grande impresa di destabilizzazione), un ex dirigente Alstom svela i retroscena dell’acquisizione del gruppo francese da parte della statunitense General Electric (GE) [1].
Pierucci, un «fantoccio nelle mani della giustizia americana», fu «vittima della strategia» del PDG Patrick Kron. La storia personale di Pierucci illustra la guerra economica degli Stati Uniti contro l’Europa, finalizzata a impadronirsi dei pezzi da novanta dell’industria del Vecchio Continente, usando la giustizia come leva per piegare le imprese, ricorrendo sia a restrizioni fisiche, quali sono le reclusioni abusive, sia a costrizioni finanziarie, usando l’espediente di ammende esorbitanti che farebbero cadere interi Paesi.
Leggi tutto
di Marta Fana e Simone Fana
Per il blocco neoliberista il principale problema del Reddito di cittadinanza è di essere troppo generoso rispetto alle retribuzioni italiane. Emerge allora il vero oggetto dello scontro: continuare a svalutare il lavoro
 Da mesi si parla dei
due cavalli di battaglia
dell’ultima legge di stabilità: quota 100 e Reddito di
cittadinanza. L’audizione alla Commissione Lavoro del Senato
sul decreto
legge 4/2019 che li introduce si è dimostrata la sede
privilegiata in cui vengono scoperte le carte delle parti
sociali chiamate a esprimersi.
È stato in quel momento infatti che i veri nodi politici sono
venuti al pettine: il problema principale del Reddito di
cittadinanza è di
essere troppo generoso rispetto ai salari italiani: la
distanza tra i due è minima e questo comporterebbe che i
lavoratori potrebbero
rinunciare ai magri salari preferendo il sussidio.
Da mesi si parla dei
due cavalli di battaglia
dell’ultima legge di stabilità: quota 100 e Reddito di
cittadinanza. L’audizione alla Commissione Lavoro del Senato
sul decreto
legge 4/2019 che li introduce si è dimostrata la sede
privilegiata in cui vengono scoperte le carte delle parti
sociali chiamate a esprimersi.
È stato in quel momento infatti che i veri nodi politici sono
venuti al pettine: il problema principale del Reddito di
cittadinanza è di
essere troppo generoso rispetto ai salari italiani: la
distanza tra i due è minima e questo comporterebbe che i
lavoratori potrebbero
rinunciare ai magri salari preferendo il sussidio.
In particolare, Tito Boeri, presidente (in scadenza) dell’Inps, spiega che «secondo i dati Inps, quasi il 45% dei dipendenti privati nel Mezzogiorno ha redditi da lavoro netti inferiori a quelli garantiti dal Reddito di cittadinanza» e che pur considerando il 50% dei trasferimenti meno generosi questi rimangono più alti «dei redditi da lavoro del 10% più basso della distribuzione dei redditi da lavoro». Sulla stessa barricata si trova Confindustria, preoccupatissima della potenziale riduzione dell’offerta di lavoro da parte dei poveri disgraziati, accusa il «livello troppo elevato del beneficio economico. I 780 euro mensili che percepirebbe un single, privo di altro reddito dichiarato, potrebbero scoraggiarlo dal cercare un impiego, considerando che in Italia lo stipendio mediano dei giovani under 30, al primo impiego, si attesta sugli 830 euro netti al mese: 910 al Nord (820 per i non laureati) e 740 al Sud (700 per i non laureati)».
La critica, avanzata dal blocco liberista italiano, che si estende al Pd e a Carlo Calenda, è nei fatti infondata dal momento che il Reddito di cittadinanza obbliga i lavoratori ad accettare una delle prime tre offerte di lavoro a prescindere dalla retribuzione, pena la decadenza del diritto al sussidio. Tuttavia, la psicosi provocata dal decreto mette in chiaro quello che fin qui in molti non avevano voluto vedere: l’oggetto dello scontro in atto non è il reddito in sé, ma il diritto del padronato italiano a perseverare nella svalutazione del lavoro e dei salari. Bassi sono e bassi devono restare altrimenti addio competitività.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Per i 5 Stelle un minuto a mezzanotte
Per i 5 Stelle un minuto a mezzanotte
di Fulvio Grimaldi
Foibe, TAV, migranti,vaccini, scienza, Italia in frantumi, Venezuela ... Negazionisti alla colonna infame!
 Negazionisti brutti,
affermazionisti belli
Negazionisti brutti,
affermazionisti belli
Viaggiamo nei paradossi. A ogni negazionista corrispondono inevitabilmente uno o più affermazionisti. A loro volta questi, a dispetto loro, risultano negazionisti riguardo a quanto affermano i negazionisti, divenuti a loro volta affermazionisti. Ma lo Zeitgeist imperante fa sì che agli affermazionisti che si confrontano con i negazionisti vengono attribuiti a priori la ragione, il vero e il giusto, così come vengono assicurati consenso e buona ragione ai negazionisti delle affermazioni dei negazionisti. E’ tutto questione di prospettive. Ma di una cosa possiamo tutti essere certi: che dei negazionisti gli affermazionisti hanno una paura fottuta. La caccia alle streghe negazioniste si spiega solo con il terrore che degli affermazionisti si possa scoprire cose gravissime. Ricordate che cosa succedeva a certi nostri temerari antenati che, con ancora granelli di libertà classica nelle vene, mettevano in discussione, che so, la transustanziazione dal corpo di Cristo nell’ostia, o, al Concilio di Nicea I, che padre e figlio fossero della stessa sostanza, in senso aristotelico, o non piuttosto due distinti esseri divini? Anche lì la paura dei dogmatici in fieri si estrinsecava in “eretici” bruciati o sepolti vivi da imperatori cristiani o vescovi. Oggi al negazionista, in sempre più paesi, ci si limita col carcere. Cosa si teme?
Giornata del ricordo…strabico
Confusione? Passiamo a un esempio, uno di tendenza: le foibe. Chi nega che in quei buchi sul Carso siano stati gettati, solo dai feroci partigiani titini, solo innocenti cittadini, solo perchè italiani e, magari, non comunisti, è un negazionista messo alla gogna dall’affermazionista che invece sancisce quella narrativa e, inesorabilmente diventa a sua volta negazionista della versione affermata dalla controparte. La quale versione potrebbe, per modo di dire, essere fondata su documenti che, grazie alla ricerche di storiche eminenti come Claudia Cernigoi e Alessandra Kersevan, mai contraddette e non contraddicibili perché documentate, che nelle foibe finirono per primi sloveni e croati rastrellati dai fascisti nelle loro terre.
Leggi tutto
Silvia Calamandrei: Il potere nasce dalla canna del fucile? Tra Resistenza e Costituzione
Il potere nasce dalla canna del fucile? Tra Resistenza e Costituzione
di Silvia Calamandrei
 Il libro di
Giuseppe Filippetta (L’estate
che imparammo a sparare. Storia partigiana della
Costituzione, Milano, Feltrinelli, 2018) già dal
titolo, che riprende un’espressione dello scrittore e
partigiano Marcello Venturi1,
e dal
sottotitolo, ci preannuncia un’interpretazione controcorrente
della genesi della nostra carta costituzionale, posta nel
segno della
discontinuità come frutto di un’esperienza di sovranità dal
basso, individuale, esercitata nelle bande partigiane.
Il libro di
Giuseppe Filippetta (L’estate
che imparammo a sparare. Storia partigiana della
Costituzione, Milano, Feltrinelli, 2018) già dal
titolo, che riprende un’espressione dello scrittore e
partigiano Marcello Venturi1,
e dal
sottotitolo, ci preannuncia un’interpretazione controcorrente
della genesi della nostra carta costituzionale, posta nel
segno della
discontinuità come frutto di un’esperienza di sovranità dal
basso, individuale, esercitata nelle bande partigiane.
Rovesciando in positivo l’entrata nella “terra di nessuno” che segue l’8 settembre, quel precipitare in uno stato hobbesiano dell’homo homini lupus a cui tanti, rifacendosi al catastrofismo del sattiano De profundis, hanno fatto risalire la “morte della patria”, l’autore ne sottolinea invece il potenziale di innesco di una ripresa di sovranità dal basso, nella scelta individuale della lotta armata partigiana. Come testi di riferimento e chiavi interpretative ha Una guerra civile di Claudio Pavone e la Resistenza perfetta di Giovanni De Luna, e scrive un saggio “post-revisionista” in cui profonde la sua cultura di giurista, per smarcarsi dall’interpretazione “continuista” che tanti giuristi hanno dato della Costituzione repubblicana, a partire da Costantino Mortati.
Per meglio valutare la novità dell’approccio e il target polemico la chiave si trova nel capitolo finale, «La sovranità dimenticata», dove, dopo aver confutato il saggio Rivoluzione e diritto di Santi Romano (settembre 1944), si stigmatizza il “catastrofismo giuridico” dei vari Satta, Capograssi e Carnelutti. Secondo Filippetta la maggioranza dei giuristi italiani vive l’8 settembre come una sorta di Tsimtsum cabalistico nel quale lo Stato si ritrae e la scena della sovranità è occupata da una moltitudine di singolarità individuali, non legittimate ad agire da sovrani. Santi Romano nega la capacità di ordinamento della Resistenza, pur cogliendone la portata rivoluzionaria. Secondo quanto scrive, «il ritrarsi dello Stato ha lasciato posto alla violenza di una moltitudine di individui che si vogliono sovrani, ma che non sono in grado di produrre un ordine e che agiscono in nome di una giustizia che in realtà non conoscono».
Leggi tutto
coniarerivolta: La pericolosa deriva dei sindacati confederali: negano il conflitto e sposano il liberismo
La pericolosa deriva dei sindacati confederali: negano il conflitto e sposano il liberismo
di coniarerivolta
 Nel 1927 il Gran Consiglio del
Fascismo deliberava la ‘Carta del Lavoro’, il documento
simbolo della nascita
dello stato corporativo e dell’indirizzo di politica economica
che il regime avrebbe condotto di lì in avanti, almeno fino
allo scoppio
del secondo conflitto mondiale. Un indirizzo politico volto
all’esplicita negazione del conflitto di classe
e, di conseguenza,
alla completa sottomissione dei lavoratori agli
interessi padronali. Espressioni quali
“collaborazione tra le forze
produttive”, “solidarietà tra i vari fattori della
produzione”, “uguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori”,
rinvenibili nell’articolato della Carta del Lavoro, trovarono
la loro compiuta sintesi nel riconoscimento, da parte del
fascismo,
dell’organizzazione privata della produzione come “funzione di
interesse nazionale” e dell’iniziativa economica privata come
motore dell’economia. Una perfetta espressione della visione
liberista (con i dovuti e gli opportuni distinguo – si pensi,
ad esempio,
alla coniugazione del lavoro, presente nella Carta fascista,
come “dovere sociale”, in contrapposizione all’ideale liberale
del
lavoro come “diritto”), che prevede il superamento della lotta
di classe in nome di un “armonico” asservimento del lavoro al
capitale, ai fini dello “sviluppo della potenza nazionale”.
Nel 1927 il Gran Consiglio del
Fascismo deliberava la ‘Carta del Lavoro’, il documento
simbolo della nascita
dello stato corporativo e dell’indirizzo di politica economica
che il regime avrebbe condotto di lì in avanti, almeno fino
allo scoppio
del secondo conflitto mondiale. Un indirizzo politico volto
all’esplicita negazione del conflitto di classe
e, di conseguenza,
alla completa sottomissione dei lavoratori agli
interessi padronali. Espressioni quali
“collaborazione tra le forze
produttive”, “solidarietà tra i vari fattori della
produzione”, “uguaglianza tra datori di lavoro e lavoratori”,
rinvenibili nell’articolato della Carta del Lavoro, trovarono
la loro compiuta sintesi nel riconoscimento, da parte del
fascismo,
dell’organizzazione privata della produzione come “funzione di
interesse nazionale” e dell’iniziativa economica privata come
motore dell’economia. Una perfetta espressione della visione
liberista (con i dovuti e gli opportuni distinguo – si pensi,
ad esempio,
alla coniugazione del lavoro, presente nella Carta fascista,
come “dovere sociale”, in contrapposizione all’ideale liberale
del
lavoro come “diritto”), che prevede il superamento della lotta
di classe in nome di un “armonico” asservimento del lavoro al
capitale, ai fini dello “sviluppo della potenza nazionale”.
La caduta del regime fascista non ha comportato, come ben sappiamo, la morte dell’ideale liberal-corporativista di unità tra le forze produttive. Esso appare infatti rintracciabile negli indirizzi di politica economica promossi dai governi italiani dal secondo dopoguerra in poi. Neanche l’alternanza tra governi di centro-sinistra e centro-destra degli ultimi decenni ha minimamente scalfito questa visione. Senza addentrarci in una complessa disamina storica, venendo ai giorni nostri, si può ritenere che quel concetto, pur rimanendo immutato nella sostanza, abbia fatto registrare dei cambiamenti nelle modalità tramite le quali esso viene declinato nel discorso pubblico.
Leggi tutto
Il Pedante: Il silenzio dei senzienti
Il silenzio dei senzienti
di Il Pedante
 Ricevo e
pubblico con gratitudine un contributo
sottoscritto da numerose associazioni per la libertà di
scelta sanitaria. Il documento, scaricabile
qui nella versione completa di allegati e
approfondimenti, contiene il lavoro svolto dalle
associazioni in preparazione delle loro audizioni
presso la Commissione igiene e sanità del Senato della
Repubblica, nell'ambito della discussione sul disegno di
legge n. 770 in materia di
vaccinazioni.
Ricevo e
pubblico con gratitudine un contributo
sottoscritto da numerose associazioni per la libertà di
scelta sanitaria. Il documento, scaricabile
qui nella versione completa di allegati e
approfondimenti, contiene il lavoro svolto dalle
associazioni in preparazione delle loro audizioni
presso la Commissione igiene e sanità del Senato della
Repubblica, nell'ambito della discussione sul disegno di
legge n. 770 in materia di
vaccinazioni.
Quelle audizioni non hanno avuto luogo né mai lo avranno, nonostante le pubbliche rassicurazioni del presidente di Commissione. Qualcuno ha infatti stabilito che il testo dovrà tradursi in legge nel più breve tempo possibile. Chi ha dettato questa accelerazione? Chi ha deciso di escludere le associazioni? E perché? Non si sa né, come già in passato, ci si degnerà di spiegarlo. La vicenda, ostinatamente derubricata dai più intelligenti, da quelli che badano alle cose serie, all'ordinaria amministrazione di cose tecniche e grige da lasciare al grigiore dei tecnici, continua a svolgersi in un silenzio equivoco da segreto di Stato e sotto l'assedio del mainstream anglosassone, scientifico e non, mentre persino il vicepremier e ministro degli Interni deve suggerire in pubblico la propria impotenza malgrado gli impegni presi con gli elettori. Sembra che nessuno possa affrontare il tema senza fulminarsi: una dinamica tipica, ci spiegano gli intelligenti, delle cose di poca importanza.
Sul disegno di legge in parola ho già speso molte pagine su questo blog (qui e qui, inter alia). Nel testo che segue se ne affrontano le criticità in modo più sistematico, nell'ambito di una battaglia ferma ed equilibrata per affermare il diritto del popolo italiano di autodeterminarsi secondo Costituzione, attraverso il voto e le altre forme di partecipazione previste dalla Carta. La ripetuta violazione di questo diritto, con questa ennesima promessa mancata, dovrebbe aprire gli occhi di tutti su un metodo che, già da solo, lascia intuire l'abnormità del merito in gioco.
Leggi tutto
Maurizia Russo Spena, Vincenzo Carbone: La società dei performanti
La società dei performanti
di Maurizia Russo Spena, Vincenzo Carbone
 Interroghiamo oggi, in questa
sede, il libro di Roberto Ciccarelli
Capitale
disumano. La vita in alternanza scuola lavoro (Manifestolibri,
2018), che è meraviglioso soprattutto nella sua sezione più
filosofico-politica (dove vi è un recupero ed una
riappropriazione della nozione di forza lavoro intesa come
produttrice di legame sociale e
valori), a partire dall’osservazione di alcune categorie
rilette sulla base delle nostre esperienze professionali di
ricercatori in ambito
socio-educativo e di genitori di figli che subiscono
costantemente le ingiunzioni performative della «scuola delle
competenze».
Interpelleremo del testo, pertanto, la parte più empirica
delle transizioni intese come misura di politica attiva
dell’alternanza scuola
lavoro (ASL), che definiremmo piuttosto come intreccio non
lineare tra formazioni e lavori, e, dunque, non l’analisi
delle transizioni quale
paradigma che concerne l’intero corso di vita.
Interroghiamo oggi, in questa
sede, il libro di Roberto Ciccarelli
Capitale
disumano. La vita in alternanza scuola lavoro (Manifestolibri,
2018), che è meraviglioso soprattutto nella sua sezione più
filosofico-politica (dove vi è un recupero ed una
riappropriazione della nozione di forza lavoro intesa come
produttrice di legame sociale e
valori), a partire dall’osservazione di alcune categorie
rilette sulla base delle nostre esperienze professionali di
ricercatori in ambito
socio-educativo e di genitori di figli che subiscono
costantemente le ingiunzioni performative della «scuola delle
competenze».
Interpelleremo del testo, pertanto, la parte più empirica
delle transizioni intese come misura di politica attiva
dell’alternanza scuola
lavoro (ASL), che definiremmo piuttosto come intreccio non
lineare tra formazioni e lavori, e, dunque, non l’analisi
delle transizioni quale
paradigma che concerne l’intero corso di vita.
Ci soffermeremo, in particolare, sulla violenza delle retoriche delle competenze, del loro carattere performativo, delle conseguenze che producono sulla vita dei soggetti in carne ed ossa, soprattutto a partire dal mondo della scuola. La costruzione di questa narrazione, secondo la quale gli studenti all’interno del principio della formazione continua, degli apprendimenti ricorsivi e della certificazione delle capacità (sapere, fare, dover-essere, imparare ad apprendere), devono essere i promotori del proprio capitale umano, è avvenuta in un quarto di secolo, a livello nazionale, ma anche sul piano internazionale ed europeo.
1. La nozione di competenza/e va aggredita non solamente in quanto dispositivo di controllo, valutazione ed asservimento, ma soprattutto perché le logiche e le metriche (adottate verso «comportamenti oggettivabili») ad essa sottese costituiscono e delimitano l’unico orizzonte di pensabilità del soggetto neoliberale.
Leggi tutto
coniarerivolta: Il lavoro manca ma De Bortoli (purtroppo) c’è: se sei disoccupato la colpa è tua
Il lavoro manca ma De Bortoli (purtroppo) c’è: se sei disoccupato la colpa è tua
di coniarerivolta
 Tornano a squillare,
se mai se ne fosse sentita la mancanza, le trombe del
padronato. Il tema è sempre lo stesso: il
lavoro c’è ma i lavoratori, in particolare i giovani, lo
scanserebbero mossi da inspiegabile snobismo. Non la
drammatica carenza di
domanda di lavoro da parte delle imprese, non la più che
decennale stagnazione, ma i giovani choosy, ve li
ricorderete, che viziati e pigri preferiscono poltrire o
dedicarsi agli studi più effimeri, invece
che guadagnarsi da vivere. Sul Corriere della Sera, la
scorsa settimana, è apparso un articolo di Ferruccio De
Bortoli (personaggio ha già fatto capolino sulle nostre onde, e
non certo per prendersi applausi) con l’eloquente titolo
“Il lavoro c’è. Ma ci interessa?”
L’articolo è particolarmente interessante perché
condensa in modo sintetico e
significativo la visione dominante sul funzionamento
del mercato del lavoro e sulle cause della disoccupazione.
L’argomentazione è chiara: di lavoro non ne manca,
sono i lavoratori che non hanno voglia di lavorare.
Tornano a squillare,
se mai se ne fosse sentita la mancanza, le trombe del
padronato. Il tema è sempre lo stesso: il
lavoro c’è ma i lavoratori, in particolare i giovani, lo
scanserebbero mossi da inspiegabile snobismo. Non la
drammatica carenza di
domanda di lavoro da parte delle imprese, non la più che
decennale stagnazione, ma i giovani choosy, ve li
ricorderete, che viziati e pigri preferiscono poltrire o
dedicarsi agli studi più effimeri, invece
che guadagnarsi da vivere. Sul Corriere della Sera, la
scorsa settimana, è apparso un articolo di Ferruccio De
Bortoli (personaggio ha già fatto capolino sulle nostre onde, e
non certo per prendersi applausi) con l’eloquente titolo
“Il lavoro c’è. Ma ci interessa?”
L’articolo è particolarmente interessante perché
condensa in modo sintetico e
significativo la visione dominante sul funzionamento
del mercato del lavoro e sulle cause della disoccupazione.
L’argomentazione è chiara: di lavoro non ne manca,
sono i lavoratori che non hanno voglia di lavorare.
Da anni, decine di economisti di ispirazione liberista cercano di convincerci che la cronica disoccupazione europea, che in molti Paesi eccede abbondantemente il 10%, sarebbe da attribuire proprio ai disoccupati che, o non hanno le competenze adeguate a rivestire ruoli e mansioni fortemente richiesti dalle imprese, o mostrano una vera e propria inettitudine, pigrizia e mancanza di volontà ad adeguarsi al salario corrente e alla tipologia di lavori richiesti. La crisi? Il crollo degli investimenti pubblici e privati? Anni di austerità che, facendo sprofondare la domanda aggregata, hanno distrutto la capacità produttiva del Paese? Dettagli! La disoccupazione è, in buona sostanza, colpa di chi per scarsa intraprendenza, non adeguata preparazione o incomprensibile scelta, non lavora.
L’articolo di De Bortoli, nel portare avanti queste tesi, sciorina tutte le convinzioni del pensiero ortodosso in termini di occupazione. Se i lavoratori sono pigri, sarà necessario disincentivare questo loro comportamento: De Bortoli fa riferimento proprio a questa visione richiamando la ormai nota retorica contro le cosiddette politiche passive del lavoro, vale a dire, i sussidi di disoccupazione, gli ammortizzatori sociali e qualsiasi altra forma di trasferimento ai disoccupati.
Leggi tutto
Gianfranco Viesti: La secessione dei ricchi
La secessione dei ricchi
Stefano Poggi* intervista Gianfranco Viesti
 Nel silenzio e nella
sostanziale indifferenza dell’opinione pubblica nazionale,
il governo gialloverde si prepara a varare il frutto della
trattativa condotta per attivare la cosiddetta “autonomia
regionale
differenziata” per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: il
passaggio di massimo 23 competenze dallo stato alle
regioni secondo l’articolo
116 della Costituzione. Si corona così la strategia
politica della “nuova” Lega di Matteo Salvini: mantenere
il tradizionale
radicamento al nord con il tema delle autonomie regionali,
conquistando al tempo stesso nuovo consenso al centro e al
sud grazie a un inedito
nazionalismo italiano.
Nel silenzio e nella
sostanziale indifferenza dell’opinione pubblica nazionale,
il governo gialloverde si prepara a varare il frutto della
trattativa condotta per attivare la cosiddetta “autonomia
regionale
differenziata” per Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto: il
passaggio di massimo 23 competenze dallo stato alle
regioni secondo l’articolo
116 della Costituzione. Si corona così la strategia
politica della “nuova” Lega di Matteo Salvini: mantenere
il tradizionale
radicamento al nord con il tema delle autonomie regionali,
conquistando al tempo stesso nuovo consenso al centro e al
sud grazie a un inedito
nazionalismo italiano.
Ne abbiamo parlato con Gianfranco Viesti, docente di economia all’Università di Bari) che nel gennaio 2019 ha pubblicato per Laterza un e-book scaricabile gratuitamente (“Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale”) in cui denuncia gli aspetti più preoccupanti di una riforma che sconvolgerebbe l’assetto istituzionale italiano, delegando nuovi poteri e risorse a tre regioni che esprimono quasi un terzo della popolazione italiana e il 40% del Pil.
* * * *
Perché ha scelto un’espressione forte come «secessione dei ricchi» per descrivere il processo di autonomia differenziata di Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto?
Bisogna intanto premettere che le carte attualmente in discussione fra regioni e governo sono segrete. Io mi rifaccio quindi al contenuto della pre-intesa siglata dalle regioni e dal governo Gentiloni il 28 febbraio 2018. All’articolo 4 di quell’intesa si trova il punto che fa pensare a una «secessione dei ricchi»: un meccanismo finanziario che prevede che – dopo un anno di transizione – si abbandoni progressivamente il criterio della spesa storica e si inizi a riferirsi a fabbisogni standard parametrati sul gettito fiscale regionale.
Leggi tutto
Transnational Social Strike Platform: L’ordine non regna in Europa
L’ordine non regna in Europa
L’insurrezione dei gilet gialli e la sfida transnazionale
di Transnational Social Strike Platform
 L’ordine non regna in Europa. La
scena politica già occupata dagli scontri tra i governi
nazionali è ora scossa da
segnali di rivolta da Est a Ovest. Il rischio di
disintegrazione dell’UE, paventato dalle istituzioni europee
dopo la crisi greca per frenare
qualsiasi tentativo di messa in discussione delle politiche
di austerity, si è ora trasformato nella paura
concreta dei governi del
diffondersi di atti d’insubordinazione. La
sollevazione in Ungheria contro la ‘slave law’ di Orbàn, le
manifestazioni in Serbia e Albania contro la violenza del
governo, la ribellione delle donne all’ordine sociale
patriarcale, gli scioperi che
attraversano tutti i settori del lavoro, dai centri
logistici agli ospedali, dagli uffici postali alle
fabbriche, l’ingovernabile movimento dei
migranti che sfida ogni giorno i confini e il razzismo
istituzionale. Sono tutte espressioni differenti, per quanto
spesso sconnesse tra di loro, di
una crescente rivolta contro lo stato di cose presente. Il
segno del rifiuto di un sistema che, in maniere diverse e
con attori politici differenti,
mira a ottenere donne e uomini ubbidienti e sfruttabili
attraverso l’impoverimento e la precarizzazione. Se in
Europa dell’Est il
tentativo di disciplinare il malcontento sociale attraverso
l’uso di una retorica nazionalista sta dando segni di
cedimento, a Ovest
l’idea che le istituzioni neoliberali possano conservare
l’ordine sociale si sta frantumando. Che ricorrano a un
comando autoritario
o facciano appello alle possibilità del mercato, i sistemi
politici sembrano incapaci di rispondere alle pretese
avanzate dai lavoratori e dai
movimenti sociali. Con il sopraggiungere delle elezioni
europee che costringono i leader politici a cercare modi per
farsi notare, cresce
l’incertezza e il transnazionale riemerge nuovamente quale
terreno di lotta cruciale. È all’interno di questo quadro
che da
novembre, la Francia (e le sue regioni e dipartimenti
oltremare) è attraversata da ondate di proteste e scioperi
ingovernabili, diffusi e
sostenuti da manifestanti con il gilet giallo (Gilets
Jaunes).
L’ordine non regna in Europa. La
scena politica già occupata dagli scontri tra i governi
nazionali è ora scossa da
segnali di rivolta da Est a Ovest. Il rischio di
disintegrazione dell’UE, paventato dalle istituzioni europee
dopo la crisi greca per frenare
qualsiasi tentativo di messa in discussione delle politiche
di austerity, si è ora trasformato nella paura
concreta dei governi del
diffondersi di atti d’insubordinazione. La
sollevazione in Ungheria contro la ‘slave law’ di Orbàn, le
manifestazioni in Serbia e Albania contro la violenza del
governo, la ribellione delle donne all’ordine sociale
patriarcale, gli scioperi che
attraversano tutti i settori del lavoro, dai centri
logistici agli ospedali, dagli uffici postali alle
fabbriche, l’ingovernabile movimento dei
migranti che sfida ogni giorno i confini e il razzismo
istituzionale. Sono tutte espressioni differenti, per quanto
spesso sconnesse tra di loro, di
una crescente rivolta contro lo stato di cose presente. Il
segno del rifiuto di un sistema che, in maniere diverse e
con attori politici differenti,
mira a ottenere donne e uomini ubbidienti e sfruttabili
attraverso l’impoverimento e la precarizzazione. Se in
Europa dell’Est il
tentativo di disciplinare il malcontento sociale attraverso
l’uso di una retorica nazionalista sta dando segni di
cedimento, a Ovest
l’idea che le istituzioni neoliberali possano conservare
l’ordine sociale si sta frantumando. Che ricorrano a un
comando autoritario
o facciano appello alle possibilità del mercato, i sistemi
politici sembrano incapaci di rispondere alle pretese
avanzate dai lavoratori e dai
movimenti sociali. Con il sopraggiungere delle elezioni
europee che costringono i leader politici a cercare modi per
farsi notare, cresce
l’incertezza e il transnazionale riemerge nuovamente quale
terreno di lotta cruciale. È all’interno di questo quadro
che da
novembre, la Francia (e le sue regioni e dipartimenti
oltremare) è attraversata da ondate di proteste e scioperi
ingovernabili, diffusi e
sostenuti da manifestanti con il gilet giallo (Gilets
Jaunes).
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2994
Hits 2224
Hits 2134
Hits 2043
Hits 2013
Hits 1923
Hits 1908
Hits 1879
Hits 1795
Hits 1740
tonino

coniarerivolta: L’eterno ritorno dell’uguale: il golpe in Venezuela tra petrolio e resistenza
L’eterno ritorno dell’uguale: il golpe in Venezuela tra petrolio e resistenza
di coniarerivolta
 Dopo vent’anni al potere, le riforme sociali
e redistributive introdotte dai
governi di Hugo Chavez e Nicolás Maduro hanno trasformato la
società venezuelana. In due decenni il governo popolare ha
cercato, con
risultati spesso lusinghieri, di sradicare la povertà
estrema, combattere le disuguaglianze e cambiare le
istituzioni politiche per trasferire
parte del potere decisionale direttamente alle classi
popolari. Vent’anni di Chavismo hanno anche spostato
enormemente in avanti il confine di
ciò che si può pensare, di ciò a cui un paese può aspirare.
Il sottosviluppo ed il colonialismo economico non sono
necessità, sono fenomeni storicamente determinati che
possono essere combattuti ed affrontati, cercando di
costruire una società che
metta al centro delle priorità i bisogni e le necessità di
chi è sempre stato spogliato di ogni minimo potere
decisionale.
È indubbio, però, che le politiche attraverso le quali si è
cercato di raggiungere questi obiettivi abbiano implicato un
conflitto con i settori economici che hanno comandato nel
Paese per decenni: si tratta, fondamentalmente
dell’oligarchia tradizionale e delle
grandi imprese multinazionali. La maggior parte
delle analisi prodotte dai media mainstream ha presentato
l’attuale situazione in
Venezuela come il risultato ovvio e naturale delle riforme
socialiste. Non stupisce la disonestà
intellettuale e politica di chi, fin
dal primo giorno di insediamento al potere di Chavez, ha
condotto una guerra sporca – a volte a bassa intensità, a
volte direttamente con
le sembianze di un colpo di Stato – contro un Governo che
metteva a repentaglio i privilegi di stampo coloniale delle
classi dominanti.
Proprio per evitare di dare fiato ai luoghi comuni
ed alle banalità con i quali siamo bombardati
quotidianamente, riteniamo sia utile
iniziare a riflettere sulle cause profonde delle
difficoltà economiche che hanno colpito il Venezuela,
in particolare negli ultimi
anni. Come cercheremo di argomentare, uno degli aspetti
cruciali, per la sopravvivenza ed il futuro successo
dell’esperienza rivoluzionaria,
risiede nella capacità di affrontare la dipendenza dalle
esportazioni di petrolio, una dipendenza che è stata usata e
sfruttata dai
nemici (nazionali ed internazionali) delle trasformazioni
economiche e sociali portate avanti da Chavez e Maduro.
Dopo vent’anni al potere, le riforme sociali
e redistributive introdotte dai
governi di Hugo Chavez e Nicolás Maduro hanno trasformato la
società venezuelana. In due decenni il governo popolare ha
cercato, con
risultati spesso lusinghieri, di sradicare la povertà
estrema, combattere le disuguaglianze e cambiare le
istituzioni politiche per trasferire
parte del potere decisionale direttamente alle classi
popolari. Vent’anni di Chavismo hanno anche spostato
enormemente in avanti il confine di
ciò che si può pensare, di ciò a cui un paese può aspirare.
Il sottosviluppo ed il colonialismo economico non sono
necessità, sono fenomeni storicamente determinati che
possono essere combattuti ed affrontati, cercando di
costruire una società che
metta al centro delle priorità i bisogni e le necessità di
chi è sempre stato spogliato di ogni minimo potere
decisionale.
È indubbio, però, che le politiche attraverso le quali si è
cercato di raggiungere questi obiettivi abbiano implicato un
conflitto con i settori economici che hanno comandato nel
Paese per decenni: si tratta, fondamentalmente
dell’oligarchia tradizionale e delle
grandi imprese multinazionali. La maggior parte
delle analisi prodotte dai media mainstream ha presentato
l’attuale situazione in
Venezuela come il risultato ovvio e naturale delle riforme
socialiste. Non stupisce la disonestà
intellettuale e politica di chi, fin
dal primo giorno di insediamento al potere di Chavez, ha
condotto una guerra sporca – a volte a bassa intensità, a
volte direttamente con
le sembianze di un colpo di Stato – contro un Governo che
metteva a repentaglio i privilegi di stampo coloniale delle
classi dominanti.
Proprio per evitare di dare fiato ai luoghi comuni
ed alle banalità con i quali siamo bombardati
quotidianamente, riteniamo sia utile
iniziare a riflettere sulle cause profonde delle
difficoltà economiche che hanno colpito il Venezuela,
in particolare negli ultimi
anni. Come cercheremo di argomentare, uno degli aspetti
cruciali, per la sopravvivenza ed il futuro successo
dell’esperienza rivoluzionaria,
risiede nella capacità di affrontare la dipendenza dalle
esportazioni di petrolio, una dipendenza che è stata usata e
sfruttata dai
nemici (nazionali ed internazionali) delle trasformazioni
economiche e sociali portate avanti da Chavez e Maduro.
Leggi tutto
Ernst Lohoff: Terrore del lavoro e critica del lavoro
Terrore del lavoro e critica del lavoro
La tolleranza repressiva e i suoi limiti
di Ernst Lohoff
 La moderna società occidentale ha
preso l'abitudine di autocelebrarsi in quanto asilo di
tolleranza e di
libertà; per quel che riguarda il soggetto moderno del
mercato, dichiara con soddisfazione di non avere tabù. A ben
guardare, tuttavia,
la sua pretesa assenza di pregiudizi si rivela una mera forma
di indolenza, e come il risultato di un adattamento mimetico
alla situazione di
amministrazione fiduciaria che la società di mercato esige.
Questo condiziona i suoi membri ad accettare il fatto che, in
ultima analisi, le
decisioni relative al contenuto della ricchezza sociale e lo
sviluppo delle relazioni sociali non si basano su degli
accordi coscienti, ma su
un'istanza anonima, in questo caso il mercato . Che si tratti
di senape o di detersivo, di preferenze sessuali o di opinioni
politiche, tutto quello
che può essere messo sul mercato è giusto, e tutto quello che
si rivela invendibile è sbagliato. Il moderno soggetto delle
merci
vive la propria vita senza riserve e pregiudizi solo a partire
dal fatto che ha dovuto interiorizzare l'idea secondo la quale
il mercato è
l'unica istanza legittima di riconoscimento, che ritraduce
sempre le relazioni sociali in relazioni di domanda e offerta.
L'identità fra
tolleranza regnante e sottomissione incondizionata al potere
della merce e de mercato. non gli conferisce tuttavia solo le
caratteristiche di
ciò che Herbert Marcuse ha definito «tolleranza
repressiva». Questa connessione interna
determina allo
stesso tempo sia i suoi limiti che il punto in cui le cose si
invertono, il punto in cui l'abbrutimento di un soggetto del
mercato, capace di digerire
tutto, lascia il posto al puro odio. In una società dove il
fatto di essere vendibili è il criterio che decide tutto,
opporle un
criterio di principio è una cosa inaccettabile ed asociale:
significa rifiutare di rischiare la propria pelle, e mancare
di disciplina per
quanto riguarda il conformare sé stessi alla merce.
La moderna società occidentale ha
preso l'abitudine di autocelebrarsi in quanto asilo di
tolleranza e di
libertà; per quel che riguarda il soggetto moderno del
mercato, dichiara con soddisfazione di non avere tabù. A ben
guardare, tuttavia,
la sua pretesa assenza di pregiudizi si rivela una mera forma
di indolenza, e come il risultato di un adattamento mimetico
alla situazione di
amministrazione fiduciaria che la società di mercato esige.
Questo condiziona i suoi membri ad accettare il fatto che, in
ultima analisi, le
decisioni relative al contenuto della ricchezza sociale e lo
sviluppo delle relazioni sociali non si basano su degli
accordi coscienti, ma su
un'istanza anonima, in questo caso il mercato . Che si tratti
di senape o di detersivo, di preferenze sessuali o di opinioni
politiche, tutto quello
che può essere messo sul mercato è giusto, e tutto quello che
si rivela invendibile è sbagliato. Il moderno soggetto delle
merci
vive la propria vita senza riserve e pregiudizi solo a partire
dal fatto che ha dovuto interiorizzare l'idea secondo la quale
il mercato è
l'unica istanza legittima di riconoscimento, che ritraduce
sempre le relazioni sociali in relazioni di domanda e offerta.
L'identità fra
tolleranza regnante e sottomissione incondizionata al potere
della merce e de mercato. non gli conferisce tuttavia solo le
caratteristiche di
ciò che Herbert Marcuse ha definito «tolleranza
repressiva». Questa connessione interna
determina allo
stesso tempo sia i suoi limiti che il punto in cui le cose si
invertono, il punto in cui l'abbrutimento di un soggetto del
mercato, capace di digerire
tutto, lascia il posto al puro odio. In una società dove il
fatto di essere vendibili è il criterio che decide tutto,
opporle un
criterio di principio è una cosa inaccettabile ed asociale:
significa rifiutare di rischiare la propria pelle, e mancare
di disciplina per
quanto riguarda il conformare sé stessi alla merce.
Leggi tutto
Eric Toussaint: La testimonianza di Yanis Varoufakis che lo condanna
La testimonianza di Yanis Varoufakis che lo condanna
I negoziati segreti e le speranze deluse
di Eric Toussaint
Eric Toussaint, dottore in scienze politiche dell’università di Liegi e di Paris VIII e coordinatore dei lavori della “Commissione per la verità sul debito pubblico greco” creata il 4 aprile 2015 su iniziativa del Presidente del Parlamento greco e poi ben presto disciolta, ha ricostruito in una serie di articoli le vicende dei febbrili negoziati tra Bruxelles e il governo greco durante i giorni più caldi della crisi, basandosi sul libro pubblicato dall’ex ministro Varoufakis e sui suoi stessi ricordi. Qui si ricostruiscono gli accordi sulle privatizzazioni con i Cinesi e le interferenze della Germania, le speranze disilluse sull’aiuto dei russi e degli americani, e la fugace esaltazione per la coraggiosa decisione, presto rientrata, di non pagare il debito al Fmi. In particolare Toussaint sottolinea la rinuncia del governo greco a comunicare col popolo degli elettori per cercar di spiegare la situazione e ottenere il sostegno ad azioni coraggiose
 Nell’undicesimo capitolo del suo
libro, Yanis Varoufakis spiega di essere intervenuto per
portare a termine
la vendita del terzo terminal del Porto del Pireo alla
compagnia cinese Cosco, che già gestiva dal 2008 i terminal 1
e 2. Come Varoufakis
stesso riconosce, Syriza prima delle elezioni aveva promesso
che non avrebbe consentito la privatizzazione della parte
restante del porto del Pireo.
Varofakis continua: “Syriza durante la campagna dal 2008
prometteva non soltanto che avrebbe impedito il nuovo
accordo, ma che avrebbe
totalmente estromesso Cosco“. E aggiunge: “Avevo
due colleghi ministri che dovevano la loro elezione a questa
promessa“. Tuttavia Varoufakis si affretta a cercar di
concludere l’accordo di vendita a Cosco. Se ne occupa con
l’assistenza
di uno dei consulenti senior di Alexis Tsipras, Spyros Sagias,
che fino all’anno precedente era stato consulente legale della
Cosco. Nella
scelta di Sagias c’era quindi un chiaro conflitto di
interessi, cosa che Varoufakis riconosce (pag. 313). Era stato
lo stesso Sagias, peraltro,
a redigere il primo accordo con Cosco nel 2008. Sagias negli
anni ’90 era stato consigliere anche del primo ministro del
PASOK Konstantinos
Simitis, che aveva organizzato la prima grande ondata di
privatizzazioni.
Nell’undicesimo capitolo del suo
libro, Yanis Varoufakis spiega di essere intervenuto per
portare a termine
la vendita del terzo terminal del Porto del Pireo alla
compagnia cinese Cosco, che già gestiva dal 2008 i terminal 1
e 2. Come Varoufakis
stesso riconosce, Syriza prima delle elezioni aveva promesso
che non avrebbe consentito la privatizzazione della parte
restante del porto del Pireo.
Varofakis continua: “Syriza durante la campagna dal 2008
prometteva non soltanto che avrebbe impedito il nuovo
accordo, ma che avrebbe
totalmente estromesso Cosco“. E aggiunge: “Avevo
due colleghi ministri che dovevano la loro elezione a questa
promessa“. Tuttavia Varoufakis si affretta a cercar di
concludere l’accordo di vendita a Cosco. Se ne occupa con
l’assistenza
di uno dei consulenti senior di Alexis Tsipras, Spyros Sagias,
che fino all’anno precedente era stato consulente legale della
Cosco. Nella
scelta di Sagias c’era quindi un chiaro conflitto di
interessi, cosa che Varoufakis riconosce (pag. 313). Era stato
lo stesso Sagias, peraltro,
a redigere il primo accordo con Cosco nel 2008. Sagias negli
anni ’90 era stato consigliere anche del primo ministro del
PASOK Konstantinos
Simitis, che aveva organizzato la prima grande ondata di
privatizzazioni.
Leggi tutto
Gerardo Marletto: Tav, tutta una questione di metodo
Tav, tutta una questione di metodo
di Gerardo Marletto
Il dibattito sulla Torino-Lione è confuso e fuorviante. Non si tratta di essere a priori pro o contro nuovi tunnel ferroviari, ma di capire se e dove ha senso realizzare opere così rilevanti sotto il profilo economico e ambientale, facendo ordine tra obiettivi politici e valutazioni tecniche
Premetto che sono circa 25 anni che mi occupo di ricerca sui trasporti, prima in organismi privati (Censis e Confindustria) e poi all’università. Qualche anno fa ho anche studiato il tema dei trasporti transalpini, contribuendo al relativo dibattito sia in sede scientifica che in sede politica. Sono abbastanza stupito dal livello bassissimo della discussione che si sta svolgendo intorno alla recente valutazione costi-benefici della nuova ferrovia Torino-Lione. Mi permetto quindi di sottoporre all’attenzione di chi è interessato alcune considerazioni di metodo e di merito, le stesse che propongo annualmente ai miei studenti.
Partiamo dal metodo. Ai miei studenti spiego che sarebbe sempre meglio valutare non un singolo progetto, ma comparare diverse alternative d’intervento (e, tra queste, anche l’“opzione zero”, cioè il non fare nulla). Spiego anche che la comparazione è possibile solo se è esplicito l’obiettivo che si vuole raggiungere (altrimenti: rispetto a che cosa si valuta se un’alternativa è meglio di un’altra?).
Leggi tutto
Piccole Note: Germania e Usa: la guerra del North Stream 2
Germania e Usa: la guerra del North Stream 2
di Piccole Note
Assalto finale degli Stati Uniti al North Stream 2, il gasdotto sottomarino che dovrebbe portare il gas russo direttamente in Germania.
Pence e il North Stream 2
Alla Conferenza sulla sicurezza di Monaco il vice-presidente Usa Mike Pence ha affondato in maniera durissima: “Non possiamo garantire la difesa dell’Occidente se i nostri alleati dipendono dall’Oriente”. Ed ha apertamente elogiato i membri della Nato che si sono opposti al gasdotto.
Angela Merkel ha rintuzzato l’attacco, elogiando il multilateralismo, contro l’America First di Trump e chiedendo al potente alleato di riannodare il filo di un dialogo transatlantico che si sta deteriorando.
Non è la prima volta che gli Stati Uniti chiedono alla Germania di “non aprire quel gasdotto”, che vincolerebbe il Paese teutonico a Mosca in maniera per loro inaccettabile.
I neocon e l’asse Mosca – Berlino
L’asse Mosca – Berlino è da sempre avversato negli Stati Uniti. Riproponiamo a tale proposito un intervento del neocon Georges Friedman al Council on Global Affairs, uno dei più influenti think tank Usa:
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Haiti in rivolta con il Venezuela
Haiti in rivolta con il Venezuela
di ilsimplicissimus
Giungono rare e sfocate le immagini di Haiti in rivolta, perché è come se questo lembo di terra caraibica fosse ancora ai confini del mondo conosciuto, immerso in un crepuscolo perenne che viene illuminato solo dalla tragedia. Ma c’è un’altra ragione per la quale si parla pochissimo di questa sollevazione popolare che dura ormai da settimane: essa è infatti direttamente collegata al Venezuela e alle sanzioni decretate contro Caracas le quali come effetto collaterale hanno affamato il paese togliendogli il petrolio a buon mercato. Anzi si potrebbe dire che Haiti non è per nulla un danno accessorio e non voluto, una vittima del fuoco amico, ma si trova a scontare sia il fatto di avere firmato il patto Petrocaribe, sia le immense ruberie, pari a 4 miliardi di dollari operate dai due ultimi presidenti, Michel Martelly e il suo successore di fiducia, Jovenel Moise.
Questa banda di conservatori eletti a furor di dollari provenienti da Washington ha rubato tutto il denaro del fondo Petrocaribe che doveva servire per le scuole, gli ospedali i servizi e per continuare la rapina hanno riconfermato – tradendo i loro sponsor americani – gli accordi con il Venezuela per la fornitura di gas e petrolio a prezzo scontato e con pagamenti differiti nel tempo. Poi quando questo denaro sottratto alla popolazione ha inciso anche sui bilanci dello stato, è intervento l’Fmi, ossia la Cia finanziaria per imporre un aumento dei carburanti.
Leggi tutto
Risposta al Gruppo di Firenze
Risposta al Gruppo di Firenze
(Una discussione col "Gruppo di Firenze", a proposito della scuola M.B.)
Il ‘GRUPPO DI FIRENZE per la scuola del merito e della responsabilità’ ha avanzato per le scuole superiori la proposta di sostituire l’organizzazione in classi con quella, tratta dal modello finlandese, in corsi disciplinari, così che lo studente ripeta solo quei corsi di cui non abbia superato l’esame
Nella maggior parte degli interventi delle persone interpellate sulla proposta, ancor più nei resoconti giornalistici, si osserva una diffusa incapacità di scorgere che la proposta nasce dalla constatazione allarmante che molti voti insufficienti sono spinti truffaldinamente alla sufficienza soltanto perché i consigli di classe tremano di fronte alla misura draconiana di far ripetere l’anno scolastico, nasce cioè dalla preoccupazione di restituire serietà all’istruzione. La diffusa incomprensione del vero intento della proposta annuncia il pericolo che la sua attuazione possa andare nel senso opposto a quello per cui era stata avanzata, verso cioè un ulteriore svuotamento dell’istruzione pubblica – per quanto ormai sia difficile immaginare come si possa fare peggio.
Qualunque siano i vantaggi e gli svantaggi della proposta, l’intento del Gruppo di Firenze può stimolare un dibattito da cui emerga come lo sfascio della scuola attuale, che della “vecchia” scuola ha ormai spento persino il ricordo, risulti non dalla mancata o parziale realizzazione della riforma dell’autonomia, ma dal suo pieno successo.
Leggi tutto
Carla Maria Fabiani: Da Hegel a Marx: fenomenologia dello Stato moderno capitalistico
Da Hegel a Marx: fenomenologia dello Stato moderno capitalistico
di Carla Maria Fabiani*
Abstract: In Chapter 24 of the first book of Capital, Marx deals with the modern capitalist State, emphasizing the existence of complex factors which affect it. The theoretical basis of his reflection is to be found in Hegel’s Phenomenology. He points out the violent methods that the State use against workers – the eslege proletariat – and the subsumtpion of the State to capital.
 1. Definire lo Stato: prima Hegel e poi Marx
1. Definire lo Stato: prima Hegel e poi Marx
È bene soffermarsi su una definizione non marxiana del potere dello Stato, ma irrinunciabile ai fini dell’analisi che svolgerò nelle pagine successive, in merito a quanto Marx espone nel celebre capitolo su «La cosiddetta accumulazione originaria» (Marx, 2011, 787-839).
Mi riferisco alla definizione hegeliana presente nella Fenomenologia dello spirito, ancor prima che nei Lineamenti di filosofia del diritto, a proposito del potere dello Stato, come sostanza che permane di contro alla ricchezza definita invece come sostanza che si sacrifica[1]. Quei passi delineano il passaggio da una concezione premoderna dello Stato a una concezione pienamente moderna: dallo Stato teocratico/assolutistico allo Stato monarchico costituzionale, così come verrà poi più dettagliatamente configurato nei Lineamenti.
La struttura cetuale della società dell’Ançien Régime, sostenuta dalla stabilità del potere statale – l’Io voglio del sovrano assoluto –, si sacrifica allo spirito del tempo moderno, che afferma con Smith: «La ricchezza, come dice Hobbes, è potere.» (Smith, 1995, 83).
Tale sacrificio non elimina il potere dello Stato in sé; rende ambivalente la sua definizione e la sua cognizione, da parte dei soggetti agenti all’interno di quella che più tardi sarà chiamata società civile, stato esterno, sistema dell’atomistica.
Il potere statale è perciò sia la sostanza semplice (l’Io voglio), principio di spiegazione e fondamento del fare di tutti e di ciascuno (di tutti i ceti), dimensione autonoma e autosufficiente del politico (l’État c’est moi!); ma anche l’opera universale, cioè proprio il risultato effettuale del fare di tutti e di ciascuno, la dimensione propriamente economica, alla quale il politico sacrifica la sua autonomia e dalla quale riceve legittimità e sussistenza (il mondo liberale della ricchezza).
Leggi tutto
Raffaele Sciortino: I dieci anni che sconvolsero il mondo
![]()
I dieci anni che sconvolsero il mondo
Introduzione
di Raffaele Sciortino
Raffaele Sciortino: I dieci anni che sconvolsero il mondo. Crisi globale e geopolitica dei neopopulismi, Asterios, 2019
 A un libro
obiettivamente denso si addice un’introduzione la più
possibile asciutta. Il lettore non troverà qui, dunque, un
riassunto del contenuto ma qualche indicazione del quadro
nel quale questo
lavoro si inserisce, della sua articolazione, delle questioni
di fondo che punta a sollevare.
A un libro
obiettivamente denso si addice un’introduzione la più
possibile asciutta. Il lettore non troverà qui, dunque, un
riassunto del contenuto ma qualche indicazione del quadro
nel quale questo
lavoro si inserisce, della sua articolazione, delle questioni
di fondo che punta a sollevare.
Il quadro. I dieci anni che hanno scosso, se non ancora sconvolto, il mondo sono gli anni della prima crisi effettivamente globale del sistema capitalistico: scoppiata tra il 2007 e il 2008, essa ha investito a cascata i meccanismi della globalizzazione finanziaria, gli assetti geopolitici mondiali, le dinamiche soggettive delle classi sociali fin dentro un Occidente che sembrava bloccato per sempre sul mantra neoliberista. Dieci anni possono essere poca cosa a scala storica ma sono un periodo già discretamente lungo a scala generazionale, tanto più se forieri di trasformazioni significative. Poco per fare un bilancio storico ma non per tentare un primo bilancio del presente inteso come un passaggio della storia. Questo libro, allora, non è un lavoro storiografico canonico - pur basandosi su fonti rigorosamente vagliate - ma è un lavoro politico come figlio di questo decennio. Non solo perché per una sua parte rielabora, sistematizza e fornisce una cornice teorica ad articoli da me scritti in tempo reale man mano che la crisi globale e i suoi risvolti venivano a delinearsi. Ma soprattutto nel senso che è il tentativo di mettere in prospettiva questi dieci anni a partire dalla convinzione che sono in corso mutazioni importanti, per certi versi veri e propri punti di non ritorno.
La dinamica degli ultimi decenni - già esito della peculiare controrivoluzione succeduta al lungo Sessantotto e segnata dal sempre eguale dello Spettacolo mercantile lubrificato dal circuito del debito - si è rimessa in moto. E lo ha fatto, finalmente, a partire da sconquassi che originano non dalla periferia ma dal centro dell’impero del capitale, scuotendo il consenso neoliberista diffuso e il suo pilastro, il soft power statunitense, rimettendo in campo l’interventismo statale a salvataggio dei mercati, riaccendendo il conflitto inter-capitalistico, suscitando anche in Occidente reazioni sociali e politiche esterne e contrarie ai dettati dell’ortodossia liberale.
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: “Talmudisti e Nicodemisti”
“Talmudisti e Nicodemisti”
di Elisabetta Teghil
 Cominciamo con un esempio che vale
più di mille parole. Il movimento indipendentista catalano non
andrebbe
appoggiato perché non è guidato dalla classe operaia e si
dovrebbe auspicare invece la repubblica federale spagnola,
progetto in grembo
agli dei che non vedranno né figli né nipoti. Maniera
elegante, quindi, per dire no alla repubblica catalana e farsi
belli evitando di
esporsi.
Cominciamo con un esempio che vale
più di mille parole. Il movimento indipendentista catalano non
andrebbe
appoggiato perché non è guidato dalla classe operaia e si
dovrebbe auspicare invece la repubblica federale spagnola,
progetto in grembo
agli dei che non vedranno né figli né nipoti. Maniera
elegante, quindi, per dire no alla repubblica catalana e farsi
belli evitando di
esporsi.
Peccato che la borghesia sappia bene cosa fare. Gli indipendentisti catalani sono in carcere, verranno processati e condannati.
Questo è l’atteggiamento di tante persone che si autodefiniscono di sinistra, colte e inclite. È molto diffuso e si ripropone in tante occasioni. Si era già presentato con la rivoluzione castrista definita una lotta interna alla borghesia e, comunque, lontana dagli interessi della lotta di classe. Costoro sono i Talmudisti.
Tranciano giudizi su ogni tentativo di uscire da questa società o anche solo di provare a dare una risposta diversa e stigmatizzano tutto e tutti: Thomas Sankara si sarebbe spinto troppo avanti, Lula, Dilma Rousseff, Kirchner sarebbero stati troppo tiepidi e avrebbero perso il contatto con le masse… Ce n’è per tutti perché i talmudisti sono i depositari del verbo, pensano a studiare le sacre scritture, a interpretarle e a fare esegesi. E questo permette loro di non prendere mai posizione, di non schierarsi mai, ma anzi di avallare chi racconta, perché adesso siamo arrivati addirittura a questo, che la colpa del colpo di stato in Cile è delle politiche sconsiderate di Allende e che Maduro e prima di lui Chavez sono dei dittatori che, circondati da pretoriani, hanno dissanguato il paese e impoverito i venezuelani.
Ma i Talmudisti si esercitano per dare interpretazioni sempre più raffinate, e infatti alcuni ci raccontano che Chavez era ben altra cosa ma il suo pensiero è stato tradito da Maduro. Chiaramente perché Chavez è morto altrimenti chissà quale sarebbe stata la versione adatta allo scopo.
Leggi tutto
Bazaar: Blockchain: un'arma del sistema neoliberale
Blockchain: un'arma del sistema neoliberale
L'agenda digitale, ossia il panopticon neoliberale
di Bazaar
Bazaar scrive: «La tecnica non è neutrale: nasce sociopoliticamente orientata per raggiungere gli obiettivi di chi ne finanzia lo sviluppo e la diffusione». A partire da questo enunciato il nostro spiega cosa sia davvero la blockchain ed a quali interessi sia funzionale, quindi la visione del mondo che ci sia dietro. Un’indagine preziosa, costata tanta fatica e che dunque merita venga letta e diffusa
 «La Camera dei
deputati del Parlamento italiano ha approvato il
cosiddetto “decreto semplificazioni” che contiene le
definizioni legali di blockchain, o
meglio, “tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT)
e degli smart contract, con le relative linee guida.» cryptonomist.ch
«La Camera dei
deputati del Parlamento italiano ha approvato il
cosiddetto “decreto semplificazioni” che contiene le
definizioni legali di blockchain, o
meglio, “tecnologie basate su registri distribuiti” (DLT)
e degli smart contract, con le relative linee guida.» cryptonomist.ch
1. L’agenda digitale presenta sé stessa, come ogni programma di riforme sociostrutturali neoliberiste, come una forma di progresso tecnologico che semplificherà la vita dei cittadini, pardon: utenti.
Questa “agenda” è un documento programmatico che va ideologicamente inquadrato in quell’ambito di provvedimenti volti alla privatizzazione dello Stato e al controllo totalitario del lavoro e di tutte le attività e funzioni in cui l’individuo sviluppa la propria personalità; ovvero, l’agenda digitale è un’agenda politica.
Inquadriamo innanzitutto il fenomeno della digitalizzazione nell’ambito privato.
La secolare propaganda del progressismo liberale – trita e ritrita – si presenta sempre con i medesimi ideologemi:
a) Il progresso scientifico permette a tutti di vivere da borghesi benestanti (e se voi invece no – ça va sans dire – è perché non meritate).
Chi riceve il messaggio dà così per scontato che il consumo di massa non abbia a che fare con particolari scelte politiche e che, a loro volta, queste scelte abbiano a che fare con lotte tra classi o durissime dialettiche tra sezioni del medesimo ceto, tra gruppi d’interesse.
I consumi di massa possono essere ottenuti e mantenuti in almeno due modi che possono avere risvolti politici e sociali contrapposti:
(I) vengono aumentati i salari in modo che la domanda aggregata cresca (tutti i lavoratori diventano mediamente più ricchi e possono comprare beni volti a migliorare la qualità della loro vita).
Leggi tutto
Matteo Bortolon: Il dogma neoliberista dell’indipendenza della banca centrale
Il dogma neoliberista dell’indipendenza della banca centrale
di Matteo Bortolon
A fine 2017 Matteo Renzi attaccava il governatore della Banca d’Italia Visco, chiedendo di non riconfermalo. Apriti cielo. Una serie così serrata di attacchi non si era vista nemmeno in merito alle peggiori imprese dell’ex sindaco di Firenze come il Jobs Act. Precarizzare il lavoro lo si può discutere, sulla indipendenza di Bankitalia si devono fare le barricate.
Il copione si riproduce oggi che Di Maio pretende di dire la sua sulla nomina dei vertici dell’istituto e su CONSOB. La reazione rasenta il panico da emergenza democratica, in prima fila la sedicente sinistra anti-populista (Repubblica, Pd), poi a seguire Brunetta, Tria, e i vertici UE. La Lega dopo aver appoggiato Tria in Consiglio dei ministri vede Salvini che attacca pure lui Bankitalia, con toni ancora più duri. Sente l’odore del sangue.
L’indipendenza della banca centrale è un principio basato sul presupposto che le dinamiche di mercato producano da sole il massimo risultato in campo economico, e che quindi vada evitata ogni interferenza di carattere politico. Per chi, al contrario, pensa che i mercati non possano autoregolarsi e che occorra un robusto intervento statale per rimediare ai loro squilibri nessuna politica monetaria è neutrale e quindi l’indipendenza che la garantirebbe è un concetto senza senso.
Leggi tutto
Dante Barontini: La secessione dei ricchi è un modello che viene dall’alto
La secessione dei ricchi è un modello che viene dall’alto
di Dante Barontini
Un editoriale da Milano Finanza, ancora una volta, che smentisce – all’interno stesso dei media economici mainstream – la narrazione fasulla sugli “europeisti” senza se e senza ma.
Francia e Germania, per la precisione Macron e Merkel, firmando il Trattato di Aquisgrana hanno rotto il giocattolo che dicevano di voler “riformare”.
Il motore franco-tedesco batte in testa, ormai, e i sintomi sono socialmente più evidenti che non le analisi pensose proposte dagli opinion maker un tanto al chilo. Dunque le élite di Parigi e Berlino serrano le fila, concentrano ciò che resta del loro potere contando sul fatto che “l’intendenza seguirà” (gli altri paesi, non più partner ma plebe intorno al castello dei signori).
Il riflesso italico è particolarmente nauseante, e anche senza speranza. Tre regioni “avanzate”, legate a doppio filo con l’economia tedesca, si giocano la carta dell’”autonomia differenziata”, sperando così di mantenere intatto il loro ruolo di contoterzisti dipendenti.
Come per tutti i ragionamenti egoistici, è loro preclusa la grandezza. Fissati sull’ombelico dei loro ordinativi, e della loro provenienza attuale, non vedono quel che sta maturando nel mondo intorno.
La competizione globale costringe a ridisegnare il modello produttivo, le relazioni internazionali, i trattati commerciali, i livelli salariali (senza mercato interno, contando solo sulle esportazioni, non c’è futuro), la visione e i “patti sociali”.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Una tabella illuminante sul “federalismo del credito” (…e altro ancora)
Una tabella illuminante sul “federalismo del credito” (…e altro ancora)
di Giuseppe Masala
In relazione alla cosiddetta autonomia differenziata richiesta dal Lombardo-Veneto ed Emilia-Romagna sono andato a vedermi l’ultimo rapporto della Banca d’Italia sulle Economie Regionali.
Al di là del fatto che ho notato che il rapporto si sostanzia di pagine e pagine di nulla, ho trovato una tabella interessante: i tassi di interesse sul credito a breve termine alle imprese disaggregato per macro-aree territoriali.
Ciò che si nota immediatamente è che i tassi d’interesse al Nord sono quasi la metà rispetto a quelli del Sud. Chiunque abbia un minimo di conoscenze economiche, ma minime, sa bene che con un simile gap (o preferite che lo chiami spread?) sui tassi di interesse il Sud non ha alcuna possibilità di sviluppo. Alcuna speranza.
Ecco, questo concetto andrebbe ben ribadito a chi parla di Sud “mantenuto” dal Nord.
Direi che vale esattamente l’opposto in considerazione del fatto che il penalizzatissimo Sud è stato chiamato a pagare il disastro delle banche venete saltate in aria l’anno scorso con un esborso di 20 miliardi solo per Veneto Banca e per Pop. Vicenza.
Peraltro ora vanno aggiunti 1,1 miliardi stanziati da Di Maio e Salvini per ristorare obbligazionisti subordinati e azionisti delle due banche fallite.
Leggi tutto
Lorenzo Ferrazano: L’attacco chimico di Douma: manuale di propaganda di guerra
L’attacco chimico di Douma: manuale di propaganda di guerra
di Lorenzo Ferrazano
“Redazione. Arriva la notizia. Panico. Che facciamo? La diamo? Non la diamo? Ne diamo mezza? E se la diamo a notte? Intanto, mentre voi stavate a parlare di nucleare, Michele Misseri ha potato l’albero di casa, e voi ve lo siete persi”. Con queste poche parole, dopo aver rassegnato le dimissioni dalla Rai, la giornalista Elisa Anzaldo dipingeva una scena di prassi quotidiania nella redazione del più importante telegiornale nazionale. Quello esposto dalla Anzaldo è un metodo giornalistico sempre in azione, che vale per tutto, dagli scandali di corruzione alle denigrazioni degli avversari politici, dalle campagne elettorali fino alla sana e profonda propaganda di guerra. Quest’ultima in particolare si realizza non solo attraverso una cinematografica mistificazione dei fatti, ma anche nascondendo quelle dichiarazioni o persino quegli eventi che possano mettere in dubbio l’autorevolezza della menzogna di Stato.
A un anno dalla battaglia di liberazione della Ghouta orientale e dagli eventi che ne seguirono, si potrebbe raccogliere una tale quantità di mistificazioni e omissioni da redigere un moderno manuale di propaganda di guerra. Chi si occupa del conflitto siriano ricorda molto bene quei giorni. L’asse russo-siriano doveva demolire una delle più minacciose roccaforti dei terroristi, che da Ghouta – a pochi chilometri da Damasco – oltre a tenere in ostaggio la popolazione locale, lanciavano continui attacchi nelle zone più affollate della capitale.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3028
Hits 2270
Hits 2190
Hits 2064
Hits 2056
Hits 1944
Hits 1936
Hits 1925
Hits 1885
Hits 1829
tonino

Giacomo Marchetti: Atto XV: lezioni francesi
Atto XV: lezioni francesi
di Giacomo Marchetti
 La “marea gialla” ha
superato il suo terzo mese di mobilitazione permanente, ed è
il movimento politico-sociale più longevo che ha conosciuto
la storia repubblicana della Francia, eccezion fatta – ma si
trattava di una
dinamica diversa – per l’appoggio alla lotta anticoloniale
del popolo vietnamita, o le mobilitazioni “per la pace in
Algeria”.
La “marea gialla” ha
superato il suo terzo mese di mobilitazione permanente, ed è
il movimento politico-sociale più longevo che ha conosciuto
la storia repubblicana della Francia, eccezion fatta – ma si
trattava di una
dinamica diversa – per l’appoggio alla lotta anticoloniale
del popolo vietnamita, o le mobilitazioni “per la pace in
Algeria”.
Intellettuali e Potere
Macron e la sua maggioranza governativa non stanno disdegnando alcun mezzo per cercare di far cessare questo movimento, aiutati in questo da una serie di operatori dell’informazione – soprattutto televisiva – e da “intellettuali organici” al suo entourage, che hanno volentieri indossato l’elmetto nella guerra mediatica per la costruzione scientifica del nemico, stigmatizzando negativamente a tutto tondo i GJ.
I “nuovi mandarini” d’Oltralpe stanno conducendo una vera e propria battaglia culturale a favore delle élites tesa a riaffermare il proprio “etno-centrismo” di classe e la sua narrazione tossica della realtà, visto l’approfondirsi della perdita di egemonia e il riemergere di una visione del mondo in cui torna centrale il mutuo appoggio, l’azione collettiva e l’identificazione in un Peuple che, come ci ha insegnato Tano D’Amico, cambia la percezione di sé, non solo nel senso della sua raffigurazione.
Per comprendere il clima mefitico che si respira nell’Esagono, basti pensare che il Ministro dell’Interno Castaner, nella versione francese del celebre format televisivo “au tableau”, di fronte a degli alunni del set televisivo ha spiegato – legittimandolo – l’uso delle varie “armi non letali” in uso alle forze dell’ordine francesi tra cui, l’LBD, senza nascondere che si tratti di dispositivi pericolosi, mostrando i punti del corpo a cui il personale poliziesco è autorizzato a mirare!
Alla domanda degli alunni – che prevede una risposta obbligatoria da parte dell’improvvisato professore della trasmissione televisiva – su cosa succederebbe se questi dispositivi fossero soppressi, Castaner ha risposto:
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: A proposito di autonomie: La Lega chiama Radetzky, i 5 Stelle si arrendono?
A proposito di autonomie: La Lega chiama Radetzky, i 5 Stelle si arrendono?
di Fulvio Grimaldi
E’ di nuovo molto lungo, ma riguarda tutti noi, oggi più di tutto il resto. Mi aspetto reazioni dall’indispettito al feroce. Ben vengano. Musica di sottofondo per questo testo
 Ragazzi
dell’800 e del 900
Ragazzi
dell’800 e del 900
Qui si fa l'Italia o si muore
Patria o
muerte
La prima frase la disse a Nino Bixio Giuseppe Garibaldi a Calatafimi, il 15 maggio 1860, e promise alla Camicie Rosse la conquista di Roma e la fine del potere temporale del papa. La seconda fu la conclusione di Ernesto Che Guevara al più memorabile discorso mai pronunciato alle Nazioni unite, l’11 dicembre 1964. Qualcuno, oggi come oggi, giudicherà questi motti retorici, ma a me vanno bene. In questo caso, la retorica esprime il massimo di determinazione della parte più nobile di un popolo. In altri casi è demagogia nutrita di ipocrisia.
Nel caso di Garibaldi e del Che, davano voce alla volontà di masse in Europa e in altri continenti di avviare un processo che abolisse forme di dominio imposte da fuori, tiranniche e predatorie, e raggiungesse l’unità, repubblicana, laica, democratica. Volontà generata da un immaginario collettivo, nato da aspirazioni antiche, lingua, comunanza di storia, territorio, forza, progetto, sconfitte e vittorie. Tutte cose oggi, inusitatamente, stupefacentemente, dissennatamente, messe a repentaglio da una dinamica regressiva che sembra invocare gli ectoplasmi dei Gonzaga, Sforza, Medici, D’Este, Borboni, dogi.
Scrive Massimo Villone, in un’ennesima denuncia della tragedia che inconsapevoli e delinquenti stanno approntando: “Può un paese dare di matto? Si, e nessuno può imporre un trattamento sanitario obbligatorio. Il solo medico abilitato a somministrare il trattamento risolutivo è il popolo sovrano”. Quando dice “paese”, Villone chiaramente si riferisce ai suoi dirigenti e a chi, nell’ombra, li manovra perché spingano il paese verso la sega circolare. Che farà il popolo sovrano, dopo aver faticato e sofferto per comporre arti separati in organismo vivente, alla vista della sua dispersione in particelle senz’anima e senza nome? Vorrà accettare, stella o pianeta, di frantumarsi in pulviscolo cosmico?
Leggi tutto
Alessandro Somma: Momento populista e momento Polanyi
Momento populista e momento Polanyi
di Alessandro Somma
 Il momento populista
Il momento populista
Siamo immersi in un momento di forti reazioni all’invadenza dei mercati, forse mai così minacciosi per la sopravvivenza della società. I conflitti che lo caratterizzano non oppongono però fronti definiti sulla base dell’appartenenza di classe: sono scontri tra popolo e oligarchie, o eventualmente tra chi viene beneficiato dalla libera circolazione di merci e capitali e chi viene invece danneggiato dagli sconfinamenti perché prigioniero della dimensione territoriale (1). Comunque sia ci troviamo di fronte a una decisa reazione al neoliberalismo. Si è infatti definitivamente spezzato l’equilibrio tra istanze libertarie e istanze egualitarie che ha tradizionalmente accompagnato la tensione tra liberalismo politico e democrazia. E si è in sua vece radicata una supremazia delle libertà economiche sull’uguaglianza e la sovranità popolare.
A questo esito ha contribuito in modo determinante la sinistra storica, che da decenni ha assunto il neoliberalismo come orizzonte immutabile della sua azione politica: ha oramai elevato il mercato a principale strumento di redistribuzione della ricchezza e dunque concepito l’inclusione sociale come inclusione nel mercato. Peraltro anche la cosiddetta sinistra radicale ha fornito il suo contributo, avendo aiutato il neoliberalismo di prendere tempo: le istanze di riconoscimento alimentate dalla prima sono state incorporate dal secondo, che le ha anzi utilizzare per affossare le istanze di redistribuzione
Ora però il re è nudo, e non è più possibile nascondere i risvolti di un impero incontrastato dell’ortodossia neoliberale: l’avvento della postdemocrazia e della postpolitica, indispensabili a sterilizzare il conflitto sociale provocato dalla virulenza di quell’ortodossia. Di qui la reazione all’invadenza dei mercati come scontro irriducibile alla lotta di classe. Di qui il momento populista, a cui Chantal Mouffe, tra le pioniere delle riflessione su questi aspetti, ha dedicato un volume recentemente uscito in traduzione italiana (2).
Leggi tutto
Guglielmo Forges Davanzati: Euro al capolinea? Su un libro di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua
Euro al capolinea? Su un libro di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua
di Guglielmo Forges Davanzati
I numerosi tentativi di individuare le cause della crisi del 2007 e, più in particolare. della crisi dell’Unione economica e monetaria europea sono sostanzialmente riconducibili a due: la crisi è da imputare a eccessiva spesa pubblica, voluta da governi spendaccioni (soprattutto nell’Europa del Sud), che ha gonfiato il rapporto debito pubblico/Pil; la crisi – seconda interpretazione – è da ricondurre a divergenze del saldo delle partite correnti all’interno dell’Eurozona e, dunque, in ultima analisi, a eccessi di esportazioni nette generati dall’economia tedesca. Quest’ultima tesi viene invocata o per legittimare misure che facciano crescere la domanda interna in Europa o per legittimare l’abbandono della moneta unica. Il libro di Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana Mortágua, dal titolo Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea (Rosenberg and Sellier, 2019) prova a proporre un’interpretazione diversa e, va detto subito, l’esito è del tutto convincente. Così come va detto subito che non si tratta di un libro di agevole lettura. È semmai un volume che restituisce una trattazione della crisi fondata più su dubbi che su certezze e che evita ogni tipo di semplificazione.
Seguiamo il filo logico che tiene insieme i diversi tasselli della loro ricostruzione.
Leggi tutto
Dante Barontini: Il morto lasciato lì per afferrare il vivo
Il morto lasciato lì per afferrare il vivo
di Dante Barontini
Da ragazzo mi è capitato di partecipare a un corso di salvataggio in mare. Il primo consiglio dell’istruttore, a noi angelici aspiranti “soccorritori”, fu drastico: “se vi avvicinate a uno che sta affogando ed è andato in panico, prima di tutto tirategli un cazzotto per tramortirlo; poi lo afferrate saldamente da dietro e provate a tirarlo verso una barca o verso riva”.
Sgranammo gli occhi e ci spiegò: “un uomo che annega si aggrappa a qualsiasi cosa con una forza mostruosa, perché sente la morte vicina; se lo lasciate aggrapparsi a voi, vi impedirà di nuotare e vi trascinerà a fondo con lui; e invece di avere un uomo salvato avremo due morti”.
Ciò che resta della “sinistra” italiana è in posizione assai simile a colui che sta per annegare. Da anni, non da un minuto. Anni passati senza eleggere qualcuno in un posto importante, quindi con sempre meno visibilità mediatica, meno finanziamenti da utilizzare per tenere insieme l’organizzazione (va riconosciuto che in parecchi casi gli eletti versavano al proprio partito quote rilevanti dello stipendio), meno agibilità politica e meno mezzi. Dunque campagne elettorali asfittiche, viaggi col contagocce, contatto con l’elettorato sempre più difficile (se si vendono le sedi per fare cassa si perde anche quel poco di presenza sul territorio). E quindi sempre meno voti, irrilevanza politica, scoramento, defezioni, scissioni, ecc.
Leggi tutto
Whitney Webb: Wikileaks: FMI e Banca Mondiale sono usate dagli USA come armi “non convenzionali” (e Guaidò batte cassa)
Wikileaks: FMI e Banca Mondiale sono usate dagli USA come armi “non convenzionali” (e Guaidò batte cassa)
di Whitney Webb
Uno dei recenti “leaks” di Wikileaks getta luce su come istituzioni finanziarie internazionali teoricamente “indipendenti” come il FMI e la Banca Mondiale vengano utilizzate come armi di guerra non convenzionale, al servizio degli interessi imperiali americani. Sebbene a prima vista si tratti di fatti ben noti a tutti da decenni, il fatto di leggerli candidamente descritti in documenti ufficiali delle forze armate americane sortisce comunque un effetto notevole. Queste rivelazioni dovrebbero, se i media mainstream avessero ancora una qualsiasi credibilità, dissolvere una volta per tutte l’illusione che il complesso di istituzioni nate dagli accordi di Bretton Woods abbiano come missione il benessere e la stabilità economica dei paesi membri, come invariabilmente recitano i loro trattati istitutivi
In un manuale militare sulla “guerra non convenzionale” recentemente svelato da WikiLeaks si legge che, secondo l’esercito americano, le principali istituzioni finanziarie globali – come la Banca Mondiale, il Fondo monetario internazionale (FMI) e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) – sono considerate come “armi finanziarie non convenzionali da usare in conflitti che possono includere guerre generali su larga scala”, e per fare leva sulle “strategie e relazioni tra stati”.
Il documento, il cui titolo letteralmente recita “Field Manual (FM) 3-05.130, Army Special Operations Forces Unconventional Warfare”, originariamente redatto nel settembre 2008, è stato recentemente portato sotto i riflettori da WikiLeaks su Twitter in relazione ai recenti eventi in Venezuela e all’annoso assedio economico del paese guidato dagli Stati Uniti tramite sanzioni e altre modalità di guerra economica.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Pratiche per una guerra senza fine nel Sahel
![]()
Pratiche per una guerra senza fine nel Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, febbraio 019. Ad ognuno la sua parte. Voi ci mettete le armi, i ‘Mirage’, i droni e le ditte per garantire la sicurezza dei regimi e noi ci mettiamo le guerre. Così anche il Sahel gioca un ruolo non trascurabile nell’economia-mondo che tutto misura in Prodotto Interno Lordo. I gruppi armati che continuano ad aumentare, fare e disfare alleanze, occupare territori per poi svanire nel nulla, hanno raggiunto e forse superato ciò che da loro ci si attendeva. Carestie, spostamenti di popolazione, nuove armate per fronteggiare gli attacchi sempre più imprevedibili e soprattutto soldi di cui i fabricanti di armi e i grandi capi militari sono i principali beneficiari. Crescono in modo preocupante le zone a rischio e in stato di eccezione che includono il coprifuoco, l’abbandono delle motociclette per gli spostamenti e il controllo sulle attività economiche dei contadini. Dalle milizie di autodifesa tradizionali si passa a gruppi paramilitari ad appartenenza comunitaria per terminare con le operazioni di rastrellamnto delle forze regolari governative. A queste ultime si aggiungono i corpi di elite, la costituzione di nuovi eserciti congiunti e dell’immancabile presenza dei caschi blu delle Nazioni Unite. Si stima che l’Africa sia il continente nel quale viaggiano più armi nel mondo. Questo tipo di mobilità sembra essere incoraggiata: armi e mercanzie passano frontiere e le persone sono incarcerate.
Leggi tutto
Matteo Luca Andriola: Psicosi rossobruna
Psicosi rossobruna
di Matteo Luca Andriola
 Uno spettro si aggira
per l’Europa. No, non è lo spettro del comunismo, contro cui
tutte le
potenze della vecchia Europa ottocentesca si coalizzarono in
una caccia alle streghe, dallo zar al papa, da Metternich a
Guizot, come scrivevano Karl
Marx e Friederich Engels nell’incipit del Manifesto del
partito comunista (1848), ma quello del
‘rossobrunismo’. Più
volte si è accennato a tale fenomeno in queste pagine, ma il
termine ora non è usato nell’accezione qui spesso utilizzata
ma come
etichetta squalificante contro chi fa la stecca nel coro del
pensiero unico liberale, imperante dal 1989 come unica
religione civile che accomuna
tutti, da centrodestra a centrosinistra, dai progressisti ai
conservatori, uniti dal prefisso ‘liberal’:
liberalprogressista,
liberaldemocratico e liberalconservatore.
Uno spettro si aggira
per l’Europa. No, non è lo spettro del comunismo, contro cui
tutte le
potenze della vecchia Europa ottocentesca si coalizzarono in
una caccia alle streghe, dallo zar al papa, da Metternich a
Guizot, come scrivevano Karl
Marx e Friederich Engels nell’incipit del Manifesto del
partito comunista (1848), ma quello del
‘rossobrunismo’. Più
volte si è accennato a tale fenomeno in queste pagine, ma il
termine ora non è usato nell’accezione qui spesso utilizzata
ma come
etichetta squalificante contro chi fa la stecca nel coro del
pensiero unico liberale, imperante dal 1989 come unica
religione civile che accomuna
tutti, da centrodestra a centrosinistra, dai progressisti ai
conservatori, uniti dal prefisso ‘liberal’:
liberalprogressista,
liberaldemocratico e liberalconservatore.
Fino a qualche anno fa la querelle sul rossobrunismo era limitata a dossier che circolavano in rete, spesso stilati da collettivi vicini o organici alla sinistra antagonista o pubblicati in siti Internet di movimenti e partiti della sinistra. È necessario perciò, a scanso di equivoci, fare un breve excursus storico del fenomeno.
Rossobruni: una breve genealogia storica
Per anni nel recente passato si sono indicati come rossobruni quei soggetti politici e culturali che, come la nouvelle droite, disconoscendo la diade destra/sinistra, proponevano un’ideologia sincretica o la convergenza strategica e/o organica con chi era situato agli antipodi politici ma condivideva una profonda avversione per il sistema liberale.
Un precedente storico, scrive lo studioso marxista Alessandro Pascale, va ricercato nel ‘concetto di ‘nazionalbolscevico’ o ‘nazional comunista’, nato in Germania nel primo dopoguerra e usato sia da una branca dell’estrema destra rivoluzionarioconservatrice sia dai marxisti del Kapd di Amburgo, fautori entrambi di una convergenza strategica fra nazionalisti rivoluzionari e comunisti contro il ‘nuovo ordine europeo’ uscito a Versailles.
Leggi tutto
Marco Paciotti: Viandanti nel nulla
Viandanti nel nulla
di Marco Paciotti
Sul libro di Stefano G. Azzarà: Comunisti, fascisti e questione nazionale. Germania 1923: fronte rossobruno o guerra d’egemonia? [Mimesis, Milano-Udine, 2018]
 Nell’attuale
dibattito politico capita sovente di imbattersi
nell’etichetta
di “rossobrunismo”, per la quale si intende, tra chi vi
aderisce entusiasticamente e chi invece vi si richiama con
intenti più
polemici (talvolta con toni crassamente scandalistici),
un’alleanza transpolitica – oltre destra e sinistra – tra
marxisti e
nazionalisti contro il nemico comune costituito dal
capitalismo globale transnazionale, stigmatizzato variamente
quale “apolide”,
“turbomondialista”, “sradicante”, “cosmopolita” etc., nel
nome della difesa della “sovranità” e
delle piccole patrie.
Nell’attuale
dibattito politico capita sovente di imbattersi
nell’etichetta
di “rossobrunismo”, per la quale si intende, tra chi vi
aderisce entusiasticamente e chi invece vi si richiama con
intenti più
polemici (talvolta con toni crassamente scandalistici),
un’alleanza transpolitica – oltre destra e sinistra – tra
marxisti e
nazionalisti contro il nemico comune costituito dal
capitalismo globale transnazionale, stigmatizzato variamente
quale “apolide”,
“turbomondialista”, “sradicante”, “cosmopolita” etc., nel
nome della difesa della “sovranità” e
delle piccole patrie.
In un testo pubblicato lo scorso autunno presso Mimesis Stefano Azzarà, con scrupolo critico, polemizza con tale posizione, mostrandone l’inconsistenza sul piano storico-filosofico a partire dall’analisi del dibattito avvenuto nell’estate del 1923 tra alcuni esponenti della Kommunistische Partei Deutschland (tra cui spiccano le figure di Karl Radek e Paul Fröhlich) e i teorici del movimento völkisch Arthur Moeller van der Bruck[1] e Ernst Reventlow. Lo scambio, descritto dall’autore come un “dialogo tra sordi”, viene presentato in una nuova traduzione di Azzarà nella seconda parte del libro.
Esso ha origine in un intervento tenuto da Karl Radek alla seduta dell’Esecutivo allargato dell’Internazionale comunista a Mosca il 20 giugno del 1923, durante il quale il dirigente comunista evocava la figura di Leo Schlageter, “coraggioso soldato della controrivoluzione” e “martire del nazionalismo tedesco”, processato e assassinato per aver compiuto azioni di sabotaggio nella Ruhr occupata dalle truppe francesi in virtù del trattato di Versailles. Schlageter era descritto come un sincero patriota che aveva pagato con la vita per le sue idee: ma egli era un “viandante nel nulla”[2], dal momento in cui aveva aderito a un movimento egemonizzato dal capitale tedesco, il quale da un lato soffiava sulle aspirazioni indipendentiste di vasti strati delle classi popolari tedesche mentre, al contempo, non disdegnava di stringere accordi affaristici con i potentati economici francesi interessati alle materie prime dei territori occupati.
Leggi tutto
Domenico Moro: Il Trattato di Aquisgrana e la fine dell’Europa politica
![]()
Il Trattato di Aquisgrana e la fine dell’Europa politica
di Domenico Moro
 Il 6
febbraio 2019 la commissaria alla concorrenza della Ue,
Margrethe Vestager, ha bocciato
la fusione tra Alstom e Siemens nel settore ferroviario.
Immediatamente la Francia e la Germania hanno dichiarato che
avrebbero dato avvio a un
processo di revisione delle regole della concorrenza. Ben
diverso è stato l’atteggiamento dei due Stati in occasione
della fusione tra
Fincantieri e Stx France, nella cantieristica. In questo caso
la Francia, sostenuta immediatamente dalla Germania, ha
chiesto alla commissione alla
concorrenza di esaminare la fusione alla luce del regolamento
sulle concentrazioni. Si tratta di un esempio che dimostra
quanto l’Europa sia
tutt’altro che un organismo unitario. La Ue, in realtà, è un
sistema intergovernativo dove gli Stati non solo continuano ad
esistere ma agiscono, sempre di più, secondo interessi e
strategie nazionali. Al di là dei numerosi esempi in tal senso
degli ultimi
anni, specie dopo lo scoppio della crisi del debito pubblico,
il Trattato di Aquisgana, siglato a gennaio dai governi di
Francia e Germania, sancisce
definitivamente l’inesistenza dell’Europa non solo come
soggetto politico unitario, ma persino come terreno politico
di coordinamento tra
Stati.
Il 6
febbraio 2019 la commissaria alla concorrenza della Ue,
Margrethe Vestager, ha bocciato
la fusione tra Alstom e Siemens nel settore ferroviario.
Immediatamente la Francia e la Germania hanno dichiarato che
avrebbero dato avvio a un
processo di revisione delle regole della concorrenza. Ben
diverso è stato l’atteggiamento dei due Stati in occasione
della fusione tra
Fincantieri e Stx France, nella cantieristica. In questo caso
la Francia, sostenuta immediatamente dalla Germania, ha
chiesto alla commissione alla
concorrenza di esaminare la fusione alla luce del regolamento
sulle concentrazioni. Si tratta di un esempio che dimostra
quanto l’Europa sia
tutt’altro che un organismo unitario. La Ue, in realtà, è un
sistema intergovernativo dove gli Stati non solo continuano ad
esistere ma agiscono, sempre di più, secondo interessi e
strategie nazionali. Al di là dei numerosi esempi in tal senso
degli ultimi
anni, specie dopo lo scoppio della crisi del debito pubblico,
il Trattato di Aquisgana, siglato a gennaio dai governi di
Francia e Germania, sancisce
definitivamente l’inesistenza dell’Europa non solo come
soggetto politico unitario, ma persino come terreno politico
di coordinamento tra
Stati.
La scelta della città di Aquisgrana ha una forte valenza simbolica. Infatti, Aquisgrana fu la capitale dell’Impero carolingio, che unì in uno stesso organismo politico Francia e Germania. Attorno al nucleo centrale composto da questi due Paesi, l’impero di Carlo Magno riuniva gli attuali Belgio, Olanda, Austria, Italia centrosettentrionale e Catalogna, insomma quello che ora è il nocciolo duro dell’area euro. Mentre l’Europa si scopre sempre più divisa su molte tematiche, e le divergenze economiche tra i Paesi si sono allargate sempre di più, la Francia e la Germania anziché lavorare, come vorrebbe la retorica europeista, ad una maggiore integrazione europea, si focalizzano sull’integrazione franco-tedesca con obiettivi e istituzioni proprie.
Leggi tutto
Domenico Moro: Un laboratorio per ricostruire una strategia di cambiamento
Un laboratorio per ricostruire una strategia di cambiamento
di Domenico Moro
La scelta del nome Laboratorio non è casuale. Oggi c’è bisogno di innovazione dal punto di vista dei lavoratori e del socialismo, non di un nuovismo che abbracci le idee dell’avversario. Di conseguenza, c’è necessità di luoghi di analisi della realtà socio-economica e di elaborazione e sperimentazione politica.
Siamo in una fase storica nuova del modo di produzione capitalistico. Di fronte a mutamenti epocali, che per molti versi rendono di nuovo attuale il socialismo, due concetti su cui il movimento dei lavoratori si è articolato per oltre un secolo, quello di sinistra e quello di comunismo, appaiono logori, almeno all’apparenza. Il significato di sinistra è stravolto e oggi si fa fatica a distinguere i conflitti sull’asse destra/sinistra. La sinistra viene identificata sempre più, anziché con la rappresentanza delle classi subalterne, con un “progressismo” legato agli interessi delle élites. Il comunismo, con la caduta dell’Urss, è presentato come un sistema destinato al fallimento, e condannato alla damnatio memoriae grazie alla lettura faziosa della sua storia.
Alla base della crisi della sinistra in Europa c’è la rottura del patto sociale tra capitale e lavoro, che aveva reso possibile “la lotta di classe parlamentare” dal dopoguerra ai primi anni 90, e, in qualche modo, fino alla crisi del 2008-2009.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: L’arrocco franco tedesco e la svolta mediterranea
L’arrocco franco tedesco e la svolta mediterranea
di Pasquale Cicalese
Dopo il Rapporto Altmaier, di cui abbiamo dato notizia la settimana scorsa, ieri si è sancito il Trattato di Acquisgrana tra Francia e Germania sulle politiche industriali, con protagonisti i ministri Altmaier e Le Maire. Ricalca in pieno il rapporto tedesco.
Si menziona il fatto che su le prime 40 aziende mondiali solo 5 sono europee. Per questo bisogna creare colossi europei che competano sul mercato mondiale, modificando le norme sull’Antitrust europeo e quelle sugli aiuti di stato. Obiettivo è raggiungere la leadership mondiale sull’intelligenza artificiale, sulle batterie elettriche, sulla digitalizzazione applicata alla sanità, all’ambiente e al manifatturiero e sull’aerospazio.
L’accordo prevede il finanziamento pubblico di grandi progetti europei con il Piano Juncker e il “temporaneo” ingresso degli stati francesi e tedeschi nelle imprese europee. Inoltre si danno misure per bloccare acquisizioni di aziende tech europee da parte dei cinesi così come vietare l’ingresso di paesi non europei, chiaro il riferimento alla Cina, sui porti.
Quest’ultima misura fu già discussa quattro mesi fa in sede comunitaria e l’Italia la bloccò. L’obiettivo di Atmaier e Le Maire è quello di bloccare l’ingresso nei porti italiani da parte dei cinesi, quando il 20 marzo prossimo, con la visita di Xi Jinping a Roma, si discuterà degli investimenti cinesi in Italia.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Recessione? C'è del marcio in Danimarca
Recessione? C'è del marcio in Danimarca
di Leonardo Mazzei
Che c'azzeccano i cantieri? E che c'azzecca l'instabilità politica con il crollo del fatturato dell'industria?
Il dato è di quelli che non ammette troppi discorsi. A dicembre il fatturato dell'industria italiana è calato del 3,5% rispetto a novembre e del 7,3% rispetto al dicembre 2017. Eravamo dunque stati facili profeti nel pronosticare il consolidarsi di una seria tendenza recessiva.
Così scrivevamo all'inizio del mese a proposito dei dati negativi del Pil:
«E' successo che il ciclo economico capitalistico volge verso il basso. E, come avviene da anni, il calo è più marcato in Europa. All'interno della quale l'Italia paga più degli altri la gabbia dell'euro. Insomma, la verità è che siamo nella norma. Quella norma da cui non si può uscire, altrimenti i "mercati" (cioè l'oligarchia finanziaria) ci puniscono con lo spread».
Proprio perché questa fotografia è difficile da contestare, lorsignori amano parlar d'altro. La loro narrazione è semplice: si va verso la recessione perché abbiamo instabilità politica ed un governo di incapaci "blocca-cantieri".
Il problema è che questa menzogna non regge. Ed i nostri pinocchietti del "partito del pil" si auto-smentiscono ogni volta che aprono bocca.
Vediamo alcuni esempi, cominciando con il commento del presidente di Confindustria sui dati dell'Istat. Per Boccia la risposta da dare è chiara: bisogna aprire i cantieri. Quali? Tutti. Quando? Domani mattina, ma che domande! Con quali soldi non si sa, dato che il Boccia reclama investimenti pubblici ma anche rigore nei conti. Peccato che le due cose abbiano qualche difficoltà a stare insieme.
Leggi tutto
Angelo D'Orsi: M5S, cronaca di una morte annunciata
M5S, cronaca di una morte annunciata
di Angelo D'Orsi
Avevo scritto in un precedente articolo su AlgaNews che il destino dei Cinquestelle appariva segnato: erano stati sconfitti, e inglobati, in certo senso, dalla Lega modello Salvini. Si erano infilati da soli in un cul-de-sac per cui se tentavano di preservare una propria identità politica, si condannavano ad essere sconfitti e in prospettiva a non lungo termine ad essere esclusi dalla stanza dei bottoni da un alleato che era palesemente sulla cresta dell’onda; se al contrario gli si piegavano, rinunciando ad ogni tentazione identitaria, non potevano che essere fagocitati dall’alleato stesso.
Oggi, con la farsa del voto sulla “Piattaforma Rousseau” (mai nome fu oggetto di stupro come quello del ginevrino), che ha sottratto Matteo Salvini al processo per il caso Diciotti, il destino del movimento “grillino” sembra deciso. I Cinquestelle, con questo atto che appare il rovesciamento di uno delle assi portanti della propria ragione sociale, hanno realizzato una formidabile accelerazione verso il baratro. Sulla base di una volontà imperscrutabile di chi comanda nel movimento, essi confermano di essere per così dire obbligati a diventare una costola della Lega (altro che la Lega “costola della sinistra” come ebbe a dire con una boutade poco felice D’Alema: ma era peraltro la Lega Nord Padania, quella degli anni Novanta).
Leggi tutto
Gaia Bindi: EARTHBOUND – Superare l’Antropocene
EARTHBOUND – Superare l’Antropocene
Prefazione
di Gaia Bindi
Lo stato dell'arte sugli studi ecocentrici in Italia: la prefazione, scritta dalla docente universitaria Gaia Bindi, di “Earthbound – Superare l'Antropocene”, volume edito da KABUL magazine che raccoglie i testi di: Karen Barad, T. J. Demos, Donna Haraway, Bruno Latour e Jason W. Moore
“Siamo compost, non posthuman – scrive Donna Haraway – abitiamo le humus-ities, non le human-ities. […] Gli esseri – umani o no – si formano l’un l’altro, componendosi e decomponendosi a vicenda, in ogni scala e registro di tempo e cosa, in grovigli sympoietici, nel mondo terreno e non”.[1] Nel mezzo dell’attuale spirale di devastazione ecologica, il concetto di compost serve alla filosofa, zoologa e biologa statunitense per indicare nuovi modi di riconfigurare le relazioni dell’essere umano con la Terra e con i suoi abitanti. Rigettando sia la definizione di “Antropocene” – termine coniato dal premio Nobel per la chimica Paul J. Crutzen[2] – per descrivere l’attuale era geologica, sia quella di “Capitalocene” (preferita dall’economista Jason W. Moore[3] e dal critico d’arte ambientalista T. J. Demos,[4] perché più efficace nel comunicare la voracità del sistema politico-economico a danno della biosfera), la studiosa propone invece la poetica definizione di “Chthulucene”, creata dalla combinazione di due radici greche: khthôn e kainos. Il termine evidenzia la necessità di riconoscere e rinnovare costantemente le simbiosi – nell’ottica della sympoiesis, ovvero “agire insieme” – così come le forze e i poteri, “dinamici e continui, dell’insieme ctonio di cui fanno parte gli esseri umani, la cui continuità è a rischio”.[5]
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3065
Hits 2297
Hits 2244
Hits 2099
Hits 2065
Hits 2001
Hits 1945
Hits 1937
Hits 1894
Hits 1839
tonino

coniarerivolta: La lezione dei gilet gialli: l’ambientalismo non è un pranzo di gala
La lezione dei gilet gialli: l’ambientalismo non è un pranzo di gala
di coniarerivolta
 In occidente le lotte dei ‘gilet
gialli’ (gilet jaunes), il movimento nato a metà
novembre 2018 come forma
di protesta per il rincaro del prezzo della benzina voluto dal
governo di Macron, vengono continuamente e
volutamente distorte da
parte degli esponenti politici liberisti filo-europeisti e
dagli organi di stampa mainstream. Si tenta di far
passare il messaggio per cui la
ragione di fondo di tali proteste, che da subito, ben oltre la
miccia dell’innesco iniziale, hanno presentato una forte e
decisa espressione di
generale dissenso verso le politiche liberiste condotte
dall’Unione Europea, vi sia la volontà di preservare lo status
quo sul
piano ambientale e sociale; mentre chi davvero combatterebbe
per cambiare il mondo è una ragazza svedese di 16 anni, di
nome Greta
Thunberg, che tutti i venerdì mattina, da sei mesi a
questa parte, salta la scuola per scioperare di fronte al
parlamento svedese contro il
cambiamento climatico. Le proteste della ragazza, anche grazie
al vastissimo eco fornitole dalla stampa internazionale, le
hanno consentito di salire
sul palco della conferenza mondiale per il cambiamento
climatico (Cop24) tenutasi in Polonia lo scorso dicembre 2018,
e di partecipare alla grande
manifestazione del 22 febbraio a Bruxelles contro il
cambiamento climatico.
In occidente le lotte dei ‘gilet
gialli’ (gilet jaunes), il movimento nato a metà
novembre 2018 come forma
di protesta per il rincaro del prezzo della benzina voluto dal
governo di Macron, vengono continuamente e
volutamente distorte da
parte degli esponenti politici liberisti filo-europeisti e
dagli organi di stampa mainstream. Si tenta di far
passare il messaggio per cui la
ragione di fondo di tali proteste, che da subito, ben oltre la
miccia dell’innesco iniziale, hanno presentato una forte e
decisa espressione di
generale dissenso verso le politiche liberiste condotte
dall’Unione Europea, vi sia la volontà di preservare lo status
quo sul
piano ambientale e sociale; mentre chi davvero combatterebbe
per cambiare il mondo è una ragazza svedese di 16 anni, di
nome Greta
Thunberg, che tutti i venerdì mattina, da sei mesi a
questa parte, salta la scuola per scioperare di fronte al
parlamento svedese contro il
cambiamento climatico. Le proteste della ragazza, anche grazie
al vastissimo eco fornitole dalla stampa internazionale, le
hanno consentito di salire
sul palco della conferenza mondiale per il cambiamento
climatico (Cop24) tenutasi in Polonia lo scorso dicembre 2018,
e di partecipare alla grande
manifestazione del 22 febbraio a Bruxelles contro il
cambiamento climatico.
I messaggi che la politica e la stampa occidentale non hanno alcuna intenzione di far passare sono, però, fondamentalmente due.
1) In primo luogo, lo scopo delle proteste dei gilet gialli non è quello di negare l’esistenza del cambiamento climatico né tantomeno di promuovere politiche antiambientaliste, bensì ottenere condizioni di vita migliori per la maggioranza della popolazione. Tale scopo passa, anche, per la strada del dissenso verso sedicenti politiche fiscali “ambientaliste”, il cui costo viene fatto ricadere sulla collettività, in particolare sulle classi sociali più deboli.
Leggi tutto
Luigi Pellizzoni: Politica, ontologie, ecologia
Politica, ontologie, ecologia
di Luigi Pellizzoni
Prende avvio, con questo intervento, la rubrica Ecologie della trasformazione, a cura di Emanuele Leonardi, che affronterà diversi aspetti del rapporto tra ecologia, politica e società
 Politica, ontologie,
ecologia: perché unire assieme queste tre parole, ciascuna
delle quali provvista di una lunga
storia? O anche: perché mettere “ontologie” in mezzo a
politica e ecologia? Si tratta di un’inutile complicazione,
che tira
in ballo (tra l’altro al plurale) un concetto tra i più
sdrucciolevoli della filosofia, o di un passo necessario? Nel
prosieguo provo a
motivare la seconda opzione.
Politica, ontologie,
ecologia: perché unire assieme queste tre parole, ciascuna
delle quali provvista di una lunga
storia? O anche: perché mettere “ontologie” in mezzo a
politica e ecologia? Si tratta di un’inutile complicazione,
che tira
in ballo (tra l’altro al plurale) un concetto tra i più
sdrucciolevoli della filosofia, o di un passo necessario? Nel
prosieguo provo a
motivare la seconda opzione.
“Ecologia politica” è un’etichetta che identifica un filone di studi piuttosto variegato dal punto di vista disciplinare (antropologia, sociologia, storia, geografia, economia, filosofia, ma anche scienze agrarie e forestali ecc.) ma ben riconoscibile nel suo incentrarsi sulla “relazione tra fattori politici, economici e sociali e le questioni e i mutamenti ambientali” (così recita la definizione che troviamo su Wikipedia)1, contestando gli approcci apolitici a tali questioni e mutamenti. Secondo Paul Robbins, autore di un libro di testo di un certo successo sull’argomento, si tratta di “un filone di ricerca critica basato sull’assunto che ogni strappo nella trama della rete globale di connessioni tra esseri umani e ambiente si riverbera sul sistema nel suo complesso”, e sull’impegno a “interrogare la relazione tra economia, politica e natura” (Robbins 2012, p. 13).
La matrice dell’ecologia politica è fondamentalmente marxista. L’interrogazione quindi riguarda non la storia umana in generale ma i processi di accumulazione capitalista, in quanto basati sul contemporaneo sfruttamento del lavoro umano e non-umano; sfruttamento che è andato depauperando e distruggendo l’uno e l’altra. L’idea portante dell’ecologia politica è così che non vi possa essere transizione ecologica senza trasformazione sociale, o viceversa. Proprio le ascendenze marxiane lasciano tuttavia in una certa ambiguità l’esatto carattere del nesso.
Leggi tutto
Christian Marazzi: Slowbalisation
Slowbalisation
di Christian Marazzi
Nelle ultime settimane la politica monetaria di alcune tra le più importanti Banche centrali, a cominciare da quella statunitense, sembra aver cambiato decisamente direzione. Di fronte all’accumularsi di una serie di rischi di recessione, di “rallentamento della crescita” (la slowbalisation, come l’ha chiamata l’Economist), di una Brexit senza accordi con la UE e del rischio di fallimento dei negoziati commerciali tra USA e Cina, la Federal Reserve ha pensato bene di passare da una politica di rialzi graduali dei tassi di interesse ad una politica di segno opposto, cioè espansiva, con addirittura possibili riduzioni dei tassi d’interesse nel corso di quest’anno.
A questa scelta della Fed hanno fatto seguito le Banche centrali australiana, indiana e inglese. L’effetto di questo voltafaccia monetario è stato immediato, con i mercati finanziari che hanno ripreso a gonfiarsi e la ripresa degli investimenti esteri nell’economia cinese. È la dimostrazione che l’economia globale non ce la fa ad uscire dalla stagnazione secolare senza il sostegno di politiche monetarie espansive, politiche che hanno però un prezzo sempre più elevato, e cioè quello di aumentare a dismisura il debito globale, sia pubblico che privato.
Leggi tutto
Francesco Erspamer: È il quarto potere: bisogna usarlo
È il quarto potere: bisogna usarlo
di Francesco Erspamer
Quanto tempo sprecato a criticare i giornali, i telegiornali e i talk show liberisti, per non parlare delle frustrazioni, della bile e soprattutto del senso di impotenza che ne deriva, quest’ultimo politicamente disastroso perché alla gente non piace chi si lamenti della propria debolezza e supplichi i potenti di diventare buoni e leali invece di accettare lo scontro e cominciare a far loro paura. Ricordate l’incipit del Manifesto di Marx e Engels? “Uno spettro si aggira per l’Europa: lo spettro del comunismo. Tutte le potenze della vecchia Europa si sono coalizzate in una sacra caccia alle streghe contro questo spettro”. Così si fa: si prende atto che i ricchi e i potenti si coalizzano e coalizzeranno sempre contro chiunque davvero minacci la loro supermazia. E non si chiede loro moderazione o pietà ma ci si organizza e si acquisiscono gli strumenti che ci permettano di diventare lo spettro che li fa cadere nel panico e li spinge a commettere errori.
A che serve ripetersi ossessivamente che i giornali italiani sono faziosi, che i giornalisti sono parte integrante della casta e dunque tutti piddini e berlusconiani, e che preferiscono la Lega ma anche Casa Pound al M5S? A che serve denunciare quotidianamente le loro calunnie, le loro omissioni, le loro manipolazioni? A che serve guardare indegni talk show per avere conferma che le celebrity che li conducono sono prevenuti, come se il solo fatto di essere dei milionari senza qualità non spieghi e tutto sommato giustifichi la loro posizione?
Leggi tutto
Geraldina Colotti: Il Venezuela, un caso di scuola nel terzo millennio
Il Venezuela, un caso di scuola nel terzo millennio
di Geraldina Colotti
Il Venezuela comunque farà storia, sia che le condizioni avverse lo sovrastino come vorrebbe l'imperialismo, sia che riesca a passare per questo imbuto tremendo. Nel primo caso, si innescherebbe una situazione dalle conseguenze incalcolabili, per il continente e non solo. Dalle zone di frontiera, verrebbe innescato quel processo di balcanizzazione che rientra tra i principali assi del “caos controllato” voluto dal Pentagono. Il Venezuela sarebbe il nuovo Vietnam degli Stati Uniti. Trump ha già annunciato che, dopo, toccherebbe al Nicaragua, e a seguire Cuba e la Bolivia.
Nel secondo caso, la discesa in campo aperta e sfacciata da parte dell'imperialismo USA e dei suoi satelliti sarà stata la prova maestra per nuove modalità di conflitto a livello globale, per la ridefinizione di un nuovo ordine economico.
Da ora in poi, chiunque riesca a portare alla vittoria un arco di forze veramente alternativo al capitalismo, dovrà assumersi quel livello di conflitto, quel livello di aggressione, dentro e fuori il paese, un livello di pressione continua che approfitterà di ogni spiraglio per incunearsi e creare voragini. Lo si era già visto parzialmente con la Grecia, che aveva abbassato la testa prima, cedendo alle minacce della Troika.
Leggi tutto
Emiliano Brancaccio e Fabiana De Cristofaro: Errori di previsione del Pil durante l’Eurocrisi: quali cause?
Errori di previsione del Pil durante l’Eurocrisi: quali cause?
di Emiliano Brancaccio e Fabiana De Cristofaro*
Da cosa dipesero i gravi errori di previsione della crescita del Pil durante la crisi? Per l’ex capo economista del FMI Olivier Blanchard si trattò di una sottostima dei “moltiplicatori keynesiani”, che portò anche a sottovalutare gli effetti recessivi dell’austerity. Alberto Alesina, Carlo Favero e Francesco Giavazzi provano a confutare questa tesi e nel loro nuovo libro suggeriscono un’interpretazione alternativa. Emiliano Brancaccio, invece, questa volta spezza una lancia a favore dell’economista francese fornendo nuove evidenze empiriche a sostegno della sua interpretazione
 Riabilitare la politica di
austerity, nella versione
basata sui tagli alla spesa pubblica: è questo l’ambizioso
obiettivo di Austerità,
il nuovo libro di Alberto Alesina, Carlo Favero e
Francesco Giavazzi, che discuteremo oggi presso
l’Università Bocconi.
Riabilitare la politica di
austerity, nella versione
basata sui tagli alla spesa pubblica: è questo l’ambizioso
obiettivo di Austerità,
il nuovo libro di Alberto Alesina, Carlo Favero e
Francesco Giavazzi, che discuteremo oggi presso
l’Università Bocconi.
Questo libro ha alcuni meriti. In primo luogo, presenta una metodologia di analisi in parte inedita, basata sul concetto di “piani fiscali” e su un insieme di dati più esteso di quelli solitamente adoperati dalla letteratura in materia. Inoltre, gli intenti scientifici del volume sono giudiziosamente delimitati: per esempio, gli autori specificano che i loro “risultati non indicano in alcun modo quali siano le dimensioni ottimali del settore pubblico” e aggiungono che l’impatto delle politiche di austerity sui livelli di disuguaglianza è “questione che esula dai propositi del libro”. Chi dunque speri di trovare in Austerità un sostegno indiscriminato alle politiche di lacrime e sangue, alle dottrine sullo “Stato minimo” o alle strategie reaganiane per “affamare la bestia” statale, rimarrà probabilmente deluso.
Nonostante le sue qualità, tuttavia, confessiamo che il libro non ci ha ammaliati. Qui ci soffermeremo su uno dei punti del volume che ci sono sembrati meno convincenti: si tratta dell’esercizio con il quale i tre autori provano a confutare una celebre tesi “keynesiana” di Olivier Blanchard. L’economista francese, ex capo della ricerca del Fondo Monetario Internazionale, ha sostenuto che gli errori di previsione sull’andamento del Pil in Europa durante la crisi sarebbero da imputare a una sottostima dei cosiddetti “moltiplicatori” della spesa autonoma. A nostro avviso la tesi di Blanchard regge alla prova empirica mentre il tentativo di confutazione di Alesina, Favero e Giavazzi ci pare contestabile. Ecco perché, dopo averlo in varie occasioni criticato, questa volta abbiamo ritenuto giusto scrivere un “Pro-Blanchard”.
Leggi tutto
Vittorio Morfino: Temporalità plurali
Temporalità plurali
La tradizione marxista a contropelo
di Vittorio Morfino
 Carlo Rovelli nel suo
libro L’ordine
del tempo, un libro divulgativo sulla fisica
relativistica e quantistica, scrive a proposito del tempo
definito da Einstein:
Carlo Rovelli nel suo
libro L’ordine
del tempo, un libro divulgativo sulla fisica
relativistica e quantistica, scrive a proposito del tempo
definito da Einstein:
[Vi è] un tempo diverso per ogni punto dello spazio. Non c’è un solo tempo. Ce ne sono tantissimi. Il tempo indicato da un particolare orologio misurato da un particolare fenomeno, in fisica si chiama tempo proprio. Ogni orologio ha il suo tempo proprio. Ogni fenomeno che accade ha il suo tempo proprio1.
Il tempo della relatività generale di Einstein non descrive «come il mondo evolve nel tempo» ma descrive «le cose evolvere in tempi locali e i tempi locali evolvere uno rispetto all’altro». In definitiva, conclude Rovelli, «il mondo non è come un plotone che avanza al ritmo di un comandante», ma «una rete di eventi che si influenzano l’un l’altro»2. Non posso negare che il concetto di temporalità plurale a cui faccio cenno nel titolo sia ispirato da un orizzonte di questo genere. Certo, non va sottovalutata la difficoltà del passaggio dal piano della fisica relativistica a quello della storia.
Facciamo allora un passo indietro e prendiamo in considerazione i due grandi modelli attraverso cui la tradizione occidentale ha pensato il tempo: il circolo e la linea. Il primo modello, con estrema generalizzazione, è quello greco, il secondo è quello che si apre con il cristianesimo. Cristo è il punto che stabilisce la doppia direzione del tempo storico, il passato come prefigurazione ed il futuro come giudizio universale. Löwith ha insistito giustamente sulle origini della filosofia della storia settecentesca e ottocentesca dal modello fornito da Gioacchino da Fiore – nel Libro della concordia tra antico e nuovo testamento3 – che aggiunge alla linea tempo ascendente una precisa epocalizzazione, che sarà ripresa dall’illuminismo al positivismo, dall’hegelismo al marxismo, sotto forma di sviluppo di fasi, gradi, stadi. Le epoche in questo contesto sono grandi aree di contemporaneità.
Leggi tutto
Paolo Massucci: Libertà come illusione nella cultura decadente
Libertà come illusione nella cultura decadente
di Paolo Massucci
Sono cresciute negli ultimi anni tesi a sostegno del determinismo e dell’illusorietà del libero arbitrio, supportate da recenti scoperte delle neuroscienze. Vero avanzamento del pensiero scientifico e filosofico o ideologia funzionale al mantenimento dello status quo?
 In un interessante testo del 2016
[1], Andrea Lavazza, studioso di filosofia
morale e di filosofia delle
neuroscienze, ci offre un quadro dell’attuale dibattito
inerente ad uno degli argomenti da alcuni anni più discussi,
che si candida ad
essere tra gli snodi più importanti della riflessione
filosofica, in virtù delle sue ricadute sull’esistenza. Si
tratta
dell’alternativa tra la nozione di determinismo,
nelle sue diverse articolazioni, e quella di libero
arbitrio
[2], questione che ha segnato la storia del pensiero sin
dall’antichità, almeno a partire da Democrito.
In un interessante testo del 2016
[1], Andrea Lavazza, studioso di filosofia
morale e di filosofia delle
neuroscienze, ci offre un quadro dell’attuale dibattito
inerente ad uno degli argomenti da alcuni anni più discussi,
che si candida ad
essere tra gli snodi più importanti della riflessione
filosofica, in virtù delle sue ricadute sull’esistenza. Si
tratta
dell’alternativa tra la nozione di determinismo,
nelle sue diverse articolazioni, e quella di libero
arbitrio
[2], questione che ha segnato la storia del pensiero sin
dall’antichità, almeno a partire da Democrito.
La prospettiva deterministica radicale, quale in particolare quella ottocentesca, fonda il divenire delle cose e del mondo - esseri viventi e uomo compresi - su un rapporto di causa/effetto basato su leggi naturali immutabili. Tale concezione è incompatibile con il libero arbitrio, in quanto quest’ultimo presuppone uno spazio di imprevedibilità, su cui interviene la libera volontà dell’individuo che decide di agire in un senso o nell’altro. L’idea che ogni evento abbia una causa fisica preclude la possibilità di una causazione prodotta dalle facoltà mentali, cioè di nuove catene causali che non siano predeterminate dagli eventi del passato. Dunque in tale concezione gli atti mentali non causerebbero mai eventi fisici e la libertà di azione della persona sarebbe illusoria. L’uomo può solo “immaginare” di essere libero, come una pietra in caduta che prende coscienza del moto e scambia tale coscienza con la causa del movimento, affermava Spinoza nel XVII secolo in una celebre metafora. Appartiene proprio a questa tradizione di pensiero la celebre affermazione di Laplace nel Saggio sulle probabilità del 1814 secondo cui un’intelligenza che conoscesse tutte le forze da cui è animata la natura, nonché la posizione rispettiva di tutta la materia, compresi gli esseri viventi, potrebbe avere, in linea di principio, completa e certa conoscenza di tutti gli accadimenti futuri.
Leggi tutto
Mauro Poggi: Il Metodo Ciampi e la Costituzione
Il Metodo Ciampi e la Costituzione
di Mauro Poggi
Nel suo libro di memorie Paolo Savona a un certo punto racconta della sua esperienza ai vertici della BNL, primi anni ’90.
“Le cose filarono lisce fino all’arrivo di Giampiero Cantoni, designato dal PSI alla presidenza della Banca. […] a Cantoni interessava ribadire il suo potere per esercitarlo a favore del PSI di Craxi, che lo aveva voluto a quel posto, e dei suoi personali interessi. […] Usava nei miei confronti parole volgari […] dato che contrastavo le sue decisioni di concedere credito al di fuori delle competenze statutarie e delle procedure interne di valutazione del merito di credito. Informai Carli, titolare del Ministero del Tesoro e [in quanto tale] azionista di maggioranza della BNL, il quale mi disse che per regolarizzare le violazioni statutarie del presidente avrebbe esteso a lui le mie competenze.
Avvertii anche Ciampi, allora governatore della Banca d’Italia, ma mi disse che non poteva proteggermi […] dato che i suoi rapporti con il Presidente del consiglio Craxi erano già molto tesi.
Alle mie obiezioni sulle violazioni statutarie compiute aggiunse che “gli statuti vanno letti e messi nel cassetto.”
(P. Savona: Come un Incubo, Come un Sogno – Rubbettino 2018, pagine 204 e 205).
L’autobiografia di Savona mi è sembrata meno interessante di quella scritta da Carli (Cinquant’anni di Vita Italiana, Laterza, 1993), ma offre comunque significativi spunti di riflessione, come testimonia la chicca che ho citato.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: La politica industriale secondo l’asse franco-tedesco
La politica industriale secondo l’asse franco-tedesco
Considerazioni sull’articolo di Pasquale Cicalese
di Giuseppe Masala
Articolo impagabile di Pasquale Cicalese dove si illustra l’accordo-manifesto reso pubblico ieri tra Altmaier e Le Maire sulla politica industriale.
Un manifesto impagabile dove la Francia e la Germania si arrogano il diritto di decidere la politica industriale dell’intera Europa, in ossequio al principio che esistano paesi di serie A e paesi di serie B ridotti di fatto a protettorati o colonie. Effetti del Trattato di Aquisgrana immagino.
Le misure prospettate dal duo franco-tedesco sono chiare e semplici: cambiare le regole antitrust europee per far nascere dei colossi europei di livello mondiale (ovviamente guidati da francesi e tedeschi); entrata dello stato francese e tedesco nell’azionariato di questi colossi (alla faccia del libero mercato); divieto di acquisto per paesi extraeuropei di industrie tecnologiche europee, una norma chiaramente anticinese (peraltro a bloccare eventuali mire dei paesi inferiori interni all’EU ci penseranno i burocrati europei con qualunque scusa, basti pensare alla guerriglia che subisce Fincantieri per l’acquisizione dei cantieri navali francesi STX); divieto all’entrata di azionisti extraeuropei nei porti europei (leggi Cina), una chiara mossa per favorire i porti del Nord Europa nei traffici extra europei a discapito dei porti mediterranei.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: Gli interessi convergenti di Lega, FI e PD
Gli interessi convergenti di Lega, FI e PD
di Fabrizio Marchi
Non bisogna lasciarsi ingannare dalla vicenda del “salvataggio” di Salvini da parte degli iscritti alla “piattaforma Rousseau” che si sono espressi a maggioranza contro l’autorizzazione a procedere del Tribunale di Catania nei confronti del ministro dell’interno sul caso della nave “Diciotti”.
L’esito della consultazione era peraltro scontato dal momento che l’indicazione ufficiosa dei vertici del movimento era quella di votare in tal senso. E sappiamo bene – al di là della retorica – che le indicazioni dei gruppi dirigenti dei partiti vengono sempre osservate dalla base (in tutti i partiti). Proprio in virtù di questa considerazione, quel 40% circa di votanti che hanno invece votato in modo contrario alle indicazioni dei vertici, è una percentuale tutt’altro che irrilevante e dimostra che in quel movimento c’è una certa vitalità e anche una pluralità di posizioni.
Del resto, in questa fase il gruppo dirigente “grillino” non aveva scelta. Votare per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini avrebbe significato rompere con la Lega e aprire ufficialmente la crisi di governo. Un’ ipotesi al momento non contemplata dal M5S e che allo stato attuale delle cose avrebbe portato ancora più consensi alla Lega e un ulteriore ridimensionamento dello stesso M5S. Non che procrastinare l’inevitabile rottura porti a risultati migliori per il movimento, per lo meno se le cose continueranno ad andare così come sono andate fino ad ora.
Leggi tutto
Federico Pieraccini: Russia e Cina devono arginare gli Stati Uniti per trasformare pacificamente l’ordine mondiale in multipolare
Russia e Cina devono arginare gli Stati Uniti per trasformare pacificamente l’ordine mondiale in multipolare
di Federico Pieraccini
Il mondo di oggi è fortunatamente molto diverso dal 2003 e le decisioni di Washington hanno un’importanza minore negli equilibri globali. Nonostante questa nuova realtà più equilibrata in termini di potenza divisa tra più nazioni, l’atteggiamento degli Stati Uniti nei confronti di alleati e nemici appare sempre più aggressiva, presidente, dopo presidente
Cina e Russia guidano questa fase storica con un obiettivo a lungo termine: evitare conflitti bellici con la superpotenza USA. Per riuscire in questa impresa, utilizzano una strategia ibrida basata su azioni diplomatiche, sostegno militare agli alleati e garanzie economiche offerte a quei paesi che si trovano ad essere aggrediti in qualche modo da Washington.
Gli Stati Uniti considerano tutto il pianeta di loro interesse, ogni angolo del globo. Questa dottrina militare e politica basata sul concetto di liberal-hegemony, come spiega John Mearsheimer, ha portato nel tempo alla creazione di un fronte semi-ufficiale di nazioni in rapporti ostili con Washington. L’ultimo atto in Venezuela dimostra come un coordinamento tra questi paesi sia ormai un’esigenza imprescindibile per accelerare la transizione da una realtà unipolare ad una multipolare, riducendo il potere degli Stati Uniti e contenendo i danni causati dalle politiche di Washington.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3110
Hits 2316
Hits 2139
Hits 2134
Hits 2075
Hits 1959
Hits 1948
Hits 1909
Hits 1845
Hits 1754
tonino

Eros Barone: Per il centesimo anniversario della fondazione della Terza Internazionale
![]()
Per il centesimo anniversario della fondazione della Terza Internazionale
di Eros Barone
 Per la prima volta, dopo
centinaia e migliaia di anni, la promessa di
“rispondere” alla guerra tra gli schiavisti con la
rivoluzione degli schiavi contro tutti gli schiavisti è
stata mantenuta fino in
fondo e lo è stata malgrado tutte le difficoltà.
Per la prima volta, dopo
centinaia e migliaia di anni, la promessa di
“rispondere” alla guerra tra gli schiavisti con la
rivoluzione degli schiavi contro tutti gli schiavisti è
stata mantenuta fino in
fondo e lo è stata malgrado tutte le difficoltà.
Noi abbiamo cominciato quest’opera. Quando, entro che termine precisamente, i proletari la condurranno a termine? Non è questa la questione essenziale. È essenziale il fatto che il ghiaccio è rotto, la via è aperta, la strada è segnata.
Lenin, Per il quarto anniversario della rivoluzione.
-
«Una nuova Internazionale veramente rivoluzionaria»
«Creare una nuova Internazionale veramente rivoluzionaria»: questa era la finalità che l’ultima delle Tesi di aprile di Lenin proponeva ai bolscevichi. La bancarotta dell’Internazionale all’inizio della guerra europea era stata infatti, per Lenin, la prova decisiva della crisi del socialismo europeo. Da questo punto di vista, la nascita di una Internazionale, che sarà la Terza dopo l’“Associazione Internazionale dei lavoratori” sorta nell’epoca di Marx e dopo l’“Internazionale Socialista” fondata nel 1889, era chiaramente la prova del maturare, ben oltre i confini della Russia, di un movimento rivoluzionario mondiale capace di assolvere il proprio compito, ossia di trasformare il pianeta in senso socialista. Così, la nuova Internazionale avrebbe dovuto essere, per un verso, la sintesi delle due Internazionali che l’avevano preceduta: della Prima doveva avere lo spirito intransigente e rigoroso, della Seconda l’organizzazione e il radicamento territoriale; ma, per un altro verso, rispetto alla Seconda essa doveva essere anche un’antitesi, in quanto doveva incarnare un netto rifiuto del riformismo, dell’opportunismo e dello spirito di compromesso che erano stati i caratteri distintivi delle socialdemocrazie europee.
Quindi, dopo la votazione dei crediti di guerra alle rispettive borghesie da parte dei partiti socialdemocratici, che segnò la bancarotta politica, ideologica e morale della Seconda Internazionale, Lenin non ebbe alcun dubbio sulla necessità e sulla urgenza della creazione di una nuova Internazionale.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Compiti per il pensiero complesso
Compiti per il pensiero complesso
di Pierluigi Fagan
 Nell’articolo, che
originariamente è pubblicato sul sito del Festival della Complessità, si
pone la
questione della agonistica separazione tra cultura
scientifica e cultura umanistica, conosciuta anche come
questione delle “due culture”.
Questa separazione,a grandi linee e con bordi sfumati,
sembra corrispondere ad una più profonda divisione tra
cultura europea e cultura
anglosassone, che oltre al suo riflesso in filosofia ha oggi
anche una sua attualità politica. Poiché finisce col
presentarsi anche come
separazione tra il fare le cose ed i fini per cui le si
fanno, nonché il loro significato ed il come le giudichiamo
criticamente e per altri
versi come separazione tra uomo e natura, la si pone come
una delle questioni in agenda per un pensiero che voglia
ripensare le cose “nel loro
complesso”, inclusa la conoscenza stessa. Parleremo anche
del sito americano -Edge- un aggregatore di pensatori tra
cui molti rappresentanti di
un certo tipo di pensiero della complessità contemporaneo.
Nell’articolo, che
originariamente è pubblicato sul sito del Festival della Complessità, si
pone la
questione della agonistica separazione tra cultura
scientifica e cultura umanistica, conosciuta anche come
questione delle “due culture”.
Questa separazione,a grandi linee e con bordi sfumati,
sembra corrispondere ad una più profonda divisione tra
cultura europea e cultura
anglosassone, che oltre al suo riflesso in filosofia ha oggi
anche una sua attualità politica. Poiché finisce col
presentarsi anche come
separazione tra il fare le cose ed i fini per cui le si
fanno, nonché il loro significato ed il come le giudichiamo
criticamente e per altri
versi come separazione tra uomo e natura, la si pone come
una delle questioni in agenda per un pensiero che voglia
ripensare le cose “nel loro
complesso”, inclusa la conoscenza stessa. Parleremo anche
del sito americano -Edge- un aggregatore di pensatori tra
cui molti rappresentanti di
un certo tipo di pensiero della complessità contemporaneo.
* * * *
L’americano John Brockman nasce come agente letterario a vocazione scientifica, ma nell’esercizio della sua professione è poi diventato depositario di così vaste conoscenze da vedere una possibile sintesi, quella sintesi di sintesi di cui abbiamo parlato in un precedente articolo (qui). E’ diventato così autore egli stesso e animatore di circoli di pensiero, sempre nell’ambito tecno-scientifico tipicamente anglosassone. Come autore, ha scritto almeno un libro l’anno negli ultimi quindici anni (più d’uno tradotto in Italia), mente quindi molto eccitata. Uno in particolare si distingue, “La terza cultura” (Garzanti, 1999), che segna il momento in cui gli si è formato un nuovo sistema mentale, un diverso modo di vedere le cose nel “loro complesso”. Di quel libro in cui il nostro ha preferito far parlare direttamente 25 scienziati tra cui molti interni alla tradizione del pensiero complesso (M. Gell Mann, F. Varela, B. Goodwin, S. Jay Gould, S. Kauffman, C. Langton, L. Margulis ed altri molto noti da S. Pinker a M. Rees, da L. Smolin a R.Penrose, più tangenziali a questa forma di pensiero) ha avuto l’intuizione del titolo che fa categoria e le categorie, si sa, ordinano le sintesi. Ma cos’è la “terza cultura”?
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Il regionalismo, il caos e l'unità nazionale
Il regionalismo, il caos e l'unità nazionale
di Leonardo Mazzei
Questa del Mazzei è senza dubbio la migliore analisi critica del cosiddetto "regionalismo differenziato"
 «Se
passasse il regionalismo differenziato l'Italia
diventerebbe, come disse il Metternich nel 1847, una mera
"espressione
geografica"...»
«Se
passasse il regionalismo differenziato l'Italia
diventerebbe, come disse il Metternich nel 1847, una mera
"espressione
geografica"...»
Diciamo le cose come stanno: con il fallimento del Consiglio dei ministri del 14 febbraio il cosiddetto "regionalismo differenziato" è stato messo su un binario morto. Per ora è solo un rinvio, ma adesso fermarlo è possibile. Lo stop imposto dai ministri M5S alle richieste di Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna non è dunque roba di poco conto.
La scadenza di metà mese sembrava quella del giudizio divino: o il progetto passava, o il governo cadeva. Così tuonava Giorgetti all'inizio dell'anno, puntualmente rilanciato dai capibastone della Lega nordista. E invece, né l'una né l'altra cosa. Bene, anzi benissimo, a condizione che il dibattito che si è finalmente aperto conduca al definitivo affossamento del disegno in questione.
Quel che è incredibile è come in tanti ancora non si rendano conto della posta in gioco, che non è solo lo spostamento delle risorse dalle regioni più povere a quelle più ricche - che già di per sé griderebbe vendetta -, ma l'avvio di un processo disgregativo potenzialmente in grado di minare la stessa unità nazionale. Il tutto per la gioia dei potentati euro-tedeschi che non potrebbero chiedere di meglio.
Sulla materia la confusione è tanta. Proviamo perciò a mettere un po' di ordine, affrontando sette questioni: 1) che cos'è il "regionalismo differenziato"; 2) da dove arriva, ovvero il problema di una Costituzione "incostituzionale"; 3) cosa chiedono le tre regioni del nord; 4) il trucco dei "fabbisogni standard"; 5) la truffa dei "residui fiscali primari"; 6) il caos di un regionalismo "fai da te"; 7) un secessionismo di fatto che farebbe il gioco dell'oligarchia eurista.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Il labirinto del Debito Pubblico
Il labirinto del Debito Pubblico
di Giuseppe Masala
Si continua a sostenere la necessità di ridurre il debito pubblico quale elemento essenziale per dare maggior stabilità al sistema e per rendere possibile una maggior crescita economica. Bene, questa affermazione è falsa in radice.
Ridurre il debito pubblico è un’operazione sociale e politica che ha quale fine quello di cambiare alle fondamenta la nostra società e la nostra vita. Già lo diceva Tommaso Padoa Schioppa in una celeberrima intervista di qualche anno fa al Corriere della Sera: * <<Ma dev’ essere guidato da un unico principio: attenuare quel diaframma di protezioni che nel corso del Ventesimo secolo hanno progressivamente allontanato l’ individuo dal contatto diretto con la durezza del vivere, con i rovesci della fortuna, con la sanzione o il premio ai suoi difetti o qualità>>* .
Ridurre il debito pubblico è facilissimo: basta privatizzare la Sanità, la Scuola, l’Università, i beni culturali e quant’altro e il debito pubblico si assorbe in una decina d’anni. Non è che ci vuole molto a capire che se vengono privatizzati gli elementi elencati qui sopra e per i quali lo stato spende centinaia di miliardi non si forma nuovo debito e quello vecchio viene pagato a scadenza riassorbendosi.
Leggi tutto
Domenico Bilotti: Gentrificazione, resilienza e implementazione
Gentrificazione, resilienza e implementazione
Dell’uso pessimo e nuovo delle parole antiche
di Domenico Bilotti
Il problema era noto già a Cicerone e a Quintiliano: in meno di due secoli di storia romana, allievo e maestro si misurano col decadimento politico-amministrativo che si associa a scadimento delle istituzioni culturali e valoriali di un popolo. I due retori certo usano un espediente vittimistico: la loro opera appartiene a due dei secoli più interessanti e densi della romanità antica; il potere politico dell’Urbe è in fase ancora espansiva e le tante crisi zonali appaiono conferma della caduta dei secoli successivi soltanto in ottica retrospettiva, nello sguardo dei “posteri”.
Notano, però, una cosa vera: la perdita di senso del linguaggio è il primo segno della sconfitta politica. Un ordinamento delle relazioni umane privo di qualità ragionativa e di sforzo di approfondimento scava scientificamente, quanto inconsapevolmente, la sua fossa. Fa prevalere la semplificazione brutale sulla sintesi razionale, il chiacchiericcio vago sulla dissertazione serrata, la forza nuda e cruda sull’argomentazione tecnico-giuridica. Presta il fianco alla stessa demagogia che nutre la crisi, come un serpente che mangiandosi la coda, anziché chiudersi in se stesso, seguita a ingrassare.
Gli anni che stiamo vivendo hanno questo segno impresso addosso, perché s’è ormai assottigliato, nella “cosa pubblica”, il confine tra il tribuno che deve in primo luogo arringare gli animi e lo specialista che deve, invece, creare il contesto applicativo della pratica di governo.
Leggi tutto
Renato Rapino: Ho visto un re, anzi, il primo re
Ho visto un re, anzi, il primo re
di Renato Rapino
Intorno al film “Il primo re” si sta generando un dibattito che forse, in base al successo del film, potrà allargarsi e magari incattivirsi.
Siamo al centro di discorsi che riguardano cinema, storia e politica che tra loro hanno avuto sempre rapporti stretti e conflittuali.
Su storia e politica si è già riflettuto molto su questa rivista. È stato ricordato spesso che “la storia la scrivono i vincitori” ed è quindi estremamente difficile per un ricercatore serio far accettare tesi controcorrente e, a tutto ciò, vorrei aggiungere una frase lapidaria di Andreotti: “Quando i politici si mettono a fare gli storici succede sempre una gran confusione”. Pronunciò questa “sentenza” in merito alla diatriba sorta intorno alle (parzialmente) false lettere di Togliatti a Stalin sulla sorte dei nostri alpini prigionieri.
L’uso politico del cinema è notorio: Mussolini lo definiva il miglior strumento di propaganda, il nazismo in Germania così come la rivoluzione bolscevica in Russia si avvarranno di registi del calibro di Leni Riefenstahl e Sergej Michajlovič Ėjzenštejn con film memorabili.
Nel secondo dopoguerra l’egemonia culturale della sinistra, in Italia e nel “primo mondo”, farà sentire il proprio peso anche nel cinema realizzando i prodotti più artisticamente rilevanti.
Leggi tutto
Domenico Moro: Critica del neoliberismo e critica dell’europeismo devono procedere assieme
Critica del neoliberismo e critica dell’europeismo devono procedere assieme
Fabio Cabrini intervista Domenico Moro
 Il titolo del tuo ultimo libro
“La gabbia dell’euro” non lascia spazio a troppe
interpretazioni.
Ci spieghi, in sintesi, perché la zona euro dovrebbe essere
intesa come una camicia di forza dalla quale liberarsi il
prima possibile? Cosa
rispondi alle critiche di coloro che vedono nell’uscita,
dati gli attuali rapporti di forza, un evento che andrebbe
ad avvantaggiare
esclusivamente i partiti nazionalisti?
Il titolo del tuo ultimo libro
“La gabbia dell’euro” non lascia spazio a troppe
interpretazioni.
Ci spieghi, in sintesi, perché la zona euro dovrebbe essere
intesa come una camicia di forza dalla quale liberarsi il
prima possibile? Cosa
rispondi alle critiche di coloro che vedono nell’uscita,
dati gli attuali rapporti di forza, un evento che andrebbe
ad avvantaggiare
esclusivamente i partiti nazionalisti?
DM: L’integrazione europea, in particolare quella monetaria, aliena alcune importati funzioni – bilancio e moneta – dallo Stato alle istituzioni sovranazionali europee. Lo scopo è sottrarre le decisioni economiche fondamentali all’influenza dei Parlamenti, ossia alla sovranità popolare e ai lavoratori, allo scopo di ricondurle sotto il controllo dello strato superiore e fortemente internazionalizzato del capitale. L’integrazione europea modifica, insieme al funzionamento delle istituzioni dello Stato, anche i rapporti di forza tra classi sociali, lavoratori salariati e capitalisti, a favore di questi ultimi. Per questa ragione, in Europa al centro di una politica democratica e favorevole alle classi subalterne non può che esserci il superamento dell’euro e dei Trattati, in pratica il superamento della Ue. Dire che per uscire bisogna aspettare rapporti di forza favorevoli è sbagliato. Infatti, se uscire espone a dei rischi e rimanere è disastroso, qual è l’alternativa? Una tale posizione è ingenua e impolitica, condannando alla irrilevanza e all’impotenza qualsiasi posizione politica progressiva e di classe. I rapporti di forza si modificano attraverso la politica, cioè mediante la creazione di consenso e la costruzione di organizzazione attorno a posizioni forti e adeguate alla fase storica. Uscire dall’euro è una di queste posizioni, anzi al momento è quella centrale, imprescindibile nella definizione di un programma di sinistra e socialista.
A maggio si terranno le elezioni europee. A parte che un eventuale spostamento dei rapporti di forza si andrebbe a realizzare in un organo, il Parlamento europeo, dal peso specifico assai relativo, c’è anche da dire che il PPE e il PSE, forze che si richiamano a un europeismo di matrice neoliberale, quasi certamente manterranno la maggioranza. Insomma, ad oggi sembra alquanto difficile immaginare, come fanno alcuni sovranisti di destra, dei cambiamenti sostanziali circa gli equilibri vigenti. Cosa ne pensi?
Leggi tutto
Marco Craviolatti: Obbligo o verità?
Obbligo o verità?
La battaglia dei vaccini e il silenzio-assenso della sinistra
di Marco Craviolatti

Copernico partì da
osservazioni note e
usò un metodo accessibile a tutti.
Molti non gli credettero, ma le sue affermazioni erano già
vere,
perché chiunque
ci sarebbe potuto arrivare, grazie alla scienza del tempo.
Il suo punto di vista non venne imposto da un re o dai
preti.
Altrimenti
sarebbe stata una verità instabile, contraddittoria e
ingiusta.
Wu Ming, Proletkult
Renzi-Gentiloni, Macron, Macri. Se vi dicessero che questi governi-modello del liberismo globale hanno imposto la stessa misura legislativa in Italia, Francia e Argentina, vi scatterebbe qualche campanello d’allarme? Nemmeno se toccasse quanto di più sacro vi appartiene, non il vostro portafoglio, bensì il vostro corpo? Nemmeno se stravolgesse all’improvviso un contesto stabile della salute pubblica, virando a 180° le norme precedenti? Se l’allarme non è scattato siete in buona compagnia della sinistra italiana (quella poca ancora tale).
Nel giugno 2017 il DL Lorenzin (procedura di urgenza! Poi convertito dalla Legge 119/2017) ha introdotto un abnorme obbligo vaccinale (10 + 4 raccomandati) dai 0 ai 16 anni, con corollario di misure coercitive e punitive: è una svolta della politica sanitaria di portata almeno equivalente a quanto rappresentò il pacchetto Treu per il lavoro, il piano inclinato della progressiva cancellazione dei diritti. Come allora, si parte da alcune fasce della popolazione per raggiungere via via tutti gli altri. Nell’intera storia italiana, dal 1939, i vaccini obbligatori non avevano mai superato i 4. Nell’ottobre 2017 è la Francia a portare da 3 a 11 i vaccini obbligatori. L’ulteriore salto di qualità arriva nel dicembre 2018 con il DDL argentino 972-D, che impone vaccinazioni certificate anche agli adulti perfino per il rilascio dei documenti di identità, seppur non vincolandoli (ma il passo è breve). In compenso diventano già indispensabili per l’accesso a scuole e università e per le visite pre-assuntive e lavorative: no iniezione – no lavoro. No Jab – No Job proclama compiaciuto in Australia il governo del Partito Liberale, che ha adottato una misura analoga, oltre a quelle No Jab – No Pay (taglio dei sussidi familiari) e No Jab – No Play (esclusione dalla scuola).
Leggi tutto
Giorgio Riolo: Per la storia. Per la politica
![]()
Per la storia. Per la politica
A proposito di Sei lezioni sulla storia di Edward H. Carr
di Giorgio Riolo
Questo breve scritto riprende una nota a suo tempo redatta come introduzione all’opera di Edward H. Carr. Come si cerca di argomentare, la storia non è solo disciplina, materia, ambito del sapere e della conoscenza. Essa è fondamento della cultura critica, dello spirito critico, tanto più necessario nella nostra realtà contemporanea, della educazione civile e della formazione della persona attiva. È fondamento e sostanza della politica
 Queste note
che seguono hanno il modesto fine di richiamare l'attenzione
sulla questione
della storia. A riconsiderare il problema della storia, come
questione cruciale della sostanza della nostra cultura, della
nostra politica, della
nostra democrazia, della nostra vita. Nell'epoca del trionfo
della filosofia complessiva del neoliberismo, non solo della
sua naturalmente potente e
decisiva dimensione economica. Nell'epoca della
destoricizzazione compiuta, della eternizzazione del presente
e quindi del potente bisogno dei
dominanti di espungere la coscienza storica, la dimensione
storica dalla coscienza diffusa delle persone. Coscienza
diffusa già manipolata e
alienata. Ma proprio al fine della manipolabilità infinita
delle coscienze delle persone. A partire dal retroterra della
filosofia
individualistica compiuta (la signora Thatcher “La società
come ente non esiste, esistono gli individui e le famiglie”),
come una
delle componenti più granitiche di questa filosofia
complessiva. Cultura dell'io, cultura del corpo, cultura del
narcisismo (Christopher
Lasch): la trinità del contemporaneo monoteismo imperante.
Queste note
che seguono hanno il modesto fine di richiamare l'attenzione
sulla questione
della storia. A riconsiderare il problema della storia, come
questione cruciale della sostanza della nostra cultura, della
nostra politica, della
nostra democrazia, della nostra vita. Nell'epoca del trionfo
della filosofia complessiva del neoliberismo, non solo della
sua naturalmente potente e
decisiva dimensione economica. Nell'epoca della
destoricizzazione compiuta, della eternizzazione del presente
e quindi del potente bisogno dei
dominanti di espungere la coscienza storica, la dimensione
storica dalla coscienza diffusa delle persone. Coscienza
diffusa già manipolata e
alienata. Ma proprio al fine della manipolabilità infinita
delle coscienze delle persone. A partire dal retroterra della
filosofia
individualistica compiuta (la signora Thatcher “La società
come ente non esiste, esistono gli individui e le famiglie”),
come una
delle componenti più granitiche di questa filosofia
complessiva. Cultura dell'io, cultura del corpo, cultura del
narcisismo (Christopher
Lasch): la trinità del contemporaneo monoteismo imperante.
Ricordiamo il problema che sottolineò Lukács, già nel 1923, e cioè che il limite del pensiero borghese (noi diremo oggi del pensiero e dell'ideologia capitalistiche), proprio perché appiattito sul “dato”, sul “compiuto”, sul “risultato” della forma-merce, occultando il processo genetico, la processualità, risiedeva nella difficoltà di considerare il presente come problema storico, il presente come storia. Questo complesso problematico è più attuale che mai proprio nell'era del capitalismo della globalizzazione neoliberista.
Queste note le facciamo cogliendo l'occasione della riproposizione di un testo importante della cultura storica, della metodologia della storia. Apparso in lingua italiana nel lontano 1966, formò molti di noi, non solo come libro di studio, liceale e universitario, ma anche come libro della formazione (e autoformazione) politica.
Leggi tutto
Andrea Aimar: Il made in Italy nel 4.0, il lavoro nell’epoca della sua riproducibiltà tecnica
Il made in Italy nel 4.0, il lavoro nell’epoca della sua riproducibiltà tecnica
di Andrea Aimar
Le cernitrici stanno lì, al fondo della linea, a guardare il pomodoro già pelato. Conoscono i difetti e le tipiche macchie sulla pelle dell’«oro rosso» italiano. Quando scovano il difetto, quello che le macchine prima non hanno trovato, prelevano il pomodoro dal nastro. A inizio stagione, quando fanno i test, ne riescono a individuare in media quindici al minuto. Dopo settimane di pratica di solito migliorano.
Dopo le cernitrici alla fine di una linea altamente automatizzata si posizionano le apparatrici, che soccorrono le bilance elettroniche: quando la scatola di latta passa, con un solo colpetto sanno capire se serve aggiungere o meno un pelato. Ci mettono un istante. Sono donne precisissime.
Il loro know how è la somma degli anni di esperienza in questo lavoro stagionale. Aristocrazia operaia campana: «i giapponesi su queste cose si incantano» dice Pasquale D’Acunzi della Fratelli D’Acunzi s.r.l., un’industria di conserve alimentari a Nocera Superiore.
Innovazione e buoi dei paesi tuoi
In Italia la narrazione sull’innovazione tecnologica è spesse volte il risultato di una traduzione. Si prende ciò che si scrive negli (e sugli) Stati Uniti e con un italiano meticcio si tracciano gli scenari sul futuro del lavoro e dell’era 4.0.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Siamo tutti venezuelani
Siamo tutti venezuelani
di ilsimplicissimus
Se ieri qualcuno di voi avesse per caso visto qualche Tg o anche qualche sequenza di patchwork informativi dovrebbe davvero cominciare a tremare. A me che di solito mi tengo ben lontano da queste forme di informazione paludata, ma paludosa è capitato ieri perché volevo sapere qualcosa sui danni prodotti dal vento e naturalmente questo ha comportato inevitabilmente l’orrore di assistere impotente allo scempio di verità perpetrato a canali unificati sul Venezuela in cui viene completamente omessa la grande manifestazione a sostengo del governo Maduro con centinaia di migliaia di persone, mentre si ciancia di tre soldati che sarebbero fuggiti in Colombia nonché degli “aiuti” che stanno gloriosamente giungendo allo squallido burattino Guaidò. Si tratta di un tipo informazione che non è nemmeno vergognosa, è metafisica, vacua, potrebbe anche essere dadaista se fosse intelligente e non vi si percepisse in sottofondo il sudore acre di Lucignoli e Pinocchi.
Non trattiene la propria indignazione persino un ex deputato del Pd e prima del Pds, il sociologo Pino Arlacchi, l’amico di Falcone e Borsellino che redasse il progetto esecutivo della Dia e ideò molte delle strategie della politica antimafia. Doveva diventare il supervisore dei servizi informativi italiani, ma la sua nomina fu bloccata con un trucco da Washington che per la bisogna fece riferimento ad ambienti criminali, in quanto “pericolo per il mondo libero”:
Leggi tutto
Lorenzo Vita: Macron, Merkel o Trump? L’Italia deve scegliersi un alleato
Macron, Merkel o Trump? L’Italia deve scegliersi un alleato
di Lorenzo Vita
Quello che è in corso nel mondo è un vero e proprio distacco, sempre più accentuato, fra Europa e Stati Uniti. Mai come in questi tempi l’oceano Atlantico è sembrato un abisso più che un mare che unisce. E gli Stati Uniti di Donald Trump non rappresentano che l’estrema sintesi di un divario già esistente ai tempi di Barack Obama e che l’attuale presidenza Usa ha avuto solo la capacità di mostrare in tutta la sua forza.
La grande spaccatura dell’Occidente
Siamo di fronte a una spaccatura dell’Occidente come non si era mai vista. Francia e Germania hanno intrapreso una direzione del tutto opposta a quella degli Stati Uniti. E Donald Trump non sembra essere disposto a cedere. Troppi gli interessi che dividono le due sponde dell’Atlantico.
Parigi e Berlino hanno deciso da tempo di blindare l’asse che unisce i due Paesi. Dopo la conclusione del Trattato di Aquisgrana, ormai è chiaro che Angela Merkel ed Emmanuel Macron vedano l’Europa come un grande territorio di caccia. L’Unione europea è sempre più esclusa dai giochi. Mentre Francia e Germania rafforzano ogni giorno di più la loro cooperazione.
Dall’altro lato, gli Stati Uniti di Donald Trump hanno avviato tutta una serie di iniziative volte da una parte a indebolire la forza dell’Unione europea e, dall’altro lato, a colpire la leadership della Germania nel Vecchio Continente.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Mario Draghi, “La sovranità in un mondo globalizzato”
Mario Draghi, “La sovranità in un mondo globalizzato”
di Alessandro Visalli
 Nel mondo
globalizzato che un sistema di azione altamente
complesso[1]
ha costruito
a partire dai primi anni settanta, non c’è alcuno spazio
per la democrazia dei nostri padri e nonni.
Nel mondo
globalizzato che un sistema di azione altamente
complesso[1]
ha costruito
a partire dai primi anni settanta, non c’è alcuno spazio
per la democrazia dei nostri padri e nonni.
Non c’è alcuno spazio, cioè, per la democrazia inclusiva e popolare che muoveva, certo sempre in modo incompiuto e come progetto da rinnovare, dall’eguaglianza dei ‘cittadini’[2] in quanto ‘persone’ e non per le loro capacità (siano esse economiche o cognitive), quanto per il loro diritto di formarsi norma a se stessi. Certo una forma, quella democratica, che è sempre cambiata nel tempo, passando dal parlamentarismo delle origini alla democrazia a suffragio universale e di massa ‘dei partiti’ novecentesca, ed alla trasformazione di questa in una ‘democrazia del pubblico’[3], centrata su pratiche di sorveglianza e discredito per le forme della politica.
Il vuoto che anche l’autore diagnostica viene però riempito dall’espressione di una diversa ‘sovranità’: la vecchia definizione del ‘controllo’, ovvero della potenza. Si torna in questo modo alla ‘sovranità’ del discorso politico seicentesco[4]. A ben vedere il discorso di Draghi, nel momento in cui retoricamente difende la pace, è quindi un discorso di guerra, è esattamente il contrario di quel che dice di essere. Quel che accusa ad altri di essere lui è.
Come dice, infatti:
“La vera sovranità si riflette non nel potere di fare le leggi, come vuole una definizione giuridica di essa, ma nel migliore controllo degli eventi in maniera da rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini: ‘la pace, la sicurezza e il pubblico bene del popolo’, secondo la definizione che John Locke ne dette nel 1690[3]. La possibilità di agire in maniera indipendente non garantisce questo controllo: in altre parole, l’indipendenza non garantisce la sovranità.”
Qui il soggetto di potenza deve ‘controllare gli eventi’ per ‘rispondere’ a bisogni, che sono oggettivati, di cittadini che diventano destinatari passivi.
Leggi tutto
Fabio Nobile: Il governo giallo-verde. Non sarà per sempre
Il governo giallo-verde. Non sarà per sempre
di Fabio Nobile
 Dopo circa nove mesi di governo giallo-verde è
possibile
tracciare un primo bilancio del suo operato che va commisurato
alle aspettative dell’articolato e contraddittorio aggregato
sociale che lo ha
sostenuto alle politiche dello scorso anno. Un bilancio che
può essere supportato, in alcuni aspetti cruciali, dai
risultati elettorali avuti
in Abruzzo. La vittoria del centrodestra a trazione leghista
(la Lega al 27,5% , il doppio rispetto ad un anno fa) e il
pesante stop elettorale del
M5s (la metà dei voti in percentuale rispetto a quelli
ottenuti alle politiche un anno fa, in confronto ad un
differenziale percentuale tra
politiche e regionali precedenti molto più basso) sono la
fotografia dei nuovi rapporti di forza nella maggioranza che
già emergevano da
recenti sondaggi. Va sottolineato, in questo senso, che ad
oggi, oltre all’Abruzzo, sono sei le Regioni governate da una
coalizione trainata
dalla nuova Lega: Liguria, Lombardia, Friuli, Molise, Sicilia
e Veneto. Al contempo la mobilità elettorale è da collocare in
una fase
fortemente instabile. Quello che è oggi, anche per la Lega,
può cambiare radicalmente in poco tempo. Come lo stesso
risultato del M5s
non può essere letto come un dato di irreversibile
arretramento. E questo è confermato ancora di più con i dati
dell’astensionismo.
Dopo circa nove mesi di governo giallo-verde è
possibile
tracciare un primo bilancio del suo operato che va commisurato
alle aspettative dell’articolato e contraddittorio aggregato
sociale che lo ha
sostenuto alle politiche dello scorso anno. Un bilancio che
può essere supportato, in alcuni aspetti cruciali, dai
risultati elettorali avuti
in Abruzzo. La vittoria del centrodestra a trazione leghista
(la Lega al 27,5% , il doppio rispetto ad un anno fa) e il
pesante stop elettorale del
M5s (la metà dei voti in percentuale rispetto a quelli
ottenuti alle politiche un anno fa, in confronto ad un
differenziale percentuale tra
politiche e regionali precedenti molto più basso) sono la
fotografia dei nuovi rapporti di forza nella maggioranza che
già emergevano da
recenti sondaggi. Va sottolineato, in questo senso, che ad
oggi, oltre all’Abruzzo, sono sei le Regioni governate da una
coalizione trainata
dalla nuova Lega: Liguria, Lombardia, Friuli, Molise, Sicilia
e Veneto. Al contempo la mobilità elettorale è da collocare in
una fase
fortemente instabile. Quello che è oggi, anche per la Lega,
può cambiare radicalmente in poco tempo. Come lo stesso
risultato del M5s
non può essere letto come un dato di irreversibile
arretramento. E questo è confermato ancora di più con i dati
dell’astensionismo.
I bassi livelli di partecipazione al voto (ancora in calo rispetto alle regionali del 2014) segnalano una volatilità dell’elettorato ancora più grande rispetto a quello che dicono i numeri dei voti assegnati. Tale dinamicità può rappresentare, allo stesso tempo, la leva su cui impostare un lavoro per iniziare a tracciare un’alternativa.
Accennati alcuni elementi di analisi del voto in Abruzzo, prima di qualunque considerazione, il primo elemento da sottolineare riguarda l’approccio sulla natura di questo governo. Senza capirne la natura si rischia di andare fuori bersaglio o peggio stare al gioco di chi, con richiami ipocriti, dipinge fronti repubblicani funzionali solo a ristabilire quell’ordine politico che negli ultimi venti anni ha significato rigore economico e impoverimento di massa.
Leggi tutto
Stefano Petrucciani: Democrazia e laicità
Democrazia e laicità
di Stefano Petrucciani
 1. Neutralità e laicità dello
Stato
democratico[1]
1. Neutralità e laicità dello
Stato
democratico[1]
Tra i diritti fondamentali le moderne democrazie costituzionali non includono solo quello di manifestare le proprie idee politiche, ma anche quello di professare la propria religione. Anzi, si può dire che uno dei principi basilari del moderno Stato costituzionale sia proprio quello della laicità o neutralità religiosa dello Stato, che si è affermato nella cultura europea attraverso la sanguinosa vicenda delle guerre di religione che si scatenarono dopo la Riforma, e che è ormai patrimonio di tutte le democrazie liberali. Nel patrimonio culturale europeo risulta dunque acquisita (in buona misura) l’idea che lo Stato non può far propri i dogmi di una determinata religione, e tantomeno ispirare ad essi la propria legislazione, ma deve invece offrire una cornice nella quale si possano riconoscere sia i cittadini appartenenti a religioni diverse sia quelli che non ne professano nessuna. E’ questo appunto il contenuto del principio di laicità dello Stato, che in Italia è stato esplicitato e definito non tanto nella Costituzione vera e propria quanto soprattutto in alcune sentenze della Corte costituzionale: prima nella sentenza n. 203/1989 e poi in quella n. 508/2000 dove si afferma che «l’atteggiamento dello Stato non può che essere di equidistanza e imparzialità nei confronti»di tutte le confessioni religiose, senza alcuna rilevanza del dato quantitativo o delle reazioni sociali conseguenti alla violazione dei loro diritti, «imponendosi la pari protezione della coscienza di ciascuna persona che si riconosce in una fede quale che sia la confessione di appartenenza»[2].
L’affermazione di questo principio, però, non risolve affatto tutti i problemi che si pongono nella convivenza tra diversi; problemi che diventano tanto più drammatici nel momento in cui migranti di etnia, cultura e religione differente dalla nostra attraversano ogni giorno i confini degli Stati europei, magari per entrare in aule scolastiche dove è esposto il crocefisso o dove il velo islamico – nelle sue tante varietà – non è ben accetto.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: La non valutabilità della Tragedia dell’Euro
La non valutabilità della Tragedia dell’Euro
di Giuseppe Masala
Interessante uno studio del Think Tank tedesco Centrum fur Europaiske Politik (Cep) che illustra quelli che sono i paesi usciti vincitori dall’adozione dell’Euro.
Il metodo utilizzato è quello del controllo sintetico che raffronta le performance dei paesi entrati nella moneta unica rispetto ad alcuni “paesi-controllo” che ovviamente non sono entrati. Naturalmente la disamina parte dall’anno dell’introduzione della moneta.
Manco a dirlo il paese che ha subito le maggiori perdite dall’adozione dell’Euro è stata l’Italia, con una perdita di 4.300 miliardi di euro ovvero 73.600 euro a testa. Sì, sì, avete capito bene: ognuno di voi che sta leggendo ha subito secondo questo studio un danno di 73.600 euro.
Al secondo posto tra i paesi danneggiati la Francia, che ha subito un danno pro capite di 56.000 euro. I maggiori vantaggi li hanno ottenuti la Germania con un guadagno di 23.000 euro a testa e l’Olanda con un guadagno a testa di 21.000 euro.
Come tutte le stime, naturalmente, è criticabile nella metodologia, ma senza tema di essere smentito vorrei ricordare che i danni per l’Italia sono iniziati ben prima, almeno dal 1992, ovvero da quando iniziò la folle rincorsa per entrare in quell’area euro che ci avevano fatto credere fosse il paradiso e si è rivelata un inferno.
Leggi tutto
Carlo Clericetti: Sanders, Corbyn, Zingaretti. Trova l’intruso
Sanders, Corbyn, Zingaretti. Trova l’intruso
di Carlo Clericetti
Nel disastro della sinistra in questi ultimi anni, con caratteristiche più o meno simili in tutti i paesi avanzati, spiccano alcune eccezioni. Alexis Tsipras in Grecia e Antonio Costa in Portogallo sono riusciti ad andare al governo dopo campagne elettorali anti-austerità e prefigurando politiche fortemente alternative a quelle attuate in Europa. Poi il primo ha dovuto cedere al “waterboarding economico” (la similitudine con la nota pratica di tortura è di Yanis Varoufakis) e del suo programma non è rimasto nulla: secondo i sondaggi, non resterà al governo dopo le prossime elezioni. Il secondo al momento ha il vento in poppa, nonostante che la politica economica portoghese non sia cambiata, se non per alcuni provvedimenti in favore del lavoro e dei meno abbienti somministrati però in dosi quasi omeopatiche. Ma, anche grazie al buon momento della congiuntura, sono bastati per dare l’impressione che la musica fosse diversa.
Negli Stati Uniti Bernie Sanders è stato il fenomeno inaspettato della scorsa campagna presidenziale. Un anziano senatore (oggi ha 77 anni) di un piccolo Stato, mai apparso prima alla ribalta delle cronache nazionali, è riuscito a mobilitare folle di sostenitori. I sondaggi lo davano vincente su Trump, ma per l’establishment del Partito democratico era decisamente troppo radicale: lo hanno ostacolato in tutti i modi e i “grandi elettori”, determinanti nel decidere la nomination, si sono schierati in grande maggioranza con la guerrafondaia Clinton, che dell’establishment è una perfetta rappresentante.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Compatibili, incompatibili e scartati
![]()
Compatibili, incompatibili e scartati
Il muro numero 78 è nel Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, febbraio 2019. Quando quello di Berlino cadeva a pezzi per i collezionisti erano giusto 15. Alla fine della seconda guerra mondiale i muri recensiti erano appena sette. Dal 1989 ai nostri giorni i muri ufficiali sono, secondo la geografa Elisabeth Vallet, almeno 77. Un numero già surclassato in conseguenza dei prossimi avvenimenti nelle geopolitiche mondiali. Quello di Trump, ai confini del Messico, non è che l’epilogo di una lunga storia iniziata prima di lui. I muri sono simboli che organizzano a loro maniera il tipo di mondo che si vorrebbe abitare. Compatibili, incompatibili e soprattutto scartati. A questo serve l’edificazione dei muri i cui mattoni sono aggiunti da volenterosi operatori di divisioni di classi e di mondi. I materiali di costruzione dei muri sono i più disparati e rispecchiano insieme continuità e innovazione. Da muri elettronici con sensori a quelli di filo spinato, ormai un classico da manuale, al cemento, alla sabbia, al mare, al cartone e alle parole. Questi materiali e altri più o meno nobili sono all’opera per congiungere fantasia e spietatezza al messaggio che si vuole veicolare a cittadini impauriti da mezzi di comunicazione assoldati dal potere. Sono passati quarant’anni dal celebre pezzo eseguito dai Pink Floyd, ‘Another Brick in The Wall’, un altro mattone nel muro. Quarant’anni di esseri umani scartati perchè incompatibili col mondo che verrà.
Leggi tutto
Carmine Tomeo: Le morti sul lavoro sono un indicatore di classe
Le morti sul lavoro sono un indicatore di classe
di Carmine Tomeo
Ogni anno nel mondo 3 milioni di persone muoiono per infortuni o malattie connesse al lavoro. Ma aumentare i controlli non basta, il problema è il paradigma economico che subordina le vite alla competitività delle imprese
 Partiamo da un presupposto: una
qualsiasi analisi degli infortuni e delle malattie
professionali che tenti di abbracciare in maniera
complessiva la materia non può prescindere dal considerare i
rapporti di produzione esistenti. Una sanzione a questa tesi
ci viene dal
compianto sociologo torinese, Luciano
Gallino: «Le imprese che per risparmiare
qualche migliaio di dollari o di euro non predispongono misure
adeguate per prevenire
incidenti o gravi patologie a lunga genesi rappresentano in
modo singolarmente efficace la lotta di classe sui luoghi di
lavoro». Una lotta
nella quale ogni anno muoiono milioni di persone.
Partiamo da un presupposto: una
qualsiasi analisi degli infortuni e delle malattie
professionali che tenti di abbracciare in maniera
complessiva la materia non può prescindere dal considerare i
rapporti di produzione esistenti. Una sanzione a questa tesi
ci viene dal
compianto sociologo torinese, Luciano
Gallino: «Le imprese che per risparmiare
qualche migliaio di dollari o di euro non predispongono misure
adeguate per prevenire
incidenti o gravi patologie a lunga genesi rappresentano in
modo singolarmente efficace la lotta di classe sui luoghi di
lavoro». Una lotta
nella quale ogni anno muoiono milioni di persone.
Due milioni di morti ogni anno
Le più recenti stime dell’Ilo (Organizzazione internazionale del lavoro) sono agghiaccianti: 2,78 milioni di lavoratori muoiono ogni anno per infortuni sul lavoro (quasi 400 mila) o per malattie connesse all’attività lavorativa (circa 2,4 milioni). Altre 160 milioni di persone contraggono malattie professionali seppure non mortali. Mentre molto spesso un incidente non mortale lascia tracce indelebili nella vita di un numero sterminato di lavoratori: 313 milioni di persone subiscono infortuni che provocano lesioni gravi e gravissime; dati Ilostat confermano che negli ultimi dodici anni, mediamente 2 milioni di persone ogni anno hanno perso in maniera permanente la capacità di svolgere le normali mansioni di lavoro nell’occupazione che avevano al momento dell’incidente; in moltissimi casi, com’è facile immaginare, la lesione ha provocato una totale incapacità lavorativa.
Così, nel tempo che avete dedicato a leggere queste poche righe, da qualche parte nel mondo 153 persone hanno subito un infortunio e 4 di esse hanno perso la vita, ammazzati da un sistema economico che fa stragi (pressoché nel silenzio generale) che non risparmiano nemmeno i minorenni, neppure i bambini.
Leggi tutto
Guillaume Deloison: Contro la sinistra del Capitale
Contro la sinistra del Capitale
di Guillaume Deloison
 L'idea stessa di rivoluzione,
sembra essersi dissolta
nell'aria, così come ogni critica radicale del capitalismo.
Naturalmente, viene generalmente ammesso che ci sarebbero
numerosi dettagli da
cambiare per quanto riguarda l'ordine del mondo. Ma uscire dal
capitalismo, e basta? E poi per sostituirlo con che cosa?
Chiunque ponga questa
domanda, rischia di passare per un nostalgico del
totalitarismo del passato, oppure per un ingenuo sognatore.
Ma, sulla base di quella che è la
nostra situazione ecologica e sociale, appare decisamente
necessario portare avanti una critica radicale del
capitalismo, mostrarne il suo carattere
distruttivo, che è allo stesso tempo anche storicamente
limitato.
L'idea stessa di rivoluzione,
sembra essersi dissolta
nell'aria, così come ogni critica radicale del capitalismo.
Naturalmente, viene generalmente ammesso che ci sarebbero
numerosi dettagli da
cambiare per quanto riguarda l'ordine del mondo. Ma uscire dal
capitalismo, e basta? E poi per sostituirlo con che cosa?
Chiunque ponga questa
domanda, rischia di passare per un nostalgico del
totalitarismo del passato, oppure per un ingenuo sognatore.
Ma, sulla base di quella che è la
nostra situazione ecologica e sociale, appare decisamente
necessario portare avanti una critica radicale del
capitalismo, mostrarne il suo carattere
distruttivo, che è allo stesso tempo anche storicamente
limitato.
Contrariamente a quanto è stato ritenuto implicitamente da Adam Smith, David Ricardo, e perfino da quasi tutti i marxisti, le categorie capitalistiche della merce, del valore, del lavoro, non sono affatto naturali ed eterne. Tali categorie esistano specificamente solo grazie al modo di produzione attuale. Il valore considera solo la quantità di lavoro contenuta nelle merci, vale a dire, la quantità di tempo necessario alla loro produzione. Tempo che può essere visto solamente secondo il modo standardizzato della produzione capitalista: come pura astrazione. Un ora, quella della fabbrica, è la stessa ora dappertutto, ovunque. Il capitalismo si caratterizza a livello profondo per il fatto che la società tutt'intera è dominata da questi fattori anonimi ed impersonali. É ciò che Marx chiama «feticismo della merce», e che non è affatto riducibile ad una semplice «mistificazione» della realtà capitalista.
Piuttosto che mettere in discussione il valore di mercato, il lavoro, ecc., in quanto principio regolatore della produzione e della vita sociale, il movimento operaio ed i suoi teorici si battevano solamente per una sua «ridistribuzione» più giusta. Accettando quella che è la struttura stessa della produzione capitalista, si preoccupavano essenzialmente di riuscire ad ottenere le migliori condizioni di vita per le classi lavoratrici.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Politicamente corretto: violenza liberista
Politicamente corretto: violenza liberista
di Carlo Formenti
La campagna “antipopulista” dei partiti e dei media allineati con gli interessi e i valori del liberismo non conosce soste e si fa più virulenta a mano a mano che si avvicinano le elezioni europee.
Negli ultimi giorni abbiamo assistito:
1. Alle sparate di Macron e dei media francesi che hanno preso spunto dal proliferare di scritte antisemite per rilanciare l’equazione antisionismo=antisemitismo (ma nell’equazione è sottinteso un senso più ampio: se non sei amico dello stato e del governo di Israele sei antisemita di default).
In particolare, dopo che alcune sinistre radicali hanno manifestato contro questo uso strumentale degli atti di antisemitismo, si è lanciata l’equazione rossi=neri=islamici, evocando una inesistente ideologia rossobrunistaislamica (per inciso: questa neutralizzazione delle differenze è stata una delle armi storiche usate dal razzismo totalitarista il cui ritorno si dice di voler esorcizzare).
Leggi tutto
Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea
di Francesco Garibaldo, Mariana Mortágua, Riccardo Bellofiore
Pubblichiamo l’introduzione del volume di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua “Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea”: un contributo rigoroso e appassionato al dibattito sull’Europa e la sua crisi
Questo libro propone un’analisi della crisi combinando una prospettiva marxiana e una prospettiva keynesiano-finanziaria. Entrambe sono interne a una visione strutturale e di lungo periodo delle dinamiche capitaliste. Ogni crisi scoppia a causa delle contraddizioni di fattori idiosincratici, gli stessi che ne spiegano l’ascesa. Stiamo vivendo la crisi non di un generico neoliberismo o di una vuota finanziarizzazione, ma di un money manager capitalism, un capitalismo dei gestori finanziari, che è stato costruito sulla centralizzazione senza concentrazione, su nuove forme di governo societario, sulla concorrenza distruttiva, sull’aumento dei prezzi delle attività finanziarie, e sul consumo a debito. Un mondo che è stato in grado di approfondire in forme nuove il vecchio sfruttamento, di procurarsi internamente la domanda, e di presentarsi come in grado di crescere dentro una Grande Moderazione apparentemente sempre più stabile. Questo mondo può essere descritto come un keynesismo privatizzato di natura finanziaria, basato su una politica monetaria e su una domanda autonoma, entrambe di tipo nuovo: una configurazione che alla fine si è rivelata insostenibile per ragioni intrinseche alla sua costituzione. La sua crisi sta evolvendo da una Grande Recessione verso una Depressione Minore.
Leggi tutto
D.C.: La politica del ferro e del fuoco
La politica del ferro e del fuoco
di D.C.
I gilets jaunes fondano un nuovo modo di fare politica nella lotta di strada, bisogna scrollarsi di dosso anni di passerelle elettorali, di rappresentanze parlamentari compromesse, di arrivisti politici
Ingrid Levavasseur è una signora di provincia che fa l’infermiera in una città della Normandia, ha un lavoro pagato al minimo che gli permette con fatica di arrivare a fine mese, due figli da allevare da sola perché divorziata, parla un francese corretto, ha dichiarato di non seguire particolarmente la politica e di aver votato Macron alle ultime elezioni, era salita alla ribalta come una delle prime portavoce del movimento.
Non ha idee di rivolta da propugnare e le poche e confuse idee che ha sono un concentrato di banalità sconcertanti: il suo ruolo “non sarà quello di prendere decisioni ma di assicurare che le scelte dei cittadini vengano rispettate”. Banalità che i media francesi hanno preso al volo per farne una dei principali protagonisti della protesta dei gilets jaunes. Un’operazione, quella delle TV francesi, confezionata ad arte, buona per chi accetta che tutto quello che passa davanti allo schermo sia vero, nello sforzo di preparare il terreno ad un partito organizzato che tolga tutto il potenziale ribelle alla protesta dei gilets jaunes.
Per questo motivo la signora in questione è diventata la capolista dei “Ralliement d’initiative citoyenne”, assieme ad altri 10 individui: manager, giuristi, contabili ma anche autisti e casalinghe, un accozzaglia di professioni rappresentanti una parte dei gilets jaunes e presentati come possibili candidati alle elezioni europee.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3173
Hits 2376
Hits 2245
Hits 2175
Hits 2097
Hits 1985
Hits 1974
Hits 1926
tonino

Gennaro Carotenuto: Venezuela, i 30 giorni nei quali Juan Guaidó non è andato da nessuna parte
Venezuela, i 30 giorni nei quali Juan Guaidó non è andato da nessuna parte
di Gennaro Carotenuto
 Escludendo l’intervento
militare in Venezuela, la riunione del gruppo di Lima (il
consesso dei governi
latinoamericani di destra, riuniti ieri a Bogotá) ha chiuso
nella sostanza la parabola del tentativo di Juan Guaidó come
presidente
autoproclamato del Venezuela e allo stesso tempo evitato la
regionalizzazione della crisi. Proviamo a mettere insieme
elementi di analisi sugli ultimi
30 giorni e in particolare sull’ultimo lungo fine settimana al
confine tra Colombia e Venezuela.
Escludendo l’intervento
militare in Venezuela, la riunione del gruppo di Lima (il
consesso dei governi
latinoamericani di destra, riuniti ieri a Bogotá) ha chiuso
nella sostanza la parabola del tentativo di Juan Guaidó come
presidente
autoproclamato del Venezuela e allo stesso tempo evitato la
regionalizzazione della crisi. Proviamo a mettere insieme
elementi di analisi sugli ultimi
30 giorni e in particolare sull’ultimo lungo fine settimana al
confine tra Colombia e Venezuela.
La guerra si allontana dai Caraibi?
Partiamo dalla fine, da Bogotá e dal cosiddetto Gruppo di Lima, creato solo nel 2017 dagli USA come istanza multilaterale per risolvere la crisi venezuelana, e che, solo a gennaio, per riconoscere Guaidó aveva registrato la defezione di un pezzo da novanta come il Messico di Andrés Manuel López Obrador, messosi alla testa della linea del dialogo con Maduro. Pur con l’augusta presidenza del vice di Trump, Mike Pence, alla quale quasi tutti i convenuti riconoscono ben più di una primogenitura, dimostrando anche plasticamente come l’America latina sia tornata subalterna a Washington, questa volta tutto è andato male per il giovane capo (forse) dell’opposizione venezuelana. Salta infatti all’occhio che questa volta la riunione è stata appena per vice-presidenti, ma soprattutto che il Perú prima, il Brasile soprattutto, abbiano escluso la soluzione militare alla crisi sulla quale ancora poche ore prima batteva la grancassa mediatica.
Del Brasile diremo di più subito sotto. Perché i latinoamericani siano riottosi sull’intervento militare è presto detto: ne hanno paura e hanno paura di opinione pubbliche nelle quali il discorso integrazionista non si è mai spento. Una guerra civile in Venezuela rischia di creare un movimento enorme e armato, brigate internazionali in difesa del Venezuela.
Leggi tutto
John Dupré: La ragionevole inefficacia della scienza di base (per la spiegazione della natura umana)
La ragionevole inefficacia della scienza di base (per la spiegazione della natura umana)
Alessandro Della Corte conversa con John Dupré
 John Dupré si è principalmente occupato della
filosofia
delle scienze della vita. Un aspetto molto interessante del
suo lavoro riguarda le ricadute dello studio degli organismi
viventi su problemi classici
dell’epistemologia come quelli riguardanti riduzionismo,
determinismo e libero arbitrio. Spero che i lettori di Anticitera
apprezzeranno l’intervista che Dupré ha gentilmente
accettato di concederci.
John Dupré si è principalmente occupato della
filosofia
delle scienze della vita. Un aspetto molto interessante del
suo lavoro riguarda le ricadute dello studio degli organismi
viventi su problemi classici
dell’epistemologia come quelli riguardanti riduzionismo,
determinismo e libero arbitrio. Spero che i lettori di Anticitera
apprezzeranno l’intervista che Dupré ha gentilmente
accettato di concederci.
* * * *
Nei suoi scritti lei ha criticato il riduzionismo, e in particolare la possibilità teorica di spiegare tutti i fenomeni naturali (inclusi comportamenti e abilità complessi tipici dell’uomo) utilizzando la fisica fondamentale. Oggi il riduzionismo è probabilmente meno popolare tra i filosofi rispetto a qualche anno fa, ma spesso continua a essere il modello epistemologico di riferimento (esplicito o implicito) per molti scienziati. Come mai, e che c’è di sbagliato in esso?
Penso che scienziati e filosofi diano alla parola riduzionismo significati leggermente diversi. Per gli scienziati, spesso è poco più che la convinzione metodologica che sia tipicamente una buona idea analizzare le varie parti di un sistema e descrivere le loro interazioni se si vuole spiegare il suo comportamento. I filosofi di solito intendono qualcosa di molto più forte, che ogni cosa è spiegabile, in linea di principio, in base alle proprietà e alle interazioni delle sue parti. Dal momento che le spiegazioni sono di solito supposte transitive, questo potrebbe implicare che tutto, in linea di principio, è spiegabile con la fisica fondamentale. L’espressione “in linea di principio” gioca un grande ruolo qui; vista la complessità dei calcoli richiesti, potrebbe essere necessario Dio per avere una vera spiegazione.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: L’oggettività ideologica del capitalismo assoluto
![]()
L’oggettività ideologica del capitalismo assoluto
di Salvatore Bravo
 Le leggi
galileane della natura, l’eternità inamovibile delle leggi
scientifiche sono il fondamento ideologico del capitalismo
assoluto. L’ideologia instaura l’eterno, anche dove non vi è
che la
realtà “umana troppo umana”, come affermerebbe Nietzsche. Ogni
piano della vita sociale è espropriato del tempo storico e di
senso, per essere sostituito dal tempo eterno della
ripetizione. La temporalità è ciclica ripetizione del sempre
eguale, nella caverna
del tempo vi cadono anche i detentori dei mezzi di produzione
e di illusione di massa, poiché ritengono le leggi
dell’economia attuale
fondate scientificamente e dunque intrasmutabili. I guinzagli
dei poteri sono scintillanti di calcoli ed oggettività, i
sudditi ne accettano il
giogo, perché dinanzi al feticcio della scienza avulsa dalla
temporalità, credono con atto di fede automatico alla verità
della
condizione attuale. Rompere tali meccanismi automatici, nei
quali siamo intrappolati è operazione non semplice, ma i
grandi mali non sono
esenti da potenziali rimedi, per riportare la storia nella
vita dei popoli è necessario capire, ed in ciò vi sono autori
imprescindibili: György Lukács in Storia e coscienza di
classe, problematizza l’economicismo e
l’esemplificazione per
reintrodurre la possibilità del senso, contro coloro che
vorrebbero congelare la storia in un silenzio esiziale e
fatale per
l’umanità ed i popoli1 :
Le leggi
galileane della natura, l’eternità inamovibile delle leggi
scientifiche sono il fondamento ideologico del capitalismo
assoluto. L’ideologia instaura l’eterno, anche dove non vi è
che la
realtà “umana troppo umana”, come affermerebbe Nietzsche. Ogni
piano della vita sociale è espropriato del tempo storico e di
senso, per essere sostituito dal tempo eterno della
ripetizione. La temporalità è ciclica ripetizione del sempre
eguale, nella caverna
del tempo vi cadono anche i detentori dei mezzi di produzione
e di illusione di massa, poiché ritengono le leggi
dell’economia attuale
fondate scientificamente e dunque intrasmutabili. I guinzagli
dei poteri sono scintillanti di calcoli ed oggettività, i
sudditi ne accettano il
giogo, perché dinanzi al feticcio della scienza avulsa dalla
temporalità, credono con atto di fede automatico alla verità
della
condizione attuale. Rompere tali meccanismi automatici, nei
quali siamo intrappolati è operazione non semplice, ma i
grandi mali non sono
esenti da potenziali rimedi, per riportare la storia nella
vita dei popoli è necessario capire, ed in ciò vi sono autori
imprescindibili: György Lukács in Storia e coscienza di
classe, problematizza l’economicismo e
l’esemplificazione per
reintrodurre la possibilità del senso, contro coloro che
vorrebbero congelare la storia in un silenzio esiziale e
fatale per
l’umanità ed i popoli1 :
”Dal punto di vista del capitalista singolo, la realtà economica appare come un mondo dominato da leggi eterne della natura, alle quali egli deve adeguare il proprio /faire e laisser /faire. La realizzazione del plusvalore, l'accumulazione si compie per lui (naturalmente non sempre, ma molto spesso) nella forma di uno scambio con altri capitalisti singoli. E l'intero problema dell'accumulazione è dunque soltanto quello di una forma delle molteplici trasformazioni subite dalle formule D-M-D e M-D-M nel corso della produzione, della circolazione, ecc. Così, esso diventa per l'economia volgare un problema scientifico-particolare di dettaglio, che non ha quasi nessun legame con il destino del capitalismo nel suo complesso, - un problema la cui soluzione è sufficientemente garantita dalla giustezza delle «formule, di Marx, che dovranno al massimo – secondo Otto Bauer - essere perfezionate in modo da renderle « aggiornate ,..
Leggi tutto
coniarerivolta: Autonomia differenziata: il sud nella trappola dell’austerità
Autonomia differenziata: il sud nella trappola dell’austerità
di coniarerivolta
Si discute molto, in questi giorni, della cosiddetta autonomia differenziata. Quest’ultima dovrebbe rappresentare il fiore all’occhiello dell’avventura leghista al governo con il Movimento 5 Stelle. Al momento (e questa dovrebbe essere una buona notizia, come vedremo a breve), il governo giallo-verde sembra non riuscire a trovare la quadra sull’argomento. Ciò avviene, questo è certo, non per le preoccupazioni del Movimento 5 Stelle sulla tenuta dell’unità nazionale o sul destino dei cittadini del Mezzogiorno, ma semplicemente per il tornaconto elettorale di un movimento politico che ha tratto gran parte del suo consenso dalle regioni del Sud e che, adesso, una volta che il bluff giallo-verde è stato svelato, sta assistendo a un inesorabile smottamento nella sua popolarità proprio in quelle regioni che ne avevano favorito l’ascesa. La riforma, però, sembra soltanto rinviata, probabilmente a dopo le imminenti elezioni europee. Vale, dunque, la pena di soffermarsi sulla questione, allo scopo di metterne in luce i contenuti e le implicazioni.
Prima di tutto, dobbiamo chiederci cosa sia l’autonomia differenziata. In generale, è possibile asserire che lo Stato tassa i cittadini e ‘accentra’ la quasi totalità delle risorse: in altre parole, le tasse pagate dai cittadini finiscono quasi integralmente all’erario, ossia nelle casse dello Stato. L’autonomia differenziata romperebbe questo meccanismo, permettendo ad enti più periferici, come le Regioni, di trattenere una quota rilevante (più o meno elevata a seconda della portata dell’eventuale riforma, ma comunque maggiore di quella attuale, davvero minima) delle tasse pagate dai cittadini.
Leggi tutto
comidad: La politica inerme di fronte alla lobby della deflazione
La politica inerme di fronte alla lobby della deflazione
di comidad
Molti commentatori si sono chiesti quale necessità vi fosse di affibbiare gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi. Forse non c’erano necessità giudiziarie, ma sicuramente vi era opportunità dal punto di vista comunicativo. Una semplice incriminazione, dati i trascorsi dei due soggetti, non avrebbe fatto notizia e sarebbe passata quasi inosservata. Grazie all’arresto c’è stato invece lo scoop. Il risultato comunicativo è il discredito ulteriore del PD attraverso la persona del suo principale boss, perciò un’eventuale caduta del governicchio Conte non potrebbe vedere candidarsi il PD come guida o componente della successione. Oggettivamente l’operato della magistratura costituisce ancora una volta un tirare la volata ad un governo “tecnico” a guida di Carlo Cottarelli.
L’amarezza dimostrata da Renzi è sembrata andare oltre l’ovvio dramma personale, come se egli in questa circostanza si fosse sentito fregato. La linea del “popcorn”, il sabotaggio dell’accordo di governo tra il PD e i 5 Stelle, è stata probabilmente suggerita a Renzi facendogli credere che in tal modo sarebbe stato lasciato in pace dal punto di vista giudiziario; invece così non è stato ed a Renzi non resta altra opzione che continuare a recitare la stessa parte.
Leggi tutto
Gianluca Piovani: L’economia globale sta peggiorando?
L’economia globale sta peggiorando?
di Gianluca Piovani
Le stime dell’ottobre 2018 del Fondo Monetario Internazionale (d’ora innanzi FMI), sono state recentemente aggiornate nel mese di gennaio 2019.
L’aggiornamento è in negativo e risente di un clima di generale sfiducia che penalizza l’attività economica. L’andamento dell’economia non è difatti unicamente influenzato da fattori oggettivi, ma è mosso anche dalle aspettative degli operatori: l’attesa di shock negativi influenza sia l’attività delle imprese, che riducono i piani di investimento e rimandano le assunzioni, che i consumatori, che riducono le spese per aumentare il risparmio. Per quanto sia già visibile un impatto negativo dovuto al peggioramento delle aspettative, l’avverarsi degli shock temuti potrebbe causare conseguenze più gravi ed innescare una crisi. In questo senso l’outlook del FMI è stato sia rivisto in negativo che soggetto a rischi a ribasso.
Paesi sviluppati
A frenare maggiormente a livello mondiale sono i paesi sviluppati. Negli Stati Uniti continua la tensione riguardo la definizione delle tariffe commerciali con Cina ed Europa. Il mese di marzo è la scadenza per la temporanea sospensione delle misure che porterebbero i dazi verso la Cina al 25%, mentre similmente è in corso di valutazione l’aumento delle tariffe verso i costruttori di auto europei fino al 25% per presunte questioni di sicurezza nazionale.
Leggi tutto
Riccardo Realfonzo e Angelantonio Viscione: Una manovra che non spinge la crescita
Una manovra che non spinge la crescita
di Riccardo Realfonzo* e Angelantonio Viscione*
La recessione sperimentata dall’economia italiana nella seconda metà del 2018 renderebbe urgente un forte sostegno del governo alla crescita. Tuttavia, le stime che presentiamo in questo lavoro, e che approfondiamo ulteriormente in economiaepolitica.it, mostrano che la manovra economica per il 2019 avrà un impatto molto modesto sulla crescita, soprattutto a causa della carenza di investimenti pubblici e della mancanza di una visione di politica industriale. Sarebbe stato possibile concepire forme di intervento ben più incisive per aggredire i nodi della competitività e rilanciare la crescita, anche a saldi invariati. Se poi si fosse fatto ricorso a una manovra che avesse ampliato il deficit, ad esempio al 2,4% del pil, come il governo stesso aveva inizialmente ipotizzato, concentrando interamente le risorse in più rispetto all’attuale 2,04% sugli investimenti, l’effetto espansivo sarebbe addirittura triplicato.
La manovra economica per il 2019
Dal punto di vista delle risorse in campo, le misure discrezionali introdotte dal governo per il 2019 possono essere sintetizzate nella Tabella 1.
Leggi tutto
Enrico Grazzini: La recessione incalza e l'euro ci soffoca
La recessione incalza e l'euro ci soffoca
E' il momento di emettere dei titoli quasi-moneta per rilanciare l'economia
di Enrico Grazzini
 Una recente indagine scientifica
dell'autorevole istituto di ricerca tedesco Centrum für
Europäische Politik e i dati della Banca Mondiale sul mancato
sviluppo dell'eurozona dimostrano chiaramente e con la forza
dei numeri che l'euro
è una moneta che frena gravemente l'economia, provoca
diseguaglianza, arricchisce alcune nazioni, come la Germania,
e ne impoverisce altre,
come l'Italia. Il Centrum für Europäische Politik dimostra,
come vedremo, che l'euro ha tolto soldi ai cittadini italiani
ma ha riempito le
tasche dei cittadini tedeschi. Questo non basta: si prospetta
una nuova recessione economica. L'Italia sembra oggettivamente
paralizzata sull'orlo del
precipizio (e questa volta non per sua colpa). Per rilanciare
l'economia il governo italiano dovrebbe finanziare estesamente
molti piccoli e grandi
investimenti pubblici, ma mancano i soldi necessari. Il
problema è che la Banca Centrale Europea non può sovvenzionare
gli stati e pompa
moneta solamente per le banche; ma le banche commerciali non
hanno interesse a fare credito a favore di una economia
depressa. Gli operatori
finanziari lucrano invece sui debiti pubblici e chiedono tassi
di interesse sempre più elevati per prestare denaro agli
stati. Così i
paesi dell'eurozona non trovano le risorse per fare gli
investimenti necessari per rivitalizzare l'economia. Inoltre
l'Unione Europea impone ulteriori
restrizioni di bilancio pubblico. Il cappio si sta stringendo.
La crisi italiana potrebbe facilmente precipitare.
Una recente indagine scientifica
dell'autorevole istituto di ricerca tedesco Centrum für
Europäische Politik e i dati della Banca Mondiale sul mancato
sviluppo dell'eurozona dimostrano chiaramente e con la forza
dei numeri che l'euro
è una moneta che frena gravemente l'economia, provoca
diseguaglianza, arricchisce alcune nazioni, come la Germania,
e ne impoverisce altre,
come l'Italia. Il Centrum für Europäische Politik dimostra,
come vedremo, che l'euro ha tolto soldi ai cittadini italiani
ma ha riempito le
tasche dei cittadini tedeschi. Questo non basta: si prospetta
una nuova recessione economica. L'Italia sembra oggettivamente
paralizzata sull'orlo del
precipizio (e questa volta non per sua colpa). Per rilanciare
l'economia il governo italiano dovrebbe finanziare estesamente
molti piccoli e grandi
investimenti pubblici, ma mancano i soldi necessari. Il
problema è che la Banca Centrale Europea non può sovvenzionare
gli stati e pompa
moneta solamente per le banche; ma le banche commerciali non
hanno interesse a fare credito a favore di una economia
depressa. Gli operatori
finanziari lucrano invece sui debiti pubblici e chiedono tassi
di interesse sempre più elevati per prestare denaro agli
stati. Così i
paesi dell'eurozona non trovano le risorse per fare gli
investimenti necessari per rivitalizzare l'economia. Inoltre
l'Unione Europea impone ulteriori
restrizioni di bilancio pubblico. Il cappio si sta stringendo.
La crisi italiana potrebbe facilmente precipitare.
In questo contesto di crisi annunciata tocca alla politica percorrere strade innovative e alternative per difendere e risollevare l'economia nazionale. A mali estremi estremi rimedi. Una maniera concreta di dare ossigeno monetario e fiscale al nostro Paese è che il governo emetta urgentemente dei titoli quasi-moneta complementari all'euro. Pur restando nell'eurozona i Titoli di Sconto Fiscale a favore delle famiglie, delle imprese e degli enti pubblici potrebbero legittimamente (e senza infrangere nessuna regola europea) affiancare l'euro e neutralizzare gli effetti deflazionistici della moneta unica.
Leggi tutto
Marco Veronese Passarella: Che Guevara, Maradona e Jim Morrison
Che Guevara, Maradona e Jim Morrison
Metaintervistina 30 – Writing Bad
Intervista a Marco Veronese Passarella
 1 ) WW: le metaintervistine sono
nate per “intervistare” persone legate al mondo della
letteratura, poi
si sono spinte verso il mondo della musica e ora… siamo
giunti all’economia. Marco Veronese Passarella: l’economia è
scienza
o è anche arte? L’economista può essere un artista nel suo
essere, appunto, economista?
1 ) WW: le metaintervistine sono
nate per “intervistare” persone legate al mondo della
letteratura, poi
si sono spinte verso il mondo della musica e ora… siamo
giunti all’economia. Marco Veronese Passarella: l’economia è
scienza
o è anche arte? L’economista può essere un artista nel suo
essere, appunto, economista?
MVP: Mi verrebbe da dire che è confusione, come rivela il fatto che si usi comunemente lo stesso nome, “economia”, per riferirsi sia alla scienza che al suo oggetto. Prescindendo da questo, l’economia politica o “economica” è l’arte di dimostrare, attraverso l’utilizzo di strumenti e metodi scientifici, che l’interesse materiale particolare della propria parte sociale corrisponde all’interesse generale. Insomma, l’una e l’altra cosa – arte della retorica e scienza – al servizio della lotta di classe nel piano più alto della sovrastruttura, quello della produzione delle lenti attraverso cui filtriamo (e modifichiamo) il mondo.
2) WW: quando l’ho contattata, lei si è definito “un barbaro”, ci spiega perché? Intendeva nel campo della letteratura?
MVP: Lo sono nell’accezione propria di straniero, appartenente a una civiltà remota – dato che sono comunista, ateo e, nei fatti anche se non per scelta, apolide. E, inoltre, lo sono anche nel senso lato di persona che legge ormai pochissimi libri, quasi nessuno. Persino nel mio lavoro la maggior parte del tempo di ricerca è assorbito dalla scrittura di codici e dalla lettura ‘diagonale’ di manuali e pubblicazioni tecnico-scientifiche. E, naturalmente, niente più carta. Solo bit. La barbarie, appunto.
3) WW: Com’è arrivato a essere lecturer in economics presso l’Economics Division della Business School, University of Leeds, e che giudizio da’ di questa sua esperienza lavorativa?
Leggi tutto
Joseph Serrano: La non-contemporaneità
La non-contemporaneità
Temporalità plurale in Louis Althusser
di Joseph Serrano
 Nel 1988, durante una conferenza dedicata a ciò
che gli
organizzatori chiamarono «L’eredità di Althusser», Étienne
Balibar presentò una relazione intitolata La
non-contemporaneità di Althusser. La distanza
temporale tra il momento in cui si tenne la conferenza e la
pubblicazione degli atti
è significativa, a maggior ragione se si tiene conto delle
ambivalenze di cui Balibar parla nella prima parte della sua
presentazione: qual
è il significato del termine «eredità» in relazione a un
filosofo come Althusser il quale, se anche non produceva più
testi filosofici come in passato, né ricopriva una posizione
nei circoli accademici e politici, non era comunque morto?1
Nel 1988, durante una conferenza dedicata a ciò
che gli
organizzatori chiamarono «L’eredità di Althusser», Étienne
Balibar presentò una relazione intitolata La
non-contemporaneità di Althusser. La distanza
temporale tra il momento in cui si tenne la conferenza e la
pubblicazione degli atti
è significativa, a maggior ragione se si tiene conto delle
ambivalenze di cui Balibar parla nella prima parte della sua
presentazione: qual
è il significato del termine «eredità» in relazione a un
filosofo come Althusser il quale, se anche non produceva più
testi filosofici come in passato, né ricopriva una posizione
nei circoli accademici e politici, non era comunque morto?1
Certo, Athusser sarebbe morto prima della pubblicazione degli atti di quella conferenza, un fatto che rende le esitazioni di Balibar ancora più palpabili, come se la non-contemporaneità che Balibar individuava nel cuore del lavoro di Althusser potesse diventare visibile solo nella discrepanza temporale della stessa Eredità di Althusser, nel fatto cioè che la conferenza sarebbe arrivata troppo presto, e il libro troppo tardi. Trent’anni dopo (a cento anni dalla nascita di Althusser), nel mezzo di un rinnovato interesse per il marxismo e il lavoro del filosofo francese, siamo in grado di comprendere la potenza piena di questa non-contemporaneità. Il mio tentativo qui consisterà dunque nel far emergere questa forza considerandola come un momento di rottura che si produce nell’incontro tra la non-contemporaneità e un concetto fortemente problematico nel marxismo: la «determinazione in ultima istanza» ad opera dell’economia.
Il luogo in cui il problema della «determinazione in ultima istanza a opera dell’economia» viene esposto con maggiore chiarezza ed enfasi è Contraddizione e surdeterminazione, dove, alle ultime pagine del saggio, Althusser scrive: «l’ora solitaria dell’ultima istanza non suona mai, né al primo momento né all’ultimo»2. È impossibile non osservare la temporalità qui in gioco, anche se essa esiste solo a un livello letterario o metaforico.
Leggi tutto
Karlo Raveli: Proprietà, patriarcato e criminalità ecologica, Cop24
![]()
Proprietà, patriarcato e criminalità ecologica, Cop24
di Karlo Raveli
Pubblichiamo un nuovo testo di Karlo Raveli, speditoci da una tappa della sua lunga odissea migrante. Si scusa per il suo limitato italiano da immigrato da lunga data e spera che "possa apportare buone energie ai nuovi processi di lotta che a quanto pare si stanno accendendo globalmente"
 “La nostra credenza
di essere separati l’uno
dall’altro, dipende da una illusione ottica della nostra
coscienza” Albert Einstein
“La nostra credenza
di essere separati l’uno
dall’altro, dipende da una illusione ottica della nostra
coscienza” Albert Einstein
Non ci conosciamo personalmente, caro Guido Viale, ma – pur navigando per mari lontani – ho per fortuna pescato un tuo bel tracciato attraverso il nuovo movimento delle donne, diretto a (ri)scoperte risolutive per la possibile uscita dal progressivo imbarbarimento della civiltà capitalista (1). Alle dipendenze del potere reale di poche migliaia di delinquenti plurimiliardari con la loro coorte di milionari, statisti, direttori di stampa, TV, ecc. e di tutti gli altri mezzi politici, culturali, educativi, sportivi e mediatici sistemici. Società che si presenta sempre più sconvolgente, come riflette per esempio con impressionante pessimismo Bifo in un suo recente messaggio in Effimera, pure caduto per caso nelle mie reti (2). Una prospettiva ancor più vicina dopo l’esito scellerato della Cop 24.
E allora vediamo con un po' d’illusione o speranza come queste tue riflessioni si possano cuocere in modo più preciso e sostanzioso. Visto che per buona sorte appaiono sempre più frequentemente tra libertari e comunisti di questo policromo “movimento mondiale (di donne) che riempie la scena politica e sociale degli ultimi anni”. Facendoci presumere “che sarà protagonista di ogni possibile processo di trasformazione dei rapporti sociali nei decenni a venire” se riuscissimo ad evitare l’immane catastrofe planetaria verso cui ci porta questo modo di “sviluppo”. Trasformazione ancora possibile, come ci sta dimostrando la magnifica e straordinaria vicenda sociale curda in Rojava, non occultiamolo! O la nuova stupenda speranza di masse giovanili sempre più coscienti e attive, accese tra l’altro dalla stupefacente scintilla Greta.
Politica e scena politica reale
Ma cominciamo da questa ‘scena politica’ che proponi, e su cui non sono d’accordo. Almeno nel senso tradizionale di politico anche in uso nelle sinistre del sistema.
Leggi tutto
Carlo Clericetti: L’economia è una scienza inutile?
L’economia è una scienza inutile?
di Carlo Clericetti
È il titolo (senza punto interrogativo) di un libro di Francesco Saraceno, che ripercorre il dibattito degli ultimi anni dall’abbandono del keynesismo alla fase attuale, in cui molte certezze sono state spazzate via dagli anni della crisi. Non è inutile, dice l’autore, se si abbandona la pretesa che esistano leggi universali applicabili in qualsiasi contesto e si impara dalla storia e dall’esperienza.
Chi vuole capire la logica in base alla quale si è voluto varare il Jobs act (e provvedimenti simili in altri paesi europei), o perché si sia istituita una banca centrale che non risponde a nessuno di ciò che fa, o ancora, perché l’Unione europea, a differenza degli altri paesi più importanti, si è sempre rifiutata di utilizzare risorse pubbliche per combattere la crisi; chi vuole capire queste logiche dovrebbe leggere il libro appena pubblicato da Francesco Saraceno.
Il titolo è provocatorio: “La scienza inutile – Tutto quello che non abbiamo voluto imparare dall’economia” (ed. Luiss). Ma fin dall’introduzione Saraceno smentisce il titolo: inutile non è, a patto però di utilizzare determinati criteri. Tra i più importanti c’è “lo studio dei pensatori e della storia del passato”, che è fondamentale per la lettura della realtà. Dicendo questo Saraceno si iscrive a una corrente di economisti che oggi è in netta minoranza: quelli che sostengono che l’economia è una scienza sociale, e non una “scienza delle leggi”, come la matematica o la fisica.
Leggi tutto
Redazione Contropiano: La battaglia sui salari: quando la sinistra era presente a se stessa
La battaglia sui salari: quando la sinistra era presente a se stessa
di Redazione Contropiano
Marziani o semplicemente razionali? In un editoriale di poche settimane fa ponevamo in grande evidenza il problema del programma politico con cui una forza che abbia l’ambizione di rappresentare – anche elettoralmente – il “blocco sociale” popolare potrebbe cominciare ad avvicinare l’obbiettivo, lavorando tra la gente, nelle strade e nei luoghi di lavoro, senza perdersi ancora una volta nei corridoi in cui si cucinano le “liste elettorali”.
Al primo punto mettevamo – siamo strani, vero? – il problema del salario. Siccome ormai si lavora per una cifra x, che ogni “datore di lavoro” decide ed impone per proprio conto (indistinguibili ormai dall’ultimo caporale mafioso nei campi di pomodori), proponevamo “l’introduzione in Italia del salario minimo, indicizzato all’inflazione e determinato nella misura di 1.200 euro per l’anno 2019. Il lavoro straordinario, festivo o notturno va pagato come minimo il 50% in più”. Ovviamente per qualsiasi tipo di lavoro, come salario d’ingresso (da incrementare con anzianità, passaggi di livello e assegni familiari) e per 40 ore settimanali.
Sognatori…
Ora un corsivo come sempre intelligente di Alessandro Robecchi va a rovistare nella memoria di quella che un tempo aveva senso chiamare “sinistra”, riscoprendo questa “banalità” del salario che deve essere sufficiente per vivere, non per arricchire chi fa finta di dartene uno.
Leggi tutto
Nicola Lagioia: Appunti su “Serotonina”
Appunti su “Serotonina”
di Nicola Lagioia
Questo pezzo è uscito sulla rivista «Gli Asini», che vi suggeriamo di leggere
Di Serotonina, settimo romanzo di Michel Houellebecq, si è molto parlato prima ancora che venisse pubblicato. Contagiati dall’ansia anticipatoria che governa la stampa quotidiana, molti critici hanno posto con faciloneria l’accento sulle facoltà divinatorie dello scrittore francese: così come Sottomissione aveva avuto la ventura di uscire nel giorno della strage di «Charlie Hebdo», quest’ultimo romanzo (“naturalmente scritto prima che la rivolta dei gilet gialli esplodesse!”, notavano molti recensori con logica ferrea) arriverebbe in perfetto tempismo rispetto ai recenti fatti di cronaca. In Serotonina si parla a un certo punto di una rivolta di agricoltori contro le politiche UE, ma è solo l’occasione narrativa di un discorso più vasto. In caso contrario sarebbero guai: se si dovessero giudicare gli scrittori in base alla loro capacità di fotografare in anticipo il paesaggio sociale, Philip K. Dick, George Orwell e Aldous Huxley chiuderebbero la partita prima del fischio di inizio.
Serotonina è la storia di Florent-Claude Labrouste e della sua battaglia persa con la vita. Quarantasei anni, un buon impiego al Ministero dell’Agricoltura, Florent-Claude si autoesilia in provincia dopo l’ennesimo rovescio sentimentale. Qui, incapace di trarre ogni residuo beneficio dal rapporto coi suoi simili, rischia letteralmente di morire di tristezza.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3222
Hits 2408
Hits 2363
Hits 2206
Hits 2116
Hits 1998
Hits 1997
Hits 1935
Hits 1873
Hits 1741
tonino

Giuseppe Masala: Capitali in fuga. Il grafico definitivo
Capitali in fuga. Il grafico definitivo
di Giuseppe Masala
Potete apprezzare come in Italia siano impiegati quasi 300 miliardi di capitali esteri a fronte di quasi 800 miliardi di capitali italiani impiegati all’estero. La più grande fuga di capitali
 Se guardate
il grafichetto qui sotto, che rappresenta il saldo Target2
della BCE sommata al
saldo cumulato della Bilancia dei Pagamenti italiana, potete
apprezzare come in Italia siano impiegati quasi 300 miliardi
di capitali esteri a fronte
di quasi 800 miliardi di capitali italiani impiegati
all’estero. Ciò significa chiaramente che siamo di fronte alla
più grande
fuga di capitali dal Sistema-Italia della storia.
Se guardate
il grafichetto qui sotto, che rappresenta il saldo Target2
della BCE sommata al
saldo cumulato della Bilancia dei Pagamenti italiana, potete
apprezzare come in Italia siano impiegati quasi 300 miliardi
di capitali esteri a fronte
di quasi 800 miliardi di capitali italiani impiegati
all’estero. Ciò significa chiaramente che siamo di fronte alla
più grande
fuga di capitali dal Sistema-Italia della storia.
Quasi 500 miliardi di risparmi italiani utilizzati all’estero. Come mai questi danari sono impiegati all’estero e non Italia? Semplice, perché lo stato italiano non può indebitarsi in ossequio ai parametri di Maastricht. O meglio ancora, chiamiamo le cose con il significato proprio: lo Stato italiano non può mobilitare il risparmio degli italiani per erogare beni e servizi agli stessi italiani. Il debito pubblico così va inteso (e così andrebbe chiamato): “Risparmio interno mobilitato dallo Stato”. Il debito pubblico non è il debito del bottegaio.
Dunque, si può dire senza tema di essere smentiti che il debito pubblico (o le “risorse italiane mobilitate dallo stato italiano”) potrebbe essere più alto di quasi 500 miliardi, senza che lo stato italiano assorba neanche un centesimo dal risparmio dei nostri “amici” stranieri. [Ovviamente semplifico, perché è chiaro che se lo stato italiano desse una spinta poderosa alla spesa pubblica, agli investimenti, dovrebbe mobilitare meno perché una determinata quantità Q della cifra in questione verrebbe mobilitata dalle imprese private e dalle famiglie].
Leggi tutto
Mauro Casadio: Un “Piano B”, anche per Potere al Popolo
Un “Piano B”, anche per Potere al Popolo
di Mauro Casadio*
 Com’è noto le elezioni producono “in
automatico”
accelerazioni e sintesi politica. Questo sta accadendo anche
nel contesto del prossimo passaggio elettorale per le
europee. Il tentativo – al
quale Potere al Popolo ha aderito definendo con chiarezza i
propri punti “non trattabili” – di dare vita alla sinistra
del PD ad una
lista che facesse riferimento a Luigi De Magistris, è
fallito in quanto il sindaco di Napoli ha ritirato la
propria disponibilità
dichiarando che: “Per quanto mi riguarda non ci sono gli
spazi per essere presente alle europee e nemmeno con una
lista che faccia riferimento
al movimento demA”.
Com’è noto le elezioni producono “in
automatico”
accelerazioni e sintesi politica. Questo sta accadendo anche
nel contesto del prossimo passaggio elettorale per le
europee. Il tentativo – al
quale Potere al Popolo ha aderito definendo con chiarezza i
propri punti “non trattabili” – di dare vita alla sinistra
del PD ad una
lista che facesse riferimento a Luigi De Magistris, è
fallito in quanto il sindaco di Napoli ha ritirato la
propria disponibilità
dichiarando che: “Per quanto mi riguarda non ci sono gli
spazi per essere presente alle europee e nemmeno con una
lista che faccia riferimento
al movimento demA”.
E’ noto anche che i motivi del mancato accordo ruotano tra l’altro attorno alla questione della “rottura dei trattati europei”, la quale ha segnato un solco invalicabile per Sinistra Italiana, Possibile e Diem, con un ruolo “centrista” del PRC che comunque sarà presente alle elezioni con il simbolo della “Sinistra Europea”, cercando di coinvolgere nella sua lista tutti quelli che in Italia si riconoscono in quell’area politica.
Se è necessario tentare di praticare tutti i passaggi elettorali, che in Italia però hanno una defatigante e deviante cadenza quasi annuale, è evidente come, appena si esce dall’ambito della miope politica delle alleanze elettorali e si arriva ai contenuti, riemerga prepotentemente la natura dei partiti e dei gruppi della sinistra nostrana.
Ovvero si evidenzia la subalternità di questi alle politiche del centrosinistra/PD, in particolare sul feticcio dell’Unione Europea, che diviene lo spartiacque strategico tra chi si oppone alla Ue reale, materiale, quella dei capitali, e chi continua a parlare di una ipotetica Europa dei popoli. Paradossalmente, questo tipo di UE oggi viene evocata anche dai cosiddetti “sovranisti di destra”, che si sono convertiti sulla via di Damasco – al mantenimento dell’Unione e dell’Euro – soprattutto dopo aver accettato a Dicembre i diktat di Juncker e Moscovici sulla legge di bilancio.
Leggi tutto
Michael Roberts: La moderna teoria della moneta II
La moderna teoria della moneta II
Una rete di protezione a favore del capitalismo
di Michael Roberts
La MMT mira a rattoppare i fallimenti della produzione capitalistica, non a rimpiazzarla
 Dopo un
lungo articolo che analizza la Teoria della moneta
moderna (Modern monetary theory - MMT), in questo
contributo, esaminerò gli
aspetti pratici di questa teoria. In altre parole, quali sono
le proposte politiche che i sostenitori della MMT propongono
al governo per creare
più posti di lavoro con salari milgiori senza provocare
inflazione?
Dopo un
lungo articolo che analizza la Teoria della moneta
moderna (Modern monetary theory - MMT), in questo
contributo, esaminerò gli
aspetti pratici di questa teoria. In altre parole, quali sono
le proposte politiche che i sostenitori della MMT propongono
al governo per creare
più posti di lavoro con salari milgiori senza provocare
inflazione?
Dopo la Grande Recessione, gli economisti di sinistra hanno cercato di confutare le teorie economiche neoliberiste che impongono l’equilibrio nei bilanci pubblici e una riduzione degli alti livelli di debito pubblico. Le politiche di austerità che scaturiscono dal punto di vista neoliberista hanno significato il taglio del welfare state, la riduzione dei servizi pubblici, la stagnazione dei salari reali e l'aumento della disoccupazione. Naturalmente, il movimento operaio vuole invertire queste politiche che fanno sì che i lavoratori paghino per il fallimento delle banche e del capitalismo.
L’alternativa tipica viene dal keynesismo tradizionale, ovvero dalla convinzione che una maggiore spesa pubblica (tramite deficit sui bilanci annuali dello stato) può aumentare la domanda effettiva nell'economia capitalista e creare posti di lavoro e aumentare i salari. Ed è qui che entra in gioco la MMT. Come dice uno dei suoi esponenti, Randall Wray, ciò che la MMT aggiunge alla politica di stimolo fiscale di stampo keynesiano è l’argomento teorico secondo cui “a un governo sovrano non può scarseggiare la propria moneta”. Fin tanto che lo stato ha il monopolio nello stabilire l'unità di conto (dollari, euro o pesos), può creare quanta moneta abbisogna, distribuirla a entità “non statali”, aumentare la domanda e quindi fornire posti di lavoro e redditi. Stephanie Kelton, uno dei principali esponenti della MMT e consigliere di Bernie Sanders, afferma: “L’entità che emette moneta non può mai rimanere senza denaro perché può sempre stampare o coniare più dollari, pesos, rubli, yen, ecc.”
Leggi tutto
Carlo Galli: Primarie Pd
Primarie Pd
Intervista a Carlo Galli
Alle primarie il Pd ha dato un flebile segno di vita. Nell’anno trascorso dalla sconfitta del 4 marzo 2018 il Pd non ha fatto politica anche perché non ha avuto il coraggio di affrontare veramente la realtà – non ha mai svolto un’analisi del voto –, perché ha temuto che affrontandola si sarebbe spaccato. Infatti, dentro il partito democratico convivono linee interpretative della politica, della società, idee di Italia ed Europa, parecchio diverse. Ora, il candidato che meno deve a Renzi, cioè Zingaretti, il quale più degli altri è accreditato di essere una persona di centro-sinistra e non di centro, non solo ha vinto, ma probabilmente è stato determinante, con la sua presenza, a far sì che il numero dei votanti diminuisse non di molto rispetto alle primarie del 2017 – le ultime vinte da Renzi, con 1 milione e ottocentomila partecipanti –. Il fatto che fra i candidati ci fosse Zingaretti, che bene o male è stato fatto passare come un momento di discontinuità – sia pure blanda – rispetto all’èra Renzi, ha fatto sì che gli italiani che hanno un orientamento di centro-sinistra si siano sentiti meno demotivati che in passato a partecipare alle primarie del Pd.
Però, resta ancora tutto da definire il contenuto di questa discontinuità, molto blanda: rispetto al rapporto fra l’Italia e l’Europa; rispetto al rapporto fra il Pd e i Cinquestelle, che è l’unico politicamente praticabile per un partito come il Pd, che – come gli altri partiti, del resto – si trova ad agire in un contesto proporzionale e non può avere una vocazione maggioritaria, perché non può pensare di prendere il 51 per cento dei voti, e non può pensare di affrontare le elezioni solo alleandosi con liste civiche.
Leggi tutto
Alessandro Volpi: Femminismo per il 99%
Femminismo per il 99%
Recensione di Alessandro Volpi
Scrivere su di un manifesto femminista, per un uomo, è sempre un’impresa che si presta a innumerevoli rischi, nella misura in cui un soggetto – che, rispetto alla contraddizione posta, si trova in una posizione di privilegio – pensa di poter prendere la parola su di un tema che non vive sulla sua pelle. Una possibile via d’uscita è assumere una prospettiva suppostamente scientifica, ma ciò non è qui possibile visto che, in questo caso, ci troviamo di fronte a un testo radicalmente politico. Una ragione che invece giustifica la mia scelta di recensire questo lavoro è che le autrici assumono apertamente una posizione anti-separatista e, anzi, pensano a una necessaria articolazione fra le varie lotte contro ogni forma di dominio e di sfruttamento prodotta dal sistema capitalista globale. In questo senso la prospettiva dalla quale posso accostarmi al testo, che però non viene menzionata, è quella di una generazione (la mia) a cui è stata negata la possibilità di immaginare una vita degna per il proprio futuro. Il volume di cui stiamo parlando è Femminismo per il 99%. Un manifesto, (ROMA-BARI: LATERZA, 2019) scritto dalle accademiche e militanti femministe degli Stati Uniti Cinzia Arruzza, Tithi Bhattachraya e Nancy Fraser, e recentemente pubblicato in Italia da Laterza, ma uscito contemporaneamente anche in altre lingue, tra cui ovviamente l’inglese e poi il francese, lo spagnolo, il portoghese e altre ancora.
Leggi tutto
Pino Arlacchi: Venezuela. La visione controcorrente di un ex dirigente dell’Onu
Venezuela. La visione controcorrente di un ex dirigente dell’Onu
di Pino Arlacchi*
Nel momento in cui il supremo teorico della guerra non-occidentale, Sun Tzu, affermava che l’ arte della guerra si basa sull’ inganno esistevano solo le guerre dichiarate e combattute con le armi della violenza fisica.
Ma l’ insegnamento del teorico cinese era abbastanza profondo da dimostrarsi valido anche oggi, in tempi di guerra coperta, non convenzionale, combattuta con le armi dell’ economia e soprattutto della finanza. Dove l’ inganno consiste nella disinformazione e la disuguaglianza tra le parti contrapposte si basa sul possesso o meno dei mezzi di disinformazione di massa.
Se c’è una lezione che ho imparato dirigendo una parte non trascurabile dell’ ONU è che, nelle cose del mondo, la verità dei fatti raramente coincide con la sua versione ufficiale. Anche in tempi di pluralismo informativo come i nostri, le idee dominanti – come diceva il vecchio Marx – sono ancora quelle della classe dominante. Che rivolta cose e fatti a suo uso e consumo.
Dietro ogni guerra c’è una menzogna.
E quello del Venezuela si configura oggi come un caso di guerra non convenzionale coperta da una gigantesca truffa informativa.
Chiunque abbia voglia di documentarsi sulla crisi del Venezuela consultando fonti diverse dalla vulgata prevalente farà fatica a mantenere la calma. Perché si scontrerà ad ogni passo con una narrativa falsa, omissiva e distorta.
Leggi tutto
Gioele P. Cima: La ripresa di Fachinelli tra Kierkegaard e Heidegger
La ripresa di Fachinelli tra Kierkegaard e Heidegger
di Gioele P. Cima
Nel terzo atto de Il paradosso della ripetizione (1973), saggio che attacca duramente l’istituzione psicoanalitica e le sue pratiche affiliative e di potere, Elvio Fachinelli espone la sua teoria della ripetizione. Per lo psicoanalista trentino, Freud si sarebbe limitato a concepire solo il “lato cattivo” della ripetizione, presentandola come un meccanismo coatto che ritaglia la realtà secondo specifiche regole pregresse e da cui scaturirebbe uno schema deterministico unilaterale e immodificabile.
“Per Freud […] il passato diventa presente: è il transfert, l’agire […]. Ma in questo modo il presente quasi non esiste di per sé, non incide; e poiché l’esperienza passata risulta essere, in buona parte, ‘al di là del principio di piacere’, la sua ripetizione tende ad essere ripetizione del negativo.”
Una visione del presente così irriducibilmente inchiodata al passato non è problematica solamente per il modo in cui semplifica la reale complessità dell’esperienza umana, ma anche per il suo risvolto politico: dire che l’uomo è giocato dalla ripetizione, che il suo avvenire non sarà altro che una copia del passato, vuole dire concepire l’inconscio come lo ‘straniero’ nella macchina che manipola l’arbitrio del soggetto e lo priva della possibilità etica di scegliere. Più nello specifico, dire che la ripetizione freudiana deresponsabilizza il soggetto dal proprio sintomo significa dire che la psicoanalisi non è una disciplina demistificatoria, ma essenzialmente reazionaria (e dunque ideologica).
Leggi tutto
Giovanna Cracco: L'Unione Europea di Hayek
L'Unione Europea di Hayek
di Giovanna Cracco
 Ci attende una lunga
campagna elettorale in vista delle europee di maggio. La
complessità dei Trattati, degli
accordi intergovernativi (come il Fiscal compact) e della
struttura legislativa e istituzionale Ue non facilita i
cittadini alla comprensione del
'sistema' Unione europea, e una politica sempre più spettacolo
e povera di cultura avrà gioco facile ad appoggiarsi a slogan
e dogmi.
Eppure non è affatto complicato capire dove siamo. Certo
occorre uscire dal postmodernismo e portare la riflessione sul
piano storico e
teorico, l'unico che consente di guardare l'Unione europea
senza le lenti distorcenti della propaganda, a favore o
contro; perché l'Unione
europea, come tutti i progetti umani, e quelli politici ed
economici non fanno certo eccezione, è figlia di un pensiero,
di un'idea di
società. Facciamo quindi un passo indietro.
Ci attende una lunga
campagna elettorale in vista delle europee di maggio. La
complessità dei Trattati, degli
accordi intergovernativi (come il Fiscal compact) e della
struttura legislativa e istituzionale Ue non facilita i
cittadini alla comprensione del
'sistema' Unione europea, e una politica sempre più spettacolo
e povera di cultura avrà gioco facile ad appoggiarsi a slogan
e dogmi.
Eppure non è affatto complicato capire dove siamo. Certo
occorre uscire dal postmodernismo e portare la riflessione sul
piano storico e
teorico, l'unico che consente di guardare l'Unione europea
senza le lenti distorcenti della propaganda, a favore o
contro; perché l'Unione
europea, come tutti i progetti umani, e quelli politici ed
economici non fanno certo eccezione, è figlia di un pensiero,
di un'idea di
società. Facciamo quindi un passo indietro.
L'affermarsi del sistema economico capitalistico ha prodotto il suo specifico conflitto sociale. Ben prima dei cosiddetti Trenta gloriosi - gli anni del dopoguerra caratterizzati, nei Paesi europei, da politiche socialdemocratiche di stampo keyne-siano - il potere politico è intervenuto nella sfera economica per disinnescare il conflitto di classe, agendo principalmente su due piani: operando una redistribuzione attraverso le politiche fiscali, e implementando uno stato sociale - la prima a strutturarlo è stata la Prussia di Bismarck di fine Ottocento, dopo aver cercato inutilmente di contenere le rivolte del nascente movimento operaio attraverso la repressione. Per il pensiero economico liberista è una inaccettabile invadenza: Friedrich von Hayek, tra i massimi esponenti della Scuola austriaca, assertore dell'esistenza di una autoregolamentazione del mercato, di un ordine spontaneo che agisce attraverso la concorrenza, sostiene che il mercato non deve subire limiti. L'economista inizia dunque a riflettere su come eliminare l'ingerenza: individua il problema nella piena sovranità che contraddistingue gli Stati nazione, che consente loro il controllo sulle politiche monetarie ed economiche e sui fattori della produzione - capitali, merci, persone - e trova la soluzione nella sua "abrogazione".
Leggi tutto
Alessandro Perri: OIL, il Lavoro è povero. Figuriamoci lavoratori e lavoratrici
OIL, il Lavoro è povero. Figuriamoci lavoratori e lavoratrici
di Alessandro Perri
 Quando Marx, quello “vero”, dei
testi letti direttamente dall’originale in tedesco e non
tramite compendi terzi,
carenti in termine di comprensione; ebbene quando fece il
suo ingresso in Italia, lo fece per mezzo della penna di
Antonio Labriola negli ultimissimi
anni del XIX secolo.
Quando Marx, quello “vero”, dei
testi letti direttamente dall’originale in tedesco e non
tramite compendi terzi,
carenti in termine di comprensione; ebbene quando fece il
suo ingresso in Italia, lo fece per mezzo della penna di
Antonio Labriola negli ultimissimi
anni del XIX secolo.
Questi, fine filosofo prima ancora che socialista della primissima ora, era solito insistere su un punto fondamentale: la praxis, ossia il lavoro come energia, è l’essenza dell’essere umano («l’uomo», scriveva in realtà Labriola…). L’individuo è il suo lavoro, e poiché sono le azioni dell’essere umano che fanno la storia (la cui scrittura, poi, è un capitolo a parte), quest’ultima va intesa come la storia del lavoro, ossia dell’insieme delle attività del genere umano.
A livello «concreto», ne consegue che le condizioni in cui è dato all’essere umano di esprimere la propria natura sono quelle, nel modo di produzione capitalistico, del mondo del lavoro propriamente detto, e dello “stato sociale” in cui queste si esprimono.
Se così stanno le cose, allora il World employment and social outlook, “Prospettive occupazionali e sociali nel mondo” rilasciato pochi giorni fa dall’Organizzazione internazionale del lavoro (Oil, Ilo nella versione internazionale), riveste un’importanza decisiva, al netto della retorica istituzionale e del linguaggio tendente al neutro, come rilevanza-accademica-vuole, per avere un quadro più ordinato del mondo nel suo insieme.
Senza remore, possiamo affermare che il documento rilasciato è un bollettino di guerra, per come questa è intesa al giorno d’oggi nei confronti del mondo del lavoro. Come riassume l’«executive summary» dello studio, che di seguito vi riportiamo nella traduzione italiana, sono molti i dati allarmanti di cui nel futuro difficilmente saremo, o meglio, chi di dovere sarà, in grado di venirne a capo.
Leggi tutto
Sonia Paone: Henri Lefebvre: una teoria critica dello spazio
Henri Lefebvre: una teoria critica dello spazio
di Sonia Paone
Pubblichiamo la prefazione di Sonia Paone al libro di Francesco Biagi, Henri Lefebvre: una teoria critica dello spazio, Jaca Book, Milano, 2019, uscito da poche settimane. Buona lettura
 Henri
Lefebvre è stato un importante intellettuale e prolifico
autore, avendo
pubblicato nel corso di una lunga vita, che ha attraversato
buona parte del Novecento, una sessantina di opere, alcune
delle quali possono essere
considerate un punto di riferimento per le scienze sociali e
per quelle territoriali. In questo ultimo ambito le sue
considerazioni e intuizioni sulle
trasformazioni dei territori e sul destino delle città sono di
grande attualità.
Henri
Lefebvre è stato un importante intellettuale e prolifico
autore, avendo
pubblicato nel corso di una lunga vita, che ha attraversato
buona parte del Novecento, una sessantina di opere, alcune
delle quali possono essere
considerate un punto di riferimento per le scienze sociali e
per quelle territoriali. In questo ultimo ambito le sue
considerazioni e intuizioni sulle
trasformazioni dei territori e sul destino delle città sono di
grande attualità.
Lefebvre aveva evidenziato la forza distruttrice che accompagnava l’affermazione dell’urbano, ovvero l’avvento di una fase storica in cui la città si sarebbe identificata con la forma complessiva della società. E da qui aveva individuato e preconizzato una serie di fattori di crisi: l’impatto della produzione capitalistica sulla organizzazione dello spazio urbano e la sua conseguente mercificazione, la città diviene un mero oggetto di scambio e di profitto; la progressiva urbanizzazione del mondo intesa come espansione del cosiddetto tessuto urbano, ovvero un processo economico-culturale che avrebbe fatto aumentare la segregazione e la frammentazione urbana e avrebbe assoggettato il rurale, facendo scomparire la campagna, attraverso l’industrializzazione della produzione agricola; il declino della vita rurale tradizionale e la distruzione del suolo e della natura. Oggi ci confrontiamo sostanzialmente con gli esiti di quelle direttrici di sviluppo che Lefebvre aveva tracciato, siamo infatti nell’epoca dell’urbanesimo planetario visto che dagli inizi del nuovo millennio la maggior parte della popolazione mondiale risiede nelle città, ma questo traguardo è coinciso con l’esplosione della marginalità urbana poiché i tassi di urbanizzazione sono cresciuti e continueranno a crescere nei prossimi anni nei paesi poveri. Siamo anche nell’epoca del pieno dispiegamento delle logiche della valorizzazione economica sui territori, sia nel contesto urbano che in quello rurale.
Leggi tutto
Italo Nobile: Ricerca, riflessione e pensiero critico nell'elaborazione del Centro Studi CESTES
Ricerca, riflessione e pensiero critico nell'elaborazione del Centro Studi CESTES
di Italo Nobile
Più passa il tempo e più la riflessione di Luciano Vasapollo e di Rita Martufi diventa vivace e appassionata. Interpreti consapevoli di un metodo materialista essi in primo luogo aggiornano i temi più rilevanti su cui si sono concentrati nel passato al fine di verificare le ipotesi fatte ma anche di registrare quei cambiamenti che ci costringono almeno in parte a mutare rotta.
Vogliamo dare uno sguardo a tre testi editi in questo periodo dalla casa editrice Efesto.
Il primo è l’aggiornamento e l’ulteriore elaborazione a partire da un testo del 2000 “Comunicazione deviante” allora edito da Media Print con la prefazione del compianto Alessandro Mazzone. In questo studio informazione e comunicazione assumono un ruolo dominante sia sul terreno della produzione e dell’accumulazione che su quello del consumo trasformando l’impresa in fabbrica sociale generalizzata. Alessandro Mazzone, nella prefazione al testo afferma “Questo libro descrive un’invasione … una invasione che non ha bisogno di varcare i confini di uno Stato … che non agisce sugli individui, ma essenzialmente dentro di essi”. Vasapollo esaminava gli effetti della comunicazione deviata e deviante sul corpo sociale e intravedeva una sorta di totalitarismo della comunicazione strategica che vanificava i tentativi di democratizzare i processi di decisione politica.
Leggi tutto
Marco Pondrelli: Il totalitarismo liberale. Le tecniche imperialiste per l'egemonia culturale
Il totalitarismo liberale. Le tecniche imperialiste per l'egemonia culturale
A cura di Alessandro Pascale. La città del Sole
di Marco Pondrelli
Il nome Seymour Hersh probabilmente ai più non dirà molto ma Hersh, vincitore anche del premio Pulitzer, ha messo in discussione la versione fornita dal governo statunitense dell'uccisione di Bin Laden (raccontata anche nel film embedded di Kathryn Bigelow Zero Dark Thirty), così come la 'verità' sul gas Sarin usato da Assad in Siria, la reazione, durante la presidenza del 'democratico' Obama, è stata la censura. Il fatto di per sé è significativo, spiega molto bene la 'fabbrica del falso', che sta alla base dell'accettazione acritica delle verità di comodo propinate da mass-media compiacenti. È spiega altrettanto bene la battaglia contro la scuola pubblica, contro la libertà d'informazione per spegnere qualsiasi visione critica ed alternativa della società e del mondo.
Lo abbiamo visto molto bene in tutte le guerre che l'Occidente ha combattuto in questi anni, i diritti umani hanno sempre nascosto interessi geopolitici, purtroppo anche la sinistra, comunista e non, ha partecipato a questa giostra (chi ricorda le manifestazioni di Ferrero sotto l'ambasciata libica prima della guerra?).
Alessandro Pascale, collaboratore di Marx Ventuno, nel suo libro (il totalitarismo liberale) analizza questi meccanismi e le radici di classe che stanno dietro ad essi.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Impressioni, alla Monet... 5 stelle: che ne è stato, che ne è, che ne sarà
Impressioni, alla Monet... 5 stelle: che ne è stato, che ne è, che ne sarà
di Fulvio Grimaldi
Ascolto Radio Rai diretta da Luca Mazzà. Luca Mazzà, prima, era stato direttore del Tg3, il telegiornale più virulentemente e goffamente anti-Cinquestelle dell’intero giro delle tv di regime (regime inteso, non come l’attuale governo, ma come regime vero, la consorteria politico-economico-finanziaria al servizio della Cupola). Prima ancora, era mio collega nella redazione Economia-Ambiente dove, mi ricordo, stava seduto a una scrivania davanti alla finestra, la migliore posizione del salone, e non s’è mai capito cosa facesse. Di servizi giornalistici non me ne ricordo neanche uno. Oggi, però, comanda e si irradia della più importante radio del paese. E quale, secondo voi, potrebbe essere stata la sua interpretazione dell’esito, negativo per i 5 Stelle, del voto in Abruzzo e Sardegna? Ma è ovvio: grazie in particolare al rientrante Di Battista, il Movimento avrebbe assunto posizioni troppo “radicali”, imponendo la sua agenda “estremista” al partner di governo, da lui implicitamente giudicato “moderato”, e pagandone il fio nelle urne
Bipolarismo finto e bipolarismo vero
La Cupola ha, anzi, le cupole, viste nel tempo e nello spazio, hanno sempre provato a governare sia la maggioranza che l’opposizione, dando in pasto alla gente tale vera e propria “combine” come bipolarismo tra opposti e contrari. Tipo l’Isis e le forze Nato che pretendevano di combatterlo.
Leggi tutto
Giacomo De Rinaldis: Le metafore teologiche di Marx
Le metafore teologiche di Marx
Recensione di Giacomo De Rinaldis
Enrique Dussel: Le metafore teologiche di Marx, Inschibboleth Edizioni, Roma 2018, pp. 400, € 28,00
“Le metafore teologiche di Marx” del filosofo e teologo latinoamericano Enrique Dussel ci pone sin dal titolo di fronte ad una contraddizione: non siamo forse abituati a considerare il pensiero di Marx come totalmente ateo e quindi nemico della religione? Questo conflitto del resto ha generato rivalità storiche dall’aura quasi mitica come quella tra i partiti comunisti e quelli cristiani, immortalata poi in letteratura dalle figure di don Camillo e Peppone, emblemi di due mondi inconciliabili. Con questo libro, pubblicato in Spagna nel 1993 e tradotto solo ora in Italia, Dussel ci mostra che questa dicotomia non è poi così cogente. Il volume è il quarto di un grande progetto di lettura e di commento delle opere economiche di Marx il cui rigore, come scrive Antonino Infranca nella prefazione al volume, ricorda molto da vicino quello dei commenti di Tommaso d’Aquino alle opere di Aristotele.
Dussel rintraccia nell’opera di Marx un uso sistematico di metafore teologiche: il teorico del comunismo si rivela infatti essere un profondo conoscitore del Nuovo e del Vecchio Testamento; egli utilizza continuamente immagini prese in prestito dalle Scritture per descrivere le dinamiche che regolano l’economia capitalistica e per sottolinearne le conseguenze ‘morali’.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3262
Hits 2445
Hits 2420
Hits 2246
Hits 2136
Hits 2019
Hits 2011
Hits 1945
Hits 1893
Hits 1756
tonino

Carlo Formenti: Manifesto per la sovranità costituzionale
Manifesto per la sovranità costituzionale
di Carlo Formenti
 Il riuscitissimo evento di ieri ha raccolto
centinaia di
persone al Teatro dei Servi di Roma per la presentazione del
Manifesto per la sovranità costituzionale lanciato da Patria
e Costituzione,
Rinascita e Senso Comune. E' così iniziato un percorso che
dovrà condurre alla formazione di un nuovo soggetto politico
all'altezza
delle sfide che l'attuale crisi del capitalismo globale e
delle sue istituzioni impongono di affrontare. Qui di
seguito pubblico il testo integrale
del mio intervento introduttivo.
Il riuscitissimo evento di ieri ha raccolto
centinaia di
persone al Teatro dei Servi di Roma per la presentazione del
Manifesto per la sovranità costituzionale lanciato da Patria
e Costituzione,
Rinascita e Senso Comune. E' così iniziato un percorso che
dovrà condurre alla formazione di un nuovo soggetto politico
all'altezza
delle sfide che l'attuale crisi del capitalismo globale e
delle sue istituzioni impongono di affrontare. Qui di
seguito pubblico il testo integrale
del mio intervento introduttivo.
* * * *
Compagni e compagne, penso che chi oggi è qui, avendo letto il Manifesto sottoscritto da Patria e Costituzione, Rinascita e Senso Comune, sia consapevole dell’ambizione che ispira il percorso politico di cui l’incontro odierno costituisce un primo passo: si tratta di farsi annunciatori di un’alternativa di sistema, nella speranza di poter essere, in un futuro non troppo lontano, parte attiva nella sua realizzazione. Non ci interessa rianimare né riscattare una sinistra che si è fatta destra, abdicando al ruolo di rappresentante degli interessi delle masse popolari per sposare l’ideologia liberista. Non vogliamo “rifare” la sinistra, non solo per motivi di opportunità linguistica, visto che la maggioranza del popolo disprezza ormai questa parola, ma perché riteniamo che il binomio destra/sinistra, da quando essere di sinistra non significa più nutrire la speranza in un cambio di civiltà, rappresenti unicamente un gioco delle parti fra le caste politiche che gestiscono gli affari correnti del capitale.
Andare oltre la dicotomia destra/sinistra significa andare oltre il paradigma politico, sociale, economico e culturale di cui questi termini sono espressione. Un paradigma che ha perso ogni legittimità dopo quella crisi del 2008 che ha segnato il culmine degli sconvolgimenti epocali iniziati negli anni Settanta del secolo scorso.
Leggi tutto
Giovanna Baer: Russiagate. Troll to control
Russiagate. Troll to control
di Giovanna Baer
 Per chi ha raggiunto la maturità
nel secolo scorso, IRA significa probabilmente Irish
Republican Army, la
celeberrima associazione militare clandestina sorta con lo
scopo di liberare l’Irlanda del nord dal dominio britannico.
Ma quell’IRA
è storia vecchia, e oggi il suo acronimo designa
un’organizzazione che ha a che fare con la propaganda del
Cremlino attraverso Internet e
i troll. Non stiamo parlando delle familiari creature
mitologiche: i nuovi troll sono soggetti che, in una comunità
virtuale, interagiscono con
gli altri utenti attraverso messaggi provocatori con
l’obiettivo di fomentare gli animi e disturbare la
comunicazione.
Per chi ha raggiunto la maturità
nel secolo scorso, IRA significa probabilmente Irish
Republican Army, la
celeberrima associazione militare clandestina sorta con lo
scopo di liberare l’Irlanda del nord dal dominio britannico.
Ma quell’IRA
è storia vecchia, e oggi il suo acronimo designa
un’organizzazione che ha a che fare con la propaganda del
Cremlino attraverso Internet e
i troll. Non stiamo parlando delle familiari creature
mitologiche: i nuovi troll sono soggetti che, in una comunità
virtuale, interagiscono con
gli altri utenti attraverso messaggi provocatori con
l’obiettivo di fomentare gli animi e disturbare la
comunicazione.
È opportuno sottolineare, prima di proseguire, che quando ci si muove in questo campo molte sono le supposizioni, molto gioca la propaganda in tutte le direzioni - Stati Uniti vs Russia, Russia vs Stati Uniti, Unione europea vs Russia, Russia vs Unione europea... - ma prove tangibili sembra che gli investigatori statunitensi le abbiano trovate.
Secondo il rapporto Assessing Russian Activities and Intentions in Recent US Elections (1), datato 6 gennaio 2017, appena due mesi quindi dalle elezioni
presidenziali americane, e realizzato congiuntamente dalle tre più importanti agenzie di intelligence americane, la Cia, l’Fbi e la Nsa, il presidente russo Vladimir Putin nel 2016 avrebbe ordinato operazioni mirate a influenzare le elezioni presidenziali. “Gli obiettivi della Russia erano di minare la fiducia del pubblico nel processo democratico degli Stati Uniti, di denigrare il segretario Clinton e di danneggiare la sua campagna elettorale per evitare che diventasse Presidente”. Le tre agenzie ritengono inoltre “che Putin e il governo russo abbiano sviluppato una chiara preferenza per il Presidente eletto Trump”.
Leggi tutto
Vincenzo Comito: Huawei, Cina, Usa e la lotta per il primato tecnologico
Huawei, Cina, Usa e la lotta per il primato tecnologico
di Vincenzo Comito
La disputa tra Cina e Stati Uniti, e l’accordo commerciale che si sta discutendo, a partire dal primato della compagnia Huawei nella tecnologia G5. Con l’Europa in ordine sparso. Ma delle 20 più grandi imprese nelle tecnologie avanzate, 11 sono statunitensi e 9 cinesi. Nessuna europea
 Cosa sta succedendo alla
Huawei
Cosa sta succedendo alla
Huawei
Intorno ai casi di Huawei, la grande compagnia di telecomunicazioni cinese, si vanno sviluppando da qualche mese molte questioni e diversi interrogativi, insieme a parecchia confusione. Appare importante soffermarsi sulle vicende di questa impresa, cruciali da molti punti di vista, per valutare tra l’altro in che direzione sta andando l’innovazione tecnologica nel mondo, come si presenta poi il quadro della situazione competitiva tra Cina e Stati Uniti, quali i risultati dei tentativi sempre più marcati di un’applicazione extraterritoriale delle leggi americane, quali infine i possibili sviluppi delle vicende relative nel prossimo futuro.
Il peso della società nei suoi mercati di riferimento
Preliminarmente ad un’analisi del quadro politico della situazione, appare opportuno ricordare il posizionamento della società cinese sui suoi due mercati principali, gli smartphone e gli apparati per telecomunicazioni.
Il mercato dei telefonini
Qualche settimana fa la Apple annunciava che l’azienda stava vendendo meno smartphone che in passato a causa di un rallentamento generale del mercato cinese. Si trattava di un annuncio che in realtà affermava al massimo solo una mezza verità.
E’ certamente vero che il mercato cinese degli smartphone sta rallentando, non si sa se temporaneamente o meno, ma è anche vero che la Apple sta vendendo di meno nel Paese anche, se non soprattutto, perché essa sta perdendo quote di mercato a favore dei produttori cinesi ed in prima fila di Huawei. Quest’ultima invece sta collocando sempre più prodotti non solo sul mercato interno, ma anche all’estero (tranne che negli Stati Uniti, dove il suo sviluppo è sostanzialmente impedito politicamente). E la Apple sta lentamente perdendo quote su tutti i mercati, non soltanto in Cina.
Leggi tutto
Domenico Moro: Le illusioni sul fratello di Montalbano
Le illusioni sul fratello di Montalbano
di Domenico Moro
L’altro giorno sulla metro di Roma un tizio, mentre commentava le primarie del Pd, ha detto seriamente: “Ha vinto il fratello di Montalbano. Strano, però, non portano lo stesso cognome.” A quanto sembra, Guy Debord il filosofo francese teorico della “società dello spettacolo” sembrerebbe essere stato ampiamente superato dall’odierno potere illusionista della Tv. La fantasia, lo spettacolo si confondono con la realtà, anzi sono parte della realtà. Purtroppo, c’è da temere che un’altra illusione si stia impadronendo di una parte della sinistra e forse del suo elettorato. Tale illusione è che ora il Pd ritornerà il partito di sinistra che era prima della parentesi di Renzi, quasi che quest’ultimo sia stato un outsider piovuto da Marte.
Si tratta di una concezione molto ingenua e semplicistica che attribuisce a Renzi una mutazione genetica del Pd che, invece, è nata ben prima del Pd e può essere fatta risalire addirittura a quando il Pci si trasformò non in socialdemocrazia ma in partito liberaldemocratico. Non è stato Renzi a iniziare a precarizzare il lavoro, ma Treu. Né è stato lui a fare le maggiori privatizzazioni, a partecipare alle cosiddette “missioni di pace” all’estero, schierandosi sempre con gli Usa e la Nato, anche quando Berlusconi nicchiava (Georgia e Libia ad esempio). Sono stati i governi di centro-sinistra come quelli di D’Alema e di Prodi.
Leggi tutto
Genova City Strike-NST: Zingaretti: le speranze stanno a zero
Zingaretti: le speranze stanno a zero
di Genova City Strike-NST
Dopo essere stato eletto, il nuovo segretario del PD Nicola Zingaretti, ha annunciato che il suo primo impegno è il TAV. Vale la pena di ricordare che, contro quel mostro inutile, si contano oramai pdecenni di lotte popolari, che i compagni hanno accumulato, in questi anni, migliaia di denunce penali (di cui alcune centinaia solo a Genova contro il Terzo Valico), si sono mobilitati in cortei, presidi e azioni milioni di persone. Se voleva dare il senso del cambiamento, Zingaretti ha deciso di calare subito un asso. Ha deciso che sta con i padroni, con la devastazione ambientale, con coloro che in questi anni hanno distribuito tangenti, con le mafie che ingrassano con gli appalti delle "grandi opere". Con quelli che non trovano le risorse per ospedali, case, servizi, stipendi, mentre i soldi per un'opera inutile li hanno sempre. Questo è l'inizio, il resto, verrà da se. Alle primarie, pare che abbia partecipato più di un milione di persone. Non sono poche, anche perché la politica ha, in questi anni, tassi di partecipazione ridicoli. Ai seggi molti anziani ma anche molti che hanno deciso, visto il clima politico e i venti reazionari che spirano, che valeva forse la pena di compiere un atto considerato di "resistenza". Nei giorni precedenti, i candidati alle primarie del PD all'unisono avevano dichiarato che il jobs act, la Fornero e altre facezie del genere erano leggi giuste e da difendere, che il legittimo presidente del Venezuela era il golpista filo NATO Guaidò e che il problema vero era combattere contro i sovranismi e i populismi.
Leggi tutto
Emilio Gentile: Se il modernismo è totalitario
Se il modernismo è totalitario
di Emilio Gentile
Quarantacinque anni fa, la rivista «Storia contemporanea», fondata e diretta da Renzo De Felice, pubblicò una nota di considerazioni sull’ideologia del fascismo. L’opinione allora dominante fra gli studiosi negava l’esistenza di una ideologia fascista. Tutt’al più si concedeva al fascismo un’ideologia abborracciata e rabberciata con scampoli di ideologie tradizionaliste e reazionarie. Invece, l’autore della nota sostenne che il fascismo non solo ebbe una propria ideologia, ma fu un’ideologia modernista, rivoluzionaria e totalitaria, espressione di un movimento politico nuovo, mosso da un ottimismo tragico e attivo alla conquista del futuro, con l’ambizione di dare inizio a una nuova epoca e costruire una nuova civiltà. Il fascismo, proseguiva la nota, animato dal «mito del futuro», mirava alla rigenerazione della nazione per creare un «uomo nuovo», entro le strutture dello Stato totalitario, dove la massa viveva in condizione di mobilitazione organizzata permanente. «Nello Stato totalitario la vita civile era uno spettacolo continuo, dove l’uomo nuovo fascista si esaltava nel flusso della massa ordinata, col suggestivo richiamo alla solidarietà collettiva fino a raggiungere, in momenti di alta tensione psicologica ed emotiva, la fusione mistica della propria individualità con l’unità della nazione e della stirpe, attraverso la mediazione magica del duce».
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Colonialisti una volta, colonialisti sempre
Colonialisti una volta, colonialisti sempre
Il razzismo degli antirazzisti
di Fulvio Grimaldi
Quanto più grande è la devastazione causata dal neoliberismo, tanto più grande è l’esplosione di ONG. Nulla dimostra questo dato in modo più convincente del fenomeno per cui gli Usa si preparano a distruggere un paese e al tempo stesso allestiscono ONG che preparino e poi bonifichino la devastazione”. (Arundhati Roy)
….ogni scherzo vale
E’ carnevale. Un tempo rito propiziatorio di greci e romani, ricco di licenze, svaghi e rovesciamenti di ruolo. Come al solito, se ne è appropriato il cristianesimo, evirandolo dei suoi elementi libertini e facendotelo pagare con 40 giorni di quaresima. Un’occasione che la nostra classe dirigente non si lascia sfuggire e festeggia con grande impegno. Irrinunciabili, al vertice, le maschere di Pulcinella, Arlecchino, Brighella, Burlamacco, Stenterello, Balanzone, che si sono alternate impersonandosi in presidenti del Consiglio, da Berlusca ad oggi. Tra loro hanno colto al volo il momento anche i pidini da Congresso della famosa canzone “Siamo sempre tre, tre somari e tre briganti, siamo tre”, che a Milano, “contro il razzismo e la xenofobia” (non gli è rimasto che quel tema,serve a riprendersi gli appalti) sfilano travestiti da politici di sinistra.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Manifesto per la Sovranità Costituzionale
Manifesto per la Sovranità Costituzionale
Istruzioni per l’Uso
di Ugo Boghetta
 La presentazione del
Manifesto per la Sovranità Costituzionale ha suscitato
attenzione e consensi, ma anche dissensi
e critiche. E’ normale. Per questi motivi, in questo scritto,
cercherò di dar conto – dal mio punto di vista – del percorso
fatto e dell’approccio che ha portato alla stesura del
Manifesto in questa forma. Il tutto tenendo conto delle
obiezioni avanzate in modo
critico ma costruttivo. Di tutti gli altri: “Non ti curar
di lor ma guarda e passa“.
La presentazione del
Manifesto per la Sovranità Costituzionale ha suscitato
attenzione e consensi, ma anche dissensi
e critiche. E’ normale. Per questi motivi, in questo scritto,
cercherò di dar conto – dal mio punto di vista – del percorso
fatto e dell’approccio che ha portato alla stesura del
Manifesto in questa forma. Il tutto tenendo conto delle
obiezioni avanzate in modo
critico ma costruttivo. Di tutti gli altri: “Non ti curar
di lor ma guarda e passa“.
Va detto in primo luogo, che il Manifesto è il frutto della convergenza di associazioni che provengono da esperienze diverse. Rinascita! nasce dal rifiuto di aderire all’esperienza di Potere al Popolo in quanto segnata dall’autoreferenzialità e dal sinistrismo. PeC nasce dal fallimento della sinistra di mezzo. Mentre Senso Comune prende il via da una lettura del populismo in senso democratico. Ciò significa che c’è tanta strada da fare. E’ tuttavia di buon auspicio che questa convergenza si sia sviluppata in modo così rapido. Con altri, ad esempio Marx21, il confronto è aperto. Il FSI ha rifiutato la proposta.
Nonostante queste diverse provenienze la discussione tuttavia è stata convergente sui temi principali.
L’obiettivo condiviso è quello di costruire un campo, un’area, un soggetto politico sovranista, costituzionale, socialista. La ricerca è stata quella di capire quale fosse il modo migliore per impostare e comunicare le questioni principali. Solo il tema dell’ immigrazione ha comportato una discussione di merito partendo da posizioni in parte diverse o, come spesso accade rispetto a questo argomento, da malintesi. La posizione assunta è quella della solidarietà internazionalista per il diritto a non essere costretti ad emigrare, e regolazione e controllo dei flussi per poter consentire una vera integrazione ed evitare, non a chiacchiere, la guerra fra poveri ed i rigurgiti razzisti e fascisti.
Il tratto comune è l’uscita dalla sinistra. Per questo motivo dobbiamo continuare a combattere contro il sinistrismo che è ancora in noi: in tutti noi.
Leggi tutto
Paul Buckermann: Sulla cibernetica socialista, i sogni accelerazionisti, e gli incubi di Tiqqun
Sulla cibernetica socialista, i sogni accelerazionisti, e gli incubi di Tiqqun
di Paul Buckermann
 Nikita Krusciov era scettico sul
fatto che i computer potessero contribuire a promuovere la
storia in direzione del comunismo.
Nondimeno, era disposto a fare un tentativo in proposito, ed
aveva ordinato un super-computer che supportasse il socialismo
sovietico. I migliori e
più preparati ingegneri sovietici avevano installato il
computer, e gli avevano chiesto di testare subito la macchina.
Krusciov, che non era
ancora convinto, aveva deciso di porgli una domanda
incredibilmente difficile e complessa: «Quando si
arriverà al
comunismo?» La scatola cominciò a tremare e
a fare degli scatti, finché con voce metallica disse: «Fra
diciassette chilometri.» Krusciov scoppiò a ridere
e ripeté di nuovo la sua domanda, pronunciandola in maniera
ancora
più chiara. Stavolta, la macchina rispose subito «Fra
diciassette chilometri». A questo punto, il
compagno cominciò ad arrabbiarsi e chiamò i suoi ingegneri per
lamentarsi della stupidità del costoso macchinario. I tecnici
si
mostrarono sorpresi, dal momento che i test precedenti erano
andati tutti sufficientemente bene; per cui chiesero
gentilmente al computer di spiegare
la sua risposta. La macchina, ferma sul tavolo, senza paura
rispose: « Il risultato di diciassette chilometri
si basa sui dati
provenienti dall'ultimo discorso del compagno Krusciov,
durante il quale ha detto che ad ogni piano quinquennale
ci saremmo avvicinati di un passo al
comunismo».
Nikita Krusciov era scettico sul
fatto che i computer potessero contribuire a promuovere la
storia in direzione del comunismo.
Nondimeno, era disposto a fare un tentativo in proposito, ed
aveva ordinato un super-computer che supportasse il socialismo
sovietico. I migliori e
più preparati ingegneri sovietici avevano installato il
computer, e gli avevano chiesto di testare subito la macchina.
Krusciov, che non era
ancora convinto, aveva deciso di porgli una domanda
incredibilmente difficile e complessa: «Quando si
arriverà al
comunismo?» La scatola cominciò a tremare e
a fare degli scatti, finché con voce metallica disse: «Fra
diciassette chilometri.» Krusciov scoppiò a ridere
e ripeté di nuovo la sua domanda, pronunciandola in maniera
ancora
più chiara. Stavolta, la macchina rispose subito «Fra
diciassette chilometri». A questo punto, il
compagno cominciò ad arrabbiarsi e chiamò i suoi ingegneri per
lamentarsi della stupidità del costoso macchinario. I tecnici
si
mostrarono sorpresi, dal momento che i test precedenti erano
andati tutti sufficientemente bene; per cui chiesero
gentilmente al computer di spiegare
la sua risposta. La macchina, ferma sul tavolo, senza paura
rispose: « Il risultato di diciassette chilometri
si basa sui dati
provenienti dall'ultimo discorso del compagno Krusciov,
durante il quale ha detto che ad ogni piano quinquennale
ci saremmo avvicinati di un passo al
comunismo».
Questa vecchia barzelletta sovietica indica come ci sia un abisso fra il potenziale tecnologico ed il progresso emancipatorio. La storia ha almeno due diversi possibili finali: o l'immaginario computer viene distrutto in quanto dimostra chiaramente quella che è l'attuale insufficienza della politica sovietica, oppure la potenza del computer viene invece assunta come punto di partenza per calcolare e decidere che cosa fare, anziché dipendere dalle deboli macchine umane e dai loro milioni di pezzi di carta.
Leggi tutto
Frank Engster: Il Capitale e il suo punto cieco: il denaro come tecnica di misura
Il Capitale e il suo punto cieco: il denaro come tecnica di misura
di Frank Engster*
Abstract: In the 1960s, a logical-categorial reading of Marx’s Capital began, especially with focus on the value-form analysis, from which the so-called «New Marx Reading» in Germany was one of the outcomes. These readings on the one hand found, with the necessity of synthesizing the theory of value with that of money, the key to opening up the further development of the capitalist mode of production. On the other hand, they stayed fixed on money’s second function as a medium of exchange and on money-mediated commodity exchange, remaining trapped in the contradiction between use-value and exchange-value and the need for an abstraction to quantify the commodity relations. In contrast, the thesis of this paper is that it is money’s first function as a measure of value which is decisive for the development of the inner connection of money and value and for the capitalist mode of production as a whole. Only through the first function can the technique of quantification be deduced, the technique to turn the negativity of a pure social relation into the positivity of quanta and to release with this turn the productive power of the capitalist mode of production. Quantification in capitalism is neither an abstraction, nor a reduction or a form of counting. Rather, in capitalism society is subjected to a measurement of its own productive power; a productive power which through its measurement is, in the first instance, released and systematically expanded. Developing the capitalist mode of production from the “standpoint” of money – the standpoint of an ideal unit which becomes by money’s main function the measure of value, the means of the realization of value and the form of its valorization – opens up an adequate understanding of how to make society an object of both science and critique
 «Tutte le
illusioni del sistema monetario derivano dal fatto che
dall’aspetto del denaro non si capisce che esso rappresenta
un rapporto di produzione
sociale, sia pure nella forma di una cosa naturale di
determinate qualità». (Marx 1961, 22)[1]
«Tutte le
illusioni del sistema monetario derivano dal fatto che
dall’aspetto del denaro non si capisce che esso rappresenta
un rapporto di produzione
sociale, sia pure nella forma di una cosa naturale di
determinate qualità». (Marx 1961, 22)[1]
C’è un compito della critica dell’economia politica che precede l’esposizione vera e propria del modo di produzione capitalistico. La prima sfida – nel senso più autentico del termine – è motivare perché la società capitalistica possa essere in generale per noi oggetto di critica e al contempo di scienza[2].
La pretesa critica della critica marxista in quanto tale e, per così dire, l’assioma materialistico che la fonda, è il tentativo di comprendere le categorie economiche come «modi d’essere, determinazioni dell’esistenza» sociali (Marx 1961, 635; cfr. anche Marx 1976, 40). Ciò significa che le categorie sono tanto forme soggettive del pensiero, della conoscenza, e necessità logiche quanto categorie dell’oggettivo esserci sociale. Esse sono inoltre storicamente connotate, e più precisamente capitalisticamente connotate, dunque non prestabilite sovratemporalmente dalla natura o da Dio, né determinate antropologicamente od ontologicamente.
Leggi tutto
Piemme: «Lazzaro, vieni fuori!»
«Lazzaro, vieni fuori!»
di Piemme
Se c'è un sostantivo che meglio di tutti esprime la entusiastica lettura che i giornaloni di questa mattina danno delle primarie del Pd questo è "ritrovamento". Il Pd avrebbe "ritrovato" il suo popolo.
La cosa è quantomeno dubbia, ma allora perché tanta l'esultanza da parte dell’élite eurista? Semplice: dopo tanti rovesci il vero “ritrovamento” è quello del proprio braccio politico in vista della cacciata dei barbari e della riconquista di Palazzo Chigi. Per cui, diversamente da Stefano Fassina, non abbiamo alcuna ragione per dire che si è trattato di “una bella domenica per la democrazia italiana”.
Lazzaro è risorto!
Nessuno meglio di Ezio Mauro poteva esprimere la soddisfazione per l’avvenuto miracolo:
«Uscire di casa, molto semplicemente, per testimoniare un’atra idea dell’Italia. Lo hanno fatto in duecentocinquantamila a Milano, sabato, alla manifestazione contro il razzismo. E ieri, oltre un milione e mezzo di persone si sono messe in coda al gazebo delle piazze di tutt’Italia, nelle primarie che hanno scelto Zingaretti come nuovo segretario del Pd. Sono due movimenti non coincidenti, ma concentrici, perché mossi, entrambi, dalla stessa spinta: la coscienza della responsabilità democratica nei confronti del Paese, di chi vuole andare avanti, di chi chiede aiuto e anche di chi ha paura».
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: Cosa raccontano alla politica italiana le primarie del PD
Cosa raccontano alla politica italiana le primarie del PD
di Tommaso Nencioni
La complessiva riuscita dell'”operazione primarie” del Partito democratico, prima ancora del suo esito a favore di Nicola Zingaretti, lancia alcuni segnali al mondo politico italiano. Segnali che sarebbe inopportuno sia ignorare che, al tempo stesso, sopravvalutare. Partiamo dai rischi di sopravvalutazione. Tutte le leadership democratiche, da che il principale partito della sinistra italiana si è dotato delle primarie aperte quale metodo di selezione dei propri gruppi dirigenti, sono state legittimate da un vasto concorso di popolo; salvo poi, nella migliore delle ipotesi, non aver saputo gli eletti rispondere a quello stesso popolo in termini di azione di governo e aver quindi dilapidato il capitale di credibilità accumulato con le primarie (Prodi, Renzi); oppure aver presto scontato lo scarto tra la legittimazione del proprio popolo e l’orientamento impietoso, o comunque meno favorevole del previsto, da parte dell’elettorato (Veltroni, Bersani). Il successo nella legittimazione della leadership non ha quindi, di solito, riscontro in una conquista dell’egemonia nel Paese. Questo fattore è diventato talmente una costante che, tra le molte similitudini che caratterizzavano i tre contendenti di questa tornata, ne figurava una abbastanza paradossale, trattandosi di un’occasione di sbandierato rilancio del PD: Zingaretti, Martina e Giachetti avevano infatti firmato in precedenza il manifesto-Calenda, e si erano perciò impegnati a priori a partecipare alla prossima contesa elettorale, quella per le europee, annacquando il PD in una lista civica nazionale in alleanza con le altre forze liberiste temperate ed europeiste.
Leggi tutto
Dante Barontini: Il Pd “svolta” rimanendo fermo
Il Pd “svolta” rimanendo fermo
di Dante Barontini
Habemus secretarium! Il popolo del centrosinistra ritrova “la ditta” anche sul piano politico, dopo l’ascesa di Maurizio Landini al trono della Cgil.
Il fratello di Montalbano sorride felice, forte di una percentuale oscillante tra il 60 e il 70% su una platea di votanti dichiarata intorno al milione e 700mila persone.
Non ci metteremo qui a discutere sella serietà democratica di “primarie aperte” (che il segretario di un partito venga scelto da chiunque passi per strada, magari anche iscritto o simpatizzante di tutt’altra formazione, resta per noi un’assurdità). Né delle procedure disinvolte, della possibilità di votare più volte, ecc.
Il dato che va assunto è politico, e non c’è stupidaggine di dettaglio – ce ne sarebbero molte – che possa cambiare il dato di fatto: il Pd torna in mano all’establishment del centrosinistra di sempre, ovviamente in nome del “cambiamento”.
Il fatto che con questa scelta venga sepolto il “renzismo” è quasi secondario. L’establishment ha visto che il “vuoto a sinistra” era gigantesco; che lo scenario al centro era superaffollato; che la destra presenta venature fascistoidi tranquillamente sopportate nella vita sociale quotidiana, ma controproducenti se diventano leggi dello Stato; che il grillismo è entrato in una crisi probabilmente irreversibile (la conferma viene dal voto di ieri: “l’affluenza è stata omogenea in tutto il territorio nazionale, con un leggero picco al centro-sud, in particolare nel Lazio e in Campania”, le regioni in cui l’avanzata Cinque Stelle era apparsa inarrestabile).
Leggi tutto
Guido Carlomagno: “Competitivismo" e meritocrazia
“Competitivismo" e meritocrazia
di Guido Carlomagno, IASSP
Due eventi apparentemente scollegati fra loro, occorsi negli ultimi giorni, racchiudono un profondo significato simbolico:
a) domenica sera nel teatrino televisivo orchestrato da Fabio Fazio, rigorosamente in prima serata sul servizio pubblico, dopo il consueto sermone del Prof. Cottarelli sui “Conti-in-Ordine”, fa il suo ingresso sulla scena, quasi in guisa catartica, Roberto Saviano. Il noto scrittore ed intellettuale si concede questa apparizione nella sua arena televisiva preferita per presentare, insieme al regista Claudio Giovannesi, il film in uscita nelle sale cinematografiche La paranza dei bambini, tratto dal suo omonimo romanzo ed avente per tema il tipico cavallo di battaglia dell’autore: la narrazione “immaginifica” del mondo della criminalità organizzata napoletana. Il suo intervento può riassumersi così: questi “scugnizzi” di Napoli sono nella maggior parte dei casi ragazzi dotati di un talento e di un acume imprenditoriale molto superiore alla media. Ciò implica che abbiano una legittima e sana aspirazione ad “emergere”, ad affermarsi economicamente, ad emanciparsi dalla subalterna condizione sociale che ha riservato loro il Destino. L’unico errore che compiono è quello di cercare scorciatoie per farlo: invece di utilizzare il loro talento al servizio della sfida della cosiddetta “meritocrazia”, cogliendo tutte le opportunità che il grande gioco della globalizzazione competitiva mette a disposizione all’interno del set di regole che lo legittimano, loro, in assenza di guide e modelli culturali che li indirizzino verso questo percorso dorato, peccano di “impazienza” e scelgono la via apparentemente più breve della criminalità.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3312
Hits 2481
Hits 2444
Hits 2291
Hits 2162
Hits 2033
Hits 1964
Hits 1905
Hits 1794
Hits 1764
tonino
tonino

Emiliano Brancaccio: Il Nobel per l’economia? Conformista e prevedibile
Il Nobel per l’economia? Conformista e prevedibile
Ecco perché bisognerebbe abolirlo (forse)
Andrea Fioravanti intervista Emiliano Brancaccio
Emiliano Brancaccio, professore di politica economica all’Università del Sannio spiega i retroscena e le critiche al premio economico più famoso al mondo nel suo libro "Il discorso del potere" (Il Saggiatore), in libreria dal 14 marzo. E ha previsto il nome del prossimo vincitore
 Il premio
Nobel per l'economia è come l'Oscar: tutti lo criticano ma
ognuno sogna di
vincerlo. Non esiste premio più controverso. L'economista
più famoso del mondo, John Maynard Keynes non l'ha mai
vinto, mentre un
matematico come John Nash è riuscito ad aggiudicarselo nel
1994 per la sua "teoria dei giochi". Può capitare che due
avversari politici
citino in un talk show economisti che l'hanno vinto per
giustificare politiche economiche radicalmente opposte.
Quasi tutti credono che vincere il
premio Nobel dia il potere di cambiare il corso
dell'economia, ma raramente queste teorie sono applicate
dalla politica che le riscopre 15 o 20 anni
dopo. E quando ogni autunno viene pubblicato il nome del
vincitore sono in pochi a cercare le motivazioni della
vittoria. Per questo Emiliano
Brancaccio, professore di politica economica all'Università
del Sannio, ha scritto in collaborazione con Giacomo Bracci
il libro "Il discorso
del potere. Il premio Nobel per l’economia tra scienza,
ideologia e politica" (Il Saggiatore) in libreria dal 14
marzo. Brancaccio da molti anni
è protagonista di confronti serrati con i principali
esponenti della dottrina economica prevalente, dall’ex capo
economista del Fondo
Monetario Internazionale Olivier Blanchard all’ex premier
Mario Montii. Il suo obiettivo è far conoscere i retroscena,
le critiche e il
meccanismo del premio economico più famoso al mondo.
Il premio
Nobel per l'economia è come l'Oscar: tutti lo criticano ma
ognuno sogna di
vincerlo. Non esiste premio più controverso. L'economista
più famoso del mondo, John Maynard Keynes non l'ha mai
vinto, mentre un
matematico come John Nash è riuscito ad aggiudicarselo nel
1994 per la sua "teoria dei giochi". Può capitare che due
avversari politici
citino in un talk show economisti che l'hanno vinto per
giustificare politiche economiche radicalmente opposte.
Quasi tutti credono che vincere il
premio Nobel dia il potere di cambiare il corso
dell'economia, ma raramente queste teorie sono applicate
dalla politica che le riscopre 15 o 20 anni
dopo. E quando ogni autunno viene pubblicato il nome del
vincitore sono in pochi a cercare le motivazioni della
vittoria. Per questo Emiliano
Brancaccio, professore di politica economica all'Università
del Sannio, ha scritto in collaborazione con Giacomo Bracci
il libro "Il discorso
del potere. Il premio Nobel per l’economia tra scienza,
ideologia e politica" (Il Saggiatore) in libreria dal 14
marzo. Brancaccio da molti anni
è protagonista di confronti serrati con i principali
esponenti della dottrina economica prevalente, dall’ex capo
economista del Fondo
Monetario Internazionale Olivier Blanchard all’ex premier
Mario Montii. Il suo obiettivo è far conoscere i retroscena,
le critiche e il
meccanismo del premio economico più famoso al mondo.
* * * *
Brancaccio, partiamo dalla provocazione contenuta nelle prime pagine del suo libro. Bisognerebbe abolire il premio Nobel?
L’idea di abolirlo non è certo nostra. Fin dalle sue origini il premio ha attirato polemiche e contestazioni. Addirittura lo stesso Alfred Nobel non aveva previsto questo premio nel suo testamento.
Leggi tutto
Mario Lupoli: A 200 anni dalla nascita di Marx
![]()
A 200 anni dalla nascita di Marx
L'attualità di un pensiero e di una battaglia rivoluzionaria
di Mario Lupoli
200 anni dalla nascita di Karl Marx. Un’occasione per avviare una nuova riflessione sull’attualità del suo pensiero e della prospettiva della sua militanza rivoluzionaria. Consapevoli che il futuro, che oggi sembra negato dal dominio capitalistico, è in realtà nelle mani della maggioranza dell’umanità attiva: nelle mani del proletariato
 Non la critica, ma la
rivoluzione
Non la critica, ma la
rivoluzione
è la forza motrice della storia
(Karl Marx)
Marx, 200 anni dalla nascita. Un anniversario che, come sempre, è occasione di bilanci e di commemorazioni. Non possono che venire in mente, come istintiva strategia difensiva, le note parole con cui V. Lenin aprì il suo opuscoletto Stato e rivoluzione:
«Accade oggi alla dottrina di Marx quel che è spesso accaduto nella storia alle dottrine dei pensatori rivoluzionari e dei capi delle classi oppresse in lotta per la loro liberazione. Le classi dominanti hanno sempre ricompensato i grandi rivoluzionari, durante la loro vita, con incessanti persecuzioni; la loro dottrina è stata sempre accolta con il più selvaggio furore, con l'odio più accanito e con le più impudenti campagne di menzogne e di diffamazioni. Ma, dopo morti, si cerca di trasformarli in icone inoffensive, di canonizzarli, per così dire, di cingere di una certa aureola di gloria il loro nome, a "consolazione" e mistificazione delle classi oppresse, mentre si svuota del contenuto la loro dottrina rivoluzionaria, se ne smussa la punta, la si avvilisce. La borghesia e gli opportunisti in seno al movimento operaio si accordano oggi per sottoporre il marxismo a un tale "trattamento". Si dimentica, si respinge, si snatura il lato rivoluzionario della dottrina, la sua anima rivoluzionaria. Si mette in primo piano e si esalta ciò che è o pare accettabile alla borghesia. Tutti i socialsciovinisti - non ridete! - sono oggi "marxisti". E gli scienziati borghesi tedeschi sino a ieri specializzati nello sterminio del marxismo, parlano sempre più spesso di un Marx "nazionaltedesco" che avrebbe educato i sindacati operai, così magnificamente organizzati per condurre una guerra di rapina!»[1].
Leggi tutto
Lanfranco Binni: Rosso di sera
Rosso di sera
di Lanfranco Binni
 L’elettorato del Pd, travolto e
tramortito dalle disfatte renziane del 4 dicembre 2016 e del 4
marzo 2018, da
più di due anni spettatore passivo di una deriva politicista
dell’apparato di un ex partito di potere in crisi, nelle
primarie del 3
marzo ha finalmente lanciato un segnale chiaro di
discontinuità con il renzismo. È un elettorato composito in
cui coesistono gruppi
sociali e orientamenti diversi: dalle confuse eredità
Pci-Pds-Ds a quelle cattoliche della Margherita, dalle
componenti anziane del
sindacalismo confederale ad alcune aree di voto al M5S
rifluite sul Pd in dissenso con le politiche dell’attuale
governo gialloverde. Il segnale
è comunque importante e sollecita i gruppi dirigenti del Pd a
“cambiare rotta”, affidando questo compito impegnativo al
nuovo
segretario eletto. Ora il problema è proprio questo: su quale
linea politica l’apparato del Pd (parlamentari, amministratori
locali,
funzionari) potrà cambiare rotta rispetto alle pratiche
berlusconiane, liberiste e atlantiste della stagione renziana.
Il tutto in presenza di
un governo nazionale in cui l’abbraccio letale tra M5S e Lega,
determinato dallo stesso Pd dopo le elezioni del 4 marzo 2018,
sta provocando il
rafforzamento della Lega su una linea di estrema destra e
l’evidente crisi del M5S su una non-linea «né di destra né di
sinistra».
L’elettorato del Pd, travolto e
tramortito dalle disfatte renziane del 4 dicembre 2016 e del 4
marzo 2018, da
più di due anni spettatore passivo di una deriva politicista
dell’apparato di un ex partito di potere in crisi, nelle
primarie del 3
marzo ha finalmente lanciato un segnale chiaro di
discontinuità con il renzismo. È un elettorato composito in
cui coesistono gruppi
sociali e orientamenti diversi: dalle confuse eredità
Pci-Pds-Ds a quelle cattoliche della Margherita, dalle
componenti anziane del
sindacalismo confederale ad alcune aree di voto al M5S
rifluite sul Pd in dissenso con le politiche dell’attuale
governo gialloverde. Il segnale
è comunque importante e sollecita i gruppi dirigenti del Pd a
“cambiare rotta”, affidando questo compito impegnativo al
nuovo
segretario eletto. Ora il problema è proprio questo: su quale
linea politica l’apparato del Pd (parlamentari, amministratori
locali,
funzionari) potrà cambiare rotta rispetto alle pratiche
berlusconiane, liberiste e atlantiste della stagione renziana.
Il tutto in presenza di
un governo nazionale in cui l’abbraccio letale tra M5S e Lega,
determinato dallo stesso Pd dopo le elezioni del 4 marzo 2018,
sta provocando il
rafforzamento della Lega su una linea di estrema destra e
l’evidente crisi del M5S su una non-linea «né di destra né di
sinistra».
Ma l’elezione di Zingaretti come opzione di centro-sinistra plurale e aperto alla “società civile” testimonia anche la forza oggi determinante degli elettorati (tutti) nella crisi del sistema politico italiano e della democrazia “rappresentativa”. Siamo all’interno di una crisi profonda di sistema: politico, economico e culturale. In crisi il sistema politico e la credibilità delle istituzioni, in crisi il sistema economico (né “crescita” né “sviluppo” di un modo di produzione in crisi nell’intero Occidente), in crisi l’assetto tradizionale, a pretesa radice unica, di una società multiculturale in rapida trasformazione demografica.
Leggi tutto
Wolfgang Streeck: “Rompere l’euro, e al più presto”
“Rompere l’euro, e al più presto”
intervista a Wolfgang Streeck
“Il” crash “di Lehman Brothers si può ripetere in qualsiasi momento”, predice il sociologo tedesco del Max Planck Institute (1).
Completo grigio, camicia scura e un discorso sereno: a prima vista non c’è assolutamente niente che faccia pensare all’intellettuale tedesco Wolfgang Streeck come uno dei più grandi pessimisti del Nord Atlantico. Tranne forse dei baffi discreti alla Pessoa, lasciano anticipare l’inquietudine che lascerà la conversazione di un’ora con lui: un filo rosso lega fatti e congetture per arrivare a concludere che il capitalismo si sta dirigendo verso il più completo disastro. Il titolo del suo ultimo libro è la sua migliore lettera di presentazione: in “Come finirà il capitalismo?” conclude, in un tono da Antico Testamento, che la credibilità delle istituzioni democratiche è crollata e che la socialdemocrazia – nella quale lui ha militato – ha fallito miseramente. Strano mix di acuto analista, moralista e profeta, il sociologo capo del prestigioso Max Planck Institute sostiene che dobbiamo rompere l’euro e che la fusoliera del sistema finanziario porta alle macerie. “Il crollo di Lehman Brothers si può ripetere in qualsiasi momento”, prevede con un fatalismo senza fine.
Streeck è stato giovedì scorso a Madrid per tenere un discorso in una serie di conferenze organizzate dalla Fondazione Ramón Areces. Gli assistenti (e l’intervistatore) sono impalliditi: la Grande Crisi è “un fallimento del sistema e delle idee che l’hanno sostenuta”, “un fraintendimento generale per il quale forse non c’è soluzione”.
Leggi tutto
Ugo Boghetta: Manifesto Sovranità Costituzionale: Istruzioni per l’uso - 2a parte
Manifesto Sovranità Costituzionale: Istruzioni per l’uso - 2a parte
Dopo il 9 marzo (e oltre)
di Ugo Boghetta
Nell’articolo precedente (su Rinascita!) ho cercato di dar conto, dal mio punto di vista, di come abbiamo lavorato all’elaborazione del Manifesto impostando diversamente la questione dell’Unione, ad esempio. Siamo partiti dalla centralità della Costituzione come leva per disvelare l’incompatibilità dei Trattati. Non solo, abbiamo proposto un modello strategico alternativo: la confederazione di stati sovrani, e affermato che la sovranità monetaria deve servire ad attuare la Costituzione.
Una sovranità, dunque, non come fine (nazionalista) ma come mezzo per politiche sociali. Su questo punto alcuni non hanno capito perchè non c’era scritto noeuro, altri non hanno voluto capire. Costoro pensano che l’uscita dall’Unione si ottenga ripentendo come un mantra: noeuro, noeuro, noeuro. Mi viene in mente la pubblicità: “Facile.it, facile.it, facile.it“.
In questo testo invece vorrei ragionare sul come andare oltre il 9 marzo, e sul come il Manifesto possa diventare articolazione programmatica e calarsi in campagne che lo trasformino in:”pane e salame“.
Il contesto in cui ci troveremo ad operare sarà caratterizzato, a larghi tratti, da nuove tensioni all’interno dell’Unione a seguito degli equilibri post elettorali, dal macinare della garrota invisibile dell’euro, e dall’accordo di Aquisgrana che realizza l’Unione a più velocità, ovvero la progressiva disunione. A livello nazionale avremo una crisi progressiva del M5S anche se non necessariamente al livello delle regionali recenti.
Leggi tutto
Sandro Moiso: Tre secoli di guerra civile
Tre secoli di guerra civile
di Sandro Moiso
Pierre Miquel, Le guerre di religione, Res Gestae, Milano, 2019, pp. 636, € 24,00
L’autore di questo libro uscito in Francia nel 1980, al tempo docente presso la Sorbona, e per la prima volta in Italia nel 1981, certamente non si sarebbe trovato d’accordo con il titolo di questa recensione. Avrebbe, cioè, tenuto fermo il punto sullo scontro di carattere religioso avvenuto in Francia tra il 1523 e il 1771, il periodo di cui appunto l’ampia ricerca si occupa. Eppure, eppure…
Oggi, ancor più di ieri, è evidente agli occhi di chi scrive
che spesso è più il presente o ancor meglio il futuro a
determinare le coordinate della ricerca storica, più che il
passato in sé. Si potrebbe forse addirittura affermare che il
passato in
sé non esiste, essendo rideterminato da ogni stagione di nuove
riletture dello stesso, messe in opera sulla base delle
esperienze e delle
esigenze del presente oppure sulle ipotesi derivate da nuove
prospettive future.
In questo senso, sia come ricercatori che come antagonisti del
presente, occupandoci di Storia e di studi sociali, così come
di qualsiasi altra scienza, possiamo essere tanto agenti
del quanto
agiti dal futuro.
Leggi tutto
Michele Ambrogio: Cacciari come Weber
Cacciari come Weber
di Michele Ambrogio
La rigenerazione del Leviatano e l’Autonomia del Politico
«Scienza e politica formano insieme la "geistige Arbeit" – devono funzionare insieme. Non vi è Stato moderno senza lavoro scientifico, senza rapporto con la Tecnica. E non vi è Tecnica se non sia intrinseca allo Stato. Eppure anche qui si tratta di Due e non di Uno! Ecco il politico di nuovo: che conosce l'essenzialità del lavoro scientifico e in uno conserva l’autonomia delle proprie decisioni. La "politica al comando" è altrettanto utopistica di una "scienza autonoma". Il capitalismo è essenzialmente il sistema che le unifica nel loro stesso contraddirsi»*
... Ma, allora, v’è ancora la possibilità di un’alternativa al sistema capitalistico?
Ho sempre letto con interesse i saggi di Cacciari, restando fermo però all’insuperato Krisis, saggio sul pensiero negativo da Nietzsche a Wittgenstein. A distanza di quasi 40 anni, ritrovo e comprendo meglio la mia distanza dalla sua (quella di Cacciari) longeva attualità. Non mi riferisco alla sua biografia (che pure la evoca, con il ritorno al PCI, il centauro e gli arcipelaghi dell’esperienza di governo del territorio come sindaco di Venezia...) ma ai suoi punti di riferimento. Costante in tutto il suo percorso dopo Krisis (che mi rassegnò ad una scelta opposta alla sua) la formula di un’autonomia del politico.
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: “Siamo all’offensiva?”
“Siamo all’offensiva?”
di Elisabetta Teghil
 Siamo tante, siamo all’offensiva,
il movimento delle donne salverà il mondo. Questo è il
refrain che circola in lungo e in largo. E non sarà questo lo
specchio dei tempi? Cioè che un movimento senza nessuna
possibilità
di incidere e di cambiare alcunché sembri vincente?
Siamo tante, siamo all’offensiva,
il movimento delle donne salverà il mondo. Questo è il
refrain che circola in lungo e in largo. E non sarà questo lo
specchio dei tempi? Cioè che un movimento senza nessuna
possibilità
di incidere e di cambiare alcunché sembri vincente?
Quello che viene propagandato come “movimento delle donne” è dichiaratamente interclassista, le sue rivendicazioni sono di richiesta di riconoscimento e di tutela allo Stato e ha un’impostazione esplicitamente corporativa.
Lo sciopero è un’arma di lotta che dovrebbe mirare a cambiare un rapporto di forza attraverso il danneggiamento della controparte e a ottenere un risultato preciso. Si può fare sciopero bloccando tutto il servizio del pubblico trasporto perché non si vuole la privatizzazione del servizio, tanto per fare un esempio, o si può fare sciopero generale bloccando tutti i servizi della città perché non si vuole l’approvazione di una legge che sta passando in parlamento come il finanziamento delle missioni militari all’estero, tanto per farne un altro, ma è impensabile fare sciopero per la pace nel mondo. C’è forse qualcuno/a che non è d’accordo sulla pace nel mondo? Farebbero sciopero anche quelli che le guerre le fanno e le fomentano. Quindi ciò che salta agli occhi di primo acchito è che non può essere impostato uno sciopero contro la violenza sulle donne o sulle ingiustizie di questa società perché tanto sono d’accordo tutti e tutte, compresi tutti gli uomini e tutte le donne che sono direttamente responsabili della costruzione della società neoliberista e della perpetuazione del patriarcato.
Però, con una lettura più attenta ma neanche chissà quanto approfondita, il motivo vero balza fuori evidente. Le donne della socialdemocrazia riformista che hanno impostato qui in Italia questo movimento vogliono soldi, vogliono finanziamenti, vogliono carriere, vogliono che sia riconosciuto il ruolo delle donne che in questa società in effetti fanno parte della struttura di dominio ai livelli e nelle modalità più disparate.
Leggi tutto
Giovanni Iozzoli: La recessione interiore
La recessione interiore
di Giovanni Iozzoli
 Avete presente i vecchi film di
indiani in cui improbabili Apaches si mettevano a culo in
aria, con un orecchio ben
piantato per terra, onde avvertire in lontananza l’arrivo del
treno o lo scalpiccio dei cavalli? Ecco, quella è la postura
assunta da
imprenditori ed economisti italiani negli ultimi cinque mesi –
più o meno dall’ultimo trimestre del 2018. Solo che i
pellerossa in
fase di ascolto erano intrepidi e impassibili, mentre le
nostre sedicenti classi dirigenti, appaiono tremebonde,
spaesate, sempre sull’orlo
della crisi di nervi. E quell’orecchio schiacciato sui
pavimenti dei loro eleganti uffici riceve solo segnali
preoccupanti. Si sa che il nemico
è in avvicinamento, se ne vedono tutti gli effetti già
pienamente squadernati: fatturati, ordinativi, scorte,
inflazione, tutti gli
indicatori hanno il segno meno, e con persistente continuità.
Avete presente i vecchi film di
indiani in cui improbabili Apaches si mettevano a culo in
aria, con un orecchio ben
piantato per terra, onde avvertire in lontananza l’arrivo del
treno o lo scalpiccio dei cavalli? Ecco, quella è la postura
assunta da
imprenditori ed economisti italiani negli ultimi cinque mesi –
più o meno dall’ultimo trimestre del 2018. Solo che i
pellerossa in
fase di ascolto erano intrepidi e impassibili, mentre le
nostre sedicenti classi dirigenti, appaiono tremebonde,
spaesate, sempre sull’orlo
della crisi di nervi. E quell’orecchio schiacciato sui
pavimenti dei loro eleganti uffici riceve solo segnali
preoccupanti. Si sa che il nemico
è in avvicinamento, se ne vedono tutti gli effetti già
pienamente squadernati: fatturati, ordinativi, scorte,
inflazione, tutti gli
indicatori hanno il segno meno, e con persistente continuità.
In Italia siamo passati da un periodo di contenuta euforia – la crisi è passata, concentriamoci sulla terribile bellezza e la geometrica potenza dell’industria 4.0 –, all’attuale panico mal dissimulato. Il dio capricciosissimo del ciclo economico sta compilando nuovi elenchi di predestinati all’inferno: i fedeli non si salveranno mediante le opere – eppure ci danno dentro di brutto, attraverso l’intensificazione dei ritmi, le condizioni di sfruttamento, la compressione dei salari, il dumping contrattuale. Fanno il loro dovere, gli imprenditori italiani: piangono e fottono, soprattutto i lombardo-veneti – che dentro la crisi, con riflesso automatico, abbandonano le compassate velleità mitteleuropee e si riscoprono interpreti del più melodrammatico mammismo mediterraneo. Aiutateci, aiutateci tutti a stare in piedi, a rimanere sul mercato, compattiamoci, abbiamo bisogno.
Adesso la panacea di tutti i mali, il rimedio anticiclico per eccellenza, sono diventate le grandi opere – come se la realizzazione di una bretella stradale Sassuolo-Campogalliano, nel modenese, ad esempio, potesse invertire il corso della crisi globale.
Leggi tutto
Jacques Sapir: La de-globalizzazione e il recupero della sovranità nazionale sulla governance
La de-globalizzazione e il recupero della sovranità nazionale sulla governance
di Jacques Sapir
La globalizzazione continua ad essere data per scontata e inevitabile, eppure il processo di de-globalizzazione è già iniziato e avanza, a partire dagli Stati Uniti e dalla stessa Europa, con un movimento di recupero della democrazia nazionale sulla “governance” in cui economia e finanza prevalgono sulla politica. Ne discute l’economista francese Jacques Sapir in un lungo articolo di cui pubblichiamo qui la prima parte. (Traduzione in collaborazione con Attivismo.info)
 Quando ho
scritto il mio libro La Demondializzazione,
pubblicato nel 2011 dalle
edizioni Seuil, era già chiaramente possibile percepire i
segni di una crisi della globalizzazione e persino l’inizio di
un processo di
de-globalizzazione. La conclusione minima che si può trarre
dagli ultimi dieci anni è che questa mondializzazione, o
globalizzazione,
è andata molto male e che ha generato forze profonde e potenti
di protesta. Oggi siamo in grado di vedere meglio ciò che era
evidente
sin dall’inizio: questo processo è in contraddizione con
l’esistenza stessa della democrazia. Ciò che colpisce oggi è
che queste patologie politiche hanno raggiunto un punto di
rottura nel Paese che si è presentato come il cuore stesso del
processo di
globalizzazione, gli Stati Uniti
Quando ho
scritto il mio libro La Demondializzazione,
pubblicato nel 2011 dalle
edizioni Seuil, era già chiaramente possibile percepire i
segni di una crisi della globalizzazione e persino l’inizio di
un processo di
de-globalizzazione. La conclusione minima che si può trarre
dagli ultimi dieci anni è che questa mondializzazione, o
globalizzazione,
è andata molto male e che ha generato forze profonde e potenti
di protesta. Oggi siamo in grado di vedere meglio ciò che era
evidente
sin dall’inizio: questo processo è in contraddizione con
l’esistenza stessa della democrazia. Ciò che colpisce oggi è
che queste patologie politiche hanno raggiunto un punto di
rottura nel Paese che si è presentato come il cuore stesso del
processo di
globalizzazione, gli Stati Uniti
Considerando le questioni sociali, le questioni ecologiche o direttamente le questioni economiche, i segni di un esaurimento del processo, ma anche di una messa in discussione del processo stesso, si accumulano. Il ritorno in prima linea delle nazioni come attori politici era evidente [2]. Vari eventi, dal referendum sull’uscita del Regno Unito dall’Unione europea (il “Brexit”) all’elezione di Donald Trump negli Stati Uniti, comprese le reazioni ai tentativi degli stessi Stati Uniti di istituzionalizzare l’applicazione extraterritoriale del diritto USA e l’ascesa dell’euroscetticismo, che è oggi molto importante nei Paesi dell’Unione europea, valgono a confermare l’analisi.
Quindi oggi parliamo di rischi di guerra su scala globale. Ed è vero che le tensioni geopolitiche sono aumentate. Ma, bisogna sapere, “la globalizzazione” non ha mai interrotto le guerre.
Leggi tutto
Jean-Luc Mélenchon, Emmanuel Maurel, Younous Omarjee: “Noi dichiariamo la morte del Trattato di austerità”
“Noi dichiariamo la morte del Trattato di austerità”
di Jean-Luc Mélenchon - Emmanuel Maurel - Younous Omarjee
Lo sapevate? Uno dei trattati fondamentali dell’Europa liberista è decaduto. Noi che ci battiamo per l’uscita dai trattati europei siamo lieti di informarvi che un trattato è uscito tutto da solo a causa della negligenza e dell’arroganza dei governi e della Commissione europea. Si tratta del TSCG.
Il Trattato sulla stabilità, coordinamento e governance (TSCG) è stato negoziato nel 2011-2012. È il risultato di un accordo politico tra due governi liberisti: in Francia, il governo di Nicolas Sarkozy e in Germania, quello di Angela Merkel. Ha trasposto in un trattato internazionale i metodi disastrosi utilizzati nella crisi del debito greco. All’epoca, sembrava spingersi così lontano nella logica dell’austerità che anche François Hollande, durante la campagna presidenziale del 2012, promise di rinegoziarlo e che la Francia non poteva firmarlo così com’era. Una volta eletto Presidente della Repubblica, non lo ha fatto. Già nel giugno 2012, ha firmato dove la signora Merkel glielo aveva indicato senza cambiare linea. Questo primo tradimento ha completato la trasformazione della social-democrazia francese nell’esecutore testamentario dell’Europa della destra tedesca.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Il culto della flessibilità e i suoi ayatollah
Il culto della flessibilità e i suoi ayatollah
di Carlo Formenti
Da non credersi: è vero che ormai il negazionismo in merito agli effetti devastanti di decenni di politiche neoliberiste sui livelli retribuitivi e sulle condizioni di vita e di lavoro delle classi subalterne attinge livelli paragonabili a quelli dei negazionismi sull’effetto serra e sulla Shoà, ma quando si parla di occupazione il limite della decenza è abbondantemente superato. Sull’inserto Innovazione del Corriere del 22 febbraio leggo un articolo in cui si ha ancora la faccia tosta di associare il lavoro precario (contratti a tempo, lavoretti della gig economy, ecc.) alla “libertà di gestire il proprio tempo”.
È pur vero che l’autrice cita le pratiche piratesche delle catene commerciali inglesi che usano i famigerati contratti a zero ore (che permettono alle imprese di convocare il lavoratore anche solo un’ora prima dell’inizio di un turno, di pagarlo un terzo dei dipendenti a tempo pieno e di massacrarlo di straordinari) ammettendo che il 90% della forza lavoro di tali imprese è in queste condizioni. Riconosce anche che dietro i contratti di lavoro apparentemente autonomo dei riders di Uber, Deliveroo, Fedora e simili si cela un rapporto di lavoro subordinato (esposto perdipiù a condizioni vessatorie). Riconosce, infine, che i contratti a tempo determinato “rischiano” (!?) di portare con sé una nuova forma di precarietà.
Leggi tutto
Matteo Trevisani: Anticipò Darwin, sfidò la Chiesa
Anticipò Darwin, sfidò la Chiesa
L’«aquila degli atei» che morì da filosofo
di Matteo Trevisani
«Andiamo a morire allegramente da filosofi», disse Giulio Cesare Vanini al suo boia, il pomeriggio del 9 febbraio 1619. Poco dopo gli verrà strappata la lingua, strumento con la quale aveva offeso Dio e il re, verrà strangolato e il suo corpo bruciato sul rogo si consumerà illuminando Place du Sulin, a Tolosa. Aveva trentaquattro anni.
È con quest’atto cruento che si compie, diciannove anni dopo il più famoso rogo di Giordano Bruno in Campo de’ Fiori, l’ultimo tratto della parabola di Vanini, filosofo italiano, principe dei libertini, aquila ateorum.
Mi sono chiesto a lungo che cosa significasse «morire da filosofi» e in che cosa questo differisse dal morire di tutti. Se fosse solo una frase a effetto, la volontà di non mostrarsi vinti del tutto, l’arroganza ultima di chi crede di essere dalla parte della ragione. Ma per capire fino in fondo il significato della morte di Vanini bisognava partire dalla sua vita. La straordinaria storia del più ateo dei filosofi del Rinascimento è fatta di fughe repentine, di abiure, di prigionìe, di spionaggio e diplomazia, ma anche di audacia e coraggio, di una fede perduta e amore per l’essere umano.
Giulio Cesare Vanini nasce a Taurisano, in Salento, nel 1585, in una famiglia piuttosto agiata. Studia diritto a Napoli, dove nel 1603 entra nell’ordine dei carmelitani.
Leggi tutto
Giuliano Granato: Venezuela. La frontiera
Venezuela. La frontiera
di Giuliano Granato*
Reportage dal Venezuela. Ci sono frontiere che vedi da lontano. Quelle presidiate dai soldati, con le dogane ben visibili, demarcate perfino con la pittura sul terreno. Tra la Colombia e il Venezuela ci sono tre ponti, tre passaggi ufficiali.
E poi uniformi di un colore da una parte; uniformi di un altro colore dall’altra. Gli Stati Uniti l’hanno segnalata come luogo chiave per capire quello che succede in Venezuela. E, soprattutto, quello che succederà.
I media hanno fatto il resto. Hanno costruito lo spettacolo, montato lo show. Giornali e TV da tutto il mondo, con la statunitense CNN a trasmettere in diretta ogni ora, con corrispondenti dai tanti paesi latinoamericani.
Per qualche settimana Cúcuta, da sconosciuta che era, è diventata un nome sulla bocca di milioni di persone in tutto il mondo. Branson, il miliardario Branson, ha deciso che quello sarebbe stato il teatro perfetto per il concerto dell’anno. Live Aid, le star mondiali della canzone in lingua spagnola, le parole gridate contro la “dittatura” e il miliardario Branson che ci mostra che lui ai poveri vuole bene. Purché siano venezuelani, però. Perché se sono i colombiani che fanno letteralmente la fame a Cúcuta e dintorni, beh, quelli cerchino altri salvatori, ché Mr. Branson ha altre cause da sposare.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3344
Hits 2531
Hits 2480
Hits 2323
Hits 2186
Hits 2054
Hits 1975
Hits 1912
Hits 1830
Hits 1775
tonino

Gabriele Giacomini: Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia?
Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia?
Luigi Somma intervista Gabriele Giacomini
 Internet sta cambiando la sfera pubblica e la
democrazia? Il web è il
luogo dell’informazione libera e autonoma o le informazioni
si stanno organizzando attorno a inediti centri di potere?
Internet promuove un
pluralismo dialogico o rischia di nutrire una crescente
polarizzazione? La democrazia rappresentativa è da superare
oppure rimane la soluzione
migliore per governare? La democrazia è certamente un
sistema aperto (quindi sempre imperfetto e in evoluzione),
ma è anche
responsabilizzante: è compito dei cittadini e delle classi
dirigenti gestire al meglio gli esiti dell’innovazione
tecnologica.
Internet sta cambiando la sfera pubblica e la
democrazia? Il web è il
luogo dell’informazione libera e autonoma o le informazioni
si stanno organizzando attorno a inediti centri di potere?
Internet promuove un
pluralismo dialogico o rischia di nutrire una crescente
polarizzazione? La democrazia rappresentativa è da superare
oppure rimane la soluzione
migliore per governare? La democrazia è certamente un
sistema aperto (quindi sempre imperfetto e in evoluzione),
ma è anche
responsabilizzante: è compito dei cittadini e delle classi
dirigenti gestire al meglio gli esiti dell’innovazione
tecnologica.
Intervistiamo su questi temi Gabriele Giacomini, autore del volume “Potere digitale. Come Internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia”, pubblicato a fine 2018 dall’editore milanese Meltemi.
* * * *
Se da una parte le nuove tecnologie digitali alimentano il bisogno di una maggiore partecipazione democratica, dall’altra dobbiamo anche registrare fenomeni di disintermediazione, che hanno investito anche la struttura dei partiti e i corpi intermedi. Che ne pensa?
Il problema della disintermediazione è strettamente correlato al tema dei partiti, dal momento che la democrazia dei moderni ha visto sempre al centro il potere dei partiti. Nonostante questi abbiano mutato nel tempo le proprie forme, costituiscono, in ogni caso, una costante della democrazia rappresentativa. Siamo passati da un partito di notabili – il partito della democrazia a suffragio ristretto – al partito di massa, e ora si è registrata un’ulteriore modificazione: i partiti stanno cambiando in rapporto stretto con quelle che sono le tecnologie della comunicazione. Per spiegare questi cambiamenti partiamo dalle caratteristiche del partito di massa tradizionale.
Leggi tutto
Maurizio Lazzarato: Pasolini e le semiotiche dell’immanenza
Pasolini e le semiotiche dell’immanenza
Segni e macchine
di Maurizio Lazzarato
Anticipiamo un estratto del libro di Maurizio Lazzarato, Segni e macchine. Il capitalismo e la produzione di soggettività, dal 14 marzo in libreria per ombre corte. Il capitale è un operatore semiotico: questa affermazione di Félix Guattari è al centro del lavoro di Lazzarato che, chiedendoci di abbandonare il logocentrismo che informa ancora tante teorie critiche, cerca di costruire una nuova teoria in grado di spiegare come funzionano i segni (e non soltanto il linguaggio) nell’economia, negli apparati di potere e nella produzione di soggettività
 Pasolini è sicuramente
uno dei primi autori ad aver colto la natura e il
funzionamento dei sistemi di segni del
«neocapitalismo». Il suo modo di liberarsi dei limiti della
linguistica e della semiotica, così come si sono costituite
nel XIX e
nel XX secolo, coincide, in molte parti, con il lavoro di
Guattari. Il «neocapitalismo» è così definito perché, a
differenza del capitalismo classico, non tollera nulla al di
fuori dei suoi rapporti di sfruttamento e di dominio. Il
neocapitalismo segna un
cambiamento del «modo di produzione» che Pasolini chiama anche
«seconda rivoluzione capitalista», che non produce solo nuove
merci, ma anche una nuova umanità e una nuova cultura che,
cinicamente, distrugge le culture contadine, sottoproletarie e
operaie, operando il
«più completo e totale genocidio»1 della storia
italiana. Quello che prima poteva ancora rimanere «fuori» è
completamente subordinato alla logica del capitale, poiché,
come
in Guattari, la produzione di soggettività (della cultura, dei
valori, dei comportamenti, dei modi di esistenza) è tra le
prime e
più importanti forme di produzione.
Pasolini è sicuramente
uno dei primi autori ad aver colto la natura e il
funzionamento dei sistemi di segni del
«neocapitalismo». Il suo modo di liberarsi dei limiti della
linguistica e della semiotica, così come si sono costituite
nel XIX e
nel XX secolo, coincide, in molte parti, con il lavoro di
Guattari. Il «neocapitalismo» è così definito perché, a
differenza del capitalismo classico, non tollera nulla al di
fuori dei suoi rapporti di sfruttamento e di dominio. Il
neocapitalismo segna un
cambiamento del «modo di produzione» che Pasolini chiama anche
«seconda rivoluzione capitalista», che non produce solo nuove
merci, ma anche una nuova umanità e una nuova cultura che,
cinicamente, distrugge le culture contadine, sottoproletarie e
operaie, operando il
«più completo e totale genocidio»1 della storia
italiana. Quello che prima poteva ancora rimanere «fuori» è
completamente subordinato alla logica del capitale, poiché,
come
in Guattari, la produzione di soggettività (della cultura, dei
valori, dei comportamenti, dei modi di esistenza) è tra le
prime e
più importanti forme di produzione.
Ma, prima di arrivare, negli anni Settanta, a una descrizione «sociologica», «antropologica» ed «economica» dell’impresa del capitalismo sull’insieme della società e delle sue modalità di espressione, Pasolini coglie, alla metà degli anni Sessanta, la natura della potenzialità della nuova «immanenza» attraverso la sua speciale semiotica. La «semiologia generale dell’azione» che vorrebbe elaborare, ritrova la continuità tra natura e cultura che la modernità aveva spezzato, concentrando tutta la soggettività sul soggetto e spogliando l’oggetto di ogni capacità di espressione. Mettendo a frutto la sua esperienza cinematografica Pasolini produce, come fa Charles Sanders Pierce, una nuova semiologia partendo dall’immagine. Non considerando quest’ultima una produzione del cervello, né un risultato del nostro sistema di percezione, supera il dualismo dell’immagine e della cosa, della coscienza e dell’oggetto.
Leggi tutto
Vincenzo Morvillo: Pil e socialismo. il nuovo corso keynesiano della Cina
Pil e socialismo. il nuovo corso keynesiano della Cina
di Vincenzo Morvillo
 Leggendo, nei giorni
scorsi, due articoli, uno pubblicato da La Stampa:
“L’Italia si prepara ad aderire alla grande rete
infrastrutturale cinese” e l’altro, invece,
pubblicato su
Contropiano, a firma di Pasquale Cicalese: “La
Cina, dopo 40 anni, proietta la sua potenza sul mercato
interno” –
come tanti altri che leggo sul cosiddetto miracolo cinese,
attualmente seconda economia mondiale, proiettata verso un
inarrestabile primato –
ho, per l’ennesima volta, fatto la stessa identica
considerazione.
Leggendo, nei giorni
scorsi, due articoli, uno pubblicato da La Stampa:
“L’Italia si prepara ad aderire alla grande rete
infrastrutturale cinese” e l’altro, invece,
pubblicato su
Contropiano, a firma di Pasquale Cicalese: “La
Cina, dopo 40 anni, proietta la sua potenza sul mercato
interno” –
come tanti altri che leggo sul cosiddetto miracolo cinese,
attualmente seconda economia mondiale, proiettata verso un
inarrestabile primato –
ho, per l’ennesima volta, fatto la stessa identica
considerazione.
La Cina compete sul mercato mondiale, nell’epoca della globalizzazione – cioè da circa trent’anni – con tutte le armi tipiche del finanzcapitalismo (per usare la significante locuzione coniata dal sociologo Luciano Gallino), accreditandosi come il più agguerrito antagonista dell’impero statunitense e il suo più legittimo successore, nella guerra interimperialista in atto sullo scacchiere internazionale.
Una guerra innescata a partire dagli anni ’70, da quella che il prof. Luciano Vasapollo indica come crisi sistemica del capitalismo mondiale, all’interno di una civiltà-mondo dominata dal sistema finanziario, finora soprattutto a guida occidentale.
Ne viene, di conseguenza, la seconda, più sofferta e perplessa considerazione. Perché molti compagni guardino alla Cina post maoista e di ispirazione denghista (“arricchirsi è glorioso, compagni”, disse Deng Xiaoping nel 1979. Sic!) come ad un modello, seppur spurio, di paese socialista, sinceramente mi è oscuro. In chiave geopolitica e geostrategica, di contrasto al dominio imperiale a stelle e strice? Posso pure comprenderlo. Ma basta? Francamente, non credo!
La Cina ha innestato, negli ultimi trent’anni, la marcia del neoliberismo più spinto. Il paradigma produttivo è quello sviluppista, tipico dei paesi a Capitalismo avanzato. Il Pil è cresciuto a due zeri. E ora, in fase di leggera, ma pur sempre indiscutibile, flessione dell’export (che ha assicurato al paese proprio quella crescita esponenziale) sta correndo ai ripari. E, ovviamente, lo fa sul piano del sostegno alla domanda interna.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi e Alessandro Visalli: Sovranità nazionale e immigrazione
![]()
Sovranità nazionale e immigrazione
Un dibattito tra Fabrizio Marchi e Alessandro Visalli
 Riportiamo di seguito uno scambio di opinioni
tra Visalli e Marchi a partire
dall'Assemblea Nazionale di Patria e Costituzione.
Riportiamo di seguito uno scambio di opinioni
tra Visalli e Marchi a partire
dall'Assemblea Nazionale di Patria e Costituzione.
* * * *
![]()
“Patria e Costituzione”: luci e ombre
di Fabrizio Marchi
Sono di ritorno dall’assemblea nazionale di Patria e Costituzione (quella di Stefano Fassina, per intendersi), alla quale hanno aderito altre associazioni dell’area della sinistra cosiddetta “sovranista”, come “Rinascita!” e “Senso Comune”. Alcuni di loro – e hanno ragione – trovano improprio l’uso del termine “sovranista” – ma si fa per capirci – altri invece lo rivendicano apertamente). Non so se ce ne siano anche altre ma non importa. Questo non vuole essere un report ma solo un commento all’evento. Saranno, eventualmente, loro stesse a comunicarcelo, se lo riterranno opportuno. Di seguito, il Manifesto per la Sovranità Costituzionale che hanno presentato: https://www.patriaecostituzione.it/wp-content/uploads/2019/02/Manifesto-per-la-sovranit%C3%A0-costituzionale-4.pdf
Sono state dette cose (che già conoscevo) condivisibili e altre meno o per nulla.
Sorvolo su quelle condivisibili perchè le potete leggere sul nostro giornale, e vado rapidamente a quelle non condivisibili che in parte ho già espresso in questo articolo e quindi non mi ripeto:
http://www.linterferenza.info/editoriali/sbaglia-la-sinistra-sovranista/
I punti di dissenso, per quanto mi riguarda (oltre a quelli già affrontati nell’articolo sopra linkato) sono l’immigrazione e il femminismo.
Il primo. Volendo sintetizzare con una battuta, potremmo dire che l’analisi che fanno è del tutto condivisibile; peccato che alla fine la risposta politica che propongono sia un topolino. Un topolino che però rischia seriamente di essere reazionario e criminale.
Leggi tutto
Renato Caputo: I comunisti e la questione nazionale
I comunisti e la questione nazionale
di Renato Caputo
La duplice lotta dei comunisti contro le posizioni dei social-sciovinisti, che nei fatti sostengono il proprio imperialismo, e dei critici del diritto all’autodeterminazione nazionale dei popoli da posizioni cosmopolite, oggi reazionarie
 Dal punto di vista di Marx
ed Engels,
i fondatori del socialismo scientifico, la
questione è chiara: per
poter vincere nella lotta di classe e
sostituire il modo di produzione capitalistico con quello
socialista bisogna muoversi in
un’ottica internazionalista. Non a caso
concludono il Manifesto
del partito comunista con il celebre:
“Proletari di tutto il mondo,
unitevi!”. Allo stesso modo, non è un caso che Marx
ed Engels dedicano la maggior parte delle loro energie allo
sviluppo
dell’Internazionale, piuttosto che allo
sviluppo di partiti socialisti su base nazionale.
Dal punto di vista di Marx
ed Engels,
i fondatori del socialismo scientifico, la
questione è chiara: per
poter vincere nella lotta di classe e
sostituire il modo di produzione capitalistico con quello
socialista bisogna muoversi in
un’ottica internazionalista. Non a caso
concludono il Manifesto
del partito comunista con il celebre:
“Proletari di tutto il mondo,
unitevi!”. Allo stesso modo, non è un caso che Marx
ed Engels dedicano la maggior parte delle loro energie allo
sviluppo
dell’Internazionale, piuttosto che allo
sviluppo di partiti socialisti su base nazionale.
Inoltre, dal punto di vista del materialismo storico, dal momento che l’unica scienza è la storia – visto che dal punto di vista radicalmente immanentistico di Marx ed Engels non esiste un piano che la trascende – lo Stato è un prodotto storico e, tanto più, lo Stato nazionale è il prodotto di un determinato sviluppo storico. Se lo Stato sorge dalla divisione del lavoro e dalla conseguente divisione della società in classi, quale strumento di dominio del blocco sociale dominante sui ceti subalterni, lo Stato nazionale è un prodotto molto più recente, dal momento che è la forma di dominio funzionale all’affermazione della borghesia quale classe dominante, in quanto consente lo sviluppo di un mercato nazionale.
In effetti, prima dello Stato nazionale borghese, esistono altre forme di Stato, adeguate ai precedenti modi di produzione, dallo Stato dispotico orientale, allo Stato schiavistico, allo Stato medievale, periodi nei quali lo Stato assume preferibilmente la forma di impero, in quanto tale transnazionale.
Dunque è essenziale, in primo luogo, non cadere nelle trappole dell’ideologia dominante che tende a naturalizzare la società borghese, dando a intendere che la forma dello Stato nazionale è appunto naturale e astorica.
Leggi tutto
Stefano Isola e Lucio Russo: Scienza e democrazia
Scienza e democrazia
di Stefano Isola e Lucio Russo
 Tra gli
argomenti che negli ultimi anni dividono l’opinione pubblica
in due tifoserie
contrapposte, vi è l’atteggiamento verso la scienza e, in
particolare, i suoi rapporti con la democrazia.
Tra gli
argomenti che negli ultimi anni dividono l’opinione pubblica
in due tifoserie
contrapposte, vi è l’atteggiamento verso la scienza e, in
particolare, i suoi rapporti con la democrazia.
La tradizionale fiducia verso la scienza, sorretta da un diffuso atteggiamento positivistico e da un più generale apprezzamento del ruolo degli intellettuali, è stata sostituita in larga parte dell’opinione pubblica da un atteggiamento critico che contrappone alla scienza, spesso qualificata dispregiativamente con aggettivi come “ufficiale” o “occidentale”, visioni alternative di diversa origine, spesso esotica.
Solo in Italia, riferiscono alcune stime, negli ultimi anni gli operatori dell’occulto – maghi, guaritori, cartomanti, medium, astrologi – sarebbero quasi il doppio degli psicologi iscritti all’albo. Allo stesso tempo i confini del tradizionale sistema delle professioni liberali si sfrangiano grazie allo sdoganamento di sempre nuove competenze “alternative”: consulenti filosofici, kinesiologi, grafologi, armonizzatori familiari, etc. e un continuum di medici alternativi di vario tipo che occupano lo spazio tra medici e maghi guaritori.
È un fenomeno preoccupante, da molti punti di vista. Ma è altresì un fenomeno complesso, che ha molte facce, un fenomeno che a uno sguardo critico e non alimentato da ansia corporativa appare come un aspetto di una più generale crisi di civiltà. La crescente diffusione dell’analfabetismo scientifico, dovuta a una crisi generale della scuola e, più in particolare, al degrado della didattica scientifica – temi sui quali avremo più occasioni di tornare in questo sito – ne costituisce certamente un aspetto importante. La generale sfiducia negli esperti e nel ruolo degli intellettuali è alimentata anche da una campagna ideologica contro i “professoroni”, concomitante alla diffusione di strumenti, come i social network, che danno l’illusione di “democratizzare” il dibattito su qualsiasi argomento, offrendo a chiunque la possibilità di rivolgersi a una platea virtualmente immensa e nei fatti tanto più ampia quanto più banali sono le tesi esposte.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Signora mia, i golpe non sono più quelli di una volta
Signora mia, i golpe non sono più quelli di una volta
Venezuela, Iran, ecc...
di Fulvio Grimaldi
 “La nostra società è governata
da dementi per obiettivi demenziali. Credo che siamo
governati da maniaci per scopi maniacali e penso che
rischio di essere rinchiuso come pazzo per
aver detto questo” (John Lennon)
“La nostra società è governata
da dementi per obiettivi demenziali. Credo che siamo
governati da maniaci per scopi maniacali e penso che
rischio di essere rinchiuso come pazzo per
aver detto questo” (John Lennon)
La notte dei morti viventi neocon
A Piazza Santi Apostoli in Roma, il 23 febbraio, ci siamo trovati in un centinaio a manifestare per il Venezuela bolivariano e contro l’ennesima aggressione Usa tramite golpe, terrorismo e fantocci. PRC, PaP, Militant. NoNato, cani sciolti… Cento meschinelli che avevano, però, più buone e giuste ragioni dei 200mila di Milano in marcia appresso a Ong, Boldrini, Zingaretti e Bersani, impegnati a coprire, sotto il lenzuolo iride della pace e dell’antirazzismi, i più efferati crimini di sanzioni, di guerra e contro l’umanità, cioè di vero razzismo ricco, bianco, cristiano, dalla Siria al Venezuela, dallo Yemen all’Afghanistan, alla Somalia, alla Corea del Nord, all’Iran, a mezza latinoamerica, a tutta l’Africa.
In compenso constatiamo con soddisfazione un dato che ai 200mila di Milano e loro guide spirituali non ha fatto per nulla piacere: il colpo di Stato lanciato dagli Usa contro il legittimo e democratico governo bolivariano di Nicola Maduro, utilizzando un teppista da guarimbas, ai primi di marzo, oltre un mese dopo risulta fallito. Il fantoccio che pare la controfigura di un modello di Dolce e Gabbana, percorre invano le Americhe, cercando conforto da altri compari nel lupanare del neoliberismo colonialista. Invano, perché nessuno vuole corroborare una mannaia che, domani, la banda neocon che fa ballare Trump, potrebbe far calare su lui stesso.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3400
Hits 2572
Hits 2503
Hits 2349
Hits 2201
Hits 2077
Hits 1998
Hits 1919
Hits 1909
Hits 1792
tonino

Domenico Moro: Il capitale globalizzato e la ripresa dello stato
Il capitale globalizzato e la ripresa dello stato
di Domenico Moro
 Tra gli aspetti della riflessione
di Marx ed Engels che trovano conferma oggi, a distanza di 150
anni dalla
pubblicazione del Capitale, ci sono la tendenza del
capitalismo alla crisi, sempre più grave, e le conseguenze
contraddittorie che porta.
Queste sono rappresentate dalla internazionalizzazione delle
imprese, dall’aumento della concorrenza tra capitali e
dall’accrescimento
delle dimensioni delle imprese, soprattutto mediante la
centralizzazione proprietaria[1]. Ma c’è un
altro aspetto della riflessione dei fondatori del materialismo
storico che è confermato: la natura di classe dello Stato, che
oggi trova una
espressione significativa anche nei processi di
centralizzazione sovrannazionali.
Tra gli aspetti della riflessione
di Marx ed Engels che trovano conferma oggi, a distanza di 150
anni dalla
pubblicazione del Capitale, ci sono la tendenza del
capitalismo alla crisi, sempre più grave, e le conseguenze
contraddittorie che porta.
Queste sono rappresentate dalla internazionalizzazione delle
imprese, dall’aumento della concorrenza tra capitali e
dall’accrescimento
delle dimensioni delle imprese, soprattutto mediante la
centralizzazione proprietaria[1]. Ma c’è un
altro aspetto della riflessione dei fondatori del materialismo
storico che è confermato: la natura di classe dello Stato, che
oggi trova una
espressione significativa anche nei processi di
centralizzazione sovrannazionali.
Dopo oltre tre decenni di liberismo di mercato e privatizzazioni stiamo assistendo al ritorno dello Stato-nazione nell’economia. In realtà, non si tratta di un ritorno alla mano pubblica, ma dello schierarsi dello Stato-nazione a sostegno del proprio capitale. Quella che viene messa in discussione non è la libertà di movimento del proprio capitale, ma la libertà di quello altrui. Questo fenomeno si manifesta soprattutto nei Paesi di più antico capitalismo, l’Europa occidentale, gli Usa e il Giappone, già alfieri della deregolamentazione e del libero mercato, ma ora costretti a cambiare rotta sotto un attacco che proviene da due fronti. Da una parte, c’è la crisi, che non vuole passare e che si è manifestata più acutamente nelle aree capitalisticamente più sviluppate, coerentemente con la teoria marxista della tendenza alla sovraccumulazione di capitale[2]. Dall’altra parte, ci sono i Paesi cosiddetti emergenti la cui quota sulle esportazioni mondiali è cresciuta enormemente: i Brics sono passati dal 7,4% del 2000 al 18,2% del 2017[3]. La minaccia è avvertita soprattutto nei confronti della Cina, in particolare nella tecnologia 5G e nell’intelligenza artificiale (IA), che hanno una enorme rilevanza industriale-commerciale e strategico-militare.
Leggi tutto
Gabriele Rèpaci: Il comunismo come “potenzialità ontologica”
Il comunismo come “potenzialità ontologica”
Breve saggio sul marxismo critico di Costanzo Preve
di Gabriele Rèpaci
 «Il recupero della filosofia significa recupero
dello spirito filosofico. Il sistema capitalistico è
talmente violento, anche se si
presenta apparentemente come tollerante e liberale, che la
gente cerca istintivamente il contrario. Lo spirito
filosofico risponde a questa esigenza
quasi sempre inespressa di conversazione e di
comunicazione, che poi è anche il solo possibile antidoto
alla perversa dialettica fra
rassegnazione apparente e scoppio improvviso di rabbia
repressa, che tutti gli osservatori possono riscontrare
nei posti di lavoro, nelle discoteche e
negli stadi»
«Il recupero della filosofia significa recupero
dello spirito filosofico. Il sistema capitalistico è
talmente violento, anche se si
presenta apparentemente come tollerante e liberale, che la
gente cerca istintivamente il contrario. Lo spirito
filosofico risponde a questa esigenza
quasi sempre inespressa di conversazione e di
comunicazione, che poi è anche il solo possibile antidoto
alla perversa dialettica fra
rassegnazione apparente e scoppio improvviso di rabbia
repressa, che tutti gli osservatori possono riscontrare
nei posti di lavoro, nelle discoteche e
negli stadi»
(Costanzo Preve)
Costanzo Preve è un autore divenuto noto ai più, soprattutto dopo la sua prematura scomparsa avvenuta all’età di settant’anni, per essere stato il maestro e l’ispiratore del filosofo Diego Fusaro nonché uno dei presunti ideologi di quella galassia politica nota oggi con il nome di “rossobrunismo”. Ma come osservava saggiamente Hegel a suo tempo «ciò che è noto, non è conosciuto. Nel processo della conoscenza, il modo più comune di ingannare sé e gli altri è di presupporre qualcosa come noto e di accettarlo come tale». Questo breve saggio senza alcuna pretesa di sistematicità vuole fare luce sul contributo di Preve alla teoria marxista novecentesca evidenziandone l’elemento di discontinuità in vista di una rifondazione filosofica e politica della prospettiva comunista¹.
La riflessione di Costanzo Preve va distinta in almeno due periodi. Negli anni ’80, in una congiuntura teorica caratterizzata dalla liquidazione differenzialista e positivista della dialettica, i cui esiti sono l’enfasi sulla pluralità disseminata dei saperi e la lettura della modernità in chiave di secolarizzazione, Preve fa riferimento ai punti alti del marxismo novecentesco per mostrare l’esistenza di alternative alle grandi narrazioni dello storicismo e dell’operaismo e per prendere le distanze da un lessico filosofico che civetta con la weberiana gabbia d’acciaio, con l’heideggeriano destino della tecnica, con il prospettivismo nietzscheano, con la complessità sistemica, per alludere all’intrascendibilità dell’universo capitalistico.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Il Marx di Bontempelli
![]()
Il Marx di Bontempelli
di Salvatore Bravo
 Massimo Bontempelli (Pisa, 26 gennaio 1946 –
Pisa, 31 luglio 2011)
interprete di Marx, a Marx ci si approssima, affermava
Costanzo Preve, per cui ogni illusione di rispecchiamento
perfetto, non è che
esemplificazione di un autore. Massimo Bontempelli si
approccia non solo con rigore metodologico, ma specialmente da
hegeliano di formazione si
accosta a Marx con metodo olistico attraverso la lettura dei
testi ne coglie il fondamento, l’umanesimo marxiano ed il
problema della
reificazione, e specialmente dimostra che non vi può essere
nulla di più ingenuo che porre in antitesi Marx ed Hegel, anzi
Marx sviluppa
e porta a compimento intuizioni, concetti e metodi presenti
nel pensiero hegeliano. L’attività filosofica è ripensare, per
ricreare in nuovi orditi teoretici concetti già dati. Il breve
saggio di Bontempelli si conclude con l’orazione funebre di
Engels
all’amico, non è un caso che Bontempelli abbia voluto così
chiudere l’introduzione a Marx, Engels parla omaggia
l’amico che ha smesso di pensare, ovvero per Marx vivere è
pensare, non è concepibile la lotta senza prassi che si
coniuga con la
teoretica. Il pensare marxiano è polisemico, speculare alla
creatività stilistica del suo filosofare. Pensare per Marx non
è il
freddo calcolare logico, ma è il pensare partecipante, è
attività, prassi, trasformazione dei comportamenti sociali,
poiché ogni soggetto umano è comunitario per sua essenza. Il
pensiero è sempre intenzionalità attraverso la quale sono
messi in atto i processi di riconoscimento, autoriconoscimento
e critica sociale. Così Engels nella sua orazione funebre
(1883)1 :
Massimo Bontempelli (Pisa, 26 gennaio 1946 –
Pisa, 31 luglio 2011)
interprete di Marx, a Marx ci si approssima, affermava
Costanzo Preve, per cui ogni illusione di rispecchiamento
perfetto, non è che
esemplificazione di un autore. Massimo Bontempelli si
approccia non solo con rigore metodologico, ma specialmente da
hegeliano di formazione si
accosta a Marx con metodo olistico attraverso la lettura dei
testi ne coglie il fondamento, l’umanesimo marxiano ed il
problema della
reificazione, e specialmente dimostra che non vi può essere
nulla di più ingenuo che porre in antitesi Marx ed Hegel, anzi
Marx sviluppa
e porta a compimento intuizioni, concetti e metodi presenti
nel pensiero hegeliano. L’attività filosofica è ripensare, per
ricreare in nuovi orditi teoretici concetti già dati. Il breve
saggio di Bontempelli si conclude con l’orazione funebre di
Engels
all’amico, non è un caso che Bontempelli abbia voluto così
chiudere l’introduzione a Marx, Engels parla omaggia
l’amico che ha smesso di pensare, ovvero per Marx vivere è
pensare, non è concepibile la lotta senza prassi che si
coniuga con la
teoretica. Il pensare marxiano è polisemico, speculare alla
creatività stilistica del suo filosofare. Pensare per Marx non
è il
freddo calcolare logico, ma è il pensare partecipante, è
attività, prassi, trasformazione dei comportamenti sociali,
poiché ogni soggetto umano è comunitario per sua essenza. Il
pensiero è sempre intenzionalità attraverso la quale sono
messi in atto i processi di riconoscimento, autoriconoscimento
e critica sociale. Così Engels nella sua orazione funebre
(1883)1 :
"Il 14 marzo, alle due e quarantacinque pomeridiane, ha cessato di pensare la più grande mente dell'epoca nostra. L'avevamo lasciato solo da appena due minuti, e al nostro ritorno l'abbiamo trovato tranquillamente addormentato nella sua poltrona, ma addormentato per sempre”.
L’economia politica
L’economia politica marxiana nella sua impostazione è hegeliana, vi sono due metodi di indagine: uno parte dal dato concreto ed astrae le strutture: gli economisti inglesi iniziano la loro indagine dalla proprietà avulsa dai processi storici, per cui la proprietà e le differenze sociali sono rese ipostasi, dogmi indiscutibili, si costruisce in tal modo l’ideologia economica che rispecchia la condizione storica eternizzandola.
Leggi tutto
Mauro Gemma: Accordo Italia-Cina: un'occasione storica per la difesa degli interessi del nostro popolo
Accordo Italia-Cina: un'occasione storica per la difesa degli interessi del nostro popolo
di Mauro Gemma
Con la firma dell'accordo con la Cina in merito al progetto sulla Via della Seta, l'Italia per la prima volta nella storia del dopoguerra avrebbe la possibilità di affermare in modo sostanzioso la propria autonomia dalle scelte imposte dall'imperialismo statunitense ed europeo. Sarebbe il primo paese del G7 a farlo e la sovranità del nostro popolo ne uscirebbe rafforzata, con l'adesione a un programma che avrebbe immense ricadute economiche e occupazionali benefiche, senza che la Cina, come ha affermato lo stesso Conte, ci chieda alcuna forma di sudditanza politico-militare.
Occorre anche aver presente che il progetto di accordo fu avviato dal governo Gentiloni e che se ne parlò nel corso di una visita del Presidente della Repubblica a Pechino. C'è da augurarsi che il PD non se ne sia dimenticato in corso d'opera e che da domani non lo si veda schierato in appoggio alle recriminazioni statunitensi e UE.
Non è un caso che contro la firma, in occasione della visita di Xi Jinping sia stata avviata una forsennata campagna mediatica, ispirata dall'esterno, per fermare il progetto.
Ci troviamo di fronte a una gigantesca operazione propagandistica al servizio degli interessi imperialisti – che certamente si intensificherà di qui all'arrivo del presidente cinese – che dovrebbe seriamente preoccupare tutti i comunisti, i sinceri antimperialisti, gli amanti della pace e la vera sinistra che ha a cuore l'indipendenza e la sovranità del nostro paese.
Leggi tutto
Federico Dezzani: Via della Seta, un nuovo South Stream
Via della Seta, un nuovo South Stream
di Federico Dezzani
L’annuncio della firma di un memorandum italo-cinese lo sviluppo della Nuova Via della Seta ha innescato una tempesta: gli USA, anche tramite il canale indiretto di Bruxelles, hanno espresso la loro contrarietà all’iniziativa, scompaginando il quadro politico e alzando un immediato coro di allarmi. La geografia della penisola italiana, collocata nel cuore del Mediterraneo e allo stesso tempo connessa col Continente, ci rende la naturale destinazione di qualsiasi infrastruttura Est-Ovest: le stesse ragioni che hanno affossato il South Stream potrebbero però condannare anche la Via della Seta. Solo la Germania dimostra di essere sufficientemente forte da sviluppare i progetti euroasiatici
Opportunità e realtà
Correva il maggio 2017 quando, unico premier tra i Paesi del G7, Paolo Gentiloni partecipava al Forum sulla Nuova Via della Seta nei pressi del suggestivo lago Yanqi, a Nord di Pechino. Il viaggio di Gentiloni era giustificato dalla prospettive dischiuse dall’ambizioso piano infrastrutturale cinese, che, nella sua variante marittima, unirà Sud-Est Asiatico, Corno d’Africa e Europa: “L’Italia può essere protagonista in questa grande operazione a cui la Cina tiene molto: per noi è una grande occasione e la mia presenza qui significa quanto la riteniamo importante1”. A distanza di quasi due anni, il percorso avviato da Gentiloni dovrebbe fare un ulteriore passo in avanti con la firma di un memorandum d’intesa, durante la prossima visita in Italia del presidente cinese Xi Jinping: si tratta di uno storico viaggio che, secondo quanto trapelato, toccherebbero anche la Sicilia, cuore nevralgico del Mediterraneo.
Leggi tutto
Sandro Mezzadra: La non continuità del dominio
La non continuità del dominio
di Sandro Mezzadra
A partire da «Il potere temporaneo» di Maurizio Ricciardi per Meltemi. Lo sguardo marxiano non si appunta più sulla sua fondazione e legittimazione. Ne segue piuttosto la «costanza dell’esercizio»
Il potere temporaneo si intitola il libro di Maurizio Ricciardi su «Karl Marx e la politica come critica della società» (Meltemi, pp. 230, euro 18). Tema onnipresente nella sconfinata opera di Marx, il potere è stato in effetti raramente fatto oggetto di un’analisi sistematica nella altrettanto sconfinata letteratura a lui dedicata.
Una delle interpreti più brillanti e raffinate che si sono soffermate sulla questione negli ultimi anni, Wendy Brown, ha preso le mosse (in La politica fuori dalla storia, a cura di Paola Rudan, Laterza) dalla focalizzazione di Marx sulla logica del potere, ponendo criticamente in rilievo lo scacco del suo tentativo di coglierla in modo «trasparente» e «oggettivo». Non è questa la via seguita da Ricciardi: la questione del potere gli offre piuttosto un filo conduttore attraverso cui seguire l’intero sviluppo dell’opera marxiana a partire dallo scarto che la scoperta del rapporto di capitale e dell’antagonismo che lo costituisce determina nei confronti della riflessione politica precedente.
Radicalmente distante da ogni pensiero che (anche solo analiticamente) riconosca il primato dell’ordine, l’autore del Capitale non si pone in alcun modo l’obiettivo di formulare una «teoria generale del potere»: in questione per lui è l’emergenza storica, in precise condizioni sistemiche, di rapporti di potere che si distendono nello spazio e lavorano su diversi ordini temporali, incidendo corpi e costituendo soggettività.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: L’eterno ritorno della sindrome del Faust
L’eterno ritorno della sindrome del Faust
di Giuseppe Masala
Davvero sbalorditiva l’intervista di H. W. Sinn – uno dei decani degli economisti tedeschi – rilasciata l’altro giorno al quotidiano economico Handelsblatt. L’oggetto dell’intervista era il noto studio de CEP di Friburgo che sostiene che i due paesi che hanno subito le più grandi perdite dall’introduzione dell’Euro sono l’Italia e la Francia mentre i paesi che hanno tratto maggiori benefici sono la Germania e l’Olanda.
La tesi sostenuta dall’insigne economista tedesco non nega quanto lo studio ha sostenuto, evidentemente ritenendole corrette e non soggette a possibili contestazioni. Però sostiene bizzarramente che nonostante tutto questo la Germania non ne ha tratto beneficio reale. Ripropongo le sue parole che mi paiono alquanto emblematiche (anche di una certa forma mentis – absit iniuria verbis – teutonica):
“Il problema è che le esportazioni, nel calcolo del PIL, sono considerate come un indice di prosperità, anche se in realtà lo diventano solo nel momento in cui sarà certo che immediatamente o successivamente potranno essere convertite in importazioni per una somma di pari valore. In effetti le eccedenze commerciali tedesche non sono sempre state investite in maniera ragionevole, e spesso sono state utilizzate per acquistare titoli di debito esteri alquanto problematici. Una parte di questi titoli consisteva in obbligazioni di dubbia utilità, in gran parte di provenienza americana, il cui mancato rimborso ha contribuito al fatto che la Germania abbia dovuto cancellare centinaia di miliardi di euro di crediti esteri dal suo bilancio delle attività nette sull’estero.”
Leggi tutto
Ventidue tesi sul “momento populista”
di Carlo Formenti
Nel suo ultimo libro, Il socialismo è morto, viva il socialismo! Dalla disfatta della sinistra al momento populista, Carlo Formenti analizza le caratteristiche dell'odierno “momento populista”, difendendo l'ipotesi di un nuovo sovranismo di sinistra
 1.
Il populismo non è un’ideologia: in primo luogo perché non
esistono testi “fondativi” (paragonabili a quelli di Marx per
la sinistra) in grado di attribuire forma coerente e unitaria
al discorso
populista, poi perché quest’ultimo non è associato a contenuti
programmatici univoci. Di più: il fenomeno ha assunto nel
tempo forme diversissime, dai populismi russo e americano di
fine Ottocento-primo Novecento (entrambi caratterizzati da
radici di classe contadine, ma
diversi sul piano ideologico) ai populismi latinoamericani di
ieri (Peron, Vargas e altri) e oggi (le rivoluzioni
bolivariane in Bolivia, Ecuador e
Venezuela) con prevalenti connotati nazionalisti i primi,
orientati al socialismo i secondi, per finire con i populismi
contemporanei di destra e
sinistra negli Stati Uniti (Trump vs Sanders) e in
Europa (Le Pen vs Mélenchon in Francia, Podemos vs
Ciudadanos in
Spagna). Esistono tuttavia elementi comuni, a partire dallo
stile comunicativo[1]. Mi riferisco, in particolare, all’uso
di un linguaggio
semplificato e diretto, marcato da un elevato contenuto
emotivo (ciò che si dice parlare alla “pancia” delle persone)
e teso a
istituire opposizioni bipolari (noi/loro, popolo/élite,
alto/basso ecc.). Per i populisti è inoltre fondamentale
raccontarsi come una
forza politica del tutto nuova, evitando di ricorrere a
parole, idee e categorie proprie dei partiti tradizionali (di
destra come di sinistra) e
tentando invece di promuovere nuovi significanti in grado di
creare un inedito senso comune (di qui il frequente
riferimento alla categoria gramsciana
di egemonia da parte di intellettuali e leader populisti di
sinistra).
1.
Il populismo non è un’ideologia: in primo luogo perché non
esistono testi “fondativi” (paragonabili a quelli di Marx per
la sinistra) in grado di attribuire forma coerente e unitaria
al discorso
populista, poi perché quest’ultimo non è associato a contenuti
programmatici univoci. Di più: il fenomeno ha assunto nel
tempo forme diversissime, dai populismi russo e americano di
fine Ottocento-primo Novecento (entrambi caratterizzati da
radici di classe contadine, ma
diversi sul piano ideologico) ai populismi latinoamericani di
ieri (Peron, Vargas e altri) e oggi (le rivoluzioni
bolivariane in Bolivia, Ecuador e
Venezuela) con prevalenti connotati nazionalisti i primi,
orientati al socialismo i secondi, per finire con i populismi
contemporanei di destra e
sinistra negli Stati Uniti (Trump vs Sanders) e in
Europa (Le Pen vs Mélenchon in Francia, Podemos vs
Ciudadanos in
Spagna). Esistono tuttavia elementi comuni, a partire dallo
stile comunicativo[1]. Mi riferisco, in particolare, all’uso
di un linguaggio
semplificato e diretto, marcato da un elevato contenuto
emotivo (ciò che si dice parlare alla “pancia” delle persone)
e teso a
istituire opposizioni bipolari (noi/loro, popolo/élite,
alto/basso ecc.). Per i populisti è inoltre fondamentale
raccontarsi come una
forza politica del tutto nuova, evitando di ricorrere a
parole, idee e categorie proprie dei partiti tradizionali (di
destra come di sinistra) e
tentando invece di promuovere nuovi significanti in grado di
creare un inedito senso comune (di qui il frequente
riferimento alla categoria gramsciana
di egemonia da parte di intellettuali e leader populisti di
sinistra).
2. Il popolo che i populisti aspirano a rappresentare non è un’entità “naturale”, preesistente all’insorgenza del loro discorso politico (a differenza del popolo evocato dal nazifascismo, che rinvia a radici comuni di tipo etnico, razziale, antropologico, storico-culturale ecc.).
Leggi tutto
Nicola Casale: Gilets jaunes, lotta di classe, neo-populismo, sovranismo
![]()
Gilets jaunes, lotta di classe, neo-populismo, sovranismo
di Nicola Casale
 L’avvento e la resistenza del
movimento dei gilets jaunes mette a dura prova la
politica di riforme che
Macron è incaricato di promuovere per trarre fuori la Francia
dal rischio di declino della sua potenza capitalistica e per
contribuire a
tirarne fuori l’intera UE. Questo genera preoccupazioni nelle
élite europeiste, mentre produce soddisfazione negli Usa,
dove, con
perfetta continuità Obama-Trump, l’Europa la si vuole unita a
condizione che sia sottomessa, e si è, in caso contrario,
pronti a
far di tutto per farla esplodere, essendo più semplice
sottomettersene i singoli paesi (se necessario anche
frammentandone qualcuno: Belgio,
Spagna, Italia...). Su assi analoghe si dividono le borghesie
nazionali, le quali, non di meno, devono misurarsi col rischio
di effetto-contagio del
movimento oltre i confini francesi.
L’avvento e la resistenza del
movimento dei gilets jaunes mette a dura prova la
politica di riforme che
Macron è incaricato di promuovere per trarre fuori la Francia
dal rischio di declino della sua potenza capitalistica e per
contribuire a
tirarne fuori l’intera UE. Questo genera preoccupazioni nelle
élite europeiste, mentre produce soddisfazione negli Usa,
dove, con
perfetta continuità Obama-Trump, l’Europa la si vuole unita a
condizione che sia sottomessa, e si è, in caso contrario,
pronti a
far di tutto per farla esplodere, essendo più semplice
sottomettersene i singoli paesi (se necessario anche
frammentandone qualcuno: Belgio,
Spagna, Italia...). Su assi analoghe si dividono le borghesie
nazionali, le quali, non di meno, devono misurarsi col rischio
di effetto-contagio del
movimento oltre i confini francesi.
Negli ultimi decenni la Francia ha già avuto forti movimenti di resistenza, ma quello in corso non ne è la semplice ripetizione. Ci sono molte differenze e sono quelle che generano più preoccupazione tra le elites.
I movimenti precedenti erano stati promossi e gestiti nell’ambito della sinistra. Il movimento dei gilets jaunes non la riconosce come guida e neanche come tutor (e perciò viene sbrigativamente etichettato di destra). Perché? Le sue rivendicazioni potrebbero figurare in programmi di sinistra, come Melenchon e Cgt si sono offerti di fare. Non hanno, infatti, alcun carattere esplicito o implicito anti-sistema, anti-capitalistico, si limitano a chiedere delle riforme nel senso classico del termine, tese a migliorare le condizioni di chi vive del proprio lavoro, di chi non ha un lavoro, o vive con misere pensioni o sussistenze, e che ci sia più eguaglianza nell’imposizione fiscale eliminando le riduzioni di Macron alle imposte su patrimoni e aziende. Nulla di diverso dalle rivendicazioni del movimento operaio novecentesco, se non che sono persino più moderate di quelle del decennio a cavallo anni 60-70.
Leggi tutto
Robert Kurz: La storia della terza rivoluzione industriale
La storia della terza rivoluzione industriale
1. Visioni dell’automazione
di Robert Kurz
 Iniziamo qui la
pubblicazione della sezione VIII di uno dei libri più famosi
di Robert Kurz, lo
Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”).
Questa sezione tratta della storia della cosiddetta terza
rivoluzione
industriale, l’epoca in cui il capitalismo si fa informatico
e cibernetico. In questo momento storico, che è quello che
stiamo vivendo,
la forza lavoro umana perde il suo ruolo centrale diventando
di fatto comprimaria di una svolta epocale in cui il
capitale raggiunge i suoi limiti e
pone il mondo e tutti noi di fronte ad una decisione molto
difficile ma non rimandabile: prendere sul serio la
possibilità (forse dovremmo dire
la necessità) del suo superamento. L’alternativa è che ad
essere superati si sia noi come esseri umani, e con noi il
mondo.
Iniziamo qui la
pubblicazione della sezione VIII di uno dei libri più famosi
di Robert Kurz, lo
Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”).
Questa sezione tratta della storia della cosiddetta terza
rivoluzione
industriale, l’epoca in cui il capitalismo si fa informatico
e cibernetico. In questo momento storico, che è quello che
stiamo vivendo,
la forza lavoro umana perde il suo ruolo centrale diventando
di fatto comprimaria di una svolta epocale in cui il
capitale raggiunge i suoi limiti e
pone il mondo e tutti noi di fronte ad una decisione molto
difficile ma non rimandabile: prendere sul serio la
possibilità (forse dovremmo dire
la necessità) del suo superamento. L’alternativa è che ad
essere superati si sia noi come esseri umani, e con noi il
mondo.
Partiamo con il primo capitolo, “Visioni dell’automazione”. A breve seguiranno gli altri otto. Tutto questo dovrebbe preludere alla pubblicazione cartacea dell’intero libro, che auspichiamo avvenga nel minor tempo possibile [redazione].
* * * *
Ormai giunto all’ultimo terzo del XX secolo il capitalismo aveva già dimostrato a sufficienza di quale maestria fosse in grado nell’arte di addestrare gli uomini, fino a che punto esso fosse riuscito nell’impresa di trasformare la maschera delle sue forme feticistiche nel volto del mondo materiale e persino di gran parte del mondo naturale, nonché a spingere verso la negazione di sé grandi masse umane. Ma neppure questa straordinaria prestazione poté mai ammutolire del tutto il disagio elementare, che è fondamentalmente insito nell’autocontraddizione logica di questo modo di produzione e di vita. La fede nel progresso si era già esaurita nel XIX secolo (anche se da allora il suo fantasma viene regolarmente invocato dagli ottimisti di professione e dagli imbonitori del capitalismo per sdrammatizzare la crisi) e il soggetto borghese-illuministico aveva tolto il disturbo, al più tardi con la Prima guerra mondiale, per lasciare il posto ai rituali sado-masochistici del sacrificio di sé in un processo sociale considerato impossibile da governare e tuttavia gli uomini del dopoguerra fordista, degradati a mera materia prima, potevano ancora anestetizzarsi mediante la scialba ebbrezza del consumo.
Leggi tutto
Gennaro Carotenuto: Venezuela: dagli aiuti umanitari USA al cyberattacco-blackout, è già guerra di nuova generazione e antica ipocrisia
Venezuela: dagli aiuti umanitari USA al cyberattacco-blackout, è già guerra di nuova generazione e antica ipocrisia
di Gennaro Carotenuto
Le denunce del New York Times e di Forbes sui casi degli aiuti umanitari bruciati e sul blackout, che analizzo qui, attestano che in Venezuela la guerra sia già cominciata e le false notizie dominino incontrastate la costruzione dell’opinione pubblica.
Le guerre di nuova generazione fanno morti come e più di quelle che si combatterono con la clava, la balestra o il fucile Chassepot. Rispetto alla gravità del blackout in Venezuela ai media italiani è piaciuto a scatola chiusa sposare la tesi dell’inettitudine chavista. I chavisti sono per definizione tutti incapaci, sanguinari e corrotti. Sta diventando un tratto tipico della cultura politica italiana quella di non rispettare l’avversario, pensando che irridere e delegittimare corrisponda a cancellare. Tale attitudine impedisce di conoscere e capire, e tradisce la ragion stessa di essere dei media. Al contrario vari media statunitensi hanno preso molto sul serio e considerano credibile che il blackout in Venezuela sia stato causato da un cyberattacco informatico USA. Se così fosse sarebbe affare serio, perché saremmo con ogni evidenza di fronte a un atto di guerra di quelle della cosiddetta quarta generazione.
Leggi tutto
Militant: La voce del padrone
La voce del padrone
di Militant
A forza di concentrare tutta la critica politica su Renzi e il presunto “renzismo”, in perfetta continuità con Berlusconi e il “berlusconismo”, Craxi e il “craxismo” e via scivolando, eccoci servita la riesumazione del centrosinistra. Messa in naftalina la parentesi democristiana, la voce del padrone torna a farsi rappresentare dalla più gestibile genia socialdemocratica. Zingaretti dunque, attorno a cui ricostruire le ragioni elettorali del nuovo fronte antipopulista. Fa specie, come sempre, la reazione della “sinistra”. Sembrava, il Pd, messo definitivamente al suo posto: il partito del grande capitale, soggetto neocentrista attorno al quale coagulare la classe dirigente dello Stato, veniva indicato come avversario naturale delle ragioni delle lotte di classe. E invece, scopriamo con la solita ingenuità, era solo Renzi il problema. Estromesso il giglio magico, riecco le alleanze territoriali, i cantieri politici, i fronti unitari. Ecco di nuovo le speranze future e gli appelli alla convergenza. Ingenui, ripetiamo, e come diciamo spesso l’ingenuità in politica è una delle colpe più gravi. Ancora una volta ci siamo cascati. Davamo per scontata la naturale avversità al Pd esattamente come naturale appare l’avversità a Forza Italia, alla Lega o a chissà quale altro soggetto politico della piccola e grande borghesia. Illusi.
Leggi tutto
Dante Barontini: Via della Seta, gli interessi al posto delle chiacchiere
Via della Seta, gli interessi al posto delle chiacchiere
di Dante Barontini
I media italiani – e la “stampa democratica” in particolare – soffrono da decenni di un particolare disturbo bipolare: quello che porta a a semplificare ogni notizia in termini di bene/male o di puro schieramento. Con effetti paradossali che dovrebbero essere evidenti, ma che tutti fanno finta di non notare. Per esempio, Trump è un “mostro” quando si parla di diritti civili negli Usa, ma resta sempre “la nostra guida” quando si parla di geopolitica e relazioni internazionali. Amici o nemici, analisi zero, credibilità idem.
Il disturbo bipolare diventa evidente quando bisogna affrontare il progetto di Via della Seta e dunque i rapporti con la Cina. Qui vengono allo scoperto gli interessi economici reali (la Cina porta investimenti che la borghesia italiana non ha mai voluto fare mai o che lo Stato non può più fare, “grazie” ai trattati europei che impongono tagli di spesa) e le paure alimentate dagli interessi geopolitici di Washington o Berlino.
Leggiamo per esempio questo titolo dell’edizione italiana dell’Huffington Post: “L’ombra della Cina sui porti di Genova e Trieste”. Una copia conforme delle cazzate leghiste sull’”invasione dall’Africa”. Va bene, è una testata statunitense, ma in Italia fa coppia col gruppo Repubblica-L’Espresso. E quindi avvelena anche la testa di molta gente che si ritiene “di sinistra”…
Leggi tutto
Giorgio Mascitelli: Tempi bui per la storia
Tempi bui per la storia
di Giorgio Mascitelli
Tra i frutti che la sua luminosa vita ci offre il deciso impegno di Liliana Segre per evitare il ridimensionamento dello studio della storia nella scuola non mi sembra certo il meno importante. Non deve ingannare l’apparente minuzia dell’oggetto del suo intervento, ossia l’eliminazione del tema storico dalle prove per l’esame di maturità, perché Segre ha colto perfettamente che esso non è che la spia di un progressivo ridimensionamento dell’insegnamento della storia nell’ambito di una riduzione di tutte le materie ‘inutili’ alla formazione del perfetto lavoratore e del perfetto consumatore.
Sarebbe bello poter affermare che questo provvedimento è opera esclusiva del ministro dell’istruzione Bussetti e dell’attuale governo, ma la verità è che questo disegno viene da lontano ed è connesso all’idea di una scuola retta dalla pseudo razionalità economica promossa dall’Unione europea, dall’OCSE e dalle politiche bipartisan di tutti i governi precedenti, in particolare dalla riforma della Buona scuola. In questa prospettiva la scuola deve fornire solo competenze utili al mercato del lavoro e, in questo contesto, lo studio della storia è fatica sprecata. Coloro che ora denunciano da Bruxelles la diffusione dell’antisemitismo e di altre forme di odio razziale sono spesso quelli che hanno lavorato per creare una scuola totalmente incapace di difendere la memoria storica, magari pensando e perfino affermando esplicitamente che oggi per informarsi su questo genere di cose basta andare su internet.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3436
Hits 2621
Hits 2523
Hits 2390
Hits 2219
Hits 2104
Hits 2011
Hits 1940
Hits 1927
Hits 1800
tonino

Alessandro Barile: Gli strani approdi di Carlo Formenti
Gli strani approdi di Carlo Formenti
di Alessandro Barile
Carlo Formenti, Il socialismo è morto. Viva il socialismo!, Meltemi, Milano, 2018, pp. 276, € 18,00

Almeno da Utopie letali (2013), Formenti porta avanti la sua personale battaglia per l’affermazione di un populismo “di sinistra”. Se però il saggio del 2013, nonché La variante populista (2016) – malgrado il tono lapidario – lasciavano i ragionamenti in sospeso, alimentando un fecondo margine d’apertura verso chi, a sinistra, insisteva nell’ideologia post-operaista variamente (e inconsapevolmente) declinata, da un po’ di tempo questa propensione alla convergenza sembra essere venuta meno. Spostandosi di propensione e di prospettiva, anche le possibilità di dialogo si disperdono. Non rimane che accettare o rifiutare un discorso che si stringe sempre più in proposta politica, che però continua a mancare (nei fatti più che nelle aspirazioni). È un peccato, perché mai come oggi continua ad essere necessario l’incontro di ragioni più che la sua vicendevole eliminazione. Partiamo dalle cose che funzionano.
Quel che la “tradizione comunista” insiste a non cogliere, è che il futuro sembra scivolare verso una riproposizione sbilenca e sgangherata (e forse anche impotente) del 1789 e non del 1917. Prima di tornare alla «autonomia politica del proletariato», per dirla in termini solenni, sembra sempre più evidente che dovremmo reintrodurre margini minimi di democrazia tanto sostanziale quanto formale. Lo sviluppo contraddittorio ma travolgente del liberismo a livello planetario sta sempre più modellando società polarizzate oltre ogni limite di sopportazione. Vista dal basso, questa polarizzazione non si presenta come mero fatto di classe. Ne abbiamo costanti prove nelle vicende della politica di questo decennio. Da Trump alla Brexit, dai gilets jaunes al governo “gialloverde”, le sfide al potere liberale-liberista non provengono da uno specifico settore di classe, ma da una multiforme e frastagliata sommatoria sociale di sconfitti. Questi hanno poco in comune tra di loro, ma quel che li tiene insieme, almeno sul piano della protesta elettorale, è la critica al capitalismo globalizzato e ai suoi referenti politico-culturali.
Leggi tutto
Alessandro Roncaglia: “L’età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo”
“L’età della disgregazione. Storia del pensiero economico contemporaneo”
di Alessandro Roncaglia
Pubblichiamo la presentazione dell’autore tenuta presso l’Accademia Nazionale dei Lincei, marzo 2019
 Il libro che vi presento arriva in libreria
in questi giorni, dopo una lunga
(e faticosa) fase di gestazione. Si intitola L’età
della disgregazione ed è, come dice il sottotitolo,
una Storia del
pensiero economico contemporaneo. Ho già consegnato
la versione inglese alla Cambridge University Press, ed è in
corso la
traduzione spagnola.
Il libro che vi presento arriva in libreria
in questi giorni, dopo una lunga
(e faticosa) fase di gestazione. Si intitola L’età
della disgregazione ed è, come dice il sottotitolo,
una Storia del
pensiero economico contemporaneo. Ho già consegnato
la versione inglese alla Cambridge University Press, ed è in
corso la
traduzione spagnola.
Il titolo allude al fatto che la ricerca in economia è sempre più frammentata, sia per campi sia per orientamenti di ricerca. Chi si occupa di finanza o di econometria raramente conosce i dibattiti di teoria del valore o dell’impresa; inoltre, in ciascun campo coesistono impostazioni radicalmente diverse: keynesiani, neoclassici, istituzionalisti, e così via, fino agli induttivisti sostenitori di una econometria ateoretica.
Questa duplice frammentazione impedisce una esposizione lineare e complica ulteriormente un compito già reso difficile dalla vastità del terreno da coprire: ogni anno escono migliaia di riviste e migliaia di volumi sui diversi temi dell’economia. Accade così che tanti ricercatori, per affrontare in modo davvero approfondito il tema prescelto, passino la vita a studiare l’ultima falange del dito mignolo, come diceva Becattini. Il problema in realtà non è concentrarsi sul dito mignolo, come in qualche momento della nostra attività tutti noi facciamo, ma farlo in totale assenza di consapevolezza del corpo umano al quale è collegato. Quindi, proprio la frammentazione rende indispensabile un tentativo di raccordo. Anche perché in moltissimi casi la disgregazione permette agli economisti attivi nei vari campi specialistici di sorvolare sulle debolezze spesso tragiche delle fondamenta della loro ricerca.
Schumpeter distingueva tre fasi nella ricerca, che spesso si intersecano in un processo non lineare. La prima fase è la concettualizzazione: la costruzione di una rete di concetti che specificano la visione del mondo; ad esempio il mercato inteso come punto nel tempo e nello spazio d’incontro tra domanda e offerta, come nelle fiere medievali o nella borsa valori moderna: questo è in sostanza il concetto utilizzato sia nel Medioevo sia dalla teoria marginalista; oppure il mercato inteso come rete di relazioni tra le diverse attività produttive in un’economia basata sulla divisione del lavoro, che è il concetto utilizzato dalla teoria classica e keynesiana.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Una nuova uni-multiversità complessa?
Una nuova uni-multiversità complessa?
di Pierluigi Fagan
Articolo pubblicato sul sito del Festival della Complessità (qui) che quest’anno giungerà alla sua Xa edizione. Alla versione on line sul sito del festival, qui si aggiungono alcune considerazioni più specifiche (in corsivo)
 Nei due
articoli precedenti sul –– ed il successivo che tornava sulla
annosa ,
abbiamo indagato l’impostazione del nostro sistema delle
conoscenze. Già avevamo introdotto a premessa l’intero
argomento. Pare a
noi evidente che un mondo sempre più complesso quindi
“intrecciato assieme”, chiami una profonda revisione del
nostro sistema delle
conoscenze, sistema che ereditiamo dal moderno, un periodo
alla fine del suo ciclo storico e culturale. A sua volta, il
sistema moderno andava a
rimpiazzare il sistema delle conoscenze medioevali, il
(latino, retorica e filosofia) e (aritmetica, geometria,
astronomia e musica) impostati da
Marziano Capella già nel V secolo. Se ogni epoca si rispecchia
in un sistema di conoscenze, potremmo interrogarci su quali
potrebbero esser le
condizioni necessarie per riformare l’attuale sistema in tempi
di nuova complessità.
Nei due
articoli precedenti sul –– ed il successivo che tornava sulla
annosa ,
abbiamo indagato l’impostazione del nostro sistema delle
conoscenze. Già avevamo introdotto a premessa l’intero
argomento. Pare a
noi evidente che un mondo sempre più complesso quindi
“intrecciato assieme”, chiami una profonda revisione del
nostro sistema delle
conoscenze, sistema che ereditiamo dal moderno, un periodo
alla fine del suo ciclo storico e culturale. A sua volta, il
sistema moderno andava a
rimpiazzare il sistema delle conoscenze medioevali, il
(latino, retorica e filosofia) e (aritmetica, geometria,
astronomia e musica) impostati da
Marziano Capella già nel V secolo. Se ogni epoca si rispecchia
in un sistema di conoscenze, potremmo interrogarci su quali
potrebbero esser le
condizioni necessarie per riformare l’attuale sistema in tempi
di nuova complessità.
La riflessione anglosassone su i sistemi di educazione e formazione va avanti già da tempo. Si sta verificando che il sistema delle iper-specializzazioni votate alla formazione -tra l’altro non di futuri cittadini, ma di futuri professionisti-, ha tre problemi. Il primo è che il mondo del lavoro richiederebbe in realtà un misto di saperi pratico-teorici, quando le scuole sono semmai prodighe dei soli saperi teorici. Il concetto stesso di specializzazione è ambiguo dato l’alto tasso di odierna evoluzione delle forme economiche che sembrano chiamare certe conoscenze per un qualche periodo di tempo, poi altre per il periodo successivo. Il secondo è che, più in generale, la formazione teorico-specialistica sembra produrre tecnici che si trovano a loro agio solo nell’applicazione di procedure e modelli, totalmente smarriti quando si tratta di improvvisare, innovare, inventare. Data la richiesta di un alto tasso di novità crescenti e data l’alta interconnessione che c’è nei sistemi complessi e dato che tutti i principali sistemi della nostra vita associata stanno diventando sistemi molto complessi, si sta venendo a creare una sorta di disadattamento cognitivo per il quale si formano esperti di procedure laddove si incontrano ogni giorno di più terre incognite che di loro natura non sono ancora mappate, né tantomeno hanno procedure indicative sul come affrontarle.
Leggi tutto
Sergio Cararo: Sul referendum contro i Trattati europei non dobbiamo mollare la presa
Sul referendum contro i Trattati europei non dobbiamo mollare la presa
di Sergio Cararo*
E’ vero che molto spesso abbiamo la sensazione che tra la realtà dei fatti e la percezione distorta della realtà prevalga la seconda. Il sociologo Filippo Viola ha dedicato a questo un libro/ricerca straordinario dedicato proprio alla “Società astratta” in cui evidenziava, anche con una inchiesta empirica, come la gente si orientasse, posizionasse o dividesse sui parametri di una società astratta, appunto, invece che su quelli della società reale in cui avvengono concretamente le cose che ne cambiano la condizione e l’esistenza.
Una verifica di questa divaricazione tra percezione e realtà l’abbiamo fatta anche noi. A cavallo tra la fine e l’inizio del secolo, abbiamo realizzato quella che viene definita “inchiesta di classe” tra le lavoratrici e i lavoratori italiani sulla loro soggettività, cioè su come valutassero le loro condizioni materiali e quello che gli stava accadendo intorno (dalla flessibilità alle privatizzazioni all’unificazione europea etc.).
Nei risultati di quella inchiesta condotta con più di 1400 questionari raccolti in decine di luoghi di lavoro e pubblicata da Cestes (“La coscienza di Cipputi”), c’erano anche due domande/risposte che ci aiutano nella discussione che stiamo facendo oggi. Alla domanda su cosa lavoratrici e lavoratori pensassero dell’unificazione europea, la risposta è stata positiva quasi in modo plebiscitario.
Leggi tutto
Bazaar: Il fardello del liberalismo di sinistra
Il fardello del liberalismo di sinistra
di Bazaar
Il 9 marzo scorso si è svolta a Roma la presentazione del Manifesto per la sovranità costituzionale, sottoscritto da Patria e Costituzione, Senso comune e Rinascita! Nonostante alcuni importanti limiti — da noi segnalati — abbiamo salutato positivamente questo tentativo di raggruppare le forze disperse di quella che chiamiamo “sinistra patriottica”
Bazaar era presente all'incontro del 9 marzo a Roma. D'appresso le sue severe considerazioni.
Una breve riflessione sul Manifesto presentato da Patria e Costituzione occorre farla.
Ciò che si ritiene ci sia di più o meno buono in questa esperienza è grosso modo tratteggiato da Ugo Boghetta.
Diciamo che il 9 marzo, dopo l’eccellente introduzione di Carlo Formenti, le contraddizioni che appaiano già nel Manifesto, e che si ritiene debbano essere assolutamente risolte affinché ci si possa effettivamente trovare di fronte agli albori di una nuova forza socialista, sono esplose in tutta la loro irrazionalità con gli interventi di alcuni relatori.
I maggiori punti dolenti sono tre, fondamentali, e rivelativi di una mancata abiura del liberalismo di sinistra: se l’ambizioso obiettivo, che onorerebbe il nome dell’associazione, è la formazione di un partito socialista, allora questi punti negano ab origine l’emancipazione dall’ideologia – liberal e politicamente corretta — che ha fatto del neoliberalismo un totalitarismo in gran parte del globo.
Leggi tutto
Lucio Caracciolo: L’Italia sul ring tra Usa e Cina
L’Italia sul ring tra Usa e Cina
di Lucio Caracciolo
Non è da tutti offrirsi contemporaneamente all’ira della superpotenza – che di fatto è il nostro padrone di casa – e della sua unica sfidante
L’Italia è finita senza accorgersene nel mezzo del ring dove Stati Uniti e Cina si sfidano per il titolo mondiale dei supermassimi. Esposta ai colpi degli uni e degli altri, sopra e sotto la cintura.
Non è da tutti offrirsi contemporaneamente all’ira del campione in carica – nostro nominale alleato, di fatto padrone di casa – e del suo sfidante unico, che vorrebbe servirsi dello Stivale per avvicinarsi al centro del quadrato, occupato dal detentore. Il match minaccia di prolungarsi oltre i tempi regolamentari. Resta da stabilire come sia stato possibile ficcarci in tanto guaio. E, se possibile, come uscirne. Per questo occorre capire che cosa vogliono e possono, nell’ordine, Cina, Stati Uniti e Italia.
La Cina usa il brillante marchio delle nuove vie della seta per costruire una controglobalizzazione a 360 gradi. Pechino si è convinta da un decennio che il sistema geopolitico ed economico centrato sugli Stati Uniti sia in decomposizione. Quindi non intende entrarvi come junior partner ma stabilire le regole del nuovo gioco sinocentrico, cui altri potranno aggregarsi. La Belt and Road Initiative (Bri), nome ufficiale della strategia, consta di almeno tre volani.
Leggi tutto
Autonomia differenziata, le ragioni del NO
Autonomia differenziata, le ragioni del NO
Una misura utile solo ai padroni che non a caso è la nuova “priorità” del governo
Col dibattito sulla autonomia regionale differenziata, i due alleati di governo da un lato si dimostrano fedeli cani da guardia degli interessi del capitale e dall’altro fanno emergere tutte le contraddizioni esistenti nel gioco della politica nel momento in cui, al di là di slogan e consensi elettorali, c’è bisogno di attuare misure antipopolari dettate dalle necessità dell’accumulazione di profitto in crisi.
Su questo giornale ci siamo già occupati in passato di tale tematica (leggi qui,qui,qui equi), essendoci schierati apertamente per il NO all’epoca del referendum consultivo tenutosi in Lombardia e in Veneto, denunciando come l’intero arco politico fosse compattamente schierato per il SI (Lega -promotrice- assieme a tutti i partiti di destra ma anche a PD e 5stelle) e al contempo come la larga parte della “sinistra d’alternativa” si fosse mantenuta su posizioni inerti, optando per una campagna di astensione attiva anziché per il NO e ponendosi, in tal modo, innocuamente e mansuetamente alla coda dei partiti padronali.
Leggi tutto
Alessandro Giannelli: Unità della sinistra e unità antifascista
Unità della sinistra e unità antifascista
di Alessandro Giannelli*
 Il
documento dei compagni della Rete dei Comunisti
dall’emblematico titolo
“Unità della sinistra? Un falso problema” ha l’indubbio merito
di voler affrontare a viso aperto quel vero e proprio
tormentone (appunto l’unità della sinistra) che, soprattutto a
ridosso di scadenze elettorali, si ripropone con sistematica e
stucchevole
puntualità.
Il
documento dei compagni della Rete dei Comunisti
dall’emblematico titolo
“Unità della sinistra? Un falso problema” ha l’indubbio merito
di voler affrontare a viso aperto quel vero e proprio
tormentone (appunto l’unità della sinistra) che, soprattutto a
ridosso di scadenze elettorali, si ripropone con sistematica e
stucchevole
puntualità.
Liberarsi da questa ossessione, appunto da questo falso problema, è la precondizione per non procrastinare oltre un dibattito, questo si urgente e non più rinviabile, sulla prospettiva e sulla costruzione di una visione organica e generale che superi quel “pensiero della vita quotidiana” basato, invece, su una visione frammentata e distorta che porta ad affidarsi all’ideologia immediatamente disponibile in un dato momento (la rapida ascesa del Movimento 5 stelle e la sua più che probabile repentina caduta costituisce da questo punto di vista un caso di scuola).
Premesso che l’unità è un valore solo se si fonda, appunto, su una visione ed un orizzonte strategico comune e non sulla sommatoria algebrica di forze politiche in vista del raggiungimento (generalmente fallimentare) della soglia di ingresso nelle istituzioni, il vero paradosso della tanto invocata unità a sinistra è in realtà proprio la sua divisività: non mi riferisco tanto alla composizione, scomposizione e poi ricomposizione delle forze politiche che se ne fanno promotrici, ma nella distanza e separatezza che tale formula ha determinato rispetto a quegli interessi sociali e popolari che almeno teoricamente si candiderebbe a rappresentare.
Insomma, mentre si invoca unità tra le varie forze della sinistra si scava il solco con i ceti popolari e le classi subalterne le quali irrimediabilmente si rivolgono e indirizzano altrove.
Ma la formula dell’unità a sinistra produce anche e soprattutto un altro effetto collaterale dirompente: i punti programmatici che dovrebbero essere costituenti e irrinunciabili per delineare una alternativa di sistema vengono progressivamente elusi o, nella migliore delle ipotesi, così annacquati da risultare indefiniti, generici e impalpabili.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Quando il calabrone non vola più
Quando il calabrone non vola più
Tra sogni federali, Regioni egoiste e Comuni abbandonati
di Alessandro Visalli
 Ci stiamo avvicinando
alle ennesime elezioni europee, nelle quali nel solito clima
da ultima spiaggia si elegge un
Parlamento che istituisce di fatto una doppia sovranità, lo
strano organismo istituzionale che si è stratificato in oltre
cinquanta anni
lascia separati tra di loro i popoli europei, che si
confrontano e spesso scontrano attraverso i loro governi, ma
crea un quasi-democratico
luogo di espressione della volontà dei cittadini europei in
quanto individui. La principale funzione di questo
dispositivo di fatto
è aiutare a dissolvere la sovranità popolare, dividendola, e
tradendola attraverso meccanismi oscuri[1] e limitazioni
inaccettabili[2].
Ci stiamo avvicinando
alle ennesime elezioni europee, nelle quali nel solito clima
da ultima spiaggia si elegge un
Parlamento che istituisce di fatto una doppia sovranità, lo
strano organismo istituzionale che si è stratificato in oltre
cinquanta anni
lascia separati tra di loro i popoli europei, che si
confrontano e spesso scontrano attraverso i loro governi, ma
crea un quasi-democratico
luogo di espressione della volontà dei cittadini europei in
quanto individui. La principale funzione di questo
dispositivo di fatto
è aiutare a dissolvere la sovranità popolare, dividendola, e
tradendola attraverso meccanismi oscuri[1] e limitazioni
inaccettabili[2].
Questa soluzione non funziona, o meglio, funziona molto bene ma è incompatibile con uno standard democratico che deve consentire ai cittadini di presumere le leggi siano generate da se medesimi tramite l’autorizzazione ad esercitare potere legittimo. Tramite i meccanismi europei gli esecutivi si sono di fatto ‘schermati’ dalle proprie stesse opinioni pubbliche e messi al sicuro dalle procedure di revoca democraticamente istituite (l’eccezione è il 4 marzo), trattando i cittadini come “bambini sotto tutela”. L’autoprogrammazione degli esecutivi, tra gli obiettivi non detti più forti, depotenziando strutturalmente gli obblighi di giustificazione e razionalizzazione depositati dalla storia delle lotte sociali nelle sfere pubbliche nazionali, li rende facili prese di forze esterne “del mercato”. Dunque la desiderata autonomia (dalla democrazia popolare) diventa facilmente etero-programmazione da parte delle forze dell’economia, in particolare finanziaria.
In questa situazione le forze politiche si allineano su una frontiera simbolica tra chi pretende di realizzare finalmente gli Stati Uniti d’Europa, trasferendo ad essi la sostanza del potere sovrano, e chi vorrebbe che questo progetto si interrompa, rientrando nei confini degli Stati Nazionali[3].
Leggi tutto
Lucio Russo: Perché nel XVII secolo vi fu un crollo della ricerca scientifica italiana?
Perché nel XVII secolo vi fu un crollo della ricerca scientifica italiana?
di Lucio Russo
Questo articolo riprende, in forma molto sintetica, una tesi esposta in L. Russo ed E. Santoni, Ingegni minuti, Una storia della scienza in Italia, Feltrinelli, 2010
 Credo che si possa tranquillamente
affermare che la
moderna scienza europea nacque nel Rinascimento italiano
(anche se gli storiografi anglosassoni tendono a spostare il
lieto evento di qualche secolo,
facendolo coincidere con il salto di qualità, sul quale
torneremo, che si realizzò alla fine del Seicento).
Credo che si possa tranquillamente
affermare che la
moderna scienza europea nacque nel Rinascimento italiano
(anche se gli storiografi anglosassoni tendono a spostare il
lieto evento di qualche secolo,
facendolo coincidere con il salto di qualità, sul quale
torneremo, che si realizzò alla fine del Seicento).
Senza ricordare i tanti successi scientifici italiani del Quattrocento e del Cinquecento, notiamo solo che una chiara prova del ruolo centrale svolto dal nostro paese nella scienza dell’epoca è fornita dalla sua capacità di attrarre studiosi stranieri. È universalmente riconosciuto il ruolo chiave svolto dal fiammingo Andrea Vesalio (Andreas van Wesel) nella nascita dell’anatomia moderna; è perciò significativo che Vesalio, dopo aver studiato a Lovanio e Parigi, abbia voluto coronare la sua carriera laureandosi a Padova, divenendovi professore e svolgendovi le sue principali ricerche. In astronomia è universalmente noto il ruolo svolto da Niccolò Copernico (Mikołaj Kopernik), che aveva studiato a Bologna, Ferrara e Padova. Ancora nel Seicento il padre riconosciuto della geologia e della stratigrafia, il danese Niccolò Stenone (Niels Stensen), svolse quasi tutta la sua attività di ricerca in Toscana.
Nel Seicento ai successi italiani nelle scienze fisico-matematiche (soprattutto, ma non solo, ad opera della scuola galileiana) si accompagnò, nelle scienze della vita, il ruolo decisivo svolto da scienziati come Francesco Redi e Marcello Malpighi.
Nel Settecento, e già alla fine del Seicento, l’Italia era tuttavia divenuta un paese scientificamente sottosviluppato (con qualche eccezione nelle scienze della vita). Quali furono le cause di un crollo verticale così rapido?
La vulgata, ripetuta infinite volte, dà una risposta netta e chiara: la colpa fu della chiesa cattolica, che bloccò le ricerche scientifiche con i processi e le condanne di Bruno (1600) e di Galileo (1633).
Leggi tutto
Mimmo Porcaro: Per il nove di marzo
Per il nove di marzo
di Mimmo Porcaro
Mimmo Porcaro non ha potuto raggiungerci a Roma ma ha voluto essere comunque con noi. Qui di seguito il testo integrale del suo intervento video alla Presentazione del Manifesto per la Sovranità Costituzionale
Il prossimo 9 marzo si terrà a Roma, al Teatro de’ Servi, l’assemblea di lancio del Manifesto per la sovranità costituzionale, recentemente elaborato da Patria e Costituzione, Senso Comune e Rinascita!.
Se l’iniziativa, come mi auguro, riuscirà e se avrà un seguito, saremo di fronte ad un fatto nuovo: ai primi passi di quel soggetto politico che da troppo tempo manca in Italia, un soggetto che sappia coniugare la grave questione sociale che tormenta il paese (uso volutamente il termine che era in auge prima della costituzione dei lavoratori in forza politica indipendente…) e la questione nazionale, mostrando il nesso tra la necessaria ricostruzione dello Stato (ripresa dell’intervento pubblico, welfare, piena occupazione), la ridefinizione della posizione geopolitica dell’Italia, la ripresa di un discorso socialista adeguato ai tempi ed alle specificità italiane.
Problemi del tutto indipendenti dalla mia volontà mi impediranno di partecipare, ma data l’importanza della cosa propongo egualmente un mio contributo alla discussione, elencando tre delle (molteplici) condizioni che devono realizzarsi perché le promesse contenute nel Manifesto possano iniziare a realizzarsi.
Leggi tutto
Alessandro Robecchi: Crolla il tetto del liceo? E’ tutta colpa di chi non vuole l’Alta velocità
Crolla il tetto del liceo? E’ tutta colpa di chi non vuole l’Alta velocità
di Alessandro Robecchi
Come sempre accade nelle grandi battaglie, è interessante quel che succede nelle retrovie, e le retrovie del caso Tav sono le parole, il linguaggio, l’apparato narrativo del grande dibattito nazionale: farla? Non farla? Rimandare finché si sarà finalmente inventato il teletrasporto? La questione è ormai quasi secondaria rispetto all’intrecciarsi delle narrazioni efficientiste. Ringrazio Tomaso Montanari per aver coniato, su questo giornale, il termine “sipuotismo” per dire di quella corrente di pensiero che considera possibile tutto, purché frutti qualche soldo. Lui parlava di spostare un Caravaggio di qualche chilometro – cosa considerata più remunerativa che far spostare di qualche chilometro chi vuole ammirarlo -ma il concetto è applicabile un po’ a tutto, e in primis alle famigerate grandi opere.
Se si riesce a mettere da parte le scempiaggini di chi si improvvisa ingegnere in tre minuti, magari in camerino prima di entrare in un talk show, o le menzogne dure e pure (tipo far passare il tunnel geognostico per la galleria del treno, un falso abbastanza diffuso), si vedrà che c’è una speciale curvatura negli argomenti dei “sipuotisti” che potremmo sintetizzare così: moderni contro antichi, futuro contro passato, sviluppo contro arretramento. E’ una retorica abbastanza efficace, variamente coniugata a seconda dell’abilità di chi la sostiene, ma insomma, la sintesi è questa.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Venezuela-Siria, Tav- Eastmed, secessione dei ricchi-reddito di cittadinanza… o si muore
Venezuela-Siria, Tav- Eastmed, secessione dei ricchi-reddito di cittadinanza… o si muore
Al crocevia del destino
di Fulvio Grimaldi
“Potevano essere indotti ad accettare le più flagranti violazioni della realtà, poiché non hanno mai pienamente compreso l’enormità di quanto da loro si pretendeva e non erano abbastanza interessati ai fatti pubblici per accorgersi di cosa stava succedendo”. (George Orwell)
Di questioni che ci impongono a scegliere fra due o più strade in direzioni divergenti, perché sono in grado di determinare il nostro presente e futuro, dopo che è stato alterato e travisato il nostro passato, ce ne sono molte. Mi sono limitato a considerarne, a volo d’uccello, alcune, quelle che mi paiono al momento le più pressanti.
Siria e Venezuela: non è fatta!
Vedo buontemponi che si fregano le mani convinti che in Siria, se non alla vittoria completa di quel popolo, dei suoi alleati e della sua dirigenza, con relativo riequilibrio geopolitico, si sia quanto meno alla sconfitta di assalitori e loro mercenari. Quando gli assalitori covano progetti elaborati nei decenni, in buona parte realizzati, dotati di forza militare (nucleare) e mediatica senza pari, decisivi per il loro ruolo e i loro obiettivi nel mondo, e dunque irrinunciabili, nessuna partita si può dire vinta, anche se nemmeno persa. E di mercenariato, tra masse alienate e alla canna del gas, ce n’è una fonte inesauribile. Colonialismo e neoliberismo ne sono prodighi.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Sale alle stelle il prezzo della «protezione» Usa
Sale alle stelle il prezzo della «protezione» Usa
di Manlio Dinucci
La Casa Bianca sta per presentare il piano «Cost Plus 50» che stabilisce il seguente criterio: i paesi alleati che ospitano forze Usa sul proprio territorio ne dovranno coprire interamente il costo e pagare agli Usa un ulteriore 50% in cambio del «privilegio» di ospitarle ed essere così da loro «protetti»
A pretendere il pizzo in cambio di «protezione» non è solo la mafia. «I paesi ricchi che stiamo proteggendo – ha avvertito minacciosamente Trump in un discorso al Pentagono – sono tutti avvisati: dovranno pagare la nostra protezione».
Il presidente Trump – rivela Bloomberg – sta per presentare il piano «Cost Plus 50» che stabilisce il seguente criterio: i paesi alleati che ospitano forze Usa sul proprio territorio ne dovranno coprire interamente il costo e pagare agli Usa un ulteriore 50% in cambio del «privilegio» di ospitarle ed essere così da loro «protetti».
Il piano prevede che i paesi ospitanti paghino anche gli stipendi dei militari Usa e i costi di gestione degli aerei e delle navi da guerra che gli Stati uniti tengono in questi paesi. L’Italia dovrebbe quindi pagare non solo gli stipendi di circa 12.000 militari Usa qui di stanza, ma anche i costi di gestione dei caccia F-16 e degli altri aerei schierati dagli Usa ad Aviano e Sigonella e i costi della Sesta Flotta basata a Gaeta.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3482
Hits 2663
Hits 2549
Hits 2411
Hits 2231
Hits 2113
Hits 2024
Hits 1959
tonino

Demostenes Floros: Grande Eurasia e le (nuove) vie dell'energia
Grande Eurasia e le (nuove) vie dell'energia
di Demostenes Floros
Negli ultimi anni, abbiamo assistito all'emergere di un centro geo economico in Eurasia, che si sta strutturando attorno alla Russia e alla Cina. Un nuovo polo di sviluppo che vuole e può diventare un'alternativa al centro euro-atlantico. E c'entra soprattutto il gas
 Nel 2018, la percentuale di gas
fornita ai paesi dell’Ue e la Turchia ha raggiunto il 36,7%,
il massimo da
sempre” (34,2% nel 2017). Lo ha affermato il Direttore
Generale di Gazprom Export, Elena Burmistrova, nel corso del
Gazprom’s Investory
Day che ha avuto luogo in Singapore il 28 febbraio.
Burmistrova ha specificato che il prezzo medio nel 2018 è
stato di 245,5 dollari per 1.000
m3 rispetto ai 167 dollari per 1.000 m3
nel 2017 (+ 24,6% anno su anno). Conformemente alle stime
preliminari rese pubbliche
dalla Gazprom, nel 2018, la compagnia controllata a
maggioranza dallo Stato russo ha esportato nell’Unione europea
più la Turchia 201,8
Gm3 di gas naturale (potere calorifico: 37,053 MJ/m3),
un ammontare pari a più di tre volte la somma degli
approvvigionamenti di LNG all’Europa.
Nel 2018, la percentuale di gas
fornita ai paesi dell’Ue e la Turchia ha raggiunto il 36,7%,
il massimo da
sempre” (34,2% nel 2017). Lo ha affermato il Direttore
Generale di Gazprom Export, Elena Burmistrova, nel corso del
Gazprom’s Investory
Day che ha avuto luogo in Singapore il 28 febbraio.
Burmistrova ha specificato che il prezzo medio nel 2018 è
stato di 245,5 dollari per 1.000
m3 rispetto ai 167 dollari per 1.000 m3
nel 2017 (+ 24,6% anno su anno). Conformemente alle stime
preliminari rese pubbliche
dalla Gazprom, nel 2018, la compagnia controllata a
maggioranza dallo Stato russo ha esportato nell’Unione europea
più la Turchia 201,8
Gm3 di gas naturale (potere calorifico: 37,053 MJ/m3),
un ammontare pari a più di tre volte la somma degli
approvvigionamenti di LNG all’Europa.
Come messo in luce da Bloomberg il 15 febbraio, la costante riduzione della produzione di gas da parte del Vecchio Continente è la principale ragione del rafforzamento della Federazione Russa come primo fornitore di gas naturale dell’Europa, soprattutto dopo che l’Olanda – il secondo estrattore europeo dopo la Norvegia – è diventata un importatore netto di gas per la prima volta da quando iniziarono le estrazioni dal giacimento di Groningen nel 1963.
Sempre a Singapore, Gazprom ha inoltre annunciato che il gasdotto Power of Siberia è prossimo al completamento. Grazie a questa nuova infrastruttura, a partire dal 1 dicembre 2019, la Federazione Russa rifornirà la Cina con 38 Gm3 di gas naturale all’anno per un arco di tempo di trent’anni e un ammontare totale stimato in circa 1 trilioni di m3 di gas. Il contratto stipulato dai due paesi nel maggio 2014 è un take or pay oil-link (collegato al prezzo del petrolio) per un valore complessivo valutato attorno ai 400 miliardi di dollari.
Tuttavia, il 28 febbraio trascorso, Bloomberg rilevava che il colosso energetico aveva perso financial appeal (interesse finanziario) nel corso degli ultimi anni a causa dei significativi costi di investimento sostenuti, i quali avevano ridotto la possibilità di remunerare gli investitori con dividendi più alti.
Leggi tutto
Il socialismo è morto, viva il socialismo
Intervista a Carlo Formenti
 Carlo Formenti è una delle menti più lucide e
preparate che quella
sinistra che non ha voluto piegarsi ai diktat del liberismo,
ha al suo interno. La sua preparazione è sotto agli occhi di
tutti: nel suo
impegno politico ma soprattutto nel suo lavoro.
Carlo Formenti è una delle menti più lucide e
preparate che quella
sinistra che non ha voluto piegarsi ai diktat del liberismo,
ha al suo interno. La sua preparazione è sotto agli occhi di
tutti: nel suo
impegno politico ma soprattutto nel suo lavoro.
Infatti, tante sono le sue pubblicazioni e tutte hanno precorso i tempi, dando modo di aprire una profonda riflessione che ha provocato la necessaria reazione al dominio neoliberista anche nel nostro paese, la stessa reazione che oggi vede diversi soggetti iniziare ad aggregarsi per costruire un campo e una prospettiva marcatamente socialista e sovranista, antimperialista, antiliberista e anticapitalista.
In occasione dell’uscita del suo ultimo libro “Il socialismo è morto, viva il socialismo“, edito da Meltemi, abbiamo chiesto ad Enea Boria di Rinascita!, di intervistare per noi Carlo Formenti sul suo libro.
Ne è scaturita una conversazione interessantissima, assolutamente da non perdere. Eccola qui di seguito.
* * * *
Enea Boria: Leggendo il tuo ultimo libro la prima sensazione che si prova è uno strappo doloroso. Non tanto per quello che riguarda un divorzio dalla sinistra ampiamente consumato, quanto per il lapidario giudizio sul ‘900 e quindi sull’esperienza storica e culturale dalla quale proveniamo, che per te sono da considerare definitivamente finiti. Questo però non lascia spazio al pessimismo. Abbiamo perso la guerra più che una battaglia, scrivi, ma poi aggiungi che la storia non è finita e che occorre ricostruire identità e capacità di mobilitazione intorno a un progetto che sia altro dal capitalismo. Per questo sostieni che bisogna cambiare prospettiva: non basta più limitarsi a ripetere, con Gramsci, che “il vecchio muore ma il nuovo non può nascere”, bisogna iniziare ad agire nel segno di un nuovo che “deve nascere”.
Mi sembra che nella prima parte del libro, sintetizzata nelle dodici tesi del primo capitolo, si evidenzi una continuità con due opere precedenti, “Utopie letali” e “La variante populista”, i cui contenuti vengono qui riproposti e sintetizzati in una necessaria pars destruens. Sgombrato il tavolo degli attrezzi consunti e ormai inservibili, nella seconda parte del libro, inaugurata da altre ventidue tesi, attrezzi il banco di lavoro con nuovi strumenti e abbozzi alcune istruzioni su come utilizzarli.
Leggi tutto
Salvatore A. Bravo: La laicità all’epoca dell’integralismo laicista
La laicità all’epoca dell’integralismo laicista
di Salvatore A. Bravo
 La
normalizzazione laicista
La
normalizzazione laicista
La secolarizzazione del capitale non ha fondato la laicità, ma una nuova forma invasiva e infiltrante di clericalismo: i nuovi chierici non sono identificabili in una casta, in una lobby, sono trasversali, sono l’asse diffuso del nuovo “potere capitale” disciplinare e penetrante. Il circo mediatico laicista si struttura in modo sempre pervasivo: accademici, economisti, burocrati dell’economia, politici dal credo-pensiero unico, tutti nichilisti sempre pronti al trasformismo, sono la struttura ed il veicolo che inibisce ogni spazio plurale, lo riduce ad un’operazione di marketing, a plusvalore, ad un’operazione di perenne sussunzione. Il linguaggio dell’aziendalizzazione, della compravendita, l’inglese organico alla globalizzazione estendono le loro maglie d’acciaio: la rete informativa in nome del capitale trova nelle istituzioni pubbliche fiancheggiatori che diffondono il linguaggio e la lingua del mercato. Si osanna l’inclusione mediante la normalizzazione delle prestazioni: per essere normali ed inclusivi si fa appello sempre ai diritti individuali. Si forma all’orientamento accondiscendente, ovvero ad adattarsi alle esigenze del mercato, mentre i servizi pubblici, i servizi alla persona – vera precondizione di ogni democrazia – sono curvati sulla privatizzazione, sui bilanci. Il pubblico con i suoi servizi non rappresenta l’alterità rispetto al privato, ma nel pubblico l’organizzazione lavorativa ed i fini sono i medesimi del privato: pertanto la laicità scompare, si eclissa nel gioco ideologico della propaganda.
Gli oratores del circo mediatico laicista
La laicità non è semplice laicismo anticlericale. L’integralismo attuale trova nella religione una contraddizione, per cui i clerici mediatici e disinibiti abbondano in notizie sui crimini della chiesa, mentre tacciono dei crimini che quotidianamente avvengono in nome del capitalismo assoluto, in primis i crimini ambientali, i migranti ridotti in stato di schiavitù effettiva, i popoli declassati a plebe in competizione.
Leggi tutto
Fabio Nobile: Antifascisti del XXI Secolo
Antifascisti del XXI Secolo
di Fabio Nobile
Sin dall’insediamento del governo giallo-verde, giornali come la Repubblica ed i media vicini al centrosinistra hanno messo il tema dell’antifascismo al centro prima dell’opposizione e poi di un’ipotesi di alternativa al governo stesso.
Questo aspetto può essere percepito come un fatto positivo. Ma da una lettura attenta, sia dei partiti politici al governo sia dell’effettiva situazione politica italiana ed europea, ci si accorge facilmente che l’antifascismo non può essere la cifra fondamentale dell’opposizione al governo in carica.
In primo luogo, per capire quanto sia strumentale tale approccio è necessario risalire alla definizione del fascismo che ne diede la Terza internazionale, che definì il fascismo “la dittatura terroristica aperta del capitale finanziario”. Ciò significa che il fascismo assunse, dalla presa del potere in poi, la forma di governo attraverso cui le classi dominanti italiane affrontarono la crisi economica e sociale del dopoguerra e schiacciarono le concrete, ancorché potenziali, velleità di conquista del potere politico da parte della classe operaia. Il tutto in un contesto in cui fascismo e il nazismo si affermavano nei Paesi usciti o sconfitti (Germania) o comunque indeboliti (Italia) dalla Grande guerra e si preparavano al secondo tempo dello scontro tra imperialismi, la Seconda guerra mondiale.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Francia: verso l’assalto al cielo!
Francia: verso l’assalto al cielo!
di Giacomo Marchetti
Sono giornate decisive in Francia.
Solo “la congiura del silenzio” imposta nella redazioni dei media mainstream italiani ha fatto sì che il più longevo e radicale movimento della storia repubblicana contemporanea d’oltralpe sia scomparso dai radar di quello che potremmo definire, con un piccolo margine di approssimazione, “informazione di regime”.
La censura sulle mobilitazioni in questi mesi è cessata solo per travolgerci con vere e proprie ondate di fake news – i presunti insulti antisemiti ad un noto filo-sionista Finkielkraut, per esempio, costituiscono la pietra miliare di questo “giornalismo creativo” – fatti e “personaggi” marginali sono stati eletti agli onori alla cronaca (non un ultimo un mitomane mentecatto che si è prestato ad incontrare Di Maio, al secolo Christophe Calencon).
Il regime discorsivo sulla Francia sembra essere stato colpito dalla sindrome che un noto personaggio del comico Antonio Albanese augura a chi gli ha rubato il motorino: quella di diventare muto, ma non totalmente, ed aprire bocca solo per dire “stronzate pazzesche”.
Sarebbe bastato che le redazioni si limitassero a tradurre le inchieste particolareggiate riportate dai maggiori media francesi (Le Monde, Libération, L’Humanité) sulla composizione sociale, l’orientamento politico e le richieste dei Gilets Jaunes; ma nelle redazioni italiane sembra sappiano solo fare copia-incolla di ciò che battono le agenzie stampa, senza nemmeno utilizzare uno strumento base dei mancati “cronisti d’assalto”, chessò, come il traduttore di Google.
Leggi tutto
Femminismo per il 99%. Un manifesto
di Daniela Danna
Questa è una recensione del libro di Cinzia Arruzza, Tithi Bhattacharya e Nancy Fraser Femminismo per il 99%. Un manifesto (Laterza 2019). Lo scrivo sperando che la lettura risparmi ad altre il costoso investimento (14 euro per sole 84 pagine scritte belle grandi) in qualcosa che – come molti fenomeni culturali e politici attuali – è volto a evocare il femminismo solo per infliggergli la coltellata mortale.
Mi vengono in mente innanzitutto una serie di equazioni: lo xenofemminismo sta al femminismo come la fantascienza sta alla storia; il queer sta al femminismo come il pesce sta alla bicicletta; il transfemminismo sta al femminismo come la donne T stanno alle donne (e sarà meglio informarsi sul “transfemminismo”, dato che sotto questa etichetta sembra che debba avvenire la più grande mobilitazione contro il raduno omofobo e misogino del 31 marzo a Verona, il Congresso Mondiale delle Famiglie); il femminismo sta a quel che vogliono le donne come il transfemminismo sta a quel che vogliono le trans; il femminismo intersezionale (così come spiegato da Nonunadimeno/Grramigna) sta al femminismo come l’accettazione della prostituzione delle “sex workers” sta alla violenza della prostituzione. Sono anche venuta a sapere leggendo la loro spiegazione del femminismo intersezionale che la depilazione delle donne che chiamano “cisgender” non è femminista mentre quella delle donne trans lo è! “Cisgender” peraltro significa: “che si riconosce nel suo genere” – quindi di chi stiamo parlando? Solo di quella che vuole sposarsi ed essere sottomessa?
Leggi tutto
Attilio Pasetto: Sulla politica industriale l’ipoteca franco-tedesca
Sulla politica industriale l’ipoteca franco-tedesca
di Attilio Pasetto
I discorsi programmatici di Macron e del ministro tedesco Altmaier hanno delineato le strategia che si dovrà seguire: “campioni europei” per fronteggiare quelli esteri, con la modifica delle regole Ue sulla concorrenza e ripensamento persino del tabù degli aiuti statali. Peccato che sembrino pensare essenzialmente non a una prospettiva comune, ma a quelle dei loro due paesi
Uno dei grandi temi su cui il nuovo Parlamento europeo si dovrà misurare dopo le elezioni di maggio sarà quello della politica industriale europea e della sua relazione con la politica della concorrenza, che finora è stata uno dei punti di forza dell’Unione europea. Per la verità una politica industriale europea finora non c’è mai stata, fatta eccezione per la complessa normativa sugli aiuti di Stato. Le cose però potrebbero cambiare in un futuro abbastanza vicino. Le premesse perché ciò avvenga sono molto evidenti.Cominciamo con il dire che, se dovesse nascere, la politica industriale europea nascerebbe sotto l’egida franco-tedesca. Nascerebbe quindi già distorta e orientata politicamente. Il perché lo vediamo attraverso cinque passaggi temporali.
1. A gennaio di quest’anno viene rinnovato, a cinquantasei anni di distanza, il Trattato di Aquisgrana sulla cooperazione e l’integrazione fra la Francia e la Germania, in cui si ribadisce l’impegno dei due Paesi a costruire un’Unione europea “competitiva” e fondata “su una base industriale forte”.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Dall’ecobuonismo all’ecosocialismo
Dall’ecobuonismo all’ecosocialismo
di Andrea Zhok
 I) Premessa
I) Premessa
Recentemente, in coda alle presentazioni del Manifesto per la Sovranità Costituzionale a Milano e Roma, mi ha sorpreso notare come le note più critiche a quel documento si siano appuntate su qualcosa che non credevo controverso, ovvero il rilievo dato alla questione ecologica.
Alcuni hanno obiettato che parlare di riscaldamento globale e di come sarà il mondo tra cent’anni è qualcosa di astratto e lontano, che non tocca le tasche di nessuno; altri che attorno a tale tema interclassista non si può mobilitare alcun ceto preferenziale, alcuna ‘identità di classe’; altri ancora, che si tratterebbe di un modo con cui le élite distraggono l’opinione pubblica da temi di maggiore urgenza.
Questa reazione di diffidenza, di sospetto, a prescindere dalla sostenibilità delle specifiche obiezioni, mi pare degna di approfondimento.
II) Il dilemma ecobuonista
Negli ultimi anni, la tematica ecologista è stata integrata con successo all’interno di una visione liberale, che l’ha resa un tema di conversazione alto borghese, garbato quanto innocuo. Il tema infatti si presta a grandi campagne sentimentali, capaci di estrudere occasionali lacrime per le sorti di un orso polare o un panda gigante, salvo poi rientrare prontamente nella sezione ‘tonici e digestivi’: dove, insieme a qualche episodio di cronaca, conferisce quel pizzico di preoccupazione postprandiale che aiuta la digestione.
I temi ecologici, addomesticati dalla ragione liberale, sfociano così in due prospettive generali.
La prima consta di appelli all’iniziativa personale e al senso di responsabilità delle ‘persone di buona volontà’: ciascuno è chiamato a ‘fare la sua parte’, a ‘contribuire col suo granello di sabbia’. Si creano così gli spazi per ‘diete ambientalmente consapevoli’, ‘acquisti etici’, ‘consumi responsabili’, ‘prodotti biologici’, ‘raccolta differenziata’, ‘beni equi e solidali’, e una miriade di altre lodevoli iniziative in cui ci si sente cavalieri dell’ideale a colpi di tofu.
Leggi tutto
Géraldine Delacroix: Il capitalismo di sorveglianza
Il capitalismo di sorveglianza
di Géraldine Delacroix
 Una recensione-conversazione a cura di
Géraldine Delacroix con
l’economista Shoshana Zuboff sul suo nuovo libro The
age of surveillance capitalisme. The Fight For a Human
Future at the New Frontier of
Power (Profile Books Ltd, 2019). È stata pubblicata
il 2 marzo 2019 su Médiapart. La traduzione in
italiano
è di Salvatore Palidda.
Una recensione-conversazione a cura di
Géraldine Delacroix con
l’economista Shoshana Zuboff sul suo nuovo libro The
age of surveillance capitalisme. The Fight For a Human
Future at the New Frontier of
Power (Profile Books Ltd, 2019). È stata pubblicata
il 2 marzo 2019 su Médiapart. La traduzione in
italiano
è di Salvatore Palidda.
Il capitalismo di sorveglianza è il fondamento di un nuovo ordine economico. Le imprese del capitalismo di sorveglianza competono nella produzione di “prodotti di predizione”, scambiati in lucrosi nuovi mercati di “comportamenti futuri”. Le architetture digitali del capitalismo di sorveglianza – quelle che Shoshana Zuboff chiama “Big Other” – sono progettate per catturare e controllare il comportamento umano per un vantaggio competitivo in questi nuovi mercati, poiché la produzione di beni e servizi è subordinata a un nuovo “mezzo di modifica dei comportamenti” che favorisce i risultati del mercato privato, svincolato da ogni supervisione o controllo democratico. Per chi fosse interessato ad approfondire, Shoshana Zuboff, professoressa di Harvard Business School, parla qui, in una recente conferenza, del suo nuovo libro.
* * * *
Per l’economista Shoshana Zuboff, il cui libro The Age of Capitalism of Surveillance è appena apparso negli Stati Uniti, il pericolo rappresentato dai giganti del web è molto maggiore di quanto generalmente si pensi. Intercettando i dati personali per modificare a loro insaputa il comportamento dei loro utenti, minacciano la democrazia stessa. Appropriatisi dei nostri dati personali, gli imprenditori del “capitalismo di sorveglianza” mettono in pericolo niente meno che la democrazia manipolando il nostro libero arbitrio. Tale è la tesi difesa da Shoshana Zuboff in questo ampio volume appena pubblicato.
Il capitalismo è entrato in una nuova era, spiega l’autrice e, per capirlo e combatterlo, dovremo indossare nuovi occhiali, perché i vecchi non operano più di fronte a un cambiamento così radicale e così veloce – una rivoluzione avvenuta in meno di venti anni. Un “nuovo pianeta”, una situazione “senza precedenti” che si sarebbe sbagliato pensare sia una semplice continuazione del passato.
Leggi tutto
Alberto Prina Cerai: La sfida eurasiatica all’egemonia degli Stati Uniti
La sfida eurasiatica all’egemonia degli Stati Uniti
di Alberto Prina Cerai
Questo articolo è il primo di una serie di contributi per approfondire il tema della sfida tra Stati Uniti e Cina per l’ordine mondiale. In seguito alle recenti dichiarazioni riguardo ad una possibile adesione dell’Italia alla Belt and Road Initiative – la cosiddetta nuova Via della Seta –, abbiamo deciso di dedicare una serie di articoli alle prospettive strategiche relative alla fase che stiamo vivendo e al possibile ruolo del nostro Paese, che merita un approfondimento di più ampio respiro. Questo primo articolo si propone di fare luce di come e perché la BRI rappresenti una sfida all’egemonia americana. Nei successivi si tenterà di capire come l’Italia possa essere un benchmark per gli equilibri geopolitici tra Washington e Pechino
 Sin dal 1945 il cuore
pulsante della politica estera statunitense è stato preservare
«un ordine internazionale
aperto e stabile, basato sul libero movimento di beni,
capitali e persone» basato su un «balance of power in
favore della
libertà». Queste iniziative, secondo lo storico Hal Brands,
hanno costituito un «impegno bipartisan di lunga data» volto a
sostenere «la leadership americana e preservare
l’ordine internazionale liberale che il potere americano ha
tradizionalmente
promosso»[1]. Per chi
vede queste continuità, al netto dei grandi cambiamenti che
hanno fortemente messo alla prova la tenuta della Pax
Americana, la natura
e le radici dell’egemonia globale degli Stati Uniti si possono
identificare nella lettura esplicita di Henry Kissinger:
Sin dal 1945 il cuore
pulsante della politica estera statunitense è stato preservare
«un ordine internazionale
aperto e stabile, basato sul libero movimento di beni,
capitali e persone» basato su un «balance of power in
favore della
libertà». Queste iniziative, secondo lo storico Hal Brands,
hanno costituito un «impegno bipartisan di lunga data» volto a
sostenere «la leadership americana e preservare
l’ordine internazionale liberale che il potere americano ha
tradizionalmente
promosso»[1]. Per chi
vede queste continuità, al netto dei grandi cambiamenti che
hanno fortemente messo alla prova la tenuta della Pax
Americana, la natura
e le radici dell’egemonia globale degli Stati Uniti si possono
identificare nella lettura esplicita di Henry Kissinger:
«Geopoliticamente l’America è un’isola al largo del grande continente eurasiatico. Il predominio da parte di una sola potenza di una delle due sfere principali dell’Eurasia […] costituisce una buona definizione di pericolo strategico per gli Stati Uniti, guerra fredda o meno. Quel pericolo dovrebbe essere sventato anche se quella potenza non mostrasse intenzioni aggressive, poiché, se queste dovessero diventare tali in seguito, l’America si troverebbe con una capacità di resistenza efficace molto diminuita e un’incapacità crescente di condizionare gli avvenimenti»[2]
La geopolitica del secondo dopoguerra è rimasta fortemente ancorata a questa visione e più in generale all’eredità imperiale degli impegni globali degli Stati Uniti. Harry Truman agli esordi della guerra fredda aveva recuperato l’immagine del paese come grande erede «della Persia di Dario I, la Grecia di Alessandro, la Roma di Adriano, la Gran Bretagna vittoriana […] Nessuna nazione ha avuto le nostre responsabilità»[3].
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Noi "sovranisti storici"
Noi "sovranisti storici"
Una risposta a Mimmo Porcaro
di Leonardo Mazzei
Abbiamo dato ampio spazio all'assemblea nazionale di presentazione del Manifesto per la Sovranità Costituzionale. Avremo tanti difetti, ma quello del settarismo sembra proprio di no.
Intervenendo sul contenuto del Manifesto, Programma 101 ha segnalato da un lato la larga convergenza con analisi e proposte che per primi abbiamo avanzato, dall'altra la sua astrattezza politica, il suo sostanziale vuoto strategico.
La lacuna più grave, scriveva P101 agli inizi di febbraio, è che:
«da nessuna parte si scrive che l’Italia deve uscire dall’eurozona e dall’Unione. Da nessuna parte si proclama a chiare lettere la necessità dell’Italia di battere moneta propria attraverso una banca centrale pubblica. Una mancanza che anche a noi ha lasciato di stucco. Data questa assenza, mentre tutti, da sinistra a destra, si trastullano nell’illusione di poter “cambiare i Trattati”, la prospettiva (di sapore gollista) di una Confederazione europea di nazioni sovrane ha un sapore davvero sinistro».
Era fondata quella critica? Ovviamente sì, come ci conferma la debole giustificazione del passo indietro compiuto, pronunciata all'assemblea di Roma da Mimmo Porcaro.
Scrive Porcaro:
Leggi tutto
Enzo Acerenza: Ora è troppo facile
Ora è troppo facile
di Enzo Acerenza
Ora è troppo facile denunciare i manager “prenditori, c’è voluto l’intervento della magistratura con gli arresti domiciliari dei due manager di Blutec per far scoppiare il bubbone. Tutti si dicono pronti a salvaguardare i lavoratori della ex FIAT di Termini Imerese che sono in mezzo ad una strada, tutti meravigliati, si chiedono come è potuto accadere che questi signori si siano intascati 21 milioni di euro per l’impegno a reindustrializzare il sito e non ne abbiano fatto niente. Non partecipiamo a queste denunce generiche, costano poco e non portano a nessun risultato. Non ci faremo prendere in giro dagli stessi che oggi gridano alla speculazione ma che solo il 5 Marzo erano seduti al tavolo del MiSE e, concordando la cassa integrazione, si accontentavano della dichiarazione della Blutec sulla ripresa dell’attività. Una serie di riunioni al Ministero dello sviluppo economico hanno scandito dal 2014 l’operazione Blutec, per non ricordare i precedenti impegni presi dalla DR-Motor al momento della chiusura della fabbrica FIAT del 2011 e mai mantenuti. Ma concentriamo l’attenzione sugli ultimi. Il 19 aprile del 2016, Bellanova, viceministro di Calenda, dichiara “E’ una sfida difficile ma i segnali sono incoraggianti. Il progetto Blutec è ormai avviato come ci ha detto l’azienda …”. Al MiSE, il 4 ottobre 2018, davanti al dottor Castano, ex sindacalista, vecchio burocrate, che chi ha lottato contro la chiusura delle fabbriche conosce bene – ne avesse salvata una -, si sottoscrive un verbale con l’impegno a far partire la produzione per il mese successivo, a novembre.
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: Il Polanyi rovesciato dal “Corriere”
Il Polanyi rovesciato dal “Corriere”
di Tommaso Nencioni
Ne “La grande trasformazione” Karl Polanyi descrive gli effetti perversi del pieno sviluppo, nel corso del XIX secolo, di una “società di mercato”. Modi di vita e di relazionarsi col prossimo secolari venivano sconvolti nell’arco di pochi decenni sull’altare delle esigenze del profitto. Prendeva corpo, in maniera del tutto innaturale e senza riscontri nella storia umana, una società nella quale era trasformato in merce ciò che non nasce come merce, e cioè la vita umana attraverso la mercificazione del lavoro, l’ambiente attraverso la mercificazione della terra, e la moneta. Di fronte a un tale sconvolgimento, aggravato dalla ferocia della crisi economica scoppiata nel ’29, le masse avevano dato vita ad un “contro-movimento” contro il mercato, sostanziatosi nel fascismo, nel bolscevismo e nel New Deal roosveltiano. La lezione da trarre, secondo Polanyi, consisteva quindi nella presa d’atto della impossibilità dell’affermazione di una piena e dispiegata società di mercato e della necessità di dare corpo a istituzioni democratiche in grado di proteggere i popoli dalle esigenze del profitto.
Una copia de “La grande trasformazione” deve essere capitata anche dalle parti di via Solferino, e l’ineffabile Michele Salvati l’ha risignificata (per usare un termine a noi caro) da par suo: nella lettura che ne dà Salvati, lo Stato deve adattare le masse alle esigenze della società di mercato.
Leggi tutto
Sebastiano Isaia: Lettera di un anticapitalista a Greta Thunberg
Lettera di un anticapitalista a Greta Thunberg
di Sebastiano Isaia
Cara Greta,
mi chiamo Sebastiano, vivo in Italia e fin dall’inizio ho seguito con molta simpatia la tua battaglia contro i cambiamenti climatici e la distruzione dell’ecosistema del nostro pianeta. Il tuo discorso alla Conferenza sul Clima (COP 24) di Katowice mi ha molto impressionato e ha ispirato la riflessione che segue, che ti consegno non per convincerti, non ne avrei le capacità, ma per esporti un punto di vista che forse non conosci sulla scottante questione che tanto ci sta a cuore.
Carissima,
chi ti scrive è un anticapitalista al quale, esattamente come te, «non importa risultare impopolare» ma che, a differenza di te, non si batte per la «giustizia climatica e un pianeta vivibile», ma per un pianeta libero da una potenza sociale che ormai da più di due secoli domina, sfrutta e devasta la natura e gli esseri umani: il Capitale. Ho capito pochissime cose di come va il mondo, e tra queste te ne segnalo una: il Capitalismo è necessariamente incompatibile con il rispetto della natura e dell’umanità. Dico necessariamente perché la prassi economica che devasta tanto l’ambiente naturale quanto quello sociale non deriva né dalla cattiva volontà dei decisori politici posti al servizio dello status quo sociale, come si rinfacciano a turno i partiti che si alternano al governo nei Paesi di tutte le nazioni, né dalla malvagità della cosiddetta élite che detiene le leve dell’economia, quanto piuttosto dalla stessa natura del Capitalismo.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3509
Hits 2700
Hits 2568
Hits 2440
Hits 2240
Hits 2133
Hits 2038
Hits 1977
Hits 1818
Hits 1816
tonino

Vladimiro Giacchè: Proprietà pubblica e privata tra Costituzione e trattati europei
![]()
Proprietà pubblica e privata tra Costituzione e trattati europei
di Vladimiro Giacchè
Pubblichiamo l’intervento di Vladimiro Giacchè all’incontro “Unione Europea, Costituzione e diritti di proprietà” tenutosi a Roma il 23 febbraio 2019, promosso dalle associazioni Patria e Costituzione e Attuare la Costituzione
 1.
Proprietà pubblica e privata: l’economia mista prevista
dalla nostra
Costituzione
1.
Proprietà pubblica e privata: l’economia mista prevista
dalla nostra
Costituzione
La nostra Costituzione dedica alcuni dei suoi articoli più importanti alle diverse forme di proprietà: si tratta degli articoli 41-43, 45-47, centrali tra gli articoli dedicati ai “Rapporti economici” (artt. 35-47). Rileggiamoli:
Art. 41.
L’iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.
Art. 42.
La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti.
La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale.
La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.
Art. 43.
A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Greta Thunberg: la posta egemonica e lo scontro per il mondo
Greta Thunberg: la posta egemonica e lo scontro per il mondo
di Alessandro Visalli
 In fondo è una storia
come tante altre, banale. Una ragazzina di quindici anni che
prende una idea semplice, in
bianco e nero, e la sposa con l’entusiasmo dei suoi
anni. Nasce in una famiglia di professionisti dello spettacolo
(una cantante ed un
attore) e traduce questa idea in performance. Queste
performance, nativamente preordinate nel codice della società
dello spettacolo, sono
utilizzate da un sistema dei media sempre alla ricerca di
eventi-mondo per costruire un prodotto efficace. Questo
efficace prodotto viene ripreso e
rilanciato, per i più diversi scopi, dalle più diverse forze
ed organizzazioni.
In fondo è una storia
come tante altre, banale. Una ragazzina di quindici anni che
prende una idea semplice, in
bianco e nero, e la sposa con l’entusiasmo dei suoi
anni. Nasce in una famiglia di professionisti dello spettacolo
(una cantante ed un
attore) e traduce questa idea in performance. Queste
performance, nativamente preordinate nel codice della società
dello spettacolo, sono
utilizzate da un sistema dei media sempre alla ricerca di
eventi-mondo per costruire un prodotto efficace. Questo
efficace prodotto viene ripreso e
rilanciato, per i più diversi scopi, dalle più diverse forze
ed organizzazioni.
Stiamo facendo un esercizio di complottismo? Un’aggressione alla simpatica ragazzina?
No. Tutt’altro, Greta Thunberg ha tutta la mia simpatia, è una ragazzina sveglia ed intelligente, piena di ottimi sentimenti e impegnata per una battaglia degna.
Semplicemente il mondo ha il suo modo di funzionare, ed usa tutto.
Ma il fatto che qualcosa sia usato significa che non sia fondato? No. Io credo fermamente che il sistema ambientale sia alterato dall’uomo, ad una profondità che è difficile da definire con precisione, e che il clima venga modificato anche da questi fattori di pressione antropogenetici.
Il fatto che qualcosa sia fondato significa che altro non lo sia? No. Io credo fermamente che la questione in campo sia il potere.
Il fatto che una cosa sia usata e fondata significa che non ci sia altro da dire? No. Io credo fermamente che buona parte del degrado dell’ambiente sia determinato dalla logica dello sfruttamento della natura per il profitto e dalla sua appropriazione da parte di pochi.
Il fatto è che, anche se Greta Thunberg può pensarlo[1], il mondo non è affatto “bianco o nero”.
Quando ad agosto 2018 il curioso “sciopero”[2] (dalla scuola) della ragazzina di Stoccolma, opportunamente spettacolarizzato, in vista delle elezioni generali di settembre, e subito rilanciato da qualche interessato sito come parte di una strategia di autopromozione commerciale/ambientale[3], sfonda il muro della irrilevanza prende avvio un processo autorafforzante imponente.
Leggi tutto
Istituto Onorato Damen: Il comunismo è la sola possibilità di salvare il pianeta Terra
Il comunismo è la sola possibilità di salvare il pianeta Terra
di Istituto Onorato Damen
 Le vaste e
significative manifestazioni studentesche che si
sono tenute in oltre 120 Paesi
contro i cambiamenti climatici spingono all’apertura di una
riflessione e di un confronto che consentano di riannodare:
Le vaste e
significative manifestazioni studentesche che si
sono tenute in oltre 120 Paesi
contro i cambiamenti climatici spingono all’apertura di una
riflessione e di un confronto che consentano di riannodare:
- l’approfondimento della critica alla distruzione ambientale connaturata al modo di produzione capitalistico;
- una critica delle ideologie ecologiste e ambientaliste, che non colgono il nesso di determinazione che vige tra capitalismo e devastazione del pianeta, e che sono inoltre agite come strumenti delle battaglie interimperialistiche e del Capitale contro il proletariato;
- la comprensione delle motivazioni che mettono in movimento migliaia di giovani, compositi dal punto di vista di classe, con grandi confusioni e con ideologie certo tutte borghesi; motivazioni che però in qualche misura rappresentano ed esprimono disagi profondi del giovane proletariato internazionale che bisogna saper collocare, con cui bisogna saper entrare in collegamento, rendendo possibile la produzione di una coscienza critica che sappia connettere, in minoranze più avanzate, la critica del capitalismo a quella dei suoi effetti disastrosi sull’ambiente;
- la lotta contro le micidiali illusioni nella democrazia borghese, nelle sue istituzioni di ogni livello, negli accordi tra briganti imperialisti su clima e ambiente;
- il rilancio della prospettiva del comunismo, una società finalmente umana che metta fine al dominio e allo sfruttamento, che riconcili umanità e natura, grazie a una prassi sociali trasparente, non mistificata, non finalizzata al profitto, ma che abbia come obiettivo e come caratteristica il muoversi in direzione degli interessi e del ben-essere degli uomini, in armonica relazione con il contesto ambientale.
Leggi tutto
Carla Filosa: Marxismo e cambiamento climatico
Marxismo e cambiamento climatico
di Carla Filosa
A chi si spende per esporre e condividere – divulgare forse sarebbe pretendere troppo date le forze limitate – l’analisi di Marx in quanto tuttora l’unica in grado di far emergere una realtà continuamente operante, ma nascosta all’evidenza di ciò che appare, giunge immancabile la richiesta del “che fare”. L’urgenza di agire in qualche modo viene espressa soprattutto da parte di coloro che intendono la teoria come una ricettina immediata della pratica, e non la sua premessa propedeutica su una realtà sociale collettiva, di cui individualmente si è sempre parte, ma la cui gestione efficace per i fini propostisi dipende da un insieme di fattori storici, che inevitabilmente sfuggono anche alla migliore volontà dei singoli. Oggi l’unico movimento veramente internazionale che sta scuotendo – almeno si spera – le politiche mondiali è quello dei giovani e giovanissimi per il ripristino degli ecosistemi, gravemente minacciati dal cambiamento climatico in atto. A un primo sguardo sembrerebbe che quest’aggregazione immediata e spontanea non abbia niente a che fare con “Il Capitale” e le sue leggi, con l’interesse per la sua conoscenza ostracizzata e denigrata sin dai tempi della sua stesura in quanto ostacolo teorico al potere costituito, che temeva soprattutto la sua efficacia pratica potenziale al tranquillo e contraddittorio avanzare del modo di produzione capitalistico.
Leggi tutto
Massimiliano Taggi: Dell'onestà, dello stadio e di altre sciocchezze
Dell'onestà, dello stadio e di altre sciocchezze
di Massimiliano Taggi
Proviamo a leggere gli eventi di questi giorni con un po' di “complessità”.
Perché, se restiamo in un dibattito speculare sulla “virtù” dell'onestà, non capiremo nulla di ciò che accade e perché.
Da una parte il PD non può che festeggiare l'arresto eccellente di un 5 stelle.
All'insegna del “Così fan tutti”, relega i fatti di corruzione e tangenti a puri “effetti indesiderati” e promuove l'indulgente garantismo che, da sempre, è direttamente proporzionale al numero di inquisiti, arrestati e condannati che il proprio schieramento colleziona.
Dall'altra il M5S che si illude di poter risolvere il problema con radiazioni immediate e calcolo delle percentuali di “disonesti” per accreditare simbolicamente l'assoluta persistenza della propria “intrinseca” e “genetica” differenza.
Ma così, nessuno discute della “radice” del problema.
In una società sana, la corruzione è una “devianza”, se i fini e gli strumenti dell'agire politico sono “retti”, il corrotto è solo un individuo che ha preferito l'arricchimento personale al perseguimento del “bene comune” che dovrebbe essere la stessa ragione per cui ci si “mette in politica”.
Ma non è questa la storia recente di questo paese e, ancor meno, di questa città.
Leggi tutto
Guido Salerno Aletta: Il punto sulla Brexit: chi, dove, quando e perché
Il punto sulla Brexit: chi, dove, quando e perché
di Guido Salerno Aletta
La strategia della premier Theresa May
Non intende rinunciare al suo schema di Accordo, e chiede di farlo votare per una terza volta mercoledì 20 marzo, nonostante sia già stato bocciato a larga maggioranza: vuole mantenere la pressione su Westminster, evitando ad ogni costo che la iniziativa politica le sfugga di mano. Se verrà finalmente approvato, la Brexit sarà differita di tre mesi, per completare l’approvazione delle normative necessarie a sostituire le fonti comunitarie. Se venisse ancora bocciato, si chiederà un lungo rinvio della Brexit per nuove trattative, dall’esito imprevedibile.
I conservatori
Sostengono il governo insieme ad una pattuglia di Unionisti nordirlandesi, ma sono divisi al loro interno, tra una maggioranza di Brexiter ed una minoranza di sostenitori del Remain, particolarmente forte nell’ambito del Gabinetto. Dodici parlamentari hanno votato, insieme all’opposizione, un emendamento che mercoledì ha stravolto la mozione governativa sulla Brexit, escludendo in ogni caso l’ipotesi di una Brexit senza Accordo.
Leggi tutto
Antonio Martone: Le favole del potere
Le favole del potere
di Antonio Martone
L’immagine di una minore scandinava di nome Greta Thunberg è diventata virale. La ragazzina, in seguito ad alcune azioni di protesta contro l’indifferenza dei governi ai cambiamenti climatici e ai disastri ambientali, si è ritrovata sulle copertine dei maggiori giornali e riviste del mondo. Nelle piazze delle città globali, tanti giovani e giovanissimi hanno manifestato a favore di una politica che rispetti l’ambiente e riconosca la terra come la nostra casa comune.
In questo quadro, risulta difficile se non impossibile trovare qualcuno tanto impudente e sconsiderato da criticare l’azione della giovanissima Greta. Non c’è cosa più evidente del fatto che l’emergenza ambientalistica sia diventata ormai un’emergenza planetaria. Sono convinto che se l’umanità dovesse sopravvivere ancora qualche secolo, o sperabilmente ancora millenni, quando gli storici faranno un consuntivo di ciò che nel nostro tempo è stato storicamente rilevante, diranno che noi in nulla ci siamo distinti quanto nella produzione di immondizia: una produzione quotidiana, incessante, irrispettosa di qualsiasi norma di civiltà e di buon senso. Immondizia non solo materiale ma culturale – tipica di un tempo che con l’alibi della produzione quantitativa ha ormai bollato con marchio d’infamia qualsiasi ricerca di tipo qualitativo. La tecnica, un tempo risorsa per l’uomo e per la sua vita, diciamolo francamente, è diventata ormai essa stessa il più grande pericolo.
Leggi tutto
Eros Barone: Critica del populismo di sinistra
![]()
Critica del populismo di sinistra
di Eros Barone
 Gli operai non hanno
patria. Non si può togliere loro quello che non hanno.
Poiché la prima cosa che il proletario deve fare è di
conquistarsi il
dominio politico, di elevarsi a classe nazionale, di
costituire se stesso in nazione, è anch'esso ancora
nazionale, seppure non certo nel senso
della borghesia.
Gli operai non hanno
patria. Non si può togliere loro quello che non hanno.
Poiché la prima cosa che il proletario deve fare è di
conquistarsi il
dominio politico, di elevarsi a classe nazionale, di
costituire se stesso in nazione, è anch'esso ancora
nazionale, seppure non certo nel senso
della borghesia.
K. Marx - F. Engels, Manifesto del Partito Comunista.
In questo articolo mi propongo di esporre alcune considerazioni critiche concernenti le ventidue tesi formulate da Carlo Formenti sul “momento populista” qui . Ritengo infatti che il testo in parola esprima in un modo particolarmente pregnante ed incisivo il succo delle posizioni politiche, economiche e culturali che caratterizzano il movimento dei populisti di sinistra.
-
Che cos’è il populismo
Parto quindi dall’‘incipit’, dove, come risposta al quesito sulla natura del populismo, viene offerta una definizione che, essendo negativa, risulta quanto mai debole: “Il populismo non è un’ideologia”. La ragione di tale debolezza va ricercata, come ammette l’autore delle tesi, nella diversità e pluralità con cui, sia nel tempo sia nello spazio, si sono manifestati, assumendo connotazioni di destra o di sinistra, i movimenti populisti: da quelli ottocenteschi a quelli contemporanei. Né contribuiscono a chiarire la reale natura dei movimenti populisti i tratti indicati in questa prima tesi: lo stile comunicativo e l’autorappresentazione in chiave nuovista. Questa incertezza terminologica e semantica è uno dei limiti, peraltro non casuali (come si vedrà), del documento redatto da Formenti.
-
Che cos’è il popolo
Nella tesi due spicca la definizione del popolo e della sua genesi attuale: “Il popolo che i populisti aspirano a rappresentare non è un’entità ‘naturale’, preesistente all’insorgenza del loro discorso politico...Si tratta al contrario d’una costruzione politica resa possibile dalla crisi catastrofica di un sistema di potere consolidato.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Il mondo - e il 5G - nascosto dai ragazzini
Il mondo - e il 5G - nascosto dai ragazzini
di Fulvio Grimaldi
Mistificazione, deresponzabilizzazione, distrazione: la manifestazione del 15 marzo
 Greta: bimba di distrazione di
massa
Greta: bimba di distrazione di
massa
Ciò che gli editocrati di schermo ed edicola ci hanno propinato nelle 72 ore, impestate di retorica e ipocrisia climatiche, tra il 14 e il 16 marzo, su ordine di servizio dei mandanti nella Cupola, non suscita solo il sospetto che merita ogni campagna politico-mediatica dell’establishment e dei media incorporati. Merita l’accusa di ipocrisia, mistificazione, occultamento della realtà. E’ uno dei più cinici assalti alla nostra integrità intellettuale e morale da almeno l’11 settembre e dalle armi di distruzione di massa di Saddam. Supera e riunisce tutte le campagne ordite e lanciate nel corso delle ultime sei presidenze Usa, dei contemporanei papati e proconsolati UE, da Delors e Prodi a Barroso e Juncker: terrorismo islamico, migrazioni, diritti umani, “dittatori” arabi e latinoamericani (limitatamente ai non-dittatori disobbedienti), #metoo, “non una di meno”, razzismo-fascismo (da che pulpito!!!), antisemitismo (sulla cui sciagurata identificazione con l’antisionismo imperversa con un inserto di ben quattro pagine il solito “manifesto”), sovranismo, populismo, medicalizzazione, bergoglismo, eccetera, eccetera.
Il suprematista bianco australiano che, uccidendo una cinquantina di musulmani in Nuova Zelanda, coglie tre piccioni con una serie di raffiche: rilancia lo scontro di (in)civiltà tra razze da colonizzare e razze colonizzanti; pompa a bue la rana esopica della minaccia razzista-fascista finalizzata a oscurare la corsa genocida alla dittatura dei pochi su chi sta fuori; collateralmente distoglie dalla catastrofe climatica che, a dispetto dei bravi ragazzi in piazza in cento paesi, torna a farsi prioritaria nella consapevolezza della gente, insieme, però, all’individuazione dei suoi responsabili. Quella che manca nelle piazze dei bravi ragazzi.
E che non ci sono neppure nei proclami della nuova Santa Giovanna d’Arco, Greta Thunberg, la ragazzetta svedese affetta dalla sindrome di Asperger (riconosciuta ufficialmente dall’Onu nel 1993, si tratta di una forma di autismo che comprende una serie di difficoltà legate soprattutto all’interazione sociale, alla sfera affettiva e motivazionale), che la campagna ha messo a capo del primo movimento mondiale degli adolescenti.
Leggi tutto
Epimeteo: Una lettera a Mario Tronti, a commento de Il popolo perduto
Una lettera a Mario Tronti, a commento de Il popolo perduto
di Epimeteo
 L'Europa si definisce
dall'interno con le
grandi correnti che non cessano di attraversarla e che la
percorrono da lunghissimi tempi (Lucien Febvre)
L'Europa si definisce
dall'interno con le
grandi correnti che non cessano di attraversarla e che la
percorrono da lunghissimi tempi (Lucien Febvre)
Caro Mario,
perdonaci il tono confidenziale di questo incipit degli appunti di lettura che abbiamo steso dopo una approfondita discussione sul tuo ultimo libro di recente pubblicazione. D’altra parte questo testo per noi non è come altri che abbiamo recensito sul nostro sito negli ultimi mesi e men che meno il suo autore è uno fra tanti. Tu sei stato per noi “il maestro” che ci ha insegnato a leggere la società e la politica con occhi nuovi, da quel famoso “punto di vista” che solo può consentire di comprendere la totalità proprio perché è il punto di vista di una parte. E poi c’è un altro motivo che giustifica questa introduzione empatica e sta nella particolare intonazione emotiva che traspare da ogni pagina de Il popolo perduto, quel pathos e quella partecipazione con cui hai esposto la tua posizione e le tue amare considerazioni sulla situazione attuale.
Il titolo stesso del libro, d’altra parte, allude a una frattura, allo spezzarsi di un legame con qualcuno con cui si è vissuto una lunga, intensissima storia, un “qualcuno” collettivo che infine si è perso di vista, per ragioni oggettive ma anche soggettive. E proprio perché siamo in presenza di responsabilità soggettive, non possiamo che sentirci compartecipi di quella sorta di “autodafé” che hai voluto mettere per iscritto alle pagine 83 e 84 del tuo testo:
“Dove ho sbagliato io insieme agli altri e a differenza di altri? Quella ricerca era tutta a livello di pensiero. Mi sono dedicato a un ‘che pensare?’ invece che applicarmi a un ‘che fare?’. Un errore intellettualistico. Per un intellettuale totus politicus, quale io credo di essere, un errore imperdonabile. Dovevo fare più politica e meno cultura malgrado la enorme importanza che do, e ho sempre dato, a quest’ultima. (…) Il primato della politica non si può teorizzare senza praticare. Chi pensa la politica deve anche farla. E, viceversa, chi fa politica deve anche pensarla.”
Leggi tutto
Carlo Formenti: Capitalismo e lotta di classe: una risposta a Alessandro Barile
Capitalismo e lotta di classe: una risposta a Alessandro Barile
di Carlo Formenti
Alessandro Barile è stato attento lettore di due miei libri recenti, “Utopie letali” e “La variante populista”, da lui commentati sul sito Carmilla con una posizione lontana dalle reazioni scandalizzate di molti intellettuali delle sinistre (cosiddette) radicali o antagoniste. In particolare, è stato fra i pochi ad apprezzare (o almeno a considerare stimolanti e legittime) due delle mie tesi di fondo: 1) quella secondo cui, oggi, lo scontro sociale non si presenta nella tradizionale forma bipolare capitale/lavoro bensì come conflitto fra potere liberal liberista e un eterogeneo blocco di soggetti sociali unificati dalla rabbia contro gli effetti del processo di globalizzazione, piuttosto che da una qualche forma – ancorché embrionale – di coscienza di classe; 2) quella che identifica nel relativismo ideologico – figlio del relativismo epistemologico delle filosofie postmoderniste – la radice culturale della perdita di ogni riferimento alla realtà sociale da parte delle sinistre radicali (in primis postoperaiste).
Recensendo – sempre su Carmilla – il mio ultimo lavoro, “Il socialismo è morto. Viva il socialismo” (di cui i lettori di Micromega hanno avuto accesso a un ampio estratto), Barile replica nella prima parte il precedente giudizio, che implica la disponibilità a raccogliere la sfida del populismo, da considerare non come ideologia (il populismo non è un’ideologia né mai lo è stato, semmai è una mentalità e una tecnica di comunicazione e di mobilitazione politica) bensì come la modalità che il conflitto sociale assume nell’attuale contesto storico – una modalità da attraversare per proiettare il movimento verso obiettivi e livelli di coscienza politica più avanzati.
Leggi tutto
coniarerivolta: Agricoltura, migranti e sfruttamento: il volto disumano del capitalismo
Agricoltura, migranti e sfruttamento: il volto disumano del capitalismo
di coniarerivolta
Pochi giorni fa la Coldiretti (Confederazione nazionale Coltivatori diretti), che rappresenta gli eterogenei interessi di piccole e medie imprese agricole, incluse molte imprese a conduzione puramente familiare, ha pubblicato un comunicato, oltre che un breve tweet, che invita ad una profonda riflessione.
Il caldo ha anticipato la maturazione dei raccolti che rischiano di rimanere nei campi senza il via libera all’ingresso in Italia dei lavoratori stagionali extracomunitari. È quanto afferma la Coldiretti che chiede l’immediata approvazione del Decreto Flussi 2019 che regola l’arrivo di manodopera dall’estero. Si tratta – sottolinea la Coldiretti – di una esigenza per l’agricoltura italiana dove i dipendenti stranieri offrono oltre ¼ della forza lavoro necessaria al settore.
Il comunicato esprime in modo esemplare e drammatico il ruolo che il capitalismo, nelle sue varie aberranti sfaccettature, immagina per i lavoratori migranti e quali interessi animano certa retorica, in un estenuante gioco delle parti in cui approcci apparentemente diversi nascondono la medesima volontà di sfruttamento.
La Coldiretti afferma una semplice verità fattuale che svela la struttura del sistema economico di un paese a capitalismo avanzato come l’Italia: l’agricoltura, specie per far fronte ai picchi stagionali, ricorre a lavoro precario e discontinuo.
Leggi tutto
Marino Badiale, Fabrizio Tringali: Sull'orlo del precipizio
Sull'orlo del precipizio
di Marino Badiale, Fabrizio Tringali
Sul numero di Marzo 2019 del mensile "L'altrapagina" appare una intervista agli autori di questo blog. L'abbiamo rielaborata per farne un articolo per il blog. Qui trovate il sito della rivista (dove mi sembra non appaiano i numeri recenti). Ringrazio l'amico Maurizio Fratta per averci dato questa opportunità [M.B.]
La maggiore urgenza del mondo contemporaneo è probabilmente quella della “conversione ecologica”, per usare il titolo di un bel libro di Guido Viale. È cioè necessario, per preservare un livello decente di condizioni di vita, ed anche di civiltà, una profonda ristrutturazione della nostra organizzazione economica e sociale, che renda il nostro modo di vivere, produrre e consumare compatibile con la preservazione degli equilibri ecologici del pianeta.
Ma questo fondamentale passaggio di civiltà è impossibile all’interno del mondo capitalista.
Il modo di produzione capitalistico, infatti, è essenzialmente un processo di accumulazione senza fine, che per potersi perpetuare, è inevitabilmente spinto a oltrepassare ogni limite, sia esso di tipo sociale o ambientale.
Ma accettare il fatto che l’attività umana debba essere compatibile con i ritmi biologici ed ecologici del pianeta significa appunto prendere atto che vi sono dei limiti che non devono essere superati. Modo di produzione capitalistico ed ecologia sono quindi essenzialmente in contraddizione fra loro, e le conseguenze del superamento dei limiti ecologici cominciano ad apparire evidenti nella stessa vita quotidiana.
Leggi tutto
Piemme: Meglio la cina che gli USA
Meglio la cina che gli USA
di Piemme
C'è qualcosa che non quadra nel casino sul Memorandum of Understanding (MoU – Memorandum d’Intesa) che l’Italia dovrebbe sottoscrivere con la Cina in merito alla “Nuova via della seta“ o Belt and Road Initiative (BRI) — il grande progetto con cui Pechino punta a rilanciare la connettività infrastrutturale e commerciale della grande massa continentale eurasiatica e a edificare una nuova architettura economico-commerciale. Conviene all'Italia diventare un partner strategico di Pechino? Secondo noi certamente sì.
Come un sol uomo, contro l'accordo tra Italia e Cina, stanno lanciando strali la Casa Bianca e la Commissione europea —quindi in Italia Pd e camerieri vari, tra cui Matteo Salvini e la Meloni. Due le parole chiave: “minaccia” e “rischio”: “Sono minacciati i valori economici dell’Occidente democratico” e “col 5G della Huawei è a rischio la sicurezza nazionale”
La piddina Mogherini, “Alto” commissario, e Katainen rincarano la dose:
«La Cina è oramai un avversario sistemico che ha modelli di governance diversi, dobbiamo difendere principi e valori… sono a rischio la prosperità, il modello sociale e i valori della Ue nel lungo periodo…. Nessuno può effettivamente raggiungere i propri obbiettivi con la Cina da solo, tutti hanno la responsabilità di assicurare il rispetto del diritto e delle pratiche europee» [Corriere della sera del 12 marzo].
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3548
Hits 2711
Hits 2583
Hits 2462
Hits 2254
Hits 2148
Hits 2048
Hits 1989
Hits 1834
Hits 1829
tonino

Sergio Cararo: Noi non dimentichiamo nulla!
Noi non dimentichiamo nulla!
Venti anni fa le bombe Nato su Belgrado
di Sergio Cararo
 La notte tra il 23 e il 24 marzo
1999, la NATO dette inizio ai bombardamenti aerei sulla
Serbia. I raid continuarono per 78
giorni, fino al 10 giugno, infliggendo danni per miliardi di
dollari, distruggendo le strutture industriali, i ponti sul
Danubio, i servizi essenziali
del paese e causando la morte di centinaia di civili. Sabato 6
aprile se ne discuterà in un convegno nazionale a Bologna e ci
saranno dibattiti
in diverse città nei prossimi giorni. Il motivo? Non essere
complici dell’oblìo su quella guerra in Europa, voluta e
attuata dalle
potenze della Nato ed anche dall’Italia. Una guerra
pretestuosa funzionale agli Usa e alla Ue per ridisegnare la
mappa geopolitica non solo dei
Balcani ma dei corridoi strategici che vanno da est a ovest, e
viceversa.
La notte tra il 23 e il 24 marzo
1999, la NATO dette inizio ai bombardamenti aerei sulla
Serbia. I raid continuarono per 78
giorni, fino al 10 giugno, infliggendo danni per miliardi di
dollari, distruggendo le strutture industriali, i ponti sul
Danubio, i servizi essenziali
del paese e causando la morte di centinaia di civili. Sabato 6
aprile se ne discuterà in un convegno nazionale a Bologna e ci
saranno dibattiti
in diverse città nei prossimi giorni. Il motivo? Non essere
complici dell’oblìo su quella guerra in Europa, voluta e
attuata dalle
potenze della Nato ed anche dall’Italia. Una guerra
pretestuosa funzionale agli Usa e alla Ue per ridisegnare la
mappa geopolitica non solo dei
Balcani ma dei corridoi strategici che vanno da est a ovest, e
viceversa.
In una pubblicazione di quelle settimane e cercando di chiarire la posta in gioco in quel conflitto, scrivevamo che: “I bombardamenti della NATO sulla Jugoslavia, sembrano essere un passaggio brutale della guerra tra Stati Uniti ed Europa per la spartizione dei mercati dell’Est. Da un lato l’aperto ostracismo degli USA contro la Serbia ha ottenuto anche il risultato di interdire i progetti europei, dall’altro l’asse anglo-americano dentro la NATO non fa mistero delle sue ambizioni al controllo strategico dei punti vitali della regione balcanica.
Gli USA hanno sabotato il progetto originario del Corridoio nr.10 ponendo il veto sull’attraversamento della Serbia. A tale scopo hanno pagato 100 milioni di dollari alla Romania per convincerla a far passare gli oleodotti più a nord (in Ungheria) invece che sul territorio jugoslavo da dove sarebbero arrivati a Zagabria, in Slovenia e poi in Germania.L’obiettivo è duplice : tagliare fuori la Jugoslavia dalle nuove rotte dell’economia e ostacolare qualasiasi interesse della Russia nei Balcani del Sud.
In secondo luogo, l’ENI aveva previsto una pipeline da Pitesti (Romania) alla raffineria di Pancevo (Jugoslavia) per la raffinazione del greggio per farlo poi arrivare con un oleodotto di 250 chilometri al terminale di Trieste.
Leggi tutto
Joseph Stiglitz: "E' l'Europa che sta spingendo l'Italia ad accettare i soldi cinesi"
"E' l'Europa che sta spingendo l'Italia ad accettare i soldi cinesi"
di Joseph Stiglitz
Parla all'Huffpost il premio Nobel: "Italexit? Se Roma esce è una tragedia per Ue, se resta è tragedia in Italia. Berlino si svegli". Con un'introduzione-commento di Giuseppe Masala
 Stiglitz, il
Bibitaro. Non ha sollevato alcun dibattito l'intervista
rilasciata da Joseph Stiglitz all'edizione italiana
dell'Huffington Post e concessa a
Bruxelles a margine della presentazione del suo ultimo
libro dal titolo emblematico: "'Rewriting the rules of
the European Economy", riscrivere le
regole dell'economia europea.
Stiglitz, il
Bibitaro. Non ha sollevato alcun dibattito l'intervista
rilasciata da Joseph Stiglitz all'edizione italiana
dell'Huffington Post e concessa a
Bruxelles a margine della presentazione del suo ultimo
libro dal titolo emblematico: "'Rewriting the rules of
the European Economy", riscrivere le
regole dell'economia europea.
Due affermazioni in particolare avrebbero dovuto portare ad una qualche riflessione. Ecco la prima:<<Se l'Italia esce causa una tragedia in Europa, se rimane la causa in Italia>>. Ed ecco l'altra:<<L'euro funziona solo se i paesi che lo usano sono simili. Ma in Europa non è così, ci sono regimi fiscali che si fanno la concorrenza all'interno della stessa Ue, i paesi si sono allontanati invece che avvicinarsi ed è successo proprio per colpa delle regole dell'euro. Vanno cambiate>>.
Mi pare evidente che Stiglitz intenda dire che un'uscita dall'Italia dall'Euro comporti una catastrofe economica e finanziaria probabilmente di livello globale mentre una sua permanenza - a regole invariate - comporti la necrosi del nostro sistema produttivo e il conseguente collasso economico e sociale. Il discorso dell'Economista è peraltro più ampio: rileva che le asimmetrie della zona euro sono insostenibili. Regole fiscali diverse per ogni singolo paese appartenente all'area (peraltro usate a fine di dumping fiscale), regole di bilancio statali rigide per tutti senza tener conto dei fondamentali [conti con l'estero]. Tutto ciò comporta la netta divaricazione sociale ed economica tra gli appartenenti all'unione. Io peraltro umilmente sostengo che l'Euro non è una moneta ma una moneta per nazione all'interno dell'area e una moneta unica verso l'esterno dell'area. Ha una natura chiaramente ambivalente.
Tornando a Stiglitz da notare anche la sottolineatura sui trattati che hanno imposto queste regole folli per il governo della moneta [Trattato di Maastricht in primis]; sono state pensate ere geologiche fa, ai tempi della sconfitta del comunismo, all'alba dell'imposizione di un sistema liberista (quelle erano le intenzioni all'epoca, poi che ci siano riusciti è altro discorso).
Leggi tutto
Roberto Romano: Via della Seta e il motore spento dell’Italia
Via della Seta e il motore spento dell’Italia
di Roberto Romano
Tria lancia un pacchetto di incentivi alle imprese ma la tesi della bassa intensità di investimenti per spiegare la bassa crescita dell’Italia non trova conferme. Piuttosto è Berlino a condurre i giochi nell’Euro-area. Così anche la Via della seta risulta uno sbocco per la Cina e per la Germania
 Inquadramento
delle politiche a sostegno della crescita degli
investimenti
Inquadramento
delle politiche a sostegno della crescita degli
investimenti
Il governo del Paese si accinge a prefigurare delle misure economiche e finanziarie per rilanciare il Paese. Il segno delle misure ricalca quanto già predisposto da altri governi. Il sole 24 ore del 17 marzo 2019 giustamente titola: “Da fisco e investimenti manovra per la crescita economia”. Le proposte del ministro dell’Economia Giovanni Tria sono relative al Patent Box semplificato, all’ampliamento dei mini-bond per finanziare le Pmi, alla Sabatini-quater in forma estesa e una nuova sezione del Fondo centrale di garanzia mirata alle medie imprese. Nel pacchetto dovrebbe rientrare anche il super-ammortamento e il taglio generalizzato dell’Ires sugli utili e le riserve che rimangono in azienda (Quest’ultimo provvedimento dovrebbe essere sostenuto con l’abbandono della mini-Ires appena nata, ma subito finita al centro di critiche per le difficoltà operative che comporterebbe la sua applicazione pratica).
L’obbiettivo è quello di rilanciare gli investimenti in macchinari e, in particolare, quelli a maggior contenuto tecnologico, unitamente ad una contrazione del carico fiscale in capo alle imprese. Se i vincoli finanziari europei compromettono gli investimenti pubblici, attraverso gli incentivi fiscali si immagina di rilanciare almeno gli investimenti privati (Cristian Perniciano della CGIL, esperto fiscale, stima gli aiuti pubblici verso le imprese pari a 10 miliardi strutturali tra il 2015 e il 2018). La logica sottesa è quella dell’ex ministro Carlo Calenda: innoviamo il sistema produttivo nazionale per rafforzare il made in Italy, in particolare nella produzione di beni strumentali e intermedi (addentrandosi nella questione, è saggio compiere una fondamentale quanto banale distinzione circa la composizione degli incentivi e le modalità con cui sono concessi; esistono, infatti, Paesi come l’Italia e la Francia che scommettono principalmente sull’utilità degli incentivi fiscali, mentre altri, come la Germania, che prediligono il finanziamento diretto a progetti selezionati tramite bando, anche attraverso la Kfw).
Leggi tutto
Lenny Benbara: La France Insoumise: dal partito al movimento
La France Insoumise: dal partito al movimento
di Lenny Benbara
Uno dei fatti più notevoli degli ultimi anni è l’evoluzione accelerata dei partiti verso l’adozione di forme movimentiste. Come conseguenza della critica alla rappresentanza e dell’ingresso in una società più fluida, le iniziative politiche hanno finito per integrare nuove forme d’impegno politico, non necessariamente più democratiche. I casi più degni di nota in Francia sono En Marche! e La France Insoumise, in parte erede del Parti de gauche. Analisi di una mutazione a partire dal caso del movimento fondato da Jean-Luc Mélenchon
 In La ragione
populista (2005), Ernesto Laclau già spiegava come
gli effetti del capitalismo globalizzato
abbiano prodotto forme di dislocazione interna ai campi
politici e pure ciò che si può
chiamare liquefazione dei
rapporti sociali; è il carattere sempre più
fragile delle norme e dei parametri di riferimento.
Predisse, a tal riguardo,
l’emergere accelerato delle forme movimentiste a spese
delle forme-partito tradizionali. I movimenti restano, in
senso generico, dei partiti, ma
rompono con le forme istituzionalizzate ereditarie della
generalizzazione del suffragio universale avvenuto nel XIX
e XX secolo. Inoltre, quando essi
emergono nella sinistra tradizionale, operano una frattura
rispetto alla forma del partito di massa [1], modello dei
movimenti operai. In Francia, il
PCF è stato a lungo ideal-tipo [2] del partito di massa,
organizzato in maniera piramidale e con più livelli in
teoria ubbidienti al
principio del centralismo democratico: la sezione, la
federazione, il consiglio nazionale e la direzione
nazionale. Per certi aspetti il PS, in
continuità con la SFIO [la socialdemocrazia francese prima
della sua rifondazione da parte di Mitterand, n.d.r] , ha
mantenuto queste forme,
mentre si organizzava attraverso correnti. Oltre a questo
modello c’erano piccoli partiti trotzkisti fondati sul
principio
dell’avanguardia illuminata. Questi partiti erano elitari,
selettivi e facevano affidamento sul ruolo guida di una
piccola minoranza nei
processi rivoluzionari. Il Parti de gauche, fondato nel
2009 da Jean-Luc Mélenchon da una scissione del PS, è da
questo punto di vista
più vicino alla tradizione trotzkista e al modello del
partito di quadri [3]. Ci sono diverse cause nell’emergere
di movimenti e nel
crollo delle strutture tradizionali. Tutto ciò ha inizio
con l’avvento dei movimenti anti-globalizzazione degli
anni ’90, come
ATTAC che ha portato ai comitati del No al referendum del
2005 sul Trattato costituzionale europeo. Poi, dagli anni
2000, abbiamo assistito al
rapidissimo sviluppo dell’uso politico di internet e dei
social network.
In La ragione
populista (2005), Ernesto Laclau già spiegava come
gli effetti del capitalismo globalizzato
abbiano prodotto forme di dislocazione interna ai campi
politici e pure ciò che si può
chiamare liquefazione dei
rapporti sociali; è il carattere sempre più
fragile delle norme e dei parametri di riferimento.
Predisse, a tal riguardo,
l’emergere accelerato delle forme movimentiste a spese
delle forme-partito tradizionali. I movimenti restano, in
senso generico, dei partiti, ma
rompono con le forme istituzionalizzate ereditarie della
generalizzazione del suffragio universale avvenuto nel XIX
e XX secolo. Inoltre, quando essi
emergono nella sinistra tradizionale, operano una frattura
rispetto alla forma del partito di massa [1], modello dei
movimenti operai. In Francia, il
PCF è stato a lungo ideal-tipo [2] del partito di massa,
organizzato in maniera piramidale e con più livelli in
teoria ubbidienti al
principio del centralismo democratico: la sezione, la
federazione, il consiglio nazionale e la direzione
nazionale. Per certi aspetti il PS, in
continuità con la SFIO [la socialdemocrazia francese prima
della sua rifondazione da parte di Mitterand, n.d.r] , ha
mantenuto queste forme,
mentre si organizzava attraverso correnti. Oltre a questo
modello c’erano piccoli partiti trotzkisti fondati sul
principio
dell’avanguardia illuminata. Questi partiti erano elitari,
selettivi e facevano affidamento sul ruolo guida di una
piccola minoranza nei
processi rivoluzionari. Il Parti de gauche, fondato nel
2009 da Jean-Luc Mélenchon da una scissione del PS, è da
questo punto di vista
più vicino alla tradizione trotzkista e al modello del
partito di quadri [3]. Ci sono diverse cause nell’emergere
di movimenti e nel
crollo delle strutture tradizionali. Tutto ciò ha inizio
con l’avvento dei movimenti anti-globalizzazione degli
anni ’90, come
ATTAC che ha portato ai comitati del No al referendum del
2005 sul Trattato costituzionale europeo. Poi, dagli anni
2000, abbiamo assistito al
rapidissimo sviluppo dell’uso politico di internet e dei
social network.
Leggi tutto
Giorgio Cremaschi: 24 marzo 1999 il giorno della vergogna di D’Alema, Berlusconi e Prodi, di Ue e Nato
24 marzo 1999 il giorno della vergogna di D’Alema, Berlusconi e Prodi, di Ue e Nato
di Giorgio Cremaschi (Potere al Popolo)
Sono stato invitato dal Forum di Belgrado alla conferenza internazionale che si terrà in questi giorni nella capitale della Serbia, per ricordare la guerra criminale che la NATO scatenò contro quel paese esattamente venti anni fa. Non potrò essere presente ma voglio qui condividere ciò che avrei detto in quella sede, anche per conto di Potere al Popolo che condivide le ragioni e i temi alla conferenza.
“Il 24 marzo 1999, violando ogni legalità internazionale e ogni diritto umano, i bombardieri della NATO iniziarono i loro raid contro quella che allora si chiamava Repubblica Federale Yogoslava di Serbia e Montenegro. Il governo italiano, guidato da D’Alema, sostenuto da Cossutta e Cossiga, appoggiato in questo caso da Berlusconi, con il consenso del presidente della Repubblica Scalfaro, decise di partecipare alla guerra. In realtà la decisione l’aveva già presa il governo Prodi, che prima di cadere per il venir meno del sostegno di Rifondazione Comunista, aveva deliberato l’Act Order con il quale si predisponevano le nostre forze armate alla guerra sotto comando NATO.
Così i bombardieri italiani ebbero l’onore, D’Alema ha sempre rivendicato l’impresa, di partecipare alla prima guerra europea dal 1945, al primo bombardamento aereo di una capitale europea, Belgrado, dalla sconfitta del fascismo.
Leggi tutto
Alberto Tarozzi: Dedicato a chi parla di 70 anni di pace europea
Dedicato a chi parla di 70 anni di pace europea
24 marzo 1999, Jugoslavia
di Alberto Tarozzi
Erano passate da poco, le 24 del 23 marzo 1999 quando sull’aeroporto di Belgrado cominciarono a piovere le bombe. Gli aerei avevano smesso di atterrare una decina di ore prima. Le bombe avrebbero continuato a cadere per 78 giorni su tutto il territorio di un paese chiamato Jugoslavia, che di lì a qualche tempo avrebbe perso quel nome.
Caddero sul petrolchimico di Pancevo e sulla raffineria di Novi Sad, con le conseguenze a orologeria di un effetto cancro, dovuto allo spargimento di veleni che vagarono come nuvole di morte entro e anche fuori dai confini della nazione. Caddero sulle fabbriche di Kragujevac e sull’abitato di Nis. Ma anche là dove si diceva che c’era gente da salvare: in Kosovo, preso di mira pure da proiettili all’uranio impoverito che non guardarono in faccia nessuno, nemmeno il colore della divisa dei soldati e l’etnia delle genti contaminate.
Fin dal primo momento qualcuno disse che non bisognava chiamarla guerra oppure, al massimo, guerra umanitaria. Operazione di polizia internazionale volta a neutralizzare le malefatte di un governo nemico.
Le colpe dei padri ricadono sui figli, come è ben noto, e le colpe dei governanti vanno fatte ricadere sui cittadini. Meglio se indifesi, al punto tale da azzerare le perdite. Ovviamente le perdite di chi guida i bombardieri.
Leggi tutto
Gennaro Carotenuto: A futura memoria per il Venezuela e per l’America latina: il posto dei militari è nelle caserme
A futura memoria per il Venezuela e per l’America latina: il posto dei militari è nelle caserme
di Gennaro Carotenuto
Sabato in Venezuela saranno due mesi dall’autoinvestitura dell’antipapa ghibellino Juan Guaidó. Due mesi trascorsi con una parte rilevante dell’opinione pubblica internazionale che attende un rovesciamento violento di Nicolás Maduro. Ma la risposta, ora e sempre in America latina, è NUNCA MÁS, mai più golpe.
Due piccoli esempi di come il partito del golpe, della mancata riflessione su cosa sia un golpe in America latina, stia inquinando i pozzi interpretativi della crisi venezuelana:
1) Un’importante televisione europea mi ha proposto un’intervista, ma a condizione che non si parlasse di politica (sic), perché sa professore, la soluzione della crisi sarà militare e quindi da lei vorremmo un quadro degli equilibri interni dell’esercito bolivariano, figure di spicco, relazioni di potere, chi può essere l’uomo chiave. Perché sa professore, la soluzione è militare. Ho declinato l’invito.
2) La settimana scorsa ho partecipato alla storica trasmissione “Radio Anch’io” di Radio1 RAI. Uno degli interlocutori, un militante antichavista, a domanda su cosa fosse andato storto con Guaidó, ha risposto che “purtroppo l’esercito non lo ha seguito”. Il secondo, un redattore dell’autorevole “Limes”, ha detto papale papale che ciò non è accaduto perché “decine di migliaia di militari cubani” sarebbero (condizionale mio) infiltrati nell’esercito venezuelano.
Leggi tutto
Giacomo Gabellini: Il Pentagono: la deindustrializzazione minaccia la sicurezza nazionale
Il Pentagono: la deindustrializzazione minaccia la sicurezza nazionale
di Giacomo Gabellini
Lo scorso settembre, il Pentagono ha pubblicato un rapporto in cui si richiamava l’attenzione sul fatto che un numero sempre più elevato componenti cruciali per il funzionamento dei sistemi di difesa nazionali viene fornito da produttori localizzati in altri Paesi stranieri. Il motivo è presto detto: il funzionamento dei missili è messo in serio pericolo dal fatto che l’impresa statunitense che fabbricava interruttori di alimentazione al silicio ha recentemente chiuso i battenti e non ne esiste un’altra sul suolo nazionale in grado di rimpiazzarla, mentre per quanto riguarda la fornitura di motori a combustibile solido si è dovuto ricorrere a un’azienda norvegese, a causa di non meglio specificati problemi tecnici riscontrati nelle fasi avanzate di fabbricazione dall’unico produttore statunitense rimasto.
Quello missilistico è tuttavia soltanto uno dei tanti settori rispetto ai quali i militari statunitensi si sono visti obbligati a rivolgersi a società straniere per garantire la continuità delle forniture; nel documento redatto dagli specialisti del Dipartimento della Difesa si fa infatti riferimento ad elementi essenziali come l’alluminio laminato a freddo da impiegare per le blindature dei mezzi pesanti, o a procedure tecniche che richiedono un elevato know-how quali la manutenzione dei sistemi di propulsione dei sottomarini. Senza contare il comparto dell’elicotteristica, messo a dura prova dal fallimento (avvenuto nel 2016) della sola società statunitense in grado di fabbricare pezzi di ricambio per le ali rotanti degli Apache Ah-64E, Osprey V-22 e Sikorsky S-65.
Leggi tutto
coniarerivolta: Flat tax, ancora tu…
Flat tax, ancora tu…
di coniarerivolta
Durante la campagna elettorale per le politiche, la Lega aveva promesso di tagliare le tasse a tutti attraverso la realizzazione del sogno liberista incarnato dall’iniqua ‘flat tax’. Quello che invece è uscito dal calderone della legge di bilancio è qualcosa di assai diverso. Ora, con l’avvicinarsi della campagna elettorale delle europee, la flat tax, nella sua versione più estesa, torna sulla scena. Tramite dichiarazioni di Salvini e del sottosegretario allo Sviluppo Siri, infatti, la Lega rilancia, promettendo un’estensione della tassa piatta “alle famiglie”, ovvero ai redditi da lavoro dipendente. Ne è seguita una bagarre politica con i 5stelle sui costi della possibile operazione con cifre che oscillano dai 59 (rapporto del MEF) ai 12 miliardi annui (studio interno della Lega). Sembra che lo studio leghista si riferisca all’applicazione della flat tax per le sole famiglie con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, una possibile variante al vaglio assai più contenuta nei suoi effetti distributivi e nei suoi costi. Ma al di là delle scaramucce tra i partiti di governo, prima di conoscere i dettagli dell’effettiva proposta della Lega (se mai ve ne sarà una definitiva), è interessante sondare alcuni umori sul tema fiscale riemersi all’improvviso nel pubblico dibattito. Si tratta di una buona occasione per fare ancora una volta il punto sulle iniquità presenti e future del sistema tributario in Italia.
Leggi tutto
Mimmo Porcaro: Se cominciamo a fare sul serio
![]()
Se cominciamo a fare sul serio
di Mimmo Porcaro
 L’assemblea che il 9 marzo, a
Roma, ha lanciato il Manifesto per la sovranità
costituzionale, ha avviato un processo che può
portare, in tempi non remoti, alla costituzione di un
soggetto politico capace di fare
uscire dal minoritarismo, e dal ghetto informativo in cui
è stato rinchiuso dal mainstream, il discorso che da tempo
lega la questione sociale
e la questione nazionale, la lotta al liberismo e la lotta
all’Unione europea.
L’assemblea che il 9 marzo, a
Roma, ha lanciato il Manifesto per la sovranità
costituzionale, ha avviato un processo che può
portare, in tempi non remoti, alla costituzione di un
soggetto politico capace di fare
uscire dal minoritarismo, e dal ghetto informativo in cui
è stato rinchiuso dal mainstream, il discorso che da tempo
lega la questione sociale
e la questione nazionale, la lotta al liberismo e la lotta
all’Unione europea.
Proprio per facilitare questo processo è opportuno iniziare a puntualizzare ed approfondire alcune questioni nodali, sia perché ogni salto politico-organizzativo richiede un avanzamento nell’analisi e nell’articolazione della proposta, sia perché quando si inizia ad uscire da spazi ristretti è necessario tradurre i concetti in un linguaggio comprensibile ed efficace. Se cominciamo a fare sul serio abbiamo bisogno di un ragionamento più complesso e di un discorso più semplice.
1
Nello spirito del Manifesto non inizio dalla questione, pur dirimente, dell’Ue e dell’euro, perché dobbiamo abituarci a concentrare il nostro discorso sugli elementi propositivi e positivi, e non su quelli negativi e distruttivi. Ho già detto, e ripeto, che il limite maggiore del sovranismo storico (un termine con cui non indico questa o quella organizzazione, ma una cultura, uno stile di pensiero ed un insieme di riflessi mentali che sono anche in me) sta nel presentarsi di fatto come il partito del “No Ue – No euro”, esaltando più il mezzo che il fine e presentando all’esterno il lato più complicato e problematico della propria proposta: cosa che può concorrere a spiegare il minoritarismo di quest’area, nonostante la ricchezza delle intuizioni e delle analisi.
E’ per questo che il Manifesto (che pure sull’Ue dice cose non equivocabili) non parte dalla questione europea ma dalla questione italiana. Una questione che a mio avviso deve essere riassunta nella necessità di ricostruzione di uno stato degno di questo nome, come risposta alle esigenze essenziali degli italiani e di tutti coloro che in Italia vivono e lavorano.
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: Il corpo: innatismo e materialismo
Il corpo: innatismo e materialismo
di Elisabetta Teghil
 “E’ maschio o femmina? lo deciderà
lo Stato!”
“E’ maschio o femmina? lo deciderà
lo Stato!”
(dal film Louise Michel- Francia 2009)
Che la lettura di classe, da sola, non sia sufficiente a leggere la società e, in particolare, la specificità delle questioni di genere, la cui caratteristica precipua è la trasversalità, non solo è condivisibile, ma è patrimonio del movimento femminista.
Ma è importante partire da questo dato perché, intorno al tema, c’è molta confusione e sottovalutandolo, non solo ci neghiamo una chiave di lettura, ma, anche e soprattutto è imprescindibile nell’odierna agenda politica delle nostre lotte.
L’uso dell’emancipazione come fine e non come mezzo, nella visione femminista socialdemocratica, ha annullato l’orizzonte della libertà, la strumentalizzazione delle diversità è stata uno dei veicoli attraverso i quali sono state promosse le guerre umanitarie, la tutela delle differenze sessuali, con una lettura asimmetrica, viene “scoperta” solo in paesi non allineati all’occidente, per cui si è arrivati al paradosso tragico, che se circola in rete il blog di una lesbica di un certo paese che denuncia persecuzione, siamo sicure che quel paese è nell’elenco dei paesi da invadere.
La generalizzazione del principio della cooptazione di persone provenienti da ceti, etnie, ambienti oppressi che, in cambio della loro personale promozione sociale, contribuiscono all’oppressione dei gruppi di provenienza e degli oppressi/e tutti/e, ha avuto la sua manifestazione più eclatante nella nomina di un presidente nero negli Stati Uniti, tra l’altro già decisa a tavolino nel 2002, mentre i neri/e d’America che sono il 12% degli americani tutti, in carcere rappresentano il 50% dei detenuti/e.
In questo quadro il pinkwashing è l’emblema delle democrazie sessuali occidentali.
Leggi tutto
Giorgio Gattei: A margine di “Proletkult” dei Wu Ming: quando Bogdanov insegnava a Bologna (1910-1911)
A margine di “Proletkult” dei Wu Ming: quando Bogdanov insegnava a Bologna (1910-1911)
di Giorgio Gattei
Con una postilla di Roberto Sassi
 1. Aleksandr
Aleksandrovič Malinovskij detto Bogdanov (1873-1928) è
stato il maggiore
antagonista politico di Lenin negli anni precedenti la
Grande Guerra e appena dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
Biologo di professione e filosofo
per vocazione, teorizzò l’empiriomonismo (stroncato da
Lenin in Materialismo ed empiriocriticismo nel
1908) e la
“tectologia”, ovvero «la scienza generale
dell’organizzazione» giusto il convincimento che «ogni
attività
umana nel campo della tecnica, della prassi sociale, della
ricerca scientifica e dell’arte» poteva essere studiata «dal
punto di vista organizzativo». Al tempo della rivoluzione
d’Ottobre fu
l’artefice del movimento di massa del Proletkult
(contrazione di Proletarskaja Kultura) che sosteneva
l’autonomia delle iniziative
culturali operaie a prescindere dalle indicazioni di
partito che alla fine del 1920 raccoglieva quasi mezzo
milione di attivisti (ma il movimento
venne ricondotto da Lenin nel 1923 nell’alveo delle
organizzazioni partitiche).
1. Aleksandr
Aleksandrovič Malinovskij detto Bogdanov (1873-1928) è
stato il maggiore
antagonista politico di Lenin negli anni precedenti la
Grande Guerra e appena dopo la Rivoluzione d’Ottobre.
Biologo di professione e filosofo
per vocazione, teorizzò l’empiriomonismo (stroncato da
Lenin in Materialismo ed empiriocriticismo nel
1908) e la
“tectologia”, ovvero «la scienza generale
dell’organizzazione» giusto il convincimento che «ogni
attività
umana nel campo della tecnica, della prassi sociale, della
ricerca scientifica e dell’arte» poteva essere studiata «dal
punto di vista organizzativo». Al tempo della rivoluzione
d’Ottobre fu
l’artefice del movimento di massa del Proletkult
(contrazione di Proletarskaja Kultura) che sosteneva
l’autonomia delle iniziative
culturali operaie a prescindere dalle indicazioni di
partito che alla fine del 1920 raccoglieva quasi mezzo
milione di attivisti (ma il movimento
venne ricondotto da Lenin nel 1923 nell’alveo delle
organizzazioni partitiche).
Ma Bogdanov è stato anche l’autore di un romanzo utopico La stella rossa in cui si racconta come un tal compagno Leonid fosse volato su Marte, “pianeta rosso” per definizione, a scoprirvi che lassù vi avevano già realizzato il socialismo (il lavoro era solo “volontario” ed il consumo dei prodotti non era limitato “in nessun modo: ognuno prende ciò che gli serve e nella quantità che vuole”). Ritornato sulla terra, l’astronauta descriverà per iscritto la sua esperienza straordinaria che Bogdanov pubblicherà nel 1908 (con continuazione nel 1913 con L’ingegnere Menni).
Nel libro dei Wu Ming la storia di Leonid ha un seguito inaspettato perchè su Marte (in verità il pianeta non era Marte, bensì Nacun) il terrestre aveva lasciato incinta la “marziana” Netti, la cui figlia Denni sarà inviata nel 1927 sul nostro pianeta in una difficile missione di sopravvivenza per Nacun minacciato di estinzione.
Leggi tutto
Domenico Moro: Centralizzazioni e salvataggio statale della Deutsche Bank
Centralizzazioni e salvataggio statale della Deutsche Bank
di Domenico Moro
Come abbiamo rilevato in un precedente articolo, “il manifesto franco-tedesco per una politica industriale europea”, firmato da Francia e Germania, facilita i processi di centralizzazione nella Ue. Le acquisizioni e fusioni tra imprese sono funzionali alla competizione su un mercato più difficile, a causa della globalizzazione, della perdurante stagnazione economica e delle più restrittive regole bancarie europee. Aspetto importante del processo di centralizzazione è il ruolo centrale che vi riveste lo Stato, a dispetto della retorica neoliberista e delle regole europee contro gli aiuti di Stato.
Un esempio emblematico di tale tendenza ci è offerto in questi giorni dalla Germania, dove è in atto un grande processo di ristrutturazione del settore bancario. A tenere banco è la fusione di Deutsche Bank e Commerz Bank, le due principali banche tedesche, che porterebbe al terzo gruppo europeo. Il ruolo dello Stato federale in questa operazione è centrale. In primo luogo, perché lo Stato detiene il controllo di Commerz, con il 15% delle azioni. In secondo luogo, perché sarà lo Stato tedesco ad accollarsi gli enormi costi della ristrutturazione delle due banche. Infatti, si prevedono tagli di almeno 30mila posti di lavoro, svalutazioni di portafoglio e badwill[1], cessioni di rami d’azienda, chiusura di centinaia di filiali e soprattutto una massiccia iniezione di capitale.
Leggi tutto
Francesco Piccioni: Arriva la Cina, traballa l’asse Ue-Usa
Arriva la Cina, traballa l’asse Ue-Usa
di Francesco Piccioni
Xi Jinping sta facendo le valige per il suo viaggio in Italia, con un piano abbastanza chiaro e progetti specifici precisi per quanto riguarda il nostro paese. Qui la situazione è decisamente più confusa, con un governo diviso e un presidente della Repubblica che è stato regista discreto di questa operazione da un paio d’anni a questa parte. Ma la confusione è in fondo anche europea, perché gli inviti alla “cautela” nei rapporti con i cinesi arrivano spesso da governi che con la Cina fanno affari immensi, senza neanche sottilizzare troppo sugli investimenti che questi portano.
Come spiega Paolo Panerai, nella sua rubrica su Milano Finanza (gruppo Class Editori, che controlla anche ItaliaOggi), in perenne attesa che “l’Europa” si muova con una prospettiva comune, “è comprensibile che l’Italia, attualmente quinto partner commerciale europeo della Cina, cerchi di non perdere l’occasione, enorme, sul piano commerciale della Via della Seta”.
Il concetto è più chiaro se si tiene conto del fatto che “Il leader della Ue, la Germania, cerca solo di cogliere le migliori occasioni di affari con la Cina senza coordinarsi con gli altri Paesi della Ue”. Ma lo stesso atteggiamento è tenuto nei confronti di molti altri partner commerciali globali. Una “concorrenza interna” che svuota alcuni paesi mentre rafforza – relativamente – solo la Germania e i suoi più stretti satelliti, a cominciare dall’Olanda.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Il «partito americano» nelle istituzioni Ue
Il «partito americano» nelle istituzioni Ue
di Manlio Dinucci
Una risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 marzo sostiene che «la Russia non può più essere considerata un partner strategico e l’Unione europea deve essere pronta a imporle ulteriori sanzioni se essa continua a violare il diritto internazionale»
«La Russia non può più essere considerata un partner strategico e l’Unione europea deve essere pronta a imporle ulteriori sanzioni se essa continua a violare il diritto internazionale»: così stabilisce la risoluzione approvata dal Parlamento europeo il 12 marzo con 402 voti a favore, 163 contro e 89 astensioni. La risoluzione, presentata dalla parlamentare lettone Sandra Kalniete, nega anzitutto la legittimità delle elezioni presidenziali in Russia, definendole «non-democratiche», presentando così il presidente Putin come un usurpatore.
Accusa la Russia non solo di «violazione dell’integrità territoriale dell’Ucraina e della Georgia», ma dell’«intervento in Siria e dell’interferenza in paesi come la Libia», e, in Europa, di «interferenza mirante ad influenzare le elezioni e ad accrescere le tensioni». Accusa la Russia di «violazione degli accordi di controllo degli armamenti», attribuendole la responsabilità di aver affossato il Trattato Inf. La accusa inoltre di «estese violazioni dei diritti umani al suo interno, comprese torture ed esecuzioni extragiudiziali», e di «assassini compiuti da suoi agenti con armi chimiche sul suolo europeo».
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Scommesse sul futuro: G7 o 5G?
Scommesse sul futuro: G7 o 5G?
di Pierluigi Fagan
L’argomento che affronteremo è molto complicato e faticherà a stare dentro un post. Chi scrive non ha conflitti di interesse sul tema (la sua vita non dipende da lavori e contatti con americani, cinesi, UE, governo, opposizione, entità di interesse geopolitico o di telecomunicazioni). Sulla competenza giudicherà chi legge.
Il recente viaggio di Xi Jinping in Italia, ha scatenato una serie di giudizi, timori, entusiasmi e smarrimenti su cosa sarebbe per noi giusto fare nella relazione col gigante cinese. Innanzitutto si tenga sempre conto di questo, quello cinese è un gigante, per popolazione, per Pil, per potenza complessiva e prospettive future. Poiché ogni relazione, idealmente, dovrebbe basarsi sulla reciprocità, tra pesi mosca e pesi massimi è assai difficile avere reciprocità, tant’è che nel pugilato si hanno categorie differenti. Altresì, il mondo non è governato da una super-parte Federazione Planetaria delle Regole e quindi è norma che si stia tutti nella stessa categoria, grandi e piccoli, forti e deboli, giovani ed anziani. Le stesse regole sono oggetto di competizione, prima della competizione in quanto tale. E’ così che il gigante americano ha governato il nostri sistema fino ad oggi, lui peso massimo, noi peso mosca.
Alcuni dei commenti che avrete letto cercando di farvi una opinione in merito, sono fatti da incompetenti.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3587
Hits 2724
Hits 2602
Hits 2486
Hits 2266
Hits 2168
Hits 2073
Hits 2011
Hits 1849
Hits 1844
tonino

Frédéric Lordon: Uscire dall’impasse europea
Uscire dall’impasse europea
di Frédéric Lordon*
 Il
provincialismo è una malattia
culturale grave. Quasi mortale. Lo dimostra ogni giorno il
livello della discussione pubblica – imposta dai media
mainstream – normalmente
al di sotto degli standard minimi vigenti altrove. E, come
andiamo ripetendo da anni, questa brutta malattia è
diffusa soprattutto “a
sinistra”, dove è totale la sudditanza alle cazzate
sparate da Repubblica e Tg3 (che pure
non dovrebbe più poter
essere scambiato con la TeleKabul del compianto
Sandro Curzi).
Il
provincialismo è una malattia
culturale grave. Quasi mortale. Lo dimostra ogni giorno il
livello della discussione pubblica – imposta dai media
mainstream – normalmente
al di sotto degli standard minimi vigenti altrove. E, come
andiamo ripetendo da anni, questa brutta malattia è
diffusa soprattutto “a
sinistra”, dove è totale la sudditanza alle cazzate
sparate da Repubblica e Tg3 (che pure
non dovrebbe più poter
essere scambiato con la TeleKabul del compianto
Sandro Curzi).
Ma neppure noi osavamo credere a una sindrome autenticamente bipolare (in senso quasi clinico), per cui se un’analisi critica impietosa dell’Unione Europea viene fatta da compagni italiani viene immediatamente bollata come “sovranista” (o peggio), mentre se arriva in traduzione da una prestigiosa rivista francese ottiene una pubblicazione in prima pagina.
E’ quello che è accaduto con la versione italiana di Le Monde Diplomatique, tradotta e pubblicata in allegato da il manifesto. Ovvero da un quotidiano che ha pesantemente contribuito a diffobdere, qui da noi, una visione ideologica, “romantica” assolutamente e fasulla della Ue.
Vi proponiamo perciò l’editoriale di apertura di Frédéric Lordon, che potremmo sottoscrivere pressoché per intero, con distinguo veramente marginali. Straordinaria, secondo noi, soprattutto l’analisi sulla “sinistra colta” incapace di prendere atto della realtà; e, al contrario, l’atteggiamento del nostro “blocco sociale” che capisce immediatamente qual’è il problema (dovendo fare i conti con la perdita di potere d’acquisto dall’introduzione dell’euro in poi).
Buona lettura e che l’ideologia “europeista” vi abbandoni…
* * * *
Invece di vertere sui problemi comuni dell’Unione, le elezioni europee giustappongono ventisette consultazioni sulla politica interna. Nella maggior parte degli Stati, gli elettori si pronunceranno soprattutto a favore o contro la squadra al governo.
Leggi tutto
humanaesfera: Internet: una storia di evocazione, di bolle e di sussunzione del capitale
Internet: una storia di evocazione, di bolle e di sussunzione del capitale
di humanaesfera
Internet: una forma che inizialmente ha impedito la proliferazione della materia bruta, selvaggia, e che ha richiesto decine di anni per poter essere domata, ed essere sussunta realmente al capitale
 1. Una forma
che non era in grado di opporsi all'irruzione di un
contenuto sociale indomabile (ma che si trovava ad
essere contenuto all'interno dei suoi limiti)
1. Una forma
che non era in grado di opporsi all'irruzione di un
contenuto sociale indomabile (ma che si trovava ad
essere contenuto all'interno dei suoi limiti)
L'iniziale apparizione pubblica di Internet (negli anni '90, con il World Wide Web [*1]) ha generato delle circostanze sociali inedite che il capitale, per decine d'anni, non è stato in grado di sussumere realmente all'interno della forma merce e della forma capitale. Per circa 20 anni, la pirateria (relativa al software, alla conoscenza e all'arte) è stata irreprimibile e generalizzata, e c'erano migliaia di ambiti (forum di discussioni, siti a tema ...) dove era possibile a chiunque - di solito, facendo uso di pseudonimi - appropriarsi, sviluppare, creare e condividere gratis ogni tipo di conoscenza e arte direttamente con qualsiasi altro essere umano sulla faccia della terra che frugasse su Internet. Uno degli aspetti era la potente comunità di software libero che spesso dettava quelli che erano i progressi di Internet e del software in opposizione alle imprese, contro la mercificazione e contro lo Stato.
L'iniziale struttura fisica di Internet era una forma materiale creata e foraggiata attraverso un afflusso di capitali provenienti da tutto il mondo, alla folle ricerca di opportunità che promettevano accumulazione. L'effetto collaterale è stato quello di creare condizioni tecniche selvagge, che a partire da una tale base, almeno sul piano intellettuale ed artistico, hanno portato ad una proliferazione di contenuto sociale libero, che nella pratica affermava senza troppe chiacchiere il principio: «da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni».
Di fronte ad un simile contenuto sociale, la proprietà privata ( e pertanto l'estrazione di plusvalore) era non solo inadeguata, ma impraticabile.
Leggi tutto
Chiara Zoccarato: Perché il lavoro di cittadinanza
Perché il lavoro di cittadinanza
di Chiara Zoccarato
 La proposta di
un lavoro di cittadinanza nasce dalla necessità di
offrire un’alternativa sostenibile alla disoccupazione e
all’inattività, purtroppo in crescita, andando a garantire un
reddito a chi ne è attualmente privo. Contemporaneamente, si
consente la fornitura di servizi che altrimenti sarebbero
fuori mercato, aumentando il benessere della comunità, cioè la
ricchezza reale
condivisa di beni e servizi, diminuendo la spesa pubblica
assistenziale e aumentando il Prodotto Interno Lordo.
La proposta di
un lavoro di cittadinanza nasce dalla necessità di
offrire un’alternativa sostenibile alla disoccupazione e
all’inattività, purtroppo in crescita, andando a garantire un
reddito a chi ne è attualmente privo. Contemporaneamente, si
consente la fornitura di servizi che altrimenti sarebbero
fuori mercato, aumentando il benessere della comunità, cioè la
ricchezza reale
condivisa di beni e servizi, diminuendo la spesa pubblica
assistenziale e aumentando il Prodotto Interno Lordo.
Perché è necessario affrontare la disoccupazione? Perché è un problema rilevante dal punto di vista economico, sociale e politico: il disoccupato non ha di che vivere e dipende interamente dai sussidi pubblici, dalla carità o dai parenti; non partecipa all’organizzazione economica e sociale del paese; rappresenta uno spreco di risorse produttive, perché non viene impiegato nella forza lavoro e il suo contributo, grande o piccolo che sia, viene comunque perso. Disoccupazione, sottoccupazione e inattività deprimono la domanda interna e costringono a fare affidamento sulla domanda estera, che non possiamo, e nemmeno vogliamo, controllare; esse, infine, aumentando «l’esercito industriale di riserva», indeboliscono il potere contrattuale nei rapporti di forza capitale-lavoro.
La proposta di attuare programmi di lavoro non è nuova, ha una storia illustre – il New Deal dell’amministrazione Roosevelt, per citare l’esempio più noto – e vanta un pedigree accademico di tutto rispetto, dal momento che a teorizzare l’intervento dello Stato per la creazione di posti di lavoro in modo diretto in fase di recessione economica furono economisti come J.M. Keynes e Hyman Minsky; oggi a spingere per questa proposta è soprattutto la scuola della Teoria della Moneta Moderna (MMT), i cui principi sono alla base delle proposte di Bernie Sanders del Programma di Lavoro Garantito Federale e del Green New Deal.
Leggi tutto
Mario Gangarossa: Sulla "confessione" di Battisti
Sulla "confessione" di Battisti
di Mario Gangarossa
Ripubblico quello che ho scritto su Battisti il 16 gennaio. Non ho motivo per cambiare una virgola.
L'abiura è l'unica strada che hanno i vinti per salvare quel poco di vita che gli resta. Se avesse abiurato in tempo o se si fosse pentito si sarebbe risparmiato una vita da fuggitivo. Se avesse denunciato e fatto arrestare i suoi sodali vivrebbe tranquillo sotto falso nome e a spese dello stato.
Perché dovrebbe finire gli ultimi anni da vecchio nella tortura dell'isolamento? Perché da lui si dovrebbe pretendere una "coerenza" maggiore di quella di chi ha abiurato (per convenienza e interesse) e si è posto al servizio dei vincitori per sua libera scelta. "Rivoluzionari" in gioventù, oggi solide colonne dell'ordine borghese.
La guerra sociale è sangue, miseria, crudeltà, paura. Non si fanno prigionieri e non si torna indietro.
* * * *
Salva la pelle, ragazzo di ieri. Sei solo. Nessuno lotterà per te.
16 gennaio 2019
Battisti è solo un ex ragazzo di 40 anni fa che ha passato la vita a sfuggire alle conseguenze delle sue “cazzate” giovanili. Non è un teorico, non è un dirigente politico-militare, non è la punta di diamante di una “internazionale rossa” che ne ha coperto la fuga e ne prepara l'apoteosi e il suo passaggio alla storia come martire di una causa giusta.
Leggi tutto
Fulvio Scaglione: Possiamo dirlo, ora? Il Russiagate era solo una trappola di Obama a Trump
Possiamo dirlo, ora? Il Russiagate era solo una trappola di Obama a Trump
di Fulvio Scaglione
Le conclusioni del rapport del procuratore speciale Robert Mueller smontano, dopo due anni di indagini, la teoria di chi pensava che The Donald fosse stato eletto grazie a Putin. Una teoria farlocca, orchestrata dall’ex presidente per aiutare Hillary (prima) e avvelenare i pozzi (poi)
Il 19 maggio del 2017, quasi due anni fa, questo giornale, Linkiesta ebbe il coraggio di pubblicare un articolo intitolato “Il Russiagate è una bufala”. Coraggio non episodico, perché il 16 giugno dello stesso anno ne pubblicò un secondo intitolato “Perché il Russiagate è uno scandalo senza prove” e il 10 settembre del 2018 un terzo intitolato “Il complotto contro Trump è molto più pericoloso di Trump”. Ora sembra niente ma ci volevano solidi attributi giornalistici. Erano infatti i tempi in cui tutti i giornali più importanti, attraverso le firme più note, riempivano pagine e pagine con annunci perentori su come Donald Trump fosse stato insediato alla Casa Bianca direttamente da Vladimir Putin e dai suoi magici hacker. I corrispondenti dagli Usa facevano a gara per raccontare, un giorno sì e l’altro anche, che era saltato fuori l’elemento chiave, quello che inchiodava il Presidente parvenu, l’idiota corrotto che non sarebbe mai arrivato tanto in alto se, appunto, non fosse stato aiutato da un complotto internazionale. E c’era chi pubblicava libri pieni di “prove”, esaltati come operazioni verità condotte in nome della democrazia.
Leggi tutto
Dante Barontini: E’ tornato Dragonda
E’ tornato Dragonda
di Dante Barontini
E’ presto per dire se la firma del Memorandum of Understanding tra Italia e Cina segnerà davvero un “svolta epocale”, ma di certo non è un atto commerciale banale, tra le centinaia che vengono firmati ogni anno.
Da parte italiana, certamente, non c’è alcun desiderio di enfatizzare oltre misura l’evento, manifestamente osteggiato dagli Stati Uniti e visto malissimo dai partner dell’Unione Europea, fin qui competitori vincenti nei rapporti con Pechino.
L’ambasciatore Usa a Roma, Lewis Eisenberg, ha fatto visita in questi giorni a tutti i membri del governo in prima fila nell’accordo – da Luigi Di Maio al ministro degli esteri Moavero Milanesi, dalla titolare della Difesa (Elisabetta Trenta) ai leghisti Giancarlo Giorgetti (contrario) e Michele Geraci (ultra favorevole).
Macron, Merkel e Juncker hanno invece deciso di fare un vertice con Xi Jinping, martedì 26, in occasione della sua visita a Parigi. Una scelta chiaramente improvvisata – questo genere di incontri si preparano per mesi, se non per anni – sulla base di una paura che ha poco a che fare con le ragioni morali e tantissimo con gli interessi economici di peso strategico.
Lasciamo da parte ogni considerazione ideologica (la natura del modello cinese, il tasso di “autenticità comunista” del partito che lo dirige, ecc).
Leggi tutto
comidad: La lobby della deflazione preoccupata dalla via della seta
La lobby della deflazione preoccupata dalla via della seta
di comidad
In queste settimane l’opinione pubblica italiana ha avuto la “sorpresa” di scoprire il “putiniano” Matteo Salvini in versione ultra-amerikana, in una polemica con i 5 Stelle a causa dell’adesione al memorandum per la nuova Via della Seta, una rete di infrastrutture che dovrebbe attraversare tutta la massa continentale eurasiatica e africana. Molti commentatori in vena di ridicolo si sono scatenati nel rinfacciare al Presidente del Consiglio Conte il presunto “sgarbo” fatto agli USA per non averne preliminarmente chiesto l’assenso prima di aderire al memorandum. In realtà gli USA sono al corrente da anni, come tutti, del progetto di nuova Via della Seta, perciò se avessero visto un pericolo effettivo per una firma italiana al memorandum si sarebbero premurati di farcelo sapere per tempo.
Nonostante ciò la piaggeria di politici e commentatori nei confronti degli USA è arrivata al punto da paventare un’insidia alla “collocazione europea e atlantica” dell’Italia a causa della firma del memorandum che comporterebbe (senti, senti) persino rischi di colonizzazione cinese e di appropriazione dei nostri know how. Si tratta chiaramente di forzature, esagerazioni o palesi sciocchezze.
L’Europa è stata inserita dai Cinesi come possibile partner del progetto infrastrutturale in parte per ovvi motivi di bon ton internazionale, in parte perché fosse meno evidente e plateale il vero obbiettivo dell’iniziativa, che non è la penetrazione in Europa bensì in Asia ed in Africa.
Leggi tutto
Fabio Fiorucci e Ruben Vezzoni: Un Green New Deal per sfuggire alla trappola della sostenibilità neoliberale
Un Green New Deal per sfuggire alla trappola della sostenibilità neoliberale
di Fabio Fiorucci e Ruben Vezzoni
La manifestazione di venerdì scorso ha riportato la crisi ecologica al centro del dibattito pubblico, e questa, al netto delle polemiche spicciole sulla giovane Greta, è senza dubbio un’ottima notizia. Del resto non è la prima volta che figure simili vengono elette a simbolo di una causa più grande (ricordiamo Severn Cullis, che allora dodicenne partecipò al Summit di Rio del ’92), ed è evidente che un’iniziativa di questa portata non possa essere semplicemente il frutto di una ragazzina intraprendente. Una constatazione ovvia che però non intacca le potenzialità politiche della mobilitazione, così come la nobiltà e l’urgenza del suo fine. Molto più di “chi c’è dietro?”, quello che bisognerebbe chiedersi una volta risvegliata l’esigenza di una lotta efficace contro gli squilibri ambientali, è come dare una risposta a queste istanze in una prospettiva concreta e realizzabile.
Non ci accorgiamo certo nel 2019 che i cambiamenti climatici, così come le altre criticità legate all’impatto umano sull’ecosistema, rappresentano una minaccia enorme per il benessere nostro e delle generazioni future. La questione ambientale ha radici lontane, e dai primi movimenti degli anni ’60 a oggi è riuscita a ritagliarsi uno spazio di egemonia sia fra le persone, sia negli apparati istituzionali del mondo occidentale, in particolare in Europa.
Leggi tutto
Marco Palazzotto: La finestra sull'euro
La finestra sull'euro
di Marco Palazzotto
 Uscire o non uscire dall’Euro?
Questo il dilemma.
Per Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana
Mortágua la risposta non è né sì né no, ma “mu”:
parola giapponese che rappresenta un terzo termine logico
possibile il cui significato è “non fare la domanda”. Viene
usato quando
il contesto della domanda “diviene troppo angusto per la
verità della risposta”. Così gli autori di Euro al
capolinea?
La vera natura della crisi europea – edito da
Rosenberg & Sellier (in distribuzione dallo scorso mese) –
rispondono alla famosa
domanda: usano le parole di Robert Pirsig in Lo Zen e
l’arte della manutenzione della motocicletta,
affermando che l’uscita
dall’Euro è la risposta alla domanda sbagliata.
Uscire o non uscire dall’Euro?
Questo il dilemma.
Per Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana
Mortágua la risposta non è né sì né no, ma “mu”:
parola giapponese che rappresenta un terzo termine logico
possibile il cui significato è “non fare la domanda”. Viene
usato quando
il contesto della domanda “diviene troppo angusto per la
verità della risposta”. Così gli autori di Euro al
capolinea?
La vera natura della crisi europea – edito da
Rosenberg & Sellier (in distribuzione dallo scorso mese) –
rispondono alla famosa
domanda: usano le parole di Robert Pirsig in Lo Zen e
l’arte della manutenzione della motocicletta,
affermando che l’uscita
dall’Euro è la risposta alla domanda sbagliata.
Il libretto può sembrare l’ennesimo saggio sull’Euro, argomento ormai inflazionato e intorno al quale siamo abituati a leggere almeno dallo scoppio della crisi dei subprime. Invece, si tratta – a dispetto delle sole 159 pagine – di un testo ricco di spunti di ricerca poco esplorati dai maggiori commentatori europei. In particolare i bersagli critici sono rappresentati dai due filoni principali di interpretazione della crisi europea: quella dominante e quella cosiddetta eterodossa, ai quali viene dedicata la prima parte del volume.
Entrambi i suddetti filoni mettono al centro dello studio, anche se in modo diverso, gli squilibri commerciali. Dalle istituzioni europee e monetarie, ma anche da numerosi studiosi, particolare attenzione, al fine di assicurare la stabilità europea, è stata data alla disciplina di bilancio, alla politica monetaria di bassa inflazione, all’integrazione e sviluppo dei mercati finanziari. Secondo le teorie neoclassiche gli squilibri commerciali nei paesi con redditi più bassi “sarebbero la conseguenza del processo di convergenza” (p. 27).
Leggi tutto
2-La razionalizzazione elimina l’uomo
di Robert Kurz
Pubblichiamo il secondo capitolo della sezione VIII dello Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”) di Robert Kurz
 La razionalizzazione
elimina l’uomo1
La razionalizzazione
elimina l’uomo1
La storia a partire dal tardo XIX secolo ha già dimostrato come lo sviluppo reale di una rivoluzione industriale avvenga in maniera disomogenea e dopo periodi di incubazione più o meno lunghi. La nascita di una nuova tecnologia non comporta di per sé il «balzo» di una corrispondente rivoluzione socio-economica e la rispettiva tecnologia di base richiede a sua volta un certo periodo di maturazione e l’interazione con innovazioni su altri livelli. Ad esempio, negli anni Ottanta del XIX secolo l’automobile era già stata inventata ma le fondamenta della seconda rivoluzione industriale vennero gettate solo a partire dal 1913 con la «scienza del lavoro» di Taylor e con i nuovi metodi di produzione di Ford; essa inoltre, dopo un primo tentativo naufragato con la crisi economica mondiale, riuscì ad affermarsi a livello globale solo molto più tardi, cioè attorno al 1950. Uno sviluppo di questo genere, durato più di mezzo secolo, può andare incontro naturalmente a interpretazioni differenti e contraddittorie, fino al momento in cui non si manifesta distintamente il suo carattere autentico di rivoluzione epocale.
Le novità tecnologiche della terza rivoluzione industriale comparvero in un’epoca in cui la seconda rivoluzione non aveva neppure terminato di imporsi. È facile individuare la qualità delle tre grandi avanzate dello sviluppo industriale in base all’attività nel processo capitalistico di produzione: la prima rivoluzione industriale si contraddistinse essenzialmente per la sostituzione della forza fisica umana con quella delle macchine mentre la seconda fu caratterizzata dalla «razionalizzazione» o, si potrebbe dire, per la «robotizzazione» della forza-lavoro umana attiva nel sistema delle macchine. Il marchio fondamentale della terza rivoluzione industriale non poteva che essere la facoltà di rendere superflua la forza-lavoro umana nel processo di produzione industriale e la «razionalizzazione per riduzione» della medesima forza-lavoro grazie a meccanismi di controllo automatico e ai sistemi informatici.
Leggi tutto
Michael Roberts: Il modello macroeconomico della MMT
![]()
Il modello macroeconomico della MMT
di Michael Roberts
È la redditività degli investimenti capitalistici che guida la crescita e l'occupazione, non le dimensioni del deficit pubblico
 “Le
identità contabili che equiparano le spese aggregate alla
produzione ed entrambe ai redditi valutati ai prezzi di
mercato sono ineludibili,
indipendentemente dalla vostra preferenza per il tipo di
economia keynesiana o classica. Dico sempre agli studenti
che il rispetto di queste
identità è il primo tocco di saggezza che distingue gli
economisti da coloro che espongono l'economia. Il secondo?
... Le
identità non dicono niente sulle cause”. James Tobin,
keynesiano di sinistra, 1997.
“Le
identità contabili che equiparano le spese aggregate alla
produzione ed entrambe ai redditi valutati ai prezzi di
mercato sono ineludibili,
indipendentemente dalla vostra preferenza per il tipo di
economia keynesiana o classica. Dico sempre agli studenti
che il rispetto di queste
identità è il primo tocco di saggezza che distingue gli
economisti da coloro che espongono l'economia. Il secondo?
... Le
identità non dicono niente sulle cause”. James Tobin,
keynesiano di sinistra, 1997.
"Il denaro è in definitiva una creazione del governo, ma ciò non significa che solo i deficit governativi determinino il livello della domanda in qualsiasi momento. Anche le azioni e le convinzioni del settore privato sono importanti. E questo a sua volta significa che è possibile avere eccedenze di bilancio ed eccesso di domanda allo stesso tempo, proprio come si possono avere deficit di bilancio e domanda carente”. Jonathan Portes (ortodosso keynesiano).
Il dibattito sempre più astruso tra gli economisti (mainstream, eterodossi e di sinistra) continua sulla validità della Teoria della moneta moderna (Modern monetary theory - MMT) e sulla sua rilevanza per la politica economica. Il dibattito tra le sinistre è ha innescato un’altra marcia a seguito della pubblicazione della feroce critica alla MMT condotta da sinistra da parte di Doug Henwood, visibile su Jacobin. Il principale esponente della MMT, Randall Wray ha risposto con rabbia al tentativo di demolizione di Henwood (qui). E poi dal cuore della terra del MMT, Pavlina Tcherneva, direttrice di programma e professore associato di economia al Bard College e un ricercatore associato presso il Levy Economics Institute hano risposto a Henwood sempre dalle colonne del Jacobin.
Tra gli economisti mainstream, Paul Krugman ci ha provato, ricevendo una risposta da Stephanie Kelton. Kelton è una professoressa di politica ed economia pubblica presso la Stony Brook University di Long Island (New York). È stata l'economista capo dei Democratici nello staff della Commissione Bilancio del Senato degli Stati Uniti e consigliere economico della campagna presidenziale del 2016 del senatore Bernie Sanders.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Atto XIX: “163 sabati prima del maggio 2022”
Atto XIX: “163 sabati prima del maggio 2022”
di Giacomo Marchetti
La strategia del terrore messa in campo da Macron ha miseramente fallito.
Nonostante questo, il clima da stato d’assedio permanente ha pesantemente condizionato lo svolgimento delle mobilitazioni in tutto l’Esagono.
Questa manifestazioni hanno apertamente sfidato l’atmosfera marziale che l’entourage macroniano ha voluto calare sull’Atto 19 e i vari divieti prefettizi che hanno riguardato i centri cittadini delle città d’Oltralpe.
Venerdì 22 marzo il governatore militare di Parigi, il generale Bruno Leray, aveva dichiarato che i militari del dispositivo Sentinelle impiegati nel mantenimento dell’ordine pubblico da questo sabato “hanno differenti mezzi d’azione per far fronte a tutte le minacce andando fino ad aprire il fuoco se la loro vita fosse minacciata o quella delle persone che difendono”.
Una delle immagini che rimarrà più impresse della giornata di sabato è quella di una manifestante di settant’anni buttata violentemente a terra, a Nizza, mentre sventolava una bandiera della pace di fronte alle forze dell’ordine, che le hanno procurato ferite gravi.
E a Nizza, come ogni sabato, i Gilet Jaunes si sono dati appuntamento a Piazza Garibaldi alle 9:30 del mattino, “sfidando” il divieto del Prefetto delle Alpi Marittime su richiesta del sindaco della città della Costa Azzurra.
Leggi tutto
coniarerivolta: Lo strano caso della BCE: liquidità per la finanza, austerità per i popoli
Lo strano caso della BCE: liquidità per la finanza, austerità per i popoli
di coniarerivolta
All’interno del contesto europeo di generalizzata stagnazione, l’operato della BCE viene spesso caratterizzato come fortemente espansivo in termini di crescita. Stando alla vulgata giornalistica, Mario Draghi starebbe inondando di liquidità il sistema economico al fine di favorire la ripresa. Cerchiamo perciò di capire meglio cosa accade: come vedremo di seguito, la politica monetaria perseguita da Draghi non solo non è sufficiente a riattivare produzione e occupazione, ma è anche saldamente collocata al servizio della perpetuazione delle politiche di austerità.
Il 13 dicembre 2018, la Banca Centrale Europea (BCE) ha annunciato la fine del Quantitative Easing (QE) a partire da Gennaio 2019. Il QE è stato avviato a Marzo 2015 come politica monetaria non convenzionale allo scopo – almeno negli intenti – di rilanciare la crescita economica nell’euro area e permettere all’inflazione di raggiungere un valore vicino al 2%, target di riferimento della BCE. A tale scopo, la BCE espanse i propri bilanci aumentando la base monetaria attraverso un massiccio acquisto di titoli, per lo più pubblici nelle mani delle banche dell’Eurozona. Come si può osservare nella figura, a partire da marzo 2015 (linea rossa), l’offerta di moneta ha subito un brusco aumento passando da 1200 miliardi di euro nel marzo 2015 fino ad arrivare ad un valore di 3200 miliardi di euro nel gennaio 2019, ossia un aumento percentuale di circa il 166% in tutto il periodo osservato.
Leggi tutto
Pino Arlacchi: Cina, è via della seta o via dell'ignoranza?
Cina, è via della seta o via dell'ignoranza?
di Pino Arlacchi
La visita del presidente cinese per la firma dell’accordo sulla “nuova via della seta” ha dato luogo a un dibattito politico-mediatico inconcludente e povero di contenuti. Anche chi difende le ragioni dell’accordo dimostra una conoscenza a dir poco incerta delle sue premesse e delle sue implicazioni. Ciò si deve a un fondamentale vuoto di conoscenza sulla Cina che viene sostituito da uno schema mentale tanto facile quanto sbagliato: Cina eguale a Stati Uniti. Il Paese di Xi Jinping è – per la quasi totalità dei commentatori italiani di politica estera e per gli sprovveduti leader dell’opposizione e del governo – nient’altro che una replica autoritaria della superpotenza americana.
Pochi di loro, in verità, dubitano che la Cina diventerà entro un decennio la maggiore economia del pianeta, con l’America al secondo posto. Ma ciò avverrebbe grazie al fatto di aver perseguito gli stessi obiettivi, seguito la stessa strategia e usato gli stessi strumenti adoperati dall’Europa negli ultimi secoli, e dagli Usa negli ultimi decenni, per impadronirsi del pianeta. Con la sola differenza della natura antidemocratica del regime di Pechino, guidato dal Partito comunista. Ma una lettura anche sbadata di qualche buon libro di storia della Cina dovrebbe essere sufficiente a smentire questo stereotipo.
Leggi tutto
Guido Salerno Aletta: Gli errori dell’Occidente hanno spianato la Via della Seta
Gli errori dell’Occidente hanno spianato la Via della Seta
di Guido Salerno Aletta
La Cina guarda al Mediterraneo, tornato nuovamente centrale nella geopolitica. La Via della Seta di cui tanto si parla, chi palesando il timore di una espansione eccessiva di Pechino e chi ipotizzando con malcelata baldanza chissà quale nuovo Eldorado, ha due componenti distinte, come chiarisce l’acronimo BRI, che sta per Belt & Road Initiative.
Si snoda dunque sia per vie terrestri che per rotte marittime, ma nessuna sembrerebbe toccare i Paesi della sponda meridionale del Mediterraneo. Dopo il Pireo, che dà accesso ai Balcani meridionali, ora sarebbe la volta dei porti italiani: se ben collegati per via ferroviaria e stradale con il resto del continente europeo, consentirebbero di ridurre i tempi di trasporto rispetto alle rotte che proseguono fino ai porti del nord Europa passando per Gibilterra.
Quando da Bruxelles si chiede all’Italia di attendere che sia l’Unione europea a trattare unitariamente con la Cina, c’è dietro il terrore di un ribaltamento dei traffici a danno dei porti tedeschi ed olandesi.
Concentrandosi su questi aspetti, i Paesi della sponda sud del Mediterraneo sembrerebbero addirittura ignorati dalla strategia cinese, che invece ha mantenuto stretti i rapporti con questa parte dell’Africa. Di queste relazioni si dà conto nell’ambito del Forum sulla cooperazione tra Cina ed Africa (FOCA) la cui ultima edizione si è tenuta il 3-4 settembre scorso a Pechino, con la partecipazione dei delegati di ben 53 Stati africani.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3636
Hits 2761
Hits 2631
Hits 2524
Hits 2281
Hits 2196
Hits 2093
Hits 2042
Hits 1931
Hits 1860
tonino

Antonella Stirati: Reddito di cittadinanza, non sparate sul governo
Reddito di cittadinanza, non sparate sul governo
di Antonella Stirati
Come funziona e un’analisi dei pro e dei contro: Ci sono sia gli uni che gli altri, ma non si può bocciare senza appello una misura che allevierà le condizioni di un numero elevato di persone, da 2,7 milioni (stima Istat) a 3,6 (secondo l’Upb). Il confronto con gli impieghi alternativi e le ipotesi sui moltiplicatori fiscali, che potrebbero essere migliori di quelli dichiarati dall’esecutivo
 L’introduzione del
Reddito di cittadinanza nel sistema di welfare italiano è
stato fortemente voluto dal
Movimento cinque stelle ora al governo insieme alla Lega, ed
è stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale
che lo ha portato a un
forte successo, con il 32% dei voti nelle elezioni dello
scorso anno. Nonostante il nome, si tratta di una misura non
universale, ma condizionata a
documentate condizioni di disagio economico del nucleo
familiare ed alla disponibilità, per i beneficiari che siano
in età da lavoro e
disoccupati, ad accettare percorsi di formazione e offerte
di lavoro. Esso consiste nell’erogazione di un reddito fino
a un massimo di 500 euro
mensili per un singolo individuo, e poi articolato secondo
la tipologia familiare: ad esempio 900 euro per una coppia
con due figli minori e di 1050
euro (l’importo più alto) per famiglie più numerose, che può
essere ulteriormente integrato da un contributo fisso di 280
euro mensili per il pagamento dell’affitto. Il RDC potrà
essere versato per intero oppure come integrazione di un
reddito (da lavoro o da
pensione) inferiore a quelle soglie (quindi ad esempio un
anziano che vive solo e percepisce una pensione di 400 euro
mensili, non ha proprietà
oltre una certa soglia e non ha altre fonti di reddito
riceverà una somma di 100 euro mensili ad integrazione del
proprio reddito). I
beneficiari in età da lavoro riceveranno Il RDC per un ciclo
di 18 mesi, che potrà essere rinnovato per altri 18 ma a
condizioni
più stringenti.
L’introduzione del
Reddito di cittadinanza nel sistema di welfare italiano è
stato fortemente voluto dal
Movimento cinque stelle ora al governo insieme alla Lega, ed
è stato un cavallo di battaglia della campagna elettorale
che lo ha portato a un
forte successo, con il 32% dei voti nelle elezioni dello
scorso anno. Nonostante il nome, si tratta di una misura non
universale, ma condizionata a
documentate condizioni di disagio economico del nucleo
familiare ed alla disponibilità, per i beneficiari che siano
in età da lavoro e
disoccupati, ad accettare percorsi di formazione e offerte
di lavoro. Esso consiste nell’erogazione di un reddito fino
a un massimo di 500 euro
mensili per un singolo individuo, e poi articolato secondo
la tipologia familiare: ad esempio 900 euro per una coppia
con due figli minori e di 1050
euro (l’importo più alto) per famiglie più numerose, che può
essere ulteriormente integrato da un contributo fisso di 280
euro mensili per il pagamento dell’affitto. Il RDC potrà
essere versato per intero oppure come integrazione di un
reddito (da lavoro o da
pensione) inferiore a quelle soglie (quindi ad esempio un
anziano che vive solo e percepisce una pensione di 400 euro
mensili, non ha proprietà
oltre una certa soglia e non ha altre fonti di reddito
riceverà una somma di 100 euro mensili ad integrazione del
proprio reddito). I
beneficiari in età da lavoro riceveranno Il RDC per un ciclo
di 18 mesi, che potrà essere rinnovato per altri 18 ma a
condizioni
più stringenti.
Si tratta quindi di una misura di sostegno del reddito e contrasto alla povertà simile a quanto già esiste in quasi tutti i paesi europei, ma che nel contesto italiano, prima di questo provvedimento, era presente solo in forma molto limitata, sia per numero di persone raggiunte, sia per l’importo modesto del reddito erogato.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Emanuele Leonardi, “Lavoro, natura, valore”
Emanuele Leonardi, “Lavoro, natura, valore”
di Alessandro Visalli
 Questo libro di
Emanuele Leonardi[1], il cui sottotitolo è “Andrè
Gorz tra marxismo e
decrescita”, individua dei temi sui quali è necessario
prendere posizione per collocare correttamente il discorso
ambientale. Nella
sua intenzione compie il difficilissimo tentativo di mettere
in comunicazione l’area culturale, frastagliata e non omogenea
ma certamente
anti-marxista, della “decrescita”[2] con gli esiti
dell’evoluzione dell’operaismo[3], con riferimento alla
versione trontiana. Lo snodo è il progressismo, esplicito o
implicito, e quindi
l’atteggiamento verso lo sviluppo tecnologico e la società
industriale. Ciò che rende pensabile il ponte, malgrado la
grande
distanza delle rive, è la valorizzazione, nel post-marxismo
del recente operaismo, del ‘cognitivismo’, dei ‘commons’,
nella migrazione progressiva dal concetto originario di
“operaio massa”[4], a quello di “operaio
sociale”[5],
ed infine, nella versione negriana di “moltitudine”.
Questo libro di
Emanuele Leonardi[1], il cui sottotitolo è “Andrè
Gorz tra marxismo e
decrescita”, individua dei temi sui quali è necessario
prendere posizione per collocare correttamente il discorso
ambientale. Nella
sua intenzione compie il difficilissimo tentativo di mettere
in comunicazione l’area culturale, frastagliata e non omogenea
ma certamente
anti-marxista, della “decrescita”[2] con gli esiti
dell’evoluzione dell’operaismo[3], con riferimento alla
versione trontiana. Lo snodo è il progressismo, esplicito o
implicito, e quindi
l’atteggiamento verso lo sviluppo tecnologico e la società
industriale. Ciò che rende pensabile il ponte, malgrado la
grande
distanza delle rive, è la valorizzazione, nel post-marxismo
del recente operaismo, del ‘cognitivismo’, dei ‘commons’,
nella migrazione progressiva dal concetto originario di
“operaio massa”[4], a quello di “operaio
sociale”[5],
ed infine, nella versione negriana di “moltitudine”.
Leggere un libro, l’autore mi perdonerà, significa sempre ri-collocarlo entro il proprio universo di discorso, e dunque io lo collocherò esattamente al punto in cui termina, prematuramente, l’ultimo post sul fenomeno mediatico e sociale di Greta Thunberg[6]. E, magari, al punto di intersezione con questo post di Andrea Zhok, con il quale sono in accordo. Bisogna prendere le distanze “dall’ecobuonismo” liberale, in ogni e qualsiasi travestimento (di cui alcune versioni della “decrescita”, interpreti dello spirito borghese, sono espressione) ed inquadrare il superamento della crisi ambientale come parte, importante, dello sforzo di mettere in questione radicalmente quella che Leonardi chiama “logica del valore”, ovvero lo “spirito del capitalismo”. Nel post “Greta Thunberg”, lo squilibrio essenziale che ha consentito agli spiriti animali del capitalismo, in primo luogo incarnati nelle grandi imprese monopoliste finanziarie e non, di superare la crisi di accumulazione degli anni settanta, prolungandola e facendola pagare alle classi lavoratrici di tutto il mondo, è stato descritto, seguendone l’esteriorità, come sfruttamento di ‘periferie interconnesse’[7] nel sistema mondo.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Dimenticare? Perdonare? Mai!
Dimenticare? Perdonare? Mai!
di Fulvio Grimaldi
Convegno internazionale a vent’anni dall’aggressione della Iugoslavia
 Il
contributo dei pellegrini di Sarajevo
Il
contributo dei pellegrini di Sarajevo
Coloro che in questi giorni, in occasione del XX anniversario dell’aggressione Nato alla Serbia, si stracciano le vesti per una guerra che ha lacerato l’Europa e sancito la fine dello jus gentium, del diritto che regola i rapporti tra i popoli e impone il governo della legge su abusi e arbitri, sono quelli che il 24 marzo 1999, la mattina dopo le prime bombe, si armarono di menzogne e partirono per Sarajevo. Quinte colonne di pellegrini della pace accorsi a offrire un contributo alla frode che parlava di nazionalismo etnico dei serbi, del “dittatore” Milosevic, della persecuzione degli albanesi nel Kosovo, dell’assedio stragista dei serbi alla città bosniaca, del massacro di 8000 innocenti di Srebrenica (solo miliziani del capobanda Nasr Oric, fiduciario del fascista islamista Izetbegovic, massacratore – vero – di 3.500 serbi attorno a Srebrenica. Ma è Karadzic, il difensore dei serbi dalle orde jihadiste del fascista Izetbegovic, reclutate dalla Nato, che oggi viene condannato all’ergastolo dal tribunale pinocchiesco dell’Aja).
Sicari civili del generale bombarolo Wesley Clark esordivano alla grande a Sarajevo e Belgrado nella missione di asfaltare, con le calunnie sui serbi e sul loro governo, la via alla distruzione dell’ultimo lembo di quel grande esperimento di convivenza e progetto comune che era stata la Jugoslavia socialista di Tito. Comunità sovrana di popoli perno di un altro grande e positivo progetto di alternativa allo spadroneggiare dell’imperialismo: l’organizzazione dei Non Allineati.
Kosovo: l’inversione delle pulizie etniche
Insieme ai pionieri del 1992, Pannella e Bonino, in mimetica accanto ai neo-ustasha croati, al Papa polacco in testa alle sue truppe in tonaca, al pacifista Alex Langer convertitosi al bellicismo Nato, con l’invocazione di bombardamenti sui serbi, ai revanscisti di Berlino, che i serbi, pur con una mano legata dietro alla schiena, avevano sconfitto da soli, torme di Ong avevano già invaso il Kosovo e s’erano già fatte apprezzare da vivandiere degli squartatori dei Balcani.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: L'interesse nazionale
L'interesse nazionale
di Pierluigi Fagan
“Noi siamo da secoli - Calpesti, derisi - Perché non siam Popolo, - Perché siam divisi”, recitava il Mameli in quel del ’47. Va ricordato che l’Italia giunse a farsi stato unitario quattro secoli dopo Portogallo, Francia, Spagna ed Inghilterra (la storia dell’Inghilterra è un po’ più complicata ma insomma, diciamo “più o meno” così). Da Machiavelli e Gramsci, molti hanno spiegato questo ritardo come dovuto all’interesse convergente tra lo Stato Pontificio e le potenze straniere. Questo dello Stato Pontificio è uno dei tanti “unicum” che fanno la nostra storia diversa e speciale, nel bene e nel male.
Arriviamo così tardi a farci stato (anche i tedeschi, ma per altri motivi) e come molti hanno notato, in maniera del tutto imperfetta visto che stretti e lunghi in latitudine, tra Sud, Centro e Nord, avevamo da amalgamare parti di un territorio assai vario, geo-storicamente parlando. Interpretato decisamente sopra le righe l’interesse nazionale nel fascismo, venne definitivamente seppellito nel dopoguerra visto che diventammo una colonia americana o quantomeno un paese ad evidente sovranità limitata.
Al minuto 12:35, F. Rampini, a proposito del commento politico sulla visita di Xi Jinping, parla di “partito dello straniero” a sottolineare questa tipicamente italica attitudine ad usare posizioni oggettivamente concorrenti all’interesse nazionale, per polemica politica interna.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Olivier Blanchard e le scienze economiche
Olivier Blanchard e le scienze economiche
Quando l'errore sta nel manico
di Giuseppe Masala
Sta facendo molto rumore uno studio del prestigioso economista francese Olivier J. Blanchard dove si asserisce che fin quando il tasso di interesse reale che un paese paga sul debito pubblico è inferiore al tasso di crescita reale dei PIL, il debito pubblico è sostenibile e non è dunque fonte di preoccupazione. Blanchard nel suo studio usa tutti i mezzi dell'armamentario dell'economista contemporaneo per dimostrare la sua tesi: dunque fa largo uso di grafici ed equazioni. A me pare che siamo di fronte alla scoperta dell'acqua calda. E peraltro se proprio devo dirlo mi pare anche che lo studio sia particolarmente deludente e sia emblematico della miseria in cui è precipitata l'economia. Lo so, non sono nessuno, ci mancherebbe e in questo momento potrei essere accusato di lesa maestà di fronte ad un mostro sacro come Blanchard. Nonostante tutto questo, vado avanti e provo a spiegarmi.
Il ragionamento di Blanchard [che il suddetto considera valido in ogni tempo e in ogni luogo in ossequio al concetto di fine della storia di Fukuyama] presenta una pecca non da poco: l'assunto è valido se e solo se c'è libertà di spostamento dei capitali. Ma questa condizione non è una condizione naturale e dunque immodificabile, si tratta di una condizione politica peraltro emersa dopo la caduta del Muro di Berlino e dunque pochi decenni fa.
Leggi tutto
Bruno Saetta: Perché “spezzare” i colossi tecnologici non è la soluzione
Perché “spezzare” i colossi tecnologici non è la soluzione
di Bruno Saetta
È l’ottobre del 2011, quando una piccola società italiana presenta un ricorso antitrust contro la multinazionale Microsoft. Un classico "Davide contro Golia": Messagenet con un fatturato (all’epoca) di 2,5 milioni di euro, contro Microsoft, un gigante da 70 miliardi di dollari. Eppure Messagenet tiene in sospeso per settimane il gigante americano bloccando (temporaneamente) l'acquisizione di Skype. Un affare da 8,5 miliardi di dollari. Alla fine Microsoft la spunta e riceve il beneplacito dell’antitrust europeo. Quello americano aveva dato subito l’ok.
Rompere i Big Tech
Pochi giorni fa la senatrice americana e candidata per le prossime elezioni, Elizabeth Warren, pubblica un articolo nel quale sostiene la tesi che occorre //medium.com/@teamwarren/heres-how-we-can-break-up-big-tech-9ad9e0da324c">“spezzare” le piattaforme del web, i Big Tech. Secondo Warren le aziende del web sono ormai troppo grandi, e usano il loro potere per eliminare la concorrenza e le aziende più piccole, e per sostituire i loro interessi finanziari agli interessi del popolo americano. Per ripristinare l’equilibrio occorre promuovere nuove forme di concorrenza, per alimentare l’innovazione occorre “spezzare” le più grandi aziende tecnologiche americane.
Leggi tutto
Dante Barontini: Pd, il “poliziotto buono” che si finge ambientalista e antifascista
Pd, il “poliziotto buono” che si finge ambientalista e antifascista
di Dante Barontini
Il rilancio di un’immagine “di sinistra” del Pd viaggia su due sole argomentazioni retoriche: antifascismo/antirazzismo e ambientalismo.
Parliamo di argomentazioni retoriche, non di sostanza politica, perché il Pd ha più volte, in più territori e in più occasioni “flirtato” con la destra estrema, in particolare con Casapound (la lussuosa sede romana fu loro concessa da Walter Veltroni, allora sindaco della Capitale). Che ha creato i lager per i migranti in Libia e venduto navi al Niger (!) per “aiutarli a casa loro”. Così come ha sostenuto – stando al governo, ma anche oggi dall’”opposizione” – le peggiori iniziative contro l’ambiente. Basterebbe pensare al Tav in Val Susa, che distingue nettamente tra ambientalisti veri e “partito del Pil”.
Due argomentazioni retoriche che però rischiano di far presa su un’opinione pubblica preoccupata per la crescita dalla Lega fasciorazzista, accompagnata e sostenuta dal revanscismo culturale oscurantista, bigotto, teocratico contro la libertà delle donne, come nell’ormai prossimo convegno di Verona.
Anche perché esiste ed è sempre fortissimo un potere mediatico mainstream che si presenta come “democratico”, ma esercita una censura micidiale, enfatizzando oltre ogni misura le iniziative “accettabili” perché “compatibiliste” con l’attuale assetto di potere economico e ignorando (o mostrificando) tutte le iniziative che invece – magari solo “oggettivamente”, per la radicalità delle proposte – mettono in discussione quegli assetti e dunque anche le forze politiche che debbono rappresentarli.
Leggi tutto
Ivan Mikhajlovič Syroežin: Pianificabilità, pianificazione, piano
![]()
Pianificabilità, pianificazione, piano
di Ivan Mikhajlovič Syroežin
Capitolo 3 - Condizioni strutturali e informative di realizzazione della pianificabilità (parte II)
Rimasi colpito da questa immagine sin dal primo momento che la vidi, per puro caso, oltre dieci anni fa, senza sapere chi l’avesse fatta e chi ritraesse. Mi colpiva la capacità avuta dal fotografo di riprendere, con discrezione esemplare (quel saper mettersi di lato senza dare fastidio, fino a confondersi con i soprammobili) e un sapiente uso della composizione fotografica (anche un profano capisce immediatamente che stiamo parlando di musica), della messa a fuoco selettiva (lessi poi che l’obbiettivo era stato aperto a f/4,5 sul volto del personaggio ritratto), e dei tempi lenti (1/15 sec., sempre seppi poi, utili a trasferire su sali d’argento la tensione dinamica della mano in primo piano), una scena per nulla semplice da “de-scrivere con la luce” (foto-grafia), come quella di un musicista al lavoro.
L’ho ritrovata qualche anno fa, sfogliando vecchi numeri del giornale Sovetskoe Foto1, raccontata dall’autore stesso, il fotografo Viktor Rujkovič. Il compositore ritratto altro poi non era che Vasilij Pavlovič Solov’ev-Sedoj (1907-1979), versatile autore di alcune fra le canzoni sovietiche più celebri del secolo scorso, nonché colonne sonore di film e balletti. Ebbene, l’autore di Podmoskovnye večera e Solov’i, in quell’immagine mi aveva colpito come sapesse scrivere e leggere le note al punto di ascoltarle senza sentirle, completamente immerso nella sua composizione al punto prefigurare e partecipare emotivamente alla sua esecuzione, vedendo i piani e i forti, cogliendo le sfumature di ciascuna parte, così come la visione d’insieme: il tutto, partendo da una semplice, “bidimensionale”, scrittura sul pentagramma, che tuttavia la sua mente sentiva già nell’aria come alla sera della prima.
La stessa capacità di visualizzazione o, meglio, di previsualizzazione, la ritrovai qualche anno più tardi in tutt’altro ambiente. Ansel Adams inaugurava la sua monumentale trilogia sulla fotografia teorizzando proprio come, nel momento dello scatto, il fotografo dovesse già prefigurare, avere in mente il prodotto finale, la stampa (in bianco e nero, ovviamente) che voleva ottenere:
Leggi tutto
Domenico Moro, Fabio Nobile: Europee: coazione a ripetere e dissolvimento della sinistra
Europee: coazione a ripetere e dissolvimento della sinistra
di Domenico Moro, Fabio Nobile
 Il contesto politico italiano
appare significativamente modificato rispetto ad appena un
anno fa. Secondo il sondaggio Emg Acqua per
Agorà, se si votasse oggi, la Lega avrebbe il 31% dei voti
contro il 17,4% delle elezioni politiche di un anno fa, mentre
il M5s avrebbe il
23,4% contro il 32,7%. Il Pd appare in lieve risalita, dal
18,5% al 21%. I sondaggi non sono elezioni e possono sbagliare
anche di alcuni punti
percentuali. Tuttavia, è indiscutibile che il rapporto di
forze tra Lega e M5s si sia ribaltato.
Il contesto politico italiano
appare significativamente modificato rispetto ad appena un
anno fa. Secondo il sondaggio Emg Acqua per
Agorà, se si votasse oggi, la Lega avrebbe il 31% dei voti
contro il 17,4% delle elezioni politiche di un anno fa, mentre
il M5s avrebbe il
23,4% contro il 32,7%. Il Pd appare in lieve risalita, dal
18,5% al 21%. I sondaggi non sono elezioni e possono sbagliare
anche di alcuni punti
percentuali. Tuttavia, è indiscutibile che il rapporto di
forze tra Lega e M5s si sia ribaltato.
Il voto fuoriesce dal M5s sia verso destra sia verso sinistra, sia per le difficoltà del M5s a mantenere le promesse elettorali, sia per l’egemonia che, all’interno del governo, si è conquistato Salvini. Questi è stato molto abile a focalizzarsi su un tema a costo zero, gli immigrati, mentre il M5s è alle prese con temi complessi e difficili, come quello dello sviluppo economico. Il non aver fatto i conti con i vincoli europei, a dispetto delle promesse “sovraniste”, rende esigui i margini di manovra, ad esempio sul reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del M5s. Tali limiti sono accentuati dall’impreparazione dei quadri del M5s e dal recente scandalo, che coinvolge il presidente del Consiglio comunale di Roma. Si tratta di un grave danno per il M5s che ha fondato la sua identità di partito sull’onestà e sulla critica morale alla “casta” dei politici.
Se quanto abbiamo detto è vero, allora la sinistra radicale dovrebbe e potrebbe intercettare almeno una parte del voto in uscita dal M5s, anche perché è verso il M5s che è andata molta parte del voto della sinistra radicale nell’ultimo decennio[1]. Invece, il rischio concreto è che la sinistra radicale non riesca in tale compito e che il voto in uscita dal M5s o vada all’astensionismo, in cui staziona molta parte delle classi subalterne, o rifluisca nel Pd.
Leggi tutto
Enzo Gamba: A proposito di Europa, sovranismi ed elezioni europee
A proposito di Europa, sovranismi ed elezioni europee
di Enzo Gamba
Il confronto tra le forze politiche di sinistra sul programma e le alleanze in vista delle elezioni europee ha palesato problemi e limiti riguardanti la corretta valutazione dei rapporti di forza e la radicalità vista come antidoto al tradimento di classe e al riformismo
 Complici le imminenti elezioni europee, si sta
sviluppando un dibattito
politico
sulla questione europea tesa a delineare una posizione
politica di classe alternativa a quelle che vanno per la
maggiore nel quadro politico italiano
ed europeo: quella europeista liberista e quella
nazional-sovranista.
Complici le imminenti elezioni europee, si sta
sviluppando un dibattito
politico
sulla questione europea tesa a delineare una posizione
politica di classe alternativa a quelle che vanno per la
maggiore nel quadro politico italiano
ed europeo: quella europeista liberista e quella
nazional-sovranista.
Nelle minoritarie forze comuniste, o in quelle che quantomeno rimangono ancorate ad una visione di classe ed ad una prospettiva di società socialista, sembra essere abbastanza acquisito il fatto che le due impostazioni ideologico-politiche dominanti, in apparenza contrapposte, siano in realtà due facce della stessa medaglia, che rispondono, all’interno del fronte borghese, l’una alla grande borghesia sovranazionale, l’altra alla piccola e media borghesia nazionale del piccolo capitale, accomunate però da un’unica politica di classe antidemocratica ed antipopolare. Appare scontato ricordare che proprio la grande borghesia sovranazionale, quella del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale, in concomitanza con il deflagrare e acuirsi della crisi dagli anni 70/80 in poi, ha diretto e gestito il processo europeo e che la contrapposizione nazional-sovranista della piccola borghesia è espressione di una contraddizione intra-capitalista in cui essa è storicamente e strategicamente perdente, contraddizione tutta interna al campo borghese.
Per non rimanere però ad un livello di critica sovrastrutturale è bene ricordare, seppur in modo succinto e schematico, alcuni aspetti che definiscono l’attuale fase imperialista europea, quella del grande capitale monopolistico finanziario transnazionale europeo. Innanzitutto il processo di “transnazionalità” che ha interessato i vari imperialismi nazionali europei, così come li abbiamo conosciuti nel secondo dopoguerra, è tuttora un aspetto che opera in maniera forte nel quadro economico del vecchio continente, anche se è ben lungi dal determinare l’esito di un imperialismo europeo univoco e strutturato, come è il caso di quello usa-americano e che come tale si pone come unico e unitario attore sulla scena imperialista internazionale.
Leggi tutto
Francesco Maringiò: La cooperazione italo-cinese e l’alternativa del diavolo
La cooperazione italo-cinese e l’alternativa del diavolo
di Francesco Maringiò
Il complesso negoziato sino-americano sul commercio vive un momento non turbolento ma tuttavia segnato da oggettive difficoltà: troppa è la distanza che separa i moniti americani dalle concessioni che la Cina è disposta a fare senza penalizzare il suo sviluppo e troppo difficile diventa contenere l’impatto della guerra sul 5G (che è parte del negoziato ma che attiene, anche, ad altri aspetti strategici) negli Stati Uniti ed in Europa. Tuttavia, per quanto difficile, non è da escludere che un accordo sia ancora possibile. Ma sono tanti gli economisti che osservano come il “great deal” metterebbe sotto scacco l’Europa, stretta in un’alleanza tra le due superpotenze ed incapace di ritagliarsi un ruolo nel commercio internazionale.
È con questa premessa che va giudicata la firma di un memorandum d’intesa tra l’Italia e la Cina durante la visita di Stato del Presidente cinese, che inizierà ufficialmente il 22 p.v. con l’incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Perché di fronte al rischio concreto di fallimento del negoziato c’è l’assoluta necessità di costruire una politica estera sovrana per il Paese e capace di tutelarne gli interessi economici e geo strategici. Per fare ciò diventa imprescindibile un accordo quadro con la Cina popolare e le economie emergenti, pena il cedere ad una condizione ricattatoria che aggraverebbe ulteriormente la già precaria condizione dell’economia dell’Italia e della stessa eurozona.
Leggi tutto
Lorenzo Vita: Quell’intrigo fra Italia e Stati Uniti prima della visita di Xi Jinping
Quell’intrigo fra Italia e Stati Uniti prima della visita di Xi Jinping
di Lorenzo Vita
La visita del presidente Xi Jinping in Italia è stata preceduta da una tempeste mediatica e politica forse senza precedenti. Ma adesso, il viaggio di Xi è diventato realtà. E il principe rosso, o forse l’imperatore, è sbarcato a Roma ed è pronto a una serie di incontri di fondamentale importanza non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista squisitamente politico.
Un viaggio che spaccato il governo ma che ha soprattutto fatto tremare molti dall’altra parte dell’oceano Atlantico e nell’Unione europea. La Cina entra nel cuore dell’Europa non più da Paesi piccoli e periferici né attraverso accordi di natura commerciale. Pechino, questa volta, ha fatto le cose in grande. E ha puntato tutto sul governo italiano per siglare un accordo magari annacquato – specie dopo i forti richiami della Nato, degli Stati Uniti e dell’Unione europea – ma sicuramente utile a dare un segnale politico di rande spessore. La Cina ora è in Europa: e ha fatto il suo ingresso da una delle porte principali. Non solo dal Mediterraneo centrale, ma anche dalla terza potenza europea e da uno dei bastioni dell’Alleanza atlantica.
È soprattutto per questo motivo che Oltreoceano hanno a subito iniziato a fare pressioni affinché questo viaggio saltasse o che, nella peggiore delle ipotesi, l’accordo non toccasse alcuni punti essenziali della strategia atlantica per l’Italia.
Leggi tutto
Aldo Scorrano: Sulle crisi e i mutamenti (geo)politici
Sulle crisi e i mutamenti (geo)politici
Una recensione al nuovo libro di Gianfranco la Grassa
di Aldo Scorrano
Nel 2007, negli Stati Uniti, scoppia una crisi finanziaria che segnerà l’inizio di un lungo periodo di recessione economica e che investirà tutto l’occidente e buona parte del globo. Le insolvenze dei mutui bancari statunitensi ad alto rischio, cosiddetti subprime, produssero effetti che si riverberarono sui mercati finanziari internazionali, con il traumatico caso del fallimento, nel 2008, della Lehman Brothers. Molti analisti accostarono questo evento drammatico ad una nuova “crisi del ‘29”.
Una crisi la cui genesi ebbe origine all’interno del settore finanziario-bancario per poi trasformarsi in crisi della, cosiddetta, economia reale. Al di la degli effetti, certamente visibili e devastanti ex post, ciò che colpì maggiormente fu il fatto che la maggior parte dei sedicenti “esperti”, nonostante i segnali fossero presenti e disseminati, o non furono in grado di prevederla o ne sottostimarono la portata durante il verificarsi. Con una piccola eccezione rappresentata da alcuni economisti “fuori dal coro” (eterodossi) 1che, invece, ne “fiutarono” l’approssimarsi con alcuni anni d’anticipo, prevedendone gli effetti che si sarebbero verificati soprattutto in Europa nei paesi aderenti all’Unione Monetaria Europea (a causa del suo assetto) e, poi, in quella che fu definita come la “crisi greca”.
Leggi tutto
Giacomo Buzzao: “Internet of Things. Persone, organizzazioni e società 4.0” di Stefano Za
“Internet of Things. Persone, organizzazioni e società 4.0” di Stefano Za
di Giacomo Buzzao*
Recensione a: Stefano Za, Internet of Things. Persone, organizzazioni e società 4.0, LUISS University Press, Roma, 2018, pp. 138, 14 euro (scheda libro)
Nel corso della storia l’uomo ha sempre cercato un modo per trascrivere e documentare ciò che accade nella realtà. Utilizzando diversi supporti di memorizzazione e linguaggi, è riuscito a codificare e condividere informazioni tra i suoi simili, presenti e futuri.
La primordiale concretizzazione della tendenza dell’uomo a essere “un animale sociale”, sono le pitture rupestri (linguaggi) su pareti di caverna (supporti). Col tempo, la codifica delle informazioni è stata progressivamente perfezionata dall’elaborazione di nuovi linguaggi e grazie all’utilizzo di supporti più evoluti e condivisi (tavole di legno, papiri, libri, videocassette sino ad arrivare ai supporti digitali).
Le diverse innovazioni digitali hanno accresciuto esponenzialmente le capacità di condivisione di informazioni e interazione dell’uomo. Oggi la quantità di realtà codificata nel “mondo digitale” è davvero notevole e se si pensa ad esempio al fenomeno dei Big Data, c’è modo di intuire che non smetterà di aumentare. Anche perché la produzione delle informazioni codificate, nel mondo dematerializzato virtuale, non è più ad esclusivo appannaggio dell’uomo; «l’ambiente inizia a documentare se stesso» attraverso gli oggetti (le cose).
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3660
Hits 2779
Hits 2638
Hits 2537
Hits 2286
Hits 2210
Hits 2102
Hits 2049
Hits 1957
Hits 1869
tonino

Pino Nicotri: Con la Nuova Via della Seta la Cina è vicina, anzi è tra noi
Con la Nuova Via della Seta la Cina è vicina, anzi è tra noi
di Pino Nicotri
E anziché cercare il dominio politico militare cerca l’incremento degli scambi. Non solo commerciali
 Il Mediterraneo – una
volta il Mare Nostrum – tornerà ad essere ciò che il
suo nome significa, e cioè “In mezzo alle terre”, dove per
terre si intende l’Europa, l’Africa e l’Asia? E’
possibile, se non probabile o certo. E a riempire
concretamente il significato del suo nome sarà il poker d’assi
porti italiani di Genova
e Trieste e quelli spagnoli di Bilbao e Valencia più quello
portoghese meridionale di Sines: questo infatti anche se
affacciato
sull’Atlantico farà da snodo verso l’Africa. Questi cinque
porti saranno i terminali occidentali del gigantesco progetto
cinese
Belt and Road Initiative, in sigla BRI, noto anche come Nuova
Via della Seta, al quale hanno già aderito 60 Paesi più oltre
40
organizzazioni internazionali e che intende stimolare anche
con rotte navali non solo l’integrazione dei commerci e delle
economie dei tre
continenti citati, ma diventare per loro “un percorso che
porta all’amicizia, allo sviluppo condiviso, alla pace,
all’armonia e ad
un futuro migliore”. Lo ha dichiarato a Shangai lo scorso
novembre il presidente della Cina Xi Jinping all’International
Economic and
Trade Forum, al quale il 5 novembre ha partecipato, con il suo
secondo viaggio in Cina, il nostro vicepremier e ministro
dello Sviluppo Economico e
del Lavoro Luigi Di Maio (https://video.repubblica.it/politica/shanghai-la-gaffe-di-luigi-di-maio-il-presidente-xi-jinping-diventa–ping/318842/319471).
Il Mediterraneo – una
volta il Mare Nostrum – tornerà ad essere ciò che il
suo nome significa, e cioè “In mezzo alle terre”, dove per
terre si intende l’Europa, l’Africa e l’Asia? E’
possibile, se non probabile o certo. E a riempire
concretamente il significato del suo nome sarà il poker d’assi
porti italiani di Genova
e Trieste e quelli spagnoli di Bilbao e Valencia più quello
portoghese meridionale di Sines: questo infatti anche se
affacciato
sull’Atlantico farà da snodo verso l’Africa. Questi cinque
porti saranno i terminali occidentali del gigantesco progetto
cinese
Belt and Road Initiative, in sigla BRI, noto anche come Nuova
Via della Seta, al quale hanno già aderito 60 Paesi più oltre
40
organizzazioni internazionali e che intende stimolare anche
con rotte navali non solo l’integrazione dei commerci e delle
economie dei tre
continenti citati, ma diventare per loro “un percorso che
porta all’amicizia, allo sviluppo condiviso, alla pace,
all’armonia e ad
un futuro migliore”. Lo ha dichiarato a Shangai lo scorso
novembre il presidente della Cina Xi Jinping all’International
Economic and
Trade Forum, al quale il 5 novembre ha partecipato, con il suo
secondo viaggio in Cina, il nostro vicepremier e ministro
dello Sviluppo Economico e
del Lavoro Luigi Di Maio (https://video.repubblica.it/politica/shanghai-la-gaffe-di-luigi-di-maio-il-presidente-xi-jinping-diventa–ping/318842/319471).
Poche settimane dopo avere pronunciato quelle parole il presidente Xi è stato in visita in Spagna dal 27 al 29 dello scorso novembre per proporre l’adesione alla BRI anche alla Spagna, Paese nel quale l’anno scorso la compagnia navale cinese Cosco Shipping Holdings si è aggiudicato il 51%, cioè la maggioranza assoluta, del gruppo spagnolo Notaum Port, gestore dei servizi portuali per le navi container a Bilbao e Valencia. E se la Spagna si è riservata di decidere, il Portogallo invece lo scorso 5 dicembre ha aderito e concesso per la BRI lo sbocco nel porto di Sines, sulla costa meridionale del Portogallo e poco distante dallo Stretto di Gibilterra.
Leggi tutto
Lorenzo Battisti: I gilet gialli francesi visti da vicino: un’analisi di classe del movimento
I gilets jaunes visti da vicino: un’analisi di classe del movimento
I limiti della sinistra italiana
di Lorenzo Battisti
 Spesso per comprendere la natura
di un fenomeno sociale è bene osservarlo da una certa
distanza. Quando
vivevo in Italia questo mi permetteva di cogliere meglio certi
aspetti delle vicende francesi, poiché non ne ero
personalmente coinvolto. Al
contempo questa distanza dovrebbe permettere ai compagni
italiani di leggere meglio di me (che ora vivo in Francia) il
movimento dei Gilets Jaunes, i
gillet gialli.
Spesso per comprendere la natura
di un fenomeno sociale è bene osservarlo da una certa
distanza. Quando
vivevo in Italia questo mi permetteva di cogliere meglio certi
aspetti delle vicende francesi, poiché non ne ero
personalmente coinvolto. Al
contempo questa distanza dovrebbe permettere ai compagni
italiani di leggere meglio di me (che ora vivo in Francia) il
movimento dei Gilets Jaunes, i
gillet gialli.
L’impressione purtroppo sembra opposta: per qualche ragione i compagni italiani hanno di questo movimento un’immagine che non corrisponde affatto alla realtà. Cercherò di fare un’analisi del movimento e di spiegare le ragioni di questa attitudine italiana a scambiare i propri sogni per la realtà.
Genesi del movimento: l’ecotassa sul carburante
Il movimento è partito nel mese di Novembre come protesta spontanea e auto-organizzata contro l’introduzione di un'accisa sui carburanti volta a finanziare il passaggio del parco auto francese verso modelli meno inquinanti. L’idea del governo era di punire i gli inquinatori, per premiare con gli introiti i cittadini responsabili. In realtà si è trattato della goccia che ha fatto traboccare il vaso di una Francia già soggetta un carico fiscale importante[i].
La struttura attuale dell’Unione Europea infatti non colpisce solo i lavoratori, lanciandoli in una competizione al ribasso, in cui ciascuno è costretto ad accettare condizioni di lavoro sempre peggiori per ottenere che il lavoro venga svolto nel proprio paese invece che nel paese a fianco. Questa colpisce anche i sistemi fiscali che vengono messi in competizione l’uno contro l’altro per far sì che le grandi imprese investano nel proprio paese. Se il paese a fianco fa uno sconto fiscale del 30%, noi dobbiamo farlo del 40%, cosa che porterà un terzo paese a farlo del 50%. Il risultato è che le grandi imprese multinazionali di fatto non pagano più imposte, e ora la competizione è sugli incentivi per farle venire o per non farle andare via: il loro saldo fiscale è passato da negativo a positivo. Queste imprese pagano imposte zero, e ricevono una parte delle imposte pagate dagli altri sotto forma di incentivi.
Leggi tutto
Lars T. Lih: ‘Tutto il potere ai Soviet!’, parte sesta
‘Tutto il potere ai Soviet!’, parte sesta
Il carattere della Rivoluzione russa: il Trotsky del 1917 contro quello del 1924
di Lars T. Lih
 Nell’aprile del 1917,
Georgii Plekhanov – venerando esponente della socialdemocrazia
russa, ma in quel momento
confinato nell’ala “difensista” dello spettro socialista –
scriveva una coppia di articoli che, per una via inaspettata e
sorprendente, sono divenuti la base dell’odierna narrazione
del “riarmo” dei bolscevichi durante la rivoluzione. In questi
articoli,
Plekhanov formulava le seguenti asserzioni:
Nell’aprile del 1917,
Georgii Plekhanov – venerando esponente della socialdemocrazia
russa, ma in quel momento
confinato nell’ala “difensista” dello spettro socialista –
scriveva una coppia di articoli che, per una via inaspettata e
sorprendente, sono divenuti la base dell’odierna narrazione
del “riarmo” dei bolscevichi durante la rivoluzione. In questi
articoli,
Plekhanov formulava le seguenti asserzioni:
1. Nelle sue Tesi di aprile, Lenin proclamava il carattere socialista della Rivoluzione russa.
2. Così facendo, Lenin sottovalutava la natura arretrata della società russa.
3. La nuova posizione assunta da Lenin costituiva un’esplicita rottura rispetto all’ortodossia marxista da lui stesso propugnata in precedenza.
4. Affermare il carattere socialista della Rivoluzione russa rappresentava una necessità logica per chiunque sostenesse il trasferimento del vlast (l’autorità politica sovrana) ai soviet.
5. Il riconoscimento della natura democratica-borghese della rivoluzione implicava logicamente il sostegno al Governo provvisorio.
Queste cinque proposizioni sono ortodossia assolutamente incontrovertibile per la maggioranza degli autori, tanto accademici quanto militanti, che si occupano di Rivoluzione russa. Curiosamente, tuttavia, lo stesso Lenin respinse ognuna di queste affermazioni.
In un articolo rivolto contro Plekhanov, pubblicato sulla Pravda il 21 aprile, Lenin sottolineava che “se i piccoli proprietari costituiscono la maggioranza della popolazione e se non esistono le condizioni oggettive per il socialismo, come può la maggioranza della popolazione dichiararsi a favore del socialismo?! Chi può dire e chi dice di introdurre il socialismo contro la volontà della maggioranza?!”. Fatto cruciale, Lenin asseriva che la via verso il potere al soviet era cionondimeno dettata dalla natura democratica della rivoluzione: “Com’è allora possibile , senza tradire la democrazia, pur intesa alla maniera di Miliukov, pronunciarsi contro la «conquista del vlast politico» da parte della «massa lavoratrice russa»?” (Si veda il quinto post di questa serie, “‘Una questione fondamentale: le glosse di Lenin alle Tesi di aprile’”).
Leggi tutto
Francesco Piccioni: Rompere l’Unione: una possibilità realistica, non ideologia
Rompere l’Unione: una possibilità realistica, non ideologia
di Francesco Piccioni
La firma del Memorandum tra Italia e Cina – mentre altri sono stati formati o lo saranno a breve da altri paesi europei – è un fatto storico. L’unico, probabilmente, che verrà ascritto a questo governo di furbetti mal assemblati anche se a metterne le basi sono stati soprattutto il Vaticano e, due anni fa, Mattarella e Gentiloni. Ovvero dai due rappresentanti “democratici” più “vicini” alla Santa Sede (non che gli altri siano dei fierissimi atei, tutt’altro).
L’origine geostrategica è importante e viene apertamente rivendicata, stamattina su La Stampa, da Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, organo dei gesuiti. Non a caso la congregazione di provenienza di papa Bergoglio.
La chiave di lettura è ovviamente quella “cultural-religiosa” (“Pechino insiste molto sugli scambi culturali tra i popoli dell’ecumene euro-afro-asiatica, e lo fa anche investendo risorse in innumerevoli iniziative dedicate al patrimonio immateriale: musei, fiere, mostre”), ma coglie un punto-chiave, un non detto che traspare sempre più spesso dietro le preoccupazioni o le isterie “sull’invasione” che hanno riempito strumentalmente molte pagine ed ore di trasmissione tv, sia “democratica” che apertamente di destra.
Il punto è questo:
“Gli storici si chiedono se stiamo sperimentando la conclusione di cinquecento anni di predominio occidentale. Il dibattito riflette il dilemma di una società dell’ovest che sente il futuro del mondo sempre meno nelle sue mani.
Leggi tutto
VRP: Caro Uolter, ti piace vincere facile
Caro Uolter, ti piace vincere facile
di VRP
Caro Uolter,
sì tu, quello che purtroppo non se n’è mai andato nemmeno dopo l’autodenuncia del suo idolo Blair, ora ci dici che dobbiamo tornare al dualismo destra-sinistra.
Ti piace vincere facile, insomma, considerato che a destra hai un ultraottuagenario mal consigliato che non si è accorto che il mondo non è più quello di trent’anni fa (e nemmeno lui), una destra tutta ordine e manganelli con un capitano più pompato di un lottatore di wrestling che non a caso combattono in match finti.
Come è finto il tema che vuoi riportare al centro della politica, tu tra i buoni, quelli che vogliono jus soli e accoglienza a go-go, Salvini a capo dei cattivi, perchè tanto dietro a lui, a manovrarli, c’è un apparato col quale si tratta bene nel segreto delle stanze di palazzo. E così ricominciamo con l’unica cosa che sai che puoi dare al popolo: il contentino dei diritti civili e altre baggianate con cui farti bello.
Come se non fosse mai caduto il Ponte di Genova. Come se questo shock non ci avesse fatto aprire gli occhi su un’Italia che cade a pezzi, che frana, ancora con le ferite del terremoto da sanare. Con i giovani senza lavoro che se ne vanno al ritmo di 5 al giorno.
Leggi tutto
coniarerivolta: Capitalismo e repressione: un binomio di lunga durata
Capitalismo e repressione: un binomio di lunga durata
di coniarerivolta
Si sente spesso ripetere, da parte di illuminati opinionisti liberali, che la lotta di classe non è altro che un residuato radioattivo del XX secolo, e che è ormai giunto il momento di rimboccarsi le maniche e lavorare insieme, imprenditori e lavoratori fianco a fianco, per accrescere la produttività delle imprese italiane e attirare (perché no?) investitori internazionali. Questo comportamento cooperativo garantirebbe, sostengono costoro, il benessere di tutti, operai e datori di lavoro.
Peccato che siano gli stessi imprenditori a smentire tale visione idilliaca ed edulcorata dei rapporti produttivi, ricorrendo a ogni mezzo, lecito e illecito, pur di ristabilire la propria preponderanza. È ben noto, infatti, che i coraggiosi capitani d’industria, quando si trovano di fronte a una classe lavoratrice restia a sottomettersi, non esitano a ricorrere a qualsiasi mezzo pur di schiacciare le rivendicazioni degli operai e ricondurli a miti consigli. Come racconta il Corriere della Sera,
«Ci hanno aggredito con bastoni e pistole elettriche. Erano una quindicina, tutti di una società che si occupa di sicurezza nei locali notturni». Così la testimonianza di un gruppo di lavoratori di tre cooperative di facchinaggio che forniscono i loro servizi a una società del Gruppo Faro collegata a Zara, brand spagnolo del patron Amancio Ortega, sesto fra i più ricchi del mondo con un patrimonio di 62,7 miliardi di dollari, secondo Forbes.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Appunti sull’insurrezione algerina
Appunti sull’insurrezione algerina
di Giacomo Marchetti
Ciò che sta avvenendo in Algeria da più di un mese – precisamente dal 22 febbraio – determina una rottura irreversibile con il “sistema Bouteflika” che ha governato il Paese dal 1999.
Anche se questo movimento politico-sociale, inedito dalla conquista dell’indipendenza nel 1962, ha un carattere intergenerazionale, la spinta della fascia giovanile è fortissima.
Più del 50% degli algerini – che sono poco più di 40 milioni e per il 70% vivono in realtà urbane – ha meno di trent’anni, il paese conta un milione e settecento mila studenti – di cui un milione sono donne – che non trovano sbocco nel mercato del lavoro dominato dall’economia informale e dal precariato sociale diffuso ed in buona parte sono costretti a vivere tra le mura domestiche dei genitori talvolta fino ai 30 anni circa.
Questi giovani che nella storica visita di Chirac circa quindici anni fa chiedevano al presidente francese “più visti” per potersi recare nell’Esagono, ora esprimono fieramente la volontà di voler rimanere nel proprio Paese contribuendo a cambiare radicalmente le condizioni di esistenza come recitano molti cartelli e riportano numerose testimonianze, alla faccia della paura di una “invasione” degli algerini prospettata da Marie Le Pen dopo lo scoppio della crisi.
Leggi tutto
Potere al Popolo: “Non ci saremo alle europee, ma saremo ovunque”
“Non ci saremo alle europee, ma saremo ovunque”
di Potere al Popolo
Il documento politico approvato dal Coordinamento nazionale di Potere al Popolo del 24 marzo
 “Sono tempi
difficili, lo so, ma non
cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza,
mai! Neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra
perduto e i mali che affliggono
l’uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di
trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È
proprio nei momenti
più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che
ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di
essere voi quella
goccia”.
“Sono tempi
difficili, lo so, ma non
cedete alla rassegnazione, non abbandonate la speranza,
mai! Neppure per un attimo. Anche quando tutto sembra
perduto e i mali che affliggono
l’uomo e la terra sembrano insormontabili, cercate di
trovare la forza e di infonderla nei vostri compagni. È
proprio nei momenti
più bui che la vostra luce serve. E ricordate sempre che
ogni tempesta comincia con una singola goccia. Cercate di
essere voi quella
goccia”.
Sono queste parole, scritte dal combattente YPG e partigiano italiano Lorenzo “Orso”, ad aver ispirato il Coordinamento Nazionale di domenica 24 marzo. Queste parole, così come il video e l’esempio di Lorenzo, hanno colpito noi come migliaia di persone. Perché hanno dimostrato di cosa è possibile una singola persona quando è animata da una grande idealità e da un forte sentimento del collettivo, ci hanno riportato al senso originario del nostro fare politica, che a volte si perde fra mille urgenze e problemi, ci hanno dato forza e mostrato l’orizzonte.
Ci siamo rivisti in queste parole perché Potere al Popolo! nasce proprio come una sfida: che tanti singoli partigiani e diverse “bande” che quotidianamente resistono, potessero mettersi insieme, trasformare le singole gocce che oggi si perdono o vengono assorbite, in una tempesta che lavi via lo sporco del nostro paese e di questo mondo.
Ci siamo rivisti in queste parole perché Potere al Popolo! non ha mai voluto essere l’ennesima forza di sinistra, magari più estrema, a fianco e in conflitto con le altre, ognuna fissata con la sua piccola verità. Ma soprattutto un messaggio, un movimento popolare, una struttura di collegamento, di diffusione e di organizzazione di pratiche, di condivisione di saperi e competenze, di finalizzazione delle lotte, di spinta all’autorganizzazione sui territori, di visibilità di un’altra Italia, di quella città futura, come diceva Gramsci, che già oggi esiste in embrione, ma che deve affermarsi contro chi impoverisce le nostre vite.
Leggi tutto
Eros Barone: Nove volte Stalin
![]()
Nove volte Stalin
di Eros Barone
 «La radio al buio e sette operai / sette
bicchieri che brindano a Lenin / e Stalingrado arriva nella
cascina e nel fienile / vola un berretto un uomo ride e
prepara il suo fucile / Sulla sua
strada gelata la croce uncinata lo sa / D’ora in poi troverà
Stalingrado in ogni città.»
«La radio al buio e sette operai / sette
bicchieri che brindano a Lenin / e Stalingrado arriva nella
cascina e nel fienile / vola un berretto un uomo ride e
prepara il suo fucile / Sulla sua
strada gelata la croce uncinata lo sa / D’ora in poi troverà
Stalingrado in ogni città.»
Stalingrado, Stormy Six.
La ricorrenza del centoquarantesimo anniversario della nascita di Iosif Vissarionovic Giugasvili, detto Stalin (1879-1953), costituisce un’occasione per interrogarsi sul ruolo di una personalità che, dopo aver dominato la scena della politica interna del suo paese e la scena della politica internazionale del mondo intero nella prima metà del ventesimo secolo, ha continuato a proiettare una lunga ombra sugli sviluppi politico-ideologici dei decenni successivi sino ai nostri giorni.
Può allora essere utile ricordare il significato di questo soprannome, gridando il quale (“Sa Stalina!”, ossia “Per Stalin!”) milioni di soldati sovietici combatterono nella Grande Guerra Patriottica, sacrificando la loro vita per difendere il primo Stato socialista del mondo: Stalin, cioè ‘acciaio’, un soprannome che indica due qualità essenziali di questo metallo, la durezza e la flessibilità, e la loro incarnazione in un leader bolscevico che lo stesso Lenin ebbe a qualificare come “quel meraviglioso georgiano” (definizione etnica che compare nel sottotitolo di una bella biografia di Stalin scritta da Gianni Rocca 1 ). Poiché una figura come quella di Stalin non permette di operare un taglio netto fra la leggenda (sia eulogica sia demonizzante), che ben presto si è formata attorno a tale figura, 2 e la concreta funzione storica che questa personalità ha svolto nel “secolo degli estremi”, proverò ad accendere su questo soggetto ad alta tensione interpretativa alcuni ‘flash’ che ne fissano quelli che, secondo il mio giudizio, sono i tratti salienti.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Impero
![]()
Impero
di Salvatore Bravo
 In Impero di Toni Negri vi è l’analisi
della condizione presente
del capitalismo assoluto; la “rete capitale” è un’invisibile
gabbia d’acciaio, il suddito vive la sussunzione formale e
materiale, in media, senza percepirne l’onnipresenza. La rete
del capitale produce ininterrottamente merci, astrae materie
prime, ma il potere
è creatura prometeica e demiurgica, nello stesso tempo
produce, con lo stesso ritmo, merci e coscienze. Il potere è
biopotere che
predetermina la vita, la gabbia d’acciaio è il trascendentale,
il potere censura linguaggi, stabilisce gerarchie, attraverso
le sue
maglie filtra un modo di essere e di esserci prestabilito, il
tempo presente con i suoi stili di vita è così eternizzato. La
guerra
è il mezzo attraverso cui l’impero risolve le contraddizioni,
essa diviene la condizione quotidiana in cui ogni
contradizione ed
alterità è assimilata al male “reductio ad Hitlerum” è la
legge che prepara l’eliminazione/assimilazione in
nome delle libertà, dei diritti civili. Si combatte il male in
nome del bene, dei diritti umani, pertanto i bombardamenti
umanitari sono
necessari perché il bene trionfi, la crisi è la normalità
dell’impero, una tattica di governo per rafforzare
l’impero, per tenere in tensione i sudditi, per farli sentire,
senza capire, che abitano nella parte giusta, che sono
l’impero del bene in
perenne lotta contro il male1 :
In Impero di Toni Negri vi è l’analisi
della condizione presente
del capitalismo assoluto; la “rete capitale” è un’invisibile
gabbia d’acciaio, il suddito vive la sussunzione formale e
materiale, in media, senza percepirne l’onnipresenza. La rete
del capitale produce ininterrottamente merci, astrae materie
prime, ma il potere
è creatura prometeica e demiurgica, nello stesso tempo
produce, con lo stesso ritmo, merci e coscienze. Il potere è
biopotere che
predetermina la vita, la gabbia d’acciaio è il trascendentale,
il potere censura linguaggi, stabilisce gerarchie, attraverso
le sue
maglie filtra un modo di essere e di esserci prestabilito, il
tempo presente con i suoi stili di vita è così eternizzato. La
guerra
è il mezzo attraverso cui l’impero risolve le contraddizioni,
essa diviene la condizione quotidiana in cui ogni
contradizione ed
alterità è assimilata al male “reductio ad Hitlerum” è la
legge che prepara l’eliminazione/assimilazione in
nome delle libertà, dei diritti civili. Si combatte il male in
nome del bene, dei diritti umani, pertanto i bombardamenti
umanitari sono
necessari perché il bene trionfi, la crisi è la normalità
dell’impero, una tattica di governo per rafforzare
l’impero, per tenere in tensione i sudditi, per farli sentire,
senza capire, che abitano nella parte giusta, che sono
l’impero del bene in
perenne lotta contro il male1 :
”C’è qualcosa di inquietante in questa rinnovata attenzione per il concetto per il concetto di justum bellum che la modernità o meglio, la moderna secolarizzazione ha ostinatamente cercato di sradicare dalla tradizione medioevale. Il concetto tradizionale di guerra giusta comporta la banalizzazione della guerra e la sua valorizzazione come strumento etico: due assunti risolutamente respinti dal pensiero politico moderno e dalla comunità degli stati-nazione. Queste tradizionali caratteristiche sono invece riapparse nel nostro mondo postmoderno: da un lato, la guerra viene ridotta ad un intervento di polizia internazionale e, dall’altro, viene sacralizzato il nuovo tipo di potere che può legittimamente esercitare funzioni etiche mediante la guerra. (…) La guerra è divenuta un atto che si giustifica da sé.
Leggi tutto
Noi Restiamo: Fratture reali e rotture possibili nella UE. la Rivoluzione nel XXI Secolo
Fratture reali e rotture possibili nella UE. la Rivoluzione nel XXI Secolo
di Noi Restiamo
Il processo di costituzione di un polo imperialista europeo in grado di competere alla pari con gli altri macro-blocchi mondiali in uno scenario internazionale sempre più bellicoso fino a questo momento si è dimostrato in grado di reggere i colpi delle contraddizioni che ha necessariamente scatenato. Trattandosi di un processo reale e non concluso naturalmente possiamo semplicemente leggere le tendenze, e impostare la nostra analisi su quelle. Diventa fondamentale quindi per una realtà politica che identifica nella competizione imperialista internazionale il proprio nemico principale (e di conseguenza costruisce la propria attività intorno all’obiettivo di rompere il proprio imperialismo) una riflessione accurata sulle fratture reali e sulle possibilità di rottura che in questi anni si sono manifestate (e si stanno manifestando) all’interno della Unione Europea.
Il 6 luglio 2015 il popolo greco – dopo sei mesi di estenuante trattativa tra il neo-eletto governo di Syriza e l’Unione Europea – dice di no con un referendum popolare al ricatto del debito e dell’austerità. Nonostante questo pochi giorni dopo lo stesso esecutivo firma un terzo memorandum che comporta ulteriori disastri sociali e di fatto la fine della sovranità politica interna. Con il 61,3% dei voti per l’OXI il popolo greco voleva voltare definitivamente pagina, nonostante la campagna terroristica condotta dalla UE ed i mass-media con lei schierati.
Leggi tutto
Internet è ufficialmente morto in Europa
Internet è ufficialmente morto in Europa
Il Parlamento Europeo ha appena approvato in pieno la direttiva sul copyright, articoli 11 e 13 compresi. "È un giorno buio per la libertà di internet."
Il Parlamento Europeo ha appena approvato la direttiva europea sul copyright. Con 348 voti a favore e 274 contrari, gli articoli 11 e 13 sono diventati realtà. Non vi è stata nemmeno la possibilità di votare per gli emendamenti che avrebbero proposto la rimozione dei singoli articoli — possibilità persa per soli 5 voti contrari.
Gli sforzi dei cittadini, degli attivisti, e degli esperti di internet — culminati con la pubblicazione domenica scorsa di una lettera contraria agli articoli 11 e 13, firmata dagli accademici di tutta Europa che si occupano di diritto informatico e proprietà intellettuale — non sono bastati a convincere la maggioranza degli europarlamentari a votare contro una direttiva che introduce una macchina della censura preventiva, che dovrà filtrare ogni contenuto caricato online.
Alcuni politici hanno intenzionalmente avvitato la discussione sulla direttiva copyright intorno alle sole posizioni dei detentori dei diritti d’autore — che non sempre combaciano con gli autori e i creatori dell’opera — e le grandi piattaforme. Lasciando completamente da parte le richieste dei cittadini, degli artisti e dei creatori di contenuti. I colpi bassi in questi mesi hanno ricordato più una stagione di Game of Thrones che un processo democratico.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Attenti, il nemico vi ascolta
Attenti, il nemico vi ascolta
di ilsimplicissimus
Oggi ho un compito facile, che alla fine si concreta nel riportare alcuni virgolettati che dovrebbero inquietare le coscienze e che invece passeranno presto nel dimenticatoio sostituite da altre e più gravi preoccupazioni di tendenza. Il fatto in sé è semplice e in qualche modo non inedito: è stato scoperta, o meglio, messa in luce una lunga collaborazione fra l’esercito britannico e l’università di Cambridge per mettere a punto sistemi di manipolazione psicologica. Niente di nuovo visto che in qualche modo essi sono stati sempre usati contro il nemico, anche nella più lontana antichità, ma in questo caso si è trattato di coniugare la ricerca sociologica e neuroscientifica con l’elaborazione dei dati di massa provenienti dal vasto e variegato mondo della rete. In effetti la ricerca con concerneva la ” manipolazione mirata delle informazioni nei domini fisici e virtuali per formare atteggiamenti e credenze nel dominio cognitivo “.
In questi ultimi vent’anni abbiamo visto come questo tipo di azioni è riuscito a creare un qualche tipo di consenso nei confronti di guerre sfacciatamente aggressive come in Siria o cambi di regime illegittimi e oscuri come in Ucraina e ora in Venezuela, riuscendo a creare una corrente di neutralità coatta o addirittura di appoggio nei confronti di azioni la cui illegittimità era ed è più che evidente.
Leggi tutto
Riccardo Paccosi: Il concetto di autonomia operaia al tempo dei gilet gialli
Il concetto di autonomia operaia al tempo dei gilet gialli
di Riccardo Paccosi
Il presente intervento, rappresenta uno sviluppo d’un mio precedente articolo, scritto esattamente un anno fa e intitolato Il concetto di autonomia operaia al tempo del populismo
Come simbolizzato nella foto in fondo, la dicotomia del
nostro tempo non è più quella destra-sinistra bensì quella
classe-capitale.
Chi la pensa diversamente e pretende di poter ancora attribuire alla sinistra la difesa della working class, nella maggior parte dei casi non fa parte di quest’ultima né la frequenta.
La classe lavoratrice non è mai stata rappresentata dalla destra, ma la novità consta del fatto ch’essa non sia più rappresentata, oggi, nemmeno dalla sinistra: e il motivo è filosofico, prima che politico. Infatti non si pone, oggi, il problema dell’esistenza di una “falsa sinistra”, bensì quello di un’irreversibile rottura etico-cognitiva tra proletariato e sinistra propriamente detta.
Prendiamo un motto indubbiamente di sinistra come “porti aperti come i nostri culi”: in questo slancio di apertura incondizionata, si palesa la sicurezza vitalistica di chi non avverte un bisogno di protezione sociale, di chi separa nettamente il principio di emancipazione da quello di protezione.
Questo si è potuto verificare perché – come dice il filosofo Jean-Claude Michéa – si sono esaurite le ragioni di quell’alleanza tra borghesia progressista e proletariato, stipulata due secoli fa contro l’ancien régime e contro i suoi addentellati di tradizionalismo, confessionalismo e patriarcato.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3692
Hits 2794
Hits 2655
Hits 2558
Hits 2288
Hits 2220
Hits 2120
Hits 2061
Hits 1983
Hits 1904
tonino

Giovanni Di Benedetto: Una spirale in continuo sviluppo
Una spirale in continuo sviluppo
Rosa Luxemburg e l'accumulazione del capitale
di Giovanni Di Benedetto
 Ciò che
Marx presuppone non è la fantasia bambinesca di una società
capitalistica sull’isola di Robinson, che fiorisce nel
chiuso,
«isolata» da continenti con popoli non-capitalistici, di una
società in cui lo sviluppo capitalistico ha raggiunto il più
alto grado immaginabile (…) e che non conosce né artigianato
né contadiname e non ha rapporti col mondo circostante
non-capitalistico. Il presupposto di Marx non è un assurdo
della fantasia, ma un’astrazione scientifica. Marx anticipa
la tendenza
realedello sviluppo capitalistico; ammette come già
raggiunto quello stato di dominio generale assoluto del
capitalismo su tutto il mondo,
quell’estrema dilatazione del mercato mondiale e
dell’economia mondiale, verso cui il capitale e l’intero suo
sviluppo economico e
politico odierno realmente tende.
Ciò che
Marx presuppone non è la fantasia bambinesca di una società
capitalistica sull’isola di Robinson, che fiorisce nel
chiuso,
«isolata» da continenti con popoli non-capitalistici, di una
società in cui lo sviluppo capitalistico ha raggiunto il più
alto grado immaginabile (…) e che non conosce né artigianato
né contadiname e non ha rapporti col mondo circostante
non-capitalistico. Il presupposto di Marx non è un assurdo
della fantasia, ma un’astrazione scientifica. Marx anticipa
la tendenza
realedello sviluppo capitalistico; ammette come già
raggiunto quello stato di dominio generale assoluto del
capitalismo su tutto il mondo,
quell’estrema dilatazione del mercato mondiale e
dell’economia mondiale, verso cui il capitale e l’intero suo
sviluppo economico e
politico odierno realmente tende.
(Rosa Luxemburg, Ciò che gli epigoni hanno fatto della teoria marxista. Una anticritica)
Quando, all’inizio del proprio discorso, nel mese di Gennaio del 1919, alcuni giorni dopo l’assassinio di Rosa Luxemburg e Karl Liebknecht, Grigorii Zinoviev, presidente del Soviet di Pietrogrado, li commemorò, ebbe a dire, pressappoco, che la Luxemburg era appartenuta a quella rara schiera di affiliati al movimento dei lavoratori che aveva avuto non solo il merito di divulgare le idee di Marx ma anche di contribuire, con la propria parola e il proprio pensiero, all’arricchimento della stessa teoria marxiana della critica dell’economia politica.
Allo scoccare del secolo dal terribile eccidio del 15 Gennaio 1919, ordinato dal socialdemocratico Gustav Noske ed eseguito dai Freikorps, questo lapidario e solenne giudizio non sembra, col passare del tempo, aver perso di vitale veridicità. Tutt’altro, considerato che, a partire dalla metà degli anni ’20 del secolo scorso, l’ortodossia stalinista aveva condannato all’oblio e a una sostanziale rimozione, l’eredità luxemburghiana. Eppure, oggi, l’opera intellettuale di Rosa Luxemburg dimostra una forza e una lucidità non comuni e, forse, una produttività, agli occhi di molti, inaspettata.
Leggi tutto
Vincenzo Russo: Sui valori dopo il neoliberismo: recensione a Laura Pennacchi
Sui valori dopo il neoliberismo: recensione a Laura Pennacchi
di Vincenzo Russo
Il libro parte dalla contestazione dell'opinione corrente secondo cui "De gustibus et de valoribusnon est disputandum" - un'opinione apparentemente di senso comune, in realtà basata sulla fallace equiparazione epistemologica dei "valori"
 Il libro “De
Valoribus Disputandum Est. Sui valori dopo il
neoliberismo” di Laura Pennacchi (Mimesis
Edizioni, 2018) è una formidabile rassegna della filosofia
morale,
dell’etica, dell’economia, della sociologia, della
psicanalisi, della teoria della giustizia sociale degli ultimi
secoli non senza
trascurare quella dei Greci e dei Romani. In considerazione
degli effetti devastanti prodotti dal neoliberismo negli
ultimi quaranta anni in termini
di scissione tra mezzi e fini, di razionalità strumentale in
un contesto di accelerazione del processo di globalizzazione
quello di Laura
Pennacchi è un importante tentativo di ricostruire una teoria
dei valori. Un contesto che ha messo in discussione
la
possibilità di conciliare globalizzazione non governata,
sovranità nazionale e democrazia secondo il noto trilemma di
Dani Rodrik.
Il libro “De
Valoribus Disputandum Est. Sui valori dopo il
neoliberismo” di Laura Pennacchi (Mimesis
Edizioni, 2018) è una formidabile rassegna della filosofia
morale,
dell’etica, dell’economia, della sociologia, della
psicanalisi, della teoria della giustizia sociale degli ultimi
secoli non senza
trascurare quella dei Greci e dei Romani. In considerazione
degli effetti devastanti prodotti dal neoliberismo negli
ultimi quaranta anni in termini
di scissione tra mezzi e fini, di razionalità strumentale in
un contesto di accelerazione del processo di globalizzazione
quello di Laura
Pennacchi è un importante tentativo di ricostruire una teoria
dei valori. Un contesto che ha messo in discussione
la
possibilità di conciliare globalizzazione non governata,
sovranità nazionale e democrazia secondo il noto trilemma di
Dani Rodrik.
Partendo dall’assunto della Scuola di Chicago secondo cui i fallimenti dello Stato sono più gravi di quelli del mercato e, quindi, dalla endemica ostilità del neoliberismo nei confronti dell’operatore pubblico, ci si aspetterebbe che l’individuo fosse seriamente valorizzato al massimo, invece, il soggetto viene ridotto a homo economicus. Un uomo razionale che massimizza il proprio interesse e, quindi, egoista, migliore giudice di sé stesso che non ha bisogno delle mediazioni di chicchessia. Dagli economisti il soggetto è assunto come individuo rappresentativo che semplifica e fa funzionare i modelli ora computabili di equilibrio economico generale. Apparentemente in contrasto con questo assunto, le forze politiche populiste e sovraniste assumono il popolo come soggetto del loro modello teorico. Sennonché, mentre l’individuo rappresentativo ha qualche risconto concreto con gli individui reali operanti nell’economia e nella società, il popolo rappresentativo è mera realtà virtuale sulla quale appaiono efficaci le semplificazioni ingannevoli ed illusorie propalate dai politici populisti e sovranisti.
Leggi tutto
Le ombre di Kafka
Le ombre di Kafka
Editoriale del numero 1: Kafka, la scrittura della destituzione?
 Con una straordinaria intuizione, Giorgio
Agamben ha
identificato la “colpa” di Josef K., protagonista del Processo,
nell’autocalunnia, nell’accusa che egli fa a sé
stesso calunniandosi e che mette in moto il romanzo (G.
Agamben, “K.”, in Id., Nudità, Roma, nottetempo,
2009). Un reato
paradossale, in cui l’accusato sa di essere innocente, ma in
cui, nel momento in cui si autoaccusa, diventa colpevole (di
calunnia, appunto). Ma
perché K. calunnia sé stesso? Secondo Agamben, nel Processo
l’accusa è la chiamata in causa dell’essere del
diritto, che è appunto accusa nella sua stessa essenza, dal
momento che l’essere, una volta “accusato”, perde la sua
innocenza, divenendo “cosa”, causa, oggetto di lite. È contro
questa origine del diritto che si scaglia Kafka.
Dall’autocalunnia discende infatti nel romanzo un processo in
cui non solo in causa non è nulla di preciso, ma in cui ad
essere chiamata
in causa è la stessa chiamata in causa, l’essenza stessa del
processo. Ma, a cosa punta l’autocalunnia di Josef K.? Qual è
il movimento che Josef K. (e Kafka) punta a mettere in opera?
La sottigliezza dell’autocalunnia consiste nel fatto che è
essa
è una strategia che mette in questione la stessa implicazione
fondamentale dell’uomo nel diritto, tentando di disattivare e
rendere
inoperosa l’accusa, la chiamata in causa che il diritto
rivolge all’essere. La calunnia che Josef K. fa nei confronti
di sé stesso
è in altri termini un modo di affermare la propria innocenza
di fronte alla legge, un mezzo di difesa contro le autorità
che minacciano
continuamente l’esistenza, irretendola nella logica della
colpa, nella dimensione di una legge che appare sempre come
una lancinante e grottesca
caricatura di una Legge originaria a cui non è possibile avere
accesso. Ma, come Kafka sperimenta proprio attraverso la
stesura del romanzo, si
tratta di una strategia insufficiente, perché il diritto
risponde a questo tentativo di destituzione trasformando in
delitto la stessa chiamata
in causa e facendo dell’autocalunnia, che doveva renderlo
inoperoso, il proprio nuovo fondamento.
Con una straordinaria intuizione, Giorgio
Agamben ha
identificato la “colpa” di Josef K., protagonista del Processo,
nell’autocalunnia, nell’accusa che egli fa a sé
stesso calunniandosi e che mette in moto il romanzo (G.
Agamben, “K.”, in Id., Nudità, Roma, nottetempo,
2009). Un reato
paradossale, in cui l’accusato sa di essere innocente, ma in
cui, nel momento in cui si autoaccusa, diventa colpevole (di
calunnia, appunto). Ma
perché K. calunnia sé stesso? Secondo Agamben, nel Processo
l’accusa è la chiamata in causa dell’essere del
diritto, che è appunto accusa nella sua stessa essenza, dal
momento che l’essere, una volta “accusato”, perde la sua
innocenza, divenendo “cosa”, causa, oggetto di lite. È contro
questa origine del diritto che si scaglia Kafka.
Dall’autocalunnia discende infatti nel romanzo un processo in
cui non solo in causa non è nulla di preciso, ma in cui ad
essere chiamata
in causa è la stessa chiamata in causa, l’essenza stessa del
processo. Ma, a cosa punta l’autocalunnia di Josef K.? Qual è
il movimento che Josef K. (e Kafka) punta a mettere in opera?
La sottigliezza dell’autocalunnia consiste nel fatto che è
essa
è una strategia che mette in questione la stessa implicazione
fondamentale dell’uomo nel diritto, tentando di disattivare e
rendere
inoperosa l’accusa, la chiamata in causa che il diritto
rivolge all’essere. La calunnia che Josef K. fa nei confronti
di sé stesso
è in altri termini un modo di affermare la propria innocenza
di fronte alla legge, un mezzo di difesa contro le autorità
che minacciano
continuamente l’esistenza, irretendola nella logica della
colpa, nella dimensione di una legge che appare sempre come
una lancinante e grottesca
caricatura di una Legge originaria a cui non è possibile avere
accesso. Ma, come Kafka sperimenta proprio attraverso la
stesura del romanzo, si
tratta di una strategia insufficiente, perché il diritto
risponde a questo tentativo di destituzione trasformando in
delitto la stessa chiamata
in causa e facendo dell’autocalunnia, che doveva renderlo
inoperoso, il proprio nuovo fondamento.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Bankitalia e l'irreversibile divorzio fra liberalismo e democrazia
Bankitalia e l'irreversibile divorzio fra liberalismo e democrazia
di Carlo Formenti
“L’insofferenza verso le autorità indipendenti è il peccato mortale di ogni populismo. La dimostrazione plastica che lo Stato di diritto va stretto a chi vorrebbe trasformare il consenso in legittimità”. Questo l’incipit del fondo di Ferruccio de Bortoli sul “Corriere” del 30 marzo. Si parla, naturalmente, del peccato di lesa maestà commesso dal governo gialloverde che si è permesso di istituire una commissione d’inchiesta sulle banche in violazione del “sacro” ed esclusivo diritto della Banca d’Italia di mettere il naso negli affari sporchi dei nostri istituti di credito. Peccato che ha turbato i sonni del Quirinale, visto che apprendiamo che Mattarella si è concesso un mese di riflessioni (ho la sensazione che i problemi reali delle masse popolari gli sottraggano meno tempo…) prima di firmare il documento che istituisce la commissione di cui sopra, un atto che ha compiuto obtorto collo e a condizione che non sia il preludio di un “processo al sistema bancario”.
Niente di nuovo sotto il sole: le preoccupazioni di Mattarella sono le stesse che hanno fatto sì che, dopo l’esplosione della bolla finanziaria del 2008, tutti i governi delle grandi potenze economiche si siano precipitati a salvare (a spese dei propri cittadini) le banche dal disastro che loro stesse avevano provocato, guardandosi bene dal chiamarne i vertici a rispondere civilmente e penalmente dei reati commessi.
Leggi tutto
Pino Arlacchi: L’economia reale è sulla Via della Seta
L’economia reale è sulla Via della Seta
di Pino Arlacchi*
La morte del pensiero unico è ormai prossima. Affermatosi dopo la caduta del Muro, come ideologia della fine della storia che doveva accompagnare la globalizzazione governata dall’Occidente (unipolarismo Usa), è oggi palesemente inadeguato a descrivere il multipolarismo di fatto che si è andato imponendo.
I segnali erano già moltissimi, come ben sanno i nostri lettori, ma ora il velo viene strappato dai sommovimenti europei innescati dal tour continentale di Xi Jinping.
Questa analisi di Pino Arlacchi, ex “zar antidroga” dell’Onu, coglie alcuni aspetti che integrano quanto siamo andati scrivendo in questi giorni. Uno dei più rilevanti è la messa in discussione del predominio del capitale finanziario rispetto all’economia reale e, di conseguenza, la premessa per la fine del ruolo centrale del dollaro statunitense.
Buona lettura!
* * * *
Èinutile minimizzare, e ridurre quanto accaduto nei rapporti tra Italia e Cina a un semplice scambio di cortesie commerciali e di finezze su Marco Polo e Matteo Ricci (il gesuita del 500 divenuto mandarino cinese). Una volta tanto, i governanti italiani l’hanno azzeccata in pieno, entrando per primi nel più grande gioco geopolitico messo in piedi dai tempi della Conferenza di Bretton Woods del 1944 in poi, e dalla fondazione delle Nazioni Unite l’anno dopo.
Leggi tutto
Italo Nobile: La demografia si appresta a riscrivere le mappe del mondo?
La demografia si appresta a riscrivere le mappe del mondo?
di Italo Nobile*
Cosa è successo nei quindici anni che sono intercorsi dal 2000 al 2015 in campo demografico?
L’incremento demografico registra la presenza di qualche caso limite il più eclatante dei quali è la Nigeria che si prevedeva nel 2015 avere circa 163 milioni di abitanti ed invece aveva nel 2014 circa 176 milioni di abitanti.
Dove si andrà di questo passo? Altri paesi con incrementi di popolazione oltre le attese sono stati l’India (che forse già nel 2025 avrà una popolazione più numerosa della Cina), gli stessi Stati Uniti, l’Indonesia, le Filippine, il Brasile, il Messico, l’Etiopia. Relativamente meglio (rispetto alle previsioni) sono andati Pakistan (che però in questi anni ha avuto un incremento di popolazione di 50 milioni di persone pari al 37%), Bangladesh, Vietnam, Egitto, Iran. I paesi dell’Est Europa hanno avuto una flessione dovuta forse all’intensa emigrazione.
La natalità più alta la hanno sempre i paesi africani anche se si è scesi da una banda tra 55/1000 (55 nati per 1000 abitanti) e 42/1000 per i primi venti nel quinquiennio 2000-2005 ad una banda tra 49/1000 e 35/1000 per i primi venti nel 2015-2020. Niger, Somalia e Angola rimangono in testa a distanza di 15 anni. I risultati migliori (ma ottenuti come? E con quale rilevanza?) sono del Ciad (sceso da 48,4 a 36,1 del 2016), dell’Angola (da 51,2 a 38,6) del Congo (da 44,2 a 35,1), del Niger (da 55,1 a 44,8) ma quest’ultimo con un tasso di fecondità che rimane altissimo (7 nati per donna).
Leggi tutto
Ascanio Bernardeschi: Il Memorandum Italia-Cina
Il Memorandum Italia-Cina
di Ascanio Bernardeschi
La Nuova Via della Seta è un’opportunità per liberarci in parte dai vincoli europei e prendere qualche distanza dalla Nato. Per questo è e sarà fortemente contrastata dagli Usa e dai loro servi locali
La firma del memorandum italo-cinese per lo sviluppo della Nuova Via della Seta ha provocato, fin dal suo annuncio, l’insurrezione degli USA e degli ambienti filo-statunitensi, fra cui la sempre genuflessa Unione europea, che anche in questa occasione ha dimostrato la sua vocazione filo-atlantica. Fra gli ambienti accodati agli Usa dobbiamo includere anche buona parte dei partiti italiani (Lega, Forza Italia e Pd in primis).
Per gli Usa, Garrett Marquis, portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale, si è espresso con un giro di parole: l’adesione dell’Italia alla nuova via della seta danneggerebbe la sua reputazione internazionale quindi si invitano “tutti gli alleati e partner, compresa l'Italia, a fare pressioni sulla Cina per allineare gli sforzi di investimento globale agli standard internazionali”. Più sinceramente Alberto Prina Cerai afferma che “la principale minaccia – come ribadisce la National Security Strategy del 2017 – proviene da una rinnovata competizione interstatale, in cui la Cina rappresenta il peer competitor per eccellenza”. Da canto suo un rapporto del Dipartimento della Difesa degli USA afferma che l’espansione cinese, attraverso la via della seta, tende a “escludere gli Stati Uniti dalla regione Indo-Pacifica” e a perseguire l’obiettivo strategico del Partito Comunista Cinese di fare della Cina ‘la potenza preminente’ del continente eurasiatico”.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: “L’Italia siamo noi. La sinistra e l’identità nazionale”
“L’Italia siamo noi. La sinistra e l’identità nazionale”
La "reimmaginazione politica" di Jacopo Custodi
di Alessandro Visalli
 Su MicroMega,
testata del gruppo La Repubblica/L’Espresso, il
dottorando in Scienze Politiche alla
Scuola Normale Superiore che “si occupa di sinistra radicale”
Jacopo Custodi[1] sostiene che alla egemonia della
destra bisogna
contrapporre un’altra idea di Italia, evitando sia il rifiuto
dell’identità nazionale sia l’interiorizzazione del discorso
della destra. E questa posizione, che dichiara frutto di “reimmaginazione
politica”, la descrive come:
Su MicroMega,
testata del gruppo La Repubblica/L’Espresso, il
dottorando in Scienze Politiche alla
Scuola Normale Superiore che “si occupa di sinistra radicale”
Jacopo Custodi[1] sostiene che alla egemonia della
destra bisogna
contrapporre un’altra idea di Italia, evitando sia il rifiuto
dell’identità nazionale sia l’interiorizzazione del discorso
della destra. E questa posizione, che dichiara frutto di “reimmaginazione
politica”, la descrive come:
“immaginare un’identità italiana che sia includente e progressista, basata sulla storia migliore del nostro paese. Che ricordi con orgoglio la storia dei nostri nonni che diedero la vita per la libertà, contro i fascisti che distrussero il nostro paese. Un’identità italiana che non dimentichi che gli italiani sono stati un popolo migrante, e che l’accoglienza e l’ospitalità italiana sono valori impressi nella nostra storia e di cui dobbiamo andare fieri. Un’Italia che ami il suo passato e la sua cultura, nella consapevolezza che la storia va avanti e le tradizioni evolvono. Un’Italia internazionalista e interculturalista, consapevole che una comunità nazionale sana ha tutto da guadagnare dall’incontro tra i popoli”.
Continua:
“Patriottismo non è chiudere le frontiere, patriottismo è lottare per un paese con scuole e ospedali pubblici di eccellenza, per la dignità di chi lavora. È rivendicare una comunità solidale che ami la sua terra e che rifiuti ogni discriminazione tra i suoi membri, ad esempio per il paese di origine o per il colore della pelle. Perché l’Italia non è la Meloni, non è Salvini, non è Minniti. L’Italia siamo noi che lottiamo per un paese migliore, che siamo attivi nella difesa dell’ambiente e nella solidarietà coi migranti, che difendiamo i nostri diritti in quanto lavoratori, donne, studenti. Non dovremmo più permettere alla destra di appropriarsi incontrastata di quel termine – «Italia» – che identifica tutti noi.
L’Italia siamo noi, ed è venuto il momento di riprendercela”.
A parte l’ultima frase retorica e aggressiva (l’Italia, evidentemente, non è della sinistra, almeno quanto non è della destra, ma è lo spazio di una contesa), questa posizione mi ricorda qualcosa.
Leggi tutto
Jacopo Foggi: Nuove note su “lavoro di cittadinanza”, salari minimi, Piano del lavoro e terzo settore
![]()
Nuove note su “lavoro di cittadinanza”, salari minimi, Piano del lavoro e terzo settore
di Jacopo Foggi
 A poche
settimane di distanza dalla più volte rinviata pubblicazione
del libro da me
curato (Tornare al lavoro. Lavoro di
cittadinanza e piena occupazione, Castelvecchi)
dedicato al “lavoro garantito”, “occupazione di ultima
istanza” o
“lavoro di cittadinanza”, che dir si voglia, mi sembra
opportuno riprendere il filo del discorso per aggiornarlo alla
luce di dibattiti e
vicende più recenti ed esplicitarne alcuni aspetti in funzione
delle esigenze di sviluppo del nostro martoriato paese.
A poche
settimane di distanza dalla più volte rinviata pubblicazione
del libro da me
curato (Tornare al lavoro. Lavoro di
cittadinanza e piena occupazione, Castelvecchi)
dedicato al “lavoro garantito”, “occupazione di ultima
istanza” o
“lavoro di cittadinanza”, che dir si voglia, mi sembra
opportuno riprendere il filo del discorso per aggiornarlo alla
luce di dibattiti e
vicende più recenti ed esplicitarne alcuni aspetti in funzione
delle esigenze di sviluppo del nostro martoriato paese.
Per chi si fosse perso il tema di cui stiamo parlando, sintetizziamo brevemente gli elementi centrali. Si tratta di una politica che consiste, almeno in prima battuta, in un intervento pubblico di “occupazione di ultima istanza” che, rifacendosi appunto all’azione delle banche centrali come prestatrici di ultima istanza, vede le istituzioni governative entrare in campo come datori di lavoro di ultima istanza nel momento in cui il mercato prevedrebbe o di non offrire alcun posto di lavoro retribuito oppure di fornirne solo di pagati al di sotto delle soglie dei redditi minimi consentiti e stabiliti per legge, o in generale a livelli di povertà – per la misera retribuzione o per le troppo poche ore. Analogamente al modo in cui la Banca centrale garantisce alle banche e allo Stato anticipazioni o scoperti di conto ad un tasso prestabilito sostenibile nei momenti di carenza di liquidità, stabilendo così un tetto massimo al tasso di interesse e garantendo la circolazione monetaria, allo stesso modo lo Stato decide di fornire un impiego retribuito, a un livello salariale di base ma dignitoso, a tutti coloro ai quali il mercato imporrebbe condizioni inaccettabili, vuoi perché semplicemente inesistenti, vuoi perché troppo basse per essere ritenute socialmente accettabili, stabilendo così un pavimento minimo alle retribuzioni1 .
Leggi tutto
Franco Romanò: L'intreccio patriarcato-capitalismo libero dai marxismi
L'intreccio patriarcato-capitalismo libero dai marxismi
di Franco Romanò
Questo saggio è stato ampiamente discusso nella redazione ed è solo la prima parte di una riflessione più ampia che seguirà. Una rinnovata critica radicale al sistema capitalistico non può prescindere dai suoi intrecci con il patriarcato: è questo il nodo che i marxismi novecenteschi in tutte le loro declinazioni, non hanno saputo o potuto affrontare. Nel pensiero più vitale e meno determinista di Marx, liberato dalle tradizioni novecentesche, ci sono tuttavia spunti che riteniamo dense di futuro. A partire da questa considerazione e dalla pratica di resistenza dei movimenti contemporanei, il saggio si propone di offrire riflessioni e idee in divenire per una nuova soggettività antagonista
 Introduzione
Introduzione
Continuiamo a rileggere Karl Marx. Un po’ per lasciarci alle spalle tutti i ‘marxismi’, un po’ perché nel Marx giovane continuiamo a trovare sorprese sulle quali ci sembra molto opportuno riflettere; ma su Overleft abbiamo anche lo sguardo puntato sul presente, soprattutto su ogni movimento che definisca la propria lotta dentro una critica radicale al capitalismo e al suo intreccio col patriarcato, un presupposto quest’ultimo per noi irrinunciabile che proviene dalle analisi e lotte di buona parte del femminismo. Il sistema patriarcale e capitalistico continua a produrre i propri antagonisti come accadeva nei due secoli precedenti (La storia non è finita con buona pace di Fukuyama e di chi è succube del Tina, There Is No Alternative, l’espressione varata da Margarteh Thatcher). Il capitalismo reale, seguito alla caduta del socialismo reale che nell’immaginario era la causa di tutti mali, ha prodotto decine di guerre nel giro di trent’anni, un impoverimento vertiginoso delle classi salariate e dei ceti medi, lo smantellamento del welfare, l’aumento vertiginoso di costi ambientali che rischiano di diventare irreversibili, riciclato tutti i modelli di oppressione a cominciare da quella di genere, modulandola in modo diverso nei diversi contesti. Tuttavia, sono nate del in questi anni ribellioni e movimenti, a volte più strutturate altre volte più caotiche, che hanno comunque prodotto lotte sociali e forme di resistenza che si collocano all’esterno e spesso contro le formazioni politiche e sindacali del marxismo novecentesco.
Leggi tutto
Alessandro Perri: La guerra alla Jugoslavia è ancora uno spartiacque
La guerra alla Jugoslavia è ancora uno spartiacque
di Alessandro Perri
Alla fine, si può ben dire che, nonostante tutto, non tutti hanno dimenticato. La sala del Sally Brown Rude-pub riempita per tre ore abbondanti nella sera di mercoledì 27 marzo da persone di tutte le fasce di età ci ridà l’importanza che l’esercizio della memoria storica (in tempi, da questo punto di vista, perlomeno discutibili) ancora riveste per alcuni di noi.
L’occasione, se così si può chiamare, sono i venti anni da quella maledetta notte tra il 23 e il 24 marzo del 1999 in cui la Nato dette inizio al primo dei 78 giorni di bombardamenti sull’allora Repubblica federale jugoslava, a Belgrado, Serbia odierna. In uno di numerosi appuntamenti che si stanno tenendo su tutto il territorio nazionale, ne abbiamo discusso con Andrea Martocchia (Cnj), Alberto Fazolo e Sergio Cararo (Contropiano), a cui è seguito un lungo e ricco dibattito con gli organizzatori della serata (Usb, Noi Restiamo, Osa, Magazzini Popolari di Casal Bertone e Coniare Rivolta) e tutti i presenti.
La discussione si è articolata intorno a tre filoni principali: il campo geopolitico su cui è stata giocata quella partita, il ruolo tenuto dall’Italia nei suoi vari segmenti (politici, sindacali, sociali), e il significato, alla luce del presente, assunto da quella guerra.
Lo smembramento della Jugoslavia non può che essere inserito nella generale frammentazione di quei territori che, dalla caduta del muro di Berlino in poi, si sono trovati nella complicata condizione di essere quella ex-terra di mezzo tra i due blocchi protagonisti della Guerra fredda, e dunque preda ghiotta per chi quella guerra l’aveva portata a casa, ossia Usa, Nato e la nascente Unione europea.
Leggi tutto
Carlo Clericetti: La Costituzione secondo Mattarella
La Costituzione secondo Mattarella
di Carlo Clericetti
“Occorre considerare la natura privata degli enti interessati la cui attività costituisce esercizio della libertà di iniziativa economica riconosciuta e garantita dall’articolo 41 della Costituzione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella lettera ai presidenti delle Camere sulla legge “Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul sistema bancario e finanziario”. Detto in parole più brutali: fate pure tutte le inchieste che volete, ma non vi azzardate poi a prendere qualunque decisione che riguardi le banche o altri enti finanziari: quelle spettano esclusivamente alla Banca d’Italia e alle altre authority indipendenti, e “occorre evitare il rischio che il ruolo della Commissione finisca con il sovrapporsi - quasi che si trattasse di un organismo ad esse sopra ordinato - all’esercizio dei compiti propri” di queste authority.
Apprendiamo così che il Parlamento, ossia l’organo dello Stato che dovrebbe esercitare la “sovranità” che “spetta al popolo”, come stabilisce il primo articolo della Costituzione, non è “sopra ordinato” agli organismi tecnici istituiti (con leggi del Parlamento stesso) per controllare e regolare i vari attori del mercato (della Banca d’Italia, caso particolare, diremo più avanti). Qui c’è materia per i costituzionalisti: è corretta questa interpretazione del presidente della Repubblica?
Leggi tutto
Mauro Armanino: La foto di famiglia della ministra Trenta
![]()
La foto di famiglia della ministra Trenta
Ultime notizie dal Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, marzo 2019. Adesso va di moda. Anche in Francia il ministero della difesa è al femminile. L’Italia non è da meno e dopo la Roberta Pinotti è il turno di Elisabetta Trenta. Spiace davvero che il femminismo si sia poi tradotto in termini di pari opportunità militari. Magari, per la salvaguardia della differenza di genere, introdurranno una fascia rosa ai militari e alle armi che dovrebbero aumentare di numero e in qualità con buona pace dell’Italia costituzionale. L’approccio, lui, è in piena contininuità coi governi precedenti, da Paolo Gentiloni in poi la musica nel Sahel non cambia. Sfacciatamente militaristi all’estero come in patria, in entrambi i casi, si afferma, per legittima difesa. Così infatti, per stravolgimento colpevole della realtà, colei che presiede alle scelte miltari della penisola, ha legittimato l’impegno crescente dell’Italia in Niger. I due Paesi, secondo la Trenta, sono entrambi confrontati a sfide comuni: il terrorismo e la migrazione clandestina. Appare dunque del tutto giustificato, per la ministra, che l’Italia si coinvolga al fianco di un alleato strategico come il Niger, primo paese al mondo per gli aiuti ricevuti. Tutto questo e altro appaiono evidenti nella foto di famiglia pubblicata dal quotidiano governativo ‘Il Sahel’. Nella foto la ministra si trova, in abito civile, tra il Presidente Mahamadou Issoufou, il direttore delle cerimonie e, naturalmente, l’ambasciatore italiano.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: “Conservatori” e “progressisti” in scena a Verona
“Conservatori” e “progressisti” in scena a Verona
di Fabrizio Marchi
Voglio essere chiaro su un punto.
Non penso affatto che sia terribilmente e spregevolmente reazionario sostenere che un bambino o una bambina debbano essere cresciuti da un padre e da una madre. Penso anzi che queste polarità – maschile (paterno) e femminile (materno) – siano assolutamente naturali, nè più e né meno di come lo è l’essere omosessuali.
Sostenere che un bambino o una bambina possano essere cresciuti indifferentemente da una coppia etero o da una gay o lesbica, significa oggettivamente sostenere che la polarità maschile-femminile non esiste, che è un mero costrutto culturale, come sostiene appunto la variante “genderista” del femminismo.
Questo non significa affatto (dovrebbe anche essere superfluo sottolinearlo ma questo è il clima che è stato costruito ad hoc che ci costringe, nostro malgrado, a queste ipocrite e penose, lo ammetto, chiarificazioni …) pensare che i gay, le lesbiche e tutte le atre persone dai più svariati orientamenti sessuali non siano in grado o adatti a crescere dei figli. Possono esserlo o non esserlo né più e né meno degli eterosessuali.
Sostenere infatti che i gay o le lesbiche in quanto tali non sarebbero adeguati ad allevare dei figli, sarebbe una posizione sessista e il sottoscritto sarebbe il primo a mobilitarsi contro quello che giudicherebbe – appunto – un inaccettabile pregiudizio sessista.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3724
Hits 2813
Hits 2663
Hits 2580
Hits 2299
Hits 2226
Hits 2127
Hits 2076
Hits 2012
Hits 1966
tonino

Lelio Demichelis: Post-democrazia e fabbrica tecno-capitalista
Post-democrazia e fabbrica tecno-capitalista
di Lelio Demichelis
La crisi della democrazia è legata all’egemonia della tecnica nel capitalismo moderno. Solo ri-democratizzando l’impresa e la tecnica sarà possibile uscire dalla crisi politica dei nostri giorni
 La democrazia
politica è in crisi. Scriverlo è scrivere niente di
nuovo. Ma
la relazione di causa-effetto tra capitalismo e crisi della
politica e della
democrazia nasce non solo dal 2008 o dagli anni ‘70, ma
dall’egemonia della tecnica come apparato/sistema tecnico
integrato al
capitalismo; dall’immaginario collettivo che questo
tecno-capitalismo sa produrre; ma soprattutto dal fatto che la
forma/norma
tecnica (Anders[i]),
è in sé e per sé a-democratica/antidemocratica ma tende a
divenire forma/norma sociale e oggi anche politica.
La democrazia
politica è in crisi. Scriverlo è scrivere niente di
nuovo. Ma
la relazione di causa-effetto tra capitalismo e crisi della
politica e della
democrazia nasce non solo dal 2008 o dagli anni ‘70, ma
dall’egemonia della tecnica come apparato/sistema tecnico
integrato al
capitalismo; dall’immaginario collettivo che questo
tecno-capitalismo sa produrre; ma soprattutto dal fatto che la
forma/norma
tecnica (Anders[i]),
è in sé e per sé a-democratica/antidemocratica ma tende a
divenire forma/norma sociale e oggi anche politica.
Ovvero, il tecno-capitalismo confligge in premessa con la democrazia[ii]. E produce antidemocrazia.
Il populismo e la disruption tecno-capitalista della democrazia
Perché i populismi, fomentando la rabbia popolare contro caste ed élite (ma non contro le vere nuove caste/élite globali, quelle della Silicon Valley[iii]) in realtà sono il proseguimento dell’egemonia tecno-capitalista con altri mezzi, perché tutti i populismi al potere oggi sono neoliberali e insieme tecnici, nel sostenere questo modello di crescita. Perché se non deve esistere la società – obiettivo del neoliberalismo, ormai pienamente raggiunto – può essere invece utile al sistema creare il popolo: molto più attivabile e plasmabile, molto più bisognoso di un pastore o di un Capitano, molto meno riflessivo/responsabile, ma soprattutto funzionale a sostenere l’incessante disruption (il populismo incarnando esso stesso la disruption del demos) richiesta dal sistema.
Uno degli elementi del populismo, uno dei suoi usi politici infatti, è anche quello di ottenere la modernizzazione e di proseguire nella rivoluzione industriale mediante il ricorso alle figure della tradizione e dell’identità[iv], cioè a meccanismi/dispositivi di compensazione emotiva/identitaria utili a ristabilire (in apparenza) un certo equilibrio psichico individuale e sociale.
Leggi tutto
Salvatore A. Bravo: La superstizione scientista
La superstizione scientista
di Salvatore A. Bravo
La verità è qualche cosa di infinitamente più dell’esattezza scientifica
 L’epoca della superstizione
è il “credo” senza la mediazione del logos.
Scienziati ed economisti, ma non solo, assumono la postura
riduzionista,
ovvero non riconoscono la pluralità dei piani della
conoscenza, giudicano il fondamento veritativo flatus
vocis.
L’epoca della superstizione
è il “credo” senza la mediazione del logos.
Scienziati ed economisti, ma non solo, assumono la postura
riduzionista,
ovvero non riconoscono la pluralità dei piani della
conoscenza, giudicano il fondamento veritativo flatus
vocis.
La verità ama la maschera affermava Nietzsche: la conoscenza è prismatica, da ogni piano traluce un aspetto fondamentale dei possibili, ma necessita dello sguardo della mente che, per giungere alla verità, individua la contraddizione della rappresentazione fenomenica.
Nei confronti della finitudine, vera sostanza della condizione umana, si può assumere una posizione di difesa (per cui si può rimuovere il problema per assolutizzare un piano e cadere nel riduzionismo) o aprirsi alla logica della modalità, dei potenziali aspetti conoscitivi che attraversano la condizione umana e non li esauriscono.
La Filosofia è disciplina del dialogo, insegna il logos, ma non vi è logos senza il limite, per cui il logos[1] è il ponte che pone in relazione con la dialettica, per trascendere i limiti.[2] L’epoca dell’assimilazione e del nichilismo economicistico – nel suo gran rifiuto della finitudine umana – tende a fagocitare ogni opposizione. L’onnipotenza dell’economicismo scientista non vuole vincoli e limiti, per cui – come un dio onnipotente – è autoreferenziale. Il Demiurgo platonico è ancora interno alla logica del limite, la chora (Χώρα) e le idee lo limitano. Lo scientismo economicistico ha piuttosto gli attributi del dio onnipotente, mondano ed unico: ambisce ad affermare se stesso ed a ridurre a nulla ogni posizione che si pone in dialettica con esso. Il primo suo imperativo è nell’affermarsi dell’unica conoscenza degna di tale nome, ovvero, la scienza. Pertanto la metariflessione – la riflessione teoretica sulla verità come fondamento – è tacciata d’essere semplicemente vuota astrazione, priva di ogni spessore conoscitivo e veritativo:
Leggi tutto
Rete dei Comunisti: Autonomia differenziata: il convitato di pietra è l’Unione Europea
Autonomia differenziata: il convitato di pietra è l’Unione Europea
di Rete dei Comunisti
 Come è stato osservato in più
interventi tenuti in una recente e riuscita assemblea a
Napoli (09
marzo – “Il Sud Conta”) sulla questione del regionalismo
differenziato, dalla riforma costituzionale del 2001 la
“questione
meridionale” (a prescindere dalle sue varie declinazioni) è
stata espulsa dalla agenda politica nazionale e, anche
formalmente, la
questione settentrionale è entrata a far parte del discorso
politico dominante, con chiara legittimazione
costituzionale.
Come è stato osservato in più
interventi tenuti in una recente e riuscita assemblea a
Napoli (09
marzo – “Il Sud Conta”) sulla questione del regionalismo
differenziato, dalla riforma costituzionale del 2001 la
“questione
meridionale” (a prescindere dalle sue varie declinazioni) è
stata espulsa dalla agenda politica nazionale e, anche
formalmente, la
questione settentrionale è entrata a far parte del discorso
politico dominante, con chiara legittimazione
costituzionale.
Il tema del recupero del “grande divario” tra Nord e Sud del Paese è stato, di conseguenza, del tutto obliterato. Le stesse politiche di orientamento della spesa pubblica nazionale hanno guardato altrove.
Nel 2001 lo Svimez, analizzando l’andamento dell’anno precedente, da un lato si rallegrava del fatto che il Sud da qualche anno presentasse incrementi del prodotto interno lordo, dei consumi e degli investimenti maggiori di quelli del resto del paese, mentre dall’altro lato evidenziava (come a dire qui lo dico e qui lo nego) delle tendenze che mostravano come tale miglioramento fosse illusorio:
«… l’economia del Mezzogiorno si presenta con dati e prospettive certamente migliori rispetto all’esperienza della prima parte degli anni ’90, avendo saputo arrestare la tendenza ad un ulteriore arretramento dei livelli relativi di prodotto, di occupazione e di investimenti. Un consolidamento ed ulteriori progressi del processo di crescita dell’economia dell’area restano più che mai legati, oltre che alla congiuntura nazionale e internazionale, all’intensità e alla regolarità dell’azione volta a rimuovere i vincoli strutturali e gli elementi di debolezza che continuano a gravare sul Mezzogiorno».
In effetti questa ripresa del mai compiuto processo di convergenza si inseriva in un quadro che la rendeva meramente congiunturale, ossia dipendente dal ciclo italiano, europeo e più propriamente mondiale.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Da sovranista a nazista il passo è Breivik?
Da sovranista a nazista il passo è Breivik?
di Pierluigi Fagan
"Ma quale sovranismo: cominciamo a chiamarlo nazismo". Titolo shock per l’Espresso che passa all’equiparazione tra sovranista e suprematista stante questo secondo nell’alveo dell’area culturale nazista. Quindi, per via delle regole del sillogismo, il sovranista diventa nazista. Accipicchia! Ma chi è il sovranista?
L’unica definizione sensata è sempre quella storico-genetica, lì dove il termine sovranità venne coniato in termini di pensiero politico. Giungiamo così a Jean Bodin, tra il Principe di Machiavelli e il Leviatano di Hobbes, il più grande filosofo politico occidentale dei primi passi della modernità. Il Bodin fu autore dei monumentali Le six livres della République 1576 dove République sta per Stato nel linguaggio politico teorico del tempo. Sovranità è una cosa, governo un altra dice il Bodin per la prima volta, analizzando poi le varie forme di governo classiche (dell'Uno, dei Pochi, dei Molti da Aristotele, Politica, IV sec. a.C.). Lui preferiva la monarchia, ma il discorso vale anche per la democrazia come ribadì il Rousseau.
Ai tempi, lo Stato si era appena formato e la sua infanzia era osteggiata in fasce dalla moltitudine dei poteri territoriali feudali aristocratici non meno che clericali che vedevano di cattivo occhio il venirsi a creare di un potere centrale sovra-ordinante. Così oggi, cinquecento anni dopo, i tanti poteri economici, finanziari, sovranazionali e geopolitici vorrebbero far volentieri il funerale allo Stato. Che diceva il nostro Bodin sulla sovranità, ai tempi?
Leggi tutto
coniarerivolta: Verso le europee: cosa significa davvero più Europa?
Verso le europee: cosa significa davvero più Europa?
di coniarerivolta
Leggere i documenti della Commissione Europea può risultare un esercizio per stomaci forti. Una volta l’anno, in particolare, la Commissione pubblica un Country Report per ogni paese membro, in cui fornisce una sua valutazione sull’andamento dell’economia e ‘propone’ una serie di ricette per correggere eventuali squilibri e tornare ad incamminarsi sul cammino della prosperità.
C’era grande attesa per il Country Report dedicato all’Italia, il primo dell’età nuova del governo gialloverde. Nonostante le fanfare con cui il Report è stato accolto dall’opposizione liberista al Governo, i toni sono sostanzialmente blandi ed accomodanti. In vista delle elezioni europee, i burocrati europei devono avere finalmente capito che dipingere come pericolosi nemici dell’Unione Europea i cosiddetti ‘populisti’ rappresenta uno straordinario assist per questi soggetti politici, i quali hanno fino ad oggi prosperato in uno scenario per loro ideale: governare con il ‘pilota automatico’ esattamente come tutte le altre forze politiche che hanno governato negli ultimi decenni, con dosi massicce di austerità ed adesione cieca ai vincoli di bilancio europei; ed al contempo godere della immotivata fama di oppositori del cieco rigore che ha soffocato l’Europa negli ultimi decenni.
Leggi tutto
Full Brexit: Brexit: la pugnalata alle spalle di Corbyn
Brexit: la pugnalata alle spalle di Corbyn
di Full Brexit*
Vedremo se l'accordo per sventare la Brexit tra il leader laburista Corbyn e Teresa May sopravviverà. Di sicuro esso attesta, per l'ennesima volta, non solo della potenza dell'élite euro-liberista, ma che non c'è da fidarsi della vecchia sinistra socialdemocratica
Per sconfiggere l'estrema destra, la sinistra deve abbracciare una Brexit socialista e internazionalista. L'Unione europea è thatcherismo in un continente: la convinzione che possa essere riformata dall'interno è illusoria
Paul Mason ha dato un contributo importante al dibattito di sinistra sulla Brexit. È un contributo importante perché Mason è, a sinistra, il sostenitore più accanito della UE: un'organizzazione capitalista antidemocratica che è diventata un pilastro della globalizzazione e un motore della disuguaglianza. Il suo pezzo era pieno della solita tattica maccartista di colpevolizzazione contro coloro che si oppongono all'UE. L'attacco di Mason a Eddie Dempsey, un sindacalista antifascista, è stato un classico esempio di questo. È fondamentale, a sinistra, andare oltre questo tipo di politica.
Mason ha ragione nel dire che c'è una brutta minaccia di una reazione di destra. Ma la verità è che questa minaccia si intensificherà se la Brexit venisse abbandonata. La decisione di lasciare l'UE è stata presa in un referendum che è stato il più partecipato della storia britannica. Questa non era certamente un'espressione politica d'estrema destra, ma la scelta consapevole di milioni di elettori laburisti e conservatori.
Leggi tutto
Sandrone Dazieri: Battisti e me
Battisti e me
di Sandrone Dazieri*
Una testimonianza, quella dello scrittore milanese Sandrone Dazieri, che fa onore a chi la rende, al di là di ogni possibile differenza di opinioni o di qualche errore materiale. Un racconto che dà la misura dei guasti provocati da Cesare Battisti nel già ristretto campo di coloro che non hanno mai chiuso occhi e orecchi (e neuroni) sotto la tempesta di cazzate di dietrologi “democratici” (ma ce ne sono anche di fascisti), sbirraglia assatanata, opinionisti lecchini del potere, imbecilli di ogni ordine e grado.
Una testimonianza che descrive dal vivo la metamorfosi mostruosa del “giornalista televisivo” quando accende la telecamera e, per una volta, non deve fare solo il supporto fisico del microfono davanti al potente di turno ma, al contrario, può far vedere al potente di riferimento (quello che gli paga lo stipendio) quanto gli somiglia. Ossia quanto è infame.
Una testimonianza che nella sua disperazione misura comunque, in qualche modo, l’abisso in cui è sprofondata la cultura politica “comune” in questo paese.
*****
Ieri (qualche giorno fa, ndr) ho fatto una cosa che in vita mia non avevo mai fatto: ho cacciato due persone da casa, letteralmente. Erano una troupe del programma Non è l’Arena, che mi avevano telefonato chiedendomi un’intervista, per approfondire le mie posizioni rispetto a Battisti. Cordiali al telefono, cordiali a casa mia (diamoci del tu, prendi un caffè, dove vivevi prima…), ma quando la telecamera si è accesa, tutto è cambiato.
Leggi tutto
Giovanni Iozzoli: Cosa resterà
Cosa resterà
di Giovanni Iozzoli
 Nel 2017 abbiamo celebrato
l’anniversario del movimento del ’77. L’anno dopo è toccato è
toccato al
’68. Nel 2019? L’autunno caldo, forse? Sia pur in forme sempre
più blande, gli anniversari scandiscono anche una memoria
generazionale, al di là della grande Storia, una memoria di
persone concrete, in carne e ossa, che ridefiniscono
dinamicamente il rapporto con
il loro passato. Uomini e donne, ogni anno più vecchi, che
discutono di sé, della loro storia, del senso del loro stare
al mondo.
Nel 2017 abbiamo celebrato
l’anniversario del movimento del ’77. L’anno dopo è toccato è
toccato al
’68. Nel 2019? L’autunno caldo, forse? Sia pur in forme sempre
più blande, gli anniversari scandiscono anche una memoria
generazionale, al di là della grande Storia, una memoria di
persone concrete, in carne e ossa, che ridefiniscono
dinamicamente il rapporto con
il loro passato. Uomini e donne, ogni anno più vecchi, che
discutono di sé, della loro storia, del senso del loro stare
al mondo.
Il susseguirsi (più o meno ritualistico) delle celebrazioni mi porta a ripensare alla mia generazione – gli attuali cinquantenni – e al suo destino di apparente mediocrità. Una generazione che non pare aver depositato un vero lascito, una generazione senza slanci epici, senza una sua mitologia da tramandare – se non qualche autoironia sulla propria balbuzie tecnologica, tipica delle “generazioni di mezzo”. Quindi: non avremo anniversari, in futuro, da proporre alla memoria collettiva; niente seminari o monografie in cui sarà esaltato il nostro ruolo di “testimoni”; non riascolteremo nostalgicamente canzoni che celebrano eventi in cui siamo stati protagonisti. Siamo cresciuti con vecchi film in bianco e nero e ci siamo ritrovati all’improvviso nel più fasullo e colorato degli universi virtuali: e tutto nello spazio di un mattino, quasi senza accorgercene.
Vecchia storia, questa della “transizione”: tutte le generazioni sono sempre in transizione, ma la mia, chissà perché, mi dà l’idea di averla subita unilateralmente, più di altre. Una generazione mai davvero protagonista, come se fosse cresciuta in un vuoto artificioso, in un deserto della storia, nel quale non ha ricevuto linfa, impulsi vitali, un ambiente sterile in cui non ha interagito e a cui non ha saputo reagire.
Leggi tutto
Fabrizio Barca: “Il capitalismo? Va ridiscusso, ora serve radicalità”
“Il capitalismo? Va ridiscusso, ora serve radicalità”
Giacomo Russo Spena intervista Fabrizio Barca
 A partire da 15 proposte elaborate per
contrastare le
crescenti disuguaglianze nella società, l’ex ministro spiega
come non sia sufficiente battersi per la sola
redistribuzione delle
ricchezze: “Su questo il pensiero keynesiano ha mostrato i
suoi limiti, si deve ricominciare ad incidere sui meccanismi
di formazione della
ricchezza”. Sa che la battaglia sarà lunga, anche per
costruire un’alternativa credibile al salvinismo: “Bisogna
mettere
insieme i mondi della ricerca e della cittadinanza attiva e
pensare nuovi luoghi che possano acquistare egemonia
culturale e politica nel
Paese”.
A partire da 15 proposte elaborate per
contrastare le
crescenti disuguaglianze nella società, l’ex ministro spiega
come non sia sufficiente battersi per la sola
redistribuzione delle
ricchezze: “Su questo il pensiero keynesiano ha mostrato i
suoi limiti, si deve ricominciare ad incidere sui meccanismi
di formazione della
ricchezza”. Sa che la battaglia sarà lunga, anche per
costruire un’alternativa credibile al salvinismo: “Bisogna
mettere
insieme i mondi della ricerca e della cittadinanza attiva e
pensare nuovi luoghi che possano acquistare egemonia
culturale e politica nel
Paese”.
Qualcuno se lo sarà chiesto: che fine ha fatto Fabrizio Barca, l’ex ministro 'illuminato' che doveva rigenerare i circoli Pd e rilanciare la sinistra? La risposta è arrivata quando, lo scorso 25 marzo, ha illustrato a Roma un rapporto con 15 proposte programmatiche che mirano a modificare i principali meccanismi che determinano la formazione e la distribuzione della ricchezza: dal cambiamento tecnologico al salario minimo, dal concetto di sovranità collettiva al campo della ricerca. “L’ingiustizia sociale e la percezione della sua ineluttabilità sono all’origine dei sentimenti di rabbia e di risentimento dei ceti deboli verso i ceti forti e della dinamica autoritaria in atto”, evidenzia Barca. Lontano dai riflettori, ha ideato il Forum disuguaglianze e diversità collaborando con le migliori menti in circolazione ed aprendo a volti noti come l’ex presidente dell’Istat Enrico Giovannini, il direttore del Servizio Analisi statistiche di Bankitalia Andrea Brandolini e a diverse onlus come la Fondazione Lelio Basso, ActionAid, Cittadinanzattiva, Caritas e Legambiente.
* * * *
Partiamo dai numeri: i dati Oxfam evidenziano come nell’era della crisi ci sia stata un’accumulazione delle ricchezze nelle mani di pochi a scapito di molti. Ciò dimostra che la crisi non è stato un fenomeno generalizzato?
Da come si evince dal grafico relativo al periodo tra il 1995 e il 2016, la quota di ricchezza dell’1% più ricco della popolazione adulta è passata dal 18 al 25%, quella del 10% più ricco dal 49 al 62%: l’andamento, quindi, è cominciato vari anni prima della crisi economica.
Leggi tutto
Toni Negri: Sulle “operations” di Mezzadra-Neilson
Sulle “operations” di Mezzadra-Neilson
di Toni Negri
Recensione letta alla riunione di EuroNomade, Bologna, 15 marzo 2019
 Nel Capitale,
il “modo di produzione capitalista” è dato in
una postura definitiva, è lì. Nei Grundrisse,
invece, Marx introduce un discorso su Die Formen
(che precedono
la produzione capitalista) proprio nel momento nel quale
dovrebbe passare dalla definizione della teoria del
plus-valore (punto centrale e scoperta
fondamentale, proprio qui, di Marx) alla teoria della
circolazione, quindi alle teorie del capitale sociale e del General
Intellect ecc.
Perché fa questa sosta (confessiamolo, talora imbarazzante per
la genericità nella quale mondo antico e civiltà asiatiche
sono
trattati) proprio quando ha scoperto nel plus-valore il cuore
del modo di produzione capitalista e l’analisi potrebbe
procedere velocemente
verso la piena esposizione di quella scoperta?
Nel Capitale,
il “modo di produzione capitalista” è dato in
una postura definitiva, è lì. Nei Grundrisse,
invece, Marx introduce un discorso su Die Formen
(che precedono
la produzione capitalista) proprio nel momento nel quale
dovrebbe passare dalla definizione della teoria del
plus-valore (punto centrale e scoperta
fondamentale, proprio qui, di Marx) alla teoria della
circolazione, quindi alle teorie del capitale sociale e del General
Intellect ecc.
Perché fa questa sosta (confessiamolo, talora imbarazzante per
la genericità nella quale mondo antico e civiltà asiatiche
sono
trattati) proprio quando ha scoperto nel plus-valore il cuore
del modo di produzione capitalista e l’analisi potrebbe
procedere velocemente
verso la piena esposizione di quella scoperta?
Mi è sempre sembrato che ciò avvenga perché la scoperta del plus-valore apriva due piste decisive per la critica dell’economia politica: la determinazione del modo di produzione capitalista come movimento antagonista (il capitale come rapporto sociale antagonista) e, d’altra parte, la dialettica di soggettivazione che dal rapporto di capitale sorgeva e che poteva innescare la ricerca politica rivoluzionaria. Così, nei Grundrisse, proponendo dentro quell’insieme problematico, il programma cui il Capitale non riuscirà a dare definitiva risposta – ivi mancando appunto il libro sul salario e quello sullo Stato.
Il libro di Sandro Mezzadra e Brett Neilson (The Politics of Operations. Excavating contemporary capitalism, Duke University Press, 2019) si propone di percorrere quelle due piste, a partire da un approccio analitico al capitalismo globalizzato contemporaneo, e di muoversi nella transizione verso le forme che seguono il modo di produzione capitalista classico, così come l’abbiamo conosciuto: industriale, keynesiano, nazionale, sviluppista, socialista, ecc., inaugurando l’epoca della globalizzazione. Inseguono dunque le operazioni capitaliste (meglio, le “politiche delle operazioni”) che definiscono, oggi, il quadro spaziale e dinamico (temporale) dello sviluppo, dal punto di vista del complesso gioco delle istituzioni e delle soggettività che sono in campo e del processo che, contemporaneamente, si apre sia al “nuovo modo di produrre” sia ad una nuova formazione sociale.
Leggi tutto
Miguel Martinez: La simbiosi conflittuale
La simbiosi conflittuale
di Miguel Martinez
Matteo Salvini, che è semplicemente un ministro che rappresenta il partito di minoranza all’interno della coalizione di governo, è assurto in questi mesi a una fama notevole.
Qui si sostiene la tesi che dietro la sua ascesa, ci sia un meccanismo irresistibile, che vale la pena di analizzare perché ci rivela diversi elementi fondamentali dell’antropologia contemporanea.
Alcuni giorni fa, si è tenuto a Verona qualcosa che gli organizzatori chiamano “Congresso mondiale delle famiglie“, per parlare di cose come “i diritti dei bambini”, una misteriosa “ecologia umana integrale” e la “bellezza del matrimonio”.
Presumiamo che ciò significhi anche parlare male di matrimoni strani, ma non lo sapremo mai perché noi, come la quasi totalità della popolazione italiana, non sapevamo che ci fosse il convegno, e lo se avessimo saputo, avremmo avuto cose più interessanti da fare.
I relatori più importanti erano il presidente della Repubblica Moldava (non sapete come si chiama?), il Patriarca della Chiesa Siro-cattolica, la ministra ombra per lo sviluppo sociale dell’Uganda e una signora che si dichiara presidente della Foundation for African Cultural Heritage (da una rapida occhiata, una sorta di incubo per leghisti, visto che promuove la “cultura pro-vita” nella già popolosa Nigeria).
Leggi tutto
Gabriele Fichera: Su Marco Gatto, Resistenze dialettiche
Su Marco Gatto, Resistenze dialettiche
di Gabriele Fichera
Marco Gatto, Resistenze dialettiche. Saggi di teoria della critica e della cultura, Roma, manifestolibri, 2018
«Un Sé […] non più solo narcisistico […] ma devoto all’esposizione, alla cancellazione dei propri limiti biologici e materiali: un Io definibile come “esposto”, religiosamente occupato dall’ostensione» (corsivi miei). Si potrebbe partire da questa citazione per parlare del nuovo, e complesso, libro di Marco Gatto, Resistenze dialettiche. Qui a colpire è il concetto di «esposizione», e la definizione di Io «esposto». E mi viene in mente il noto saggio di Benjamin sull’opera d’arte nell’epoca della riproducibilità tecnica, nel quale valore cultuale dell’arte e suo valore espositivo erano considerati elementi antitetici. Nel primo caso l’opera tende a nascondersi, nel secondo a rivelarsi. Lo sviluppo tecnologico spinge nella direzione della esponibilità dell’arte e della crisi della sua “aura”. Questa emancipazione dell’arte dal rituale si prospettava per Benjamin in termini potenzialmente positivi. Qualora però la rivoluzione proletaria avesse spodestato il potere del capitale. Ma poiché questo in Occidente fino ad ora non è avvenuto, bisogna chiedersi a cosa abbia portato lo sviluppo esponenziale delle tecniche della riproducibilità gestite nell’ambito di rapporti di produzione saldamente capitalistici. Il libro di Gatto fornisce preziosi stimoli in tal senso.
Leggi tutto
Thierry Meyssan: L’ONU fatto a pezzi dall’“eccezionalismo” statunitense
L’ONU fatto a pezzi dall’“eccezionalismo” statunitense
di Thierry Meyssan
Indeboliti rispetto ai concorrenti russo e cinese, gli Stati Uniti ritrovano le loro storiche inclinazioni. Nelle relazioni con l’estero abbandonano l’ordine internazionale liberale e fanno ritorno alla dottrina eccezionalista. Mettendo in discussione il proprio impegno nel Consiglio di Sicurezza, gli USA hanno aperto la strada a una decostruzione del diritto internazionale e, in ultima analisi, delle Nazioni Unite. Quest’evoluzione ha colto di sorpresa gli europei occidentali e li ha gettati nello sgomento; Cina e Russia l’avevano invece prevista e vi si sono preparate
L’ex ambasciatore all’ONU del presidente Bush Jr., nonché attuale consigliere per la sicurezza nazionale del presidente Donald Trump, John Bolton, dissente da un particolare aspetto delle Nazioni Unite. Secondo lui è fuori questione che chicchessia possa far sottostare gli Stati Uniti a obblighi di qualunque tipo. Ne consegue che le cinque potenze, membri permanenti del Consiglio di Sicurezza di New York, sebbene costituiscano un direttorio mondiale che sancisce il diritto regolatore dei rapporti tra le nazioni … non possono imporre alcunché agli Stati Uniti.
A questo concetto, l’“eccezionalismo”, Washington si è sempre ispirato, benché il resto del mondo non se ne sia mai accorto [1]. L’eccezionalismo si riaffaccia oggi in un contesto internazionale particolare e sta per sconvolgere il mondo che conosciamo.
L’eccezionalismo statunitense si rifà al mito dei Padri Pellegrini: dei puritani, perseguitati in Inghilterra perché percepiti come pericolosi fanatici, che dapprima si rifugiarono in Olanda e poi nelle Americhe, dove arrivarono a bordo della Mayflower (1620).
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2689
Hits 2347
Hits 2242
Hits 2129
Hits 2125
Hits 2114
Hits 2045
tonino

Eric Toussaint: La crisi economica e le banche centrali
La crisi economica e le banche centrali
di Eric Toussaint
 Gli elementi di una
nuova crisi finanziaria internazionale sono tutti presenti;
non si sa quando
essa scoppierà ma quando accadrà il suo effetto su tutto il
pianeta sarà importante.
Gli elementi di una
nuova crisi finanziaria internazionale sono tutti presenti;
non si sa quando
essa scoppierà ma quando accadrà il suo effetto su tutto il
pianeta sarà importante.
I principali fattori di crisi sono da una parte l’aumento ingente dei debiti privati delle imprese, dall’altra la bolla speculativa sui prezzi degli attivi finanziari: borse valori, prezzi dei titoli del debito, e, in certi paesi (Stati Uniti, Cina …), di nuovo il settore immobiliare. I due fattori sono strettamente interconnessi. Anche le imprese che hanno un’enorme liquidità a loro disposizione come Apple si indebitano massicciamente perché approfittano dei bassi tassi di interesse per prestare ad altre il denaro che esse prendono a prestito. Apple e numerose altre imprese prendono a prestito per prestare a loro volta e non per investire nella produzione. Apple prende a prestito anche per riacquistare le proprie azioni in borsa. Ho spiegato questo in un articolo intitolato «» , pubblicato il 9 novembre del 1917.
Banche centrali e bolla in arrivo
Le bolle speculative ora citate sono il risultato delle politiche condotte dalle grandi banche centrali (Federal Rèserve degli Stati Uniti, BCE7, Banca d’Inghilterra, da 10 anni, e dalla Banca del Giappone dallo scoppio della bolla immobiliare negli anni 1990) che hanno iniettato migliaia di miliardi di dollari, euro, sterline, yen nelle banche private per mantenerle a galla. Queste politiche sono state chiamate Quantitative easing o allentamento monetario quantitativo. I mezzi finanziari che le banche centrali hanno distribuito a profusione non sono stati utilizzati dalle banche e dalle grandi imprese capitaliste degli altri settori per l’investimento produttivo. Essi sono serviti a acquistare attivi finanziari: azioni di borsa, obbligazioni di debiti delle imprese, titoli di Stato sovrani, prodotti strutturati e derivati… Questo ha generato una bolla speculativa sul mercato borsistico, sul mercato obbligazionario (vale a dire le obbligazioni dei debiti) e, in alcuni paesi, nel settore immobiliare. Tutte le grandi imprese sono sovra-indebitate.
Leggi tutto
Rémy Herrera: La Cina è capitalista?
La Cina è capitalista?
Intervista a Rémy Herrera
 “La Cina
è capitalista?”. Questo il titolo del nuovo di libro di
Rémy Herrera (economista marxista francese,
ricercatore al CNRS e alla Sorbona, Parigi) e Zhiming
Long
(economista marxista cinese della Scuola di Marxismo
all’Università Tsinghua, Pechino), uscito a Marzo per le Éditions
Critiques. Gli autori intendono smentire
stereotipi e incomprensioni sulla Repubblica popolare
cinese, ripercorrendo la storia dello sviluppo
economico del paese dal 1950 a oggi. L’intervista che
trascriviamo è stata realizzata da Le
Média, un nuovo media alternativo legato alla sinistra
francese.
“La Cina
è capitalista?”. Questo il titolo del nuovo di libro di
Rémy Herrera (economista marxista francese,
ricercatore al CNRS e alla Sorbona, Parigi) e Zhiming
Long
(economista marxista cinese della Scuola di Marxismo
all’Università Tsinghua, Pechino), uscito a Marzo per le Éditions
Critiques. Gli autori intendono smentire
stereotipi e incomprensioni sulla Repubblica popolare
cinese, ripercorrendo la storia dello sviluppo
economico del paese dal 1950 a oggi. L’intervista che
trascriviamo è stata realizzata da Le
Média, un nuovo media alternativo legato alla sinistra
francese.
* * * *
Il vostro è un libro controcorrente. Presenta un punto di vista piuttosto raro in Francia, che merita di essere segnalato e discusso. Innanzi tutto, come fate notare, quando si parla dell’economia cinese spesso lo si fa attraverso un prisma occidentale, usando dati prodotti da occidentali: secondo voi, ciò falsifica la visione che noi abbiamo del successo cinese.
Esattamente, ed è un punto fondamentale. Tutti infatti hanno un’opinione sulla Cina, ma che rischia di non essere necessariamente ben fondata. Ciò è dovuto, secondo noi, alle difficoltà rappresentate dalla lingua e dalla lontananza geografica. Difficoltà che rendono in qualche modo inaccessibili gran parte dei dibattiti interni alla Cina e che obbligano passare attraverso questo prisma occidentale. Uno sguardo esterno che occupa in pratica la totalità della nostra percezione della Cina. E questo è un problema, esso è dovuto innanzi tutto a una difficoltà di accesso ai dati, ma non certo perché le statistiche cinesi siano nascoste – al contrario esistono, sono molto numerose e diffuse. Tuttavia sono nella maggioranza dei casi in cinese, cosa che le rende di difficile utilizzo. Queste statistiche sono, contrariamente all’opinione comune, abbastanza serie, ben costruite e relativamente affidabili e questo da molto tempo – grazie all’Ufficio nazionale di statistica che esiste dal 1952. Tuttavia possono risultare incomplete, per noi che avevamo bisogno di un certo numero di indicatori che non esistevano oppure, laddove esistevano, non erano esenti da imperfezioni.
Leggi tutto
Girolamo De Michele: 7 aprile
7 aprile
di Girolamo De Michele
Una data che segna l’operazione giudiziaria e politica con cui vengono regolati i conti con pezzi importanti dei movimenti degli anni Settanta. Accusati di “insurrezione armata contro i poteri dello stato”
 Il 7 aprile
1979 decine di militanti (che diventeranno centinaia nel corso
dell’inchiesta) dell’area dell’Autonomia furono arrestati, in
esecuzione di un duplice mandato di cattura emesso dai giudici
Pietro
Calogero e Achille Gallucci delle procure di Padova e Roma,
con l’accusa di associazione sovversiva, banda armata e
partecipazione a diciannove
omicidi, fra i quali spiccava quello di Aldo Moro. L’accusa
era di aver costituito una organizzazione segreta che dirigeva
dietro le quinte ogni
possibile formazione armata: come scriverà l’Unità
due giorni dopo, «un unico filo, insomma, percorrerebbe tutte
le
formazioni terroristiche, dalla nebulosa del “terrorismo
diffuso” alla perfezione militare delle Br. La mano che questo
filo tira e
manovra sarebbe quella dell’Autonomia», organizzazione nata
dopo lo scioglimento di Potere Operaio e poi cresciuta nel
corso degli anni
Settanta, ovvero quella di Toni Negri, per il quale il giudice
Calogero ricorre, prima volta nella storia dell’Italia
repubblicana
all’articolo 284 del codice penale «per aver promosso una
insurrezione armata contro i poteri dello Stato e commesso
fatti diretti a
suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato».
Il 7 aprile
1979 decine di militanti (che diventeranno centinaia nel corso
dell’inchiesta) dell’area dell’Autonomia furono arrestati, in
esecuzione di un duplice mandato di cattura emesso dai giudici
Pietro
Calogero e Achille Gallucci delle procure di Padova e Roma,
con l’accusa di associazione sovversiva, banda armata e
partecipazione a diciannove
omicidi, fra i quali spiccava quello di Aldo Moro. L’accusa
era di aver costituito una organizzazione segreta che dirigeva
dietro le quinte ogni
possibile formazione armata: come scriverà l’Unità
due giorni dopo, «un unico filo, insomma, percorrerebbe tutte
le
formazioni terroristiche, dalla nebulosa del “terrorismo
diffuso” alla perfezione militare delle Br. La mano che questo
filo tira e
manovra sarebbe quella dell’Autonomia», organizzazione nata
dopo lo scioglimento di Potere Operaio e poi cresciuta nel
corso degli anni
Settanta, ovvero quella di Toni Negri, per il quale il giudice
Calogero ricorre, prima volta nella storia dell’Italia
repubblicana
all’articolo 284 del codice penale «per aver promosso una
insurrezione armata contro i poteri dello Stato e commesso
fatti diretti a
suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato».
L’operazione 7 aprile svolge un ruolo nevralgico nello scontro sociale che si è consumato negli anni Settanta, un decennio eccezionale dal punto di vista delle lotte sociali e del protagonismo operaio. La sostenne un battage giornalistico impressionante. Nel giro di pochi giorni l’Italia apprendeva l’esistenza di una sorta di Spectre nostrana, la cui esistenza si affermava con certezza essere comprovata da solidi elementi e testimoni inconfutabili: fra questi un uomo del generale Dalla Chiesa e un brigatista pentito padovano. In particolare, era l’Unità a distinguersi nel distillare, giorno per giorno, le rivelazioni provenienti dalla procura di Padova: Negri era ideatore dei primi sequestri di persona effettuati dalle Br, membro della direzione Br sin dalla metà del ’73, il telefonista che comunicava con la famiglia Moro durante il sequestro del leader Dc, ma anche, con estrema versatilità, l’uomo che «insegnava la tecnica di costruzione delle bottiglie molotov».
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: Prima che sia troppo tardi
Prima che sia troppo tardi
di Elisabetta Teghil
E’ in preparazione un articolo del disegno di legge Concretezza che prevede la sostituzione del badge per i dipendenti pubblici con sistemi di controllo biometrico, vale a dire impronte digitali, controllo dell’iride e via discorrendo. Tutto contrabbandato dal “nobile” intento di contrastare l’assenteismo nella pubblica amministrazione e invece per coinvolgere la popolazione contro un settore lavorativo e far perdere la visione del progetto globale. Ma la proposta di questo governo è solo l’ultimo atto di un lungo percorso, quello della naturalizzazione del neoliberismo attuato scientemente dalla socialdemocrazia riformista da tanti anni a questa parte. Spero nessuno e nessuna si sia dimenticato dei sindaci/sceriffi, della detenzione amministrativa di Livia Turco e Giorgio Napolitano, dei decreti Minniti, della miriade di telecamere installate in tutti gli angoli del paese, dei varchi elettronici, dei tornelli negli uffici, ma anche del libro bianco di Marco Biagi, dell’organizzazione neoliberista dell’istruzione di Luigi Berlinguer, ma anche di Urban Operation 2020 della Nato sugli scenari per il controllo del dissenso e delle rivolte negli ambiti metropolitani ma anche dell’esercito nelle strade e nelle metropolitane e della militarizzazione dei territori e si potrebbe continuare senza fine. E spero che nessuno e nessuna sia così ingenuo o buontempone o in malafede da dichiarare che tutto ciò ha un qualsivoglia intento di tutela della cittadinanza.
Leggi tutto
Enzo Pennetta: Su Le Scienze un Appello per la Nuova Atlantide
Su Le Scienze un Appello per la Nuova Atlantide
di Enzo Pennetta
Si chiede che il Parlamento italiano si doti di un “Comitato per la scienza e la tecnologia” che supporti le scelte politiche ma di fatto le condizionerebbe
Le intenzioni sono buone, ma lo erano anche quelle del famoso lastricato, e come scritto su Le Scienze la prima è spiegata così:
…una quantità crescente del tempo e delle attività dei parlamentari ha a che fare con temi correlati alla scienza e alla tecnologia. Non è una sorpresa. È, semplicemente, il segno dei tempi. Viviamo nella società e nell’economia della conoscenza. Viviamo nell’era della domanda crescente di nuovi diritti di cittadinanza: i diritti di cittadinanza scientifica.
Di conseguenza, le massime agorà della democrazia – i parlamenti, appunto – non possono non occuparsi di conoscenza: sia della produzione di nuova conoscenza (la scienza) sia delle applicazioni delle nuove conoscenze (l’innovazione tecnologica fondata sulla scienza).
Spiegare cosa siano i “diritti di cittadinanza scientifica” lo lasciamo ai teologi del clero accademico, di seguito riportiamo il secondo motivo:
…essere in grado di prendere decisioni ponderate su «problemi di politica pubblica che hanno a che fare con la scienza e la tecnologia», devono poter contare su «analisi indipendenti, bilanciate e accessibili» realizzate da consulenti scientifici.
Leggi tutto
Owen Jones: Come risolvere la crisi della Brexit e fare a pezzi i Tories
Come risolvere la crisi della Brexit e fare a pezzi i Tories
di Owen Jones
Pubblichiamo di seguito la traduzione di un articolo apparso giovedì sul quotidiano The Guardian. Owen Jones, influente giornalista ed esponente della sinistra laburista, prova a tracciare le linee fondamentali di quelle che dovrebbero essere la tattica e la strategia del Partito Laburista nelle negoziazioni sulla Brexit con Theresa May.
La posizione di Jones risulta significativa in quanto allineata con l’atteggiamento tenuto da Jeremy Corbyn nel corso di questi ultimi anni:
accettazione del verdetto referendario del 23 Giugno 2016;
riluttanza ad allinearsi alla proposta di una seconda consultazione (considerata pericolosamente divisiva);
implementazione di una Brexit morbida;
promozione di un programma socialmente avanzato in grado di fungere da collante per un paese attraversato da profondissime fratture geografiche, politiche e sociali.
Owen Jones sottolinea come alcuni di questi obiettivi potrebbero essere alla portata del Labour, in considerazione delle fibrillazioni interne al partito di Theresa May che una trattativa impostata in questi termini potrebbe produrre.
Leggi tutto
Alessandro De Toni: Abolire i paradisi fiscali europei
Abolire i paradisi fiscali europei
di Alessandro De Toni
Pierre Moscovici, commissario europeo per gli affari economici e monetari, sostiene senza vergogna che non esistono paradisi fiscali in Europa. Anche se precisa: “senza dubbio alcuni paesi incoraggiano l’eccesso di ottimizzazione fiscale“. Sottile distinzione. Basta intendersi sul significato delle parole.
Fatto sta che secondo l’Oxfam, mancano almeno 5 paesi nella blacklist dei paradisi fiscali approntata dall’Ecofin. Paesi che stringono accordi riservati con le multinazionali. Sempre secondo questa Ong solo nel 2015, Italia, Francia, Spagna e Germania hanno perso un gettito fiscale di circa 35 miliardi di euro. In particolare, i paradisi fiscali costano all’Italia 6,5 miliardi di euro l’anno. Un gettito che è finito per l’80% in Olanda, Lussemburgo e Irlanda, grazie a sofisticate operazioni contabili. A questi tre paesi si aggiungono Malta e Cipro.
D’altronde, la Commissione europea in merito all’elusione fiscale delle multinazionali ha una lunga coda di paglia, ad iniziare dal suo Presidente Jean-Claude Juncker. Nel 2014, il consorzio internazionale di giornalisti d’inchiesta (ICIJ) che raggruppa 185 giornalisti in oltre 65 Paesi, ha rivelato che il Granducato del Lussemburgo aveva concesso in 10 anni generosi accordi fiscali a una lunga lista di multinazionali. Si trattava di 550 intese fiscali attraverso le quali aziende internazionali avevano trasferito denaro nel Granducato per pagare meno imposte.
Leggi tutto
Sandro Moiso: Una guerra civile ancora invisibile
Una guerra civile ancora invisibile
di Sandro Moiso
Marco Revelli, La politica senza politica. Perché la crisi ha fatto entrare il populismo nelle nostre vite, Einaudi, Torino 2019, pp. 224, 14,00 euro
 Nell’attuale buriana
di riflessioni, più ideologiche che seriamente politiche,
foriere
più di confusione che di chiarezza, la riunificazione e la
rielaborazione in un unico volume di tre saggi di Marco
Revelli già
precedentemente apparsi in libreria appare davvero come cosa
utile e necessaria. Si tratta infatti di Populismo 2.0
(Einaudi 2017),
Finale di partito (Einaudi 2016) e Poveri noi
(Einaudi 2010) e fin dai titoli si comprende come siano
tutti indirizzati a
comprendere la rinascita del fenomeno populista e la crisi
dei partiti politici così come si sono caratterizzati nel
corso del ‘900 (in
particolare di quelli di ‘”sinistra”) nel corso dell’ultimo
decennio. Guarda caso quello determinato, socialmente e
politicamente, dalla più grave crisi economica successiva a
quella del 1929 e sicuramente non inferiore alla prima sia
in termini qualitativi
che quantitativi (miliardi di dollari e di euro perduti,
disoccupazione, riduzione degli apparati produttivi e
fallimenti bancari e aziendali).
Nell’attuale buriana
di riflessioni, più ideologiche che seriamente politiche,
foriere
più di confusione che di chiarezza, la riunificazione e la
rielaborazione in un unico volume di tre saggi di Marco
Revelli già
precedentemente apparsi in libreria appare davvero come cosa
utile e necessaria. Si tratta infatti di Populismo 2.0
(Einaudi 2017),
Finale di partito (Einaudi 2016) e Poveri noi
(Einaudi 2010) e fin dai titoli si comprende come siano
tutti indirizzati a
comprendere la rinascita del fenomeno populista e la crisi
dei partiti politici così come si sono caratterizzati nel
corso del ‘900 (in
particolare di quelli di ‘”sinistra”) nel corso dell’ultimo
decennio. Guarda caso quello determinato, socialmente e
politicamente, dalla più grave crisi economica successiva a
quella del 1929 e sicuramente non inferiore alla prima sia
in termini qualitativi
che quantitativi (miliardi di dollari e di euro perduti,
disoccupazione, riduzione degli apparati produttivi e
fallimenti bancari e aziendali).
Revelli, docente di Scienze della Politica presso l’Università del Piemonte orientale, costituisce una delle poche voci superstiti e menti ancora lucide dell’esperienza torinese di Lotta Continua e la parte migliore di quell’ormai lontana stagione politica si riflette nell’attenzione con cui l’attuale insorgenza di movimenti anomali e potenzialmente fascisti viene esaminata non a partire da principi assoluti e universali, ma dalle reali cause economiche e sociali che li hanno determinati. Così come, ad esempio, quel gruppo politico, scomparso a Rimini nel 1976, aveva cercato già di fare nei confronti del malessere del Meridione d’Italia a cavallo tra anni Sessanta e Settanta, da quello indirettamente manifestato dal sottoproletariato napoletano fino ai fatti di Reggio Calabria e ai boia chi molla che ne avevano preso in mano le redini.
Leggi tutto
Sergio Farris: Le asimmetrie della zona euro
![]()
Le asimmetrie della zona euro
di Sergio Farris
Relazione presentata al convegno UE: riforma o uscita, tenuto ad Udine 30 marzo 2019 su invito del gruppo locale di Senso comune
 1. Ci vuole più
Europa e meno Europa?
1. Ci vuole più
Europa e meno Europa?
Serve meno Europa.
Il processo di aggregazione dei paesi europei è il portato dell'ideologia del libero mercato, condotta ai suoi estremi. L'unificazione monetaria rappresenta l'apice di tale processo.
La storia che ha condotto all'euro è una storia tutta incentrata su tentativi di ricostituire un accordo di cambio valutario dopo la cessazione del sistema di Bretton Woods, avvenuta nel 1971. Risiede alla sua base il postulato che - innanzitutto - l'integrazione dei mercati incentivi gli scambi internazionali e rechi vantaggi generalizzati; oltreciò, tale risultato si otterrebbe tramite l'abolizione di fattori di impedimento o di incertezza per gli scambi commerciali e la circolazione finanziaria.
L'euro, in particolare, è il risultato di diverse esigenze, condensate in un compromesso: da un lato la Germania - da sempre titubante per via della propria concentrazione sul pericolo dell'inflazione -, la quale ha acconsentito all'istituzione della moneta unica dopo varie proposte avanzate nei decenni, da parte francese. Pare che, alla fine, la Germania abbia acconsentito all'istituzione della moneta unica con l'occhio rivolto alla possibilità di difendersi dalle svalutazioni competitive dei vicini e, si dice, anche per ottenere il via libera alla riunificazione. Dall'altro lato la Francia, con le sue mire rivolte a contenere il potere del marco e altri paesi - come l'Italia - preoccupati dell'inflazione, dovuta anche alle svalutazioni e alle fluttuazioni dei tassi di cambio (oltre che mossa dalla richiesta padronale di frenare la dinamica salariale).
Ne è emerso un modello fondato sull'esasperazione della concorrenza e sull'ossessione per l'inflazione (i sistemi di cambio valutario fisso hanno infatti - quale costante giustificazione, il timore per l'inflazione e per i presunti danni che l'incertezza derivante dalle oscillazioni del cambio arrecherebbe alle relazioni di mercato).
Leggi tutto
Marco Gatto: Critica, occasione e disciplina
Critica, occasione e disciplina
Appunti sparsi sull’oggi
di Marco Gatto
Con un sentito ringraziamento all’autore, pubblichiamo di seguito un estratto del libro di Marco Gatto, Resistenze dialettiche. Saggi di teoria della critica e della cultura, Roma, manifestolibri, 2018
 1.
1.
Introducendo Minima moralia (1951), Renato Solmi così si esprimeva sul carattere solo apparentemente frammentistico della raccolta di Adorno: «i trapassi bruschi, e a prima vista sconcertanti, dall’infinitamente grande all’infinitamente piccolo, e viceversa», non sono la manifestazione di «un linguaggio metaforico e suggestivo», non hanno nulla di «arbitrario e di fantastico», bensì rappresentano «le scorciatoie della dialettica». La rinuncia al sistema o all’esibita unitarietà, «mentre corrisponde alla dispersione apparente dell’oggetto, serve, nello stesso tempo, a un’intenzione precisa»: «l’analisi disimpegnata», nel momento in cui «confuta la pretesa del particolare a valere come essenza, si ritorce contro il cattivo universale; mentre l’esposizione sistematica finirebbe per dare ragione al sistema». Il meccanismo hegeliano della critica all’assolutizzazione assumeva, nelle mani del filosofo più influente della Scuola di Francoforte, un’ulteriore funzione demistificatoria: mostrava il carattere falso della realtà o, per dirla in termini schiettamente adorniani, della “vita vera”, cautelando il discorso intellettuale nei riguardi di qualsivoglia diretta presa di posizione. Di fronte allo strapotere dell’americanizzazione, capace di affossare i tradizionali modelli interpretativi di origine borghese e di disinnescare la persistenza dei grandi orientamenti di senso, la critica ha pertanto l’obbligo di una permanente autoverifica, in larga parte consistente nel sorvegliare la propria tendenza a porsi come falsa universalità o come opposizione passibile di integrazione in un sistema che ha dimostrato d’essere, nella sua coerenza sistematica, più ampio e agguerrito. «In questo senso – insiste Solmi –, nel sistema del dominio, l’apparenza è la sede della verità. Ma non appena si ritiene tale, si capovolge nel suo contrario», generando quell’ambivalenza che è costitutiva del pensiero di Adorno, moralista e pessimista intransigente, ma «pronto ad aprirsi alla speranza», seppure irrisolto nel saper convertire «la critica dell’interiorità» in una «critica della prassi», senza che la prima diventi un alibi per il disimpegno e la disillusione.1
Leggi tutto
Assemblée des assemblées des Gilets Jaunes: L’appello finale dell’Assemblea delle assemblee
Gilets Jaunes. L’appello finale dell’Assemblea delle assemblee
di Assemblée des assemblées des Gilets Jaunes
Noi Gilets Jaunes, costituiti in assemblee locali, riuniti a Saint-Nazaire, il 5-6-7 aprile 2019, ci rivolgiamo a tutto il popolo nel suo complesso. In seguito alla prima assemblea di Commercy, circa 200 delegazioni presenti hanno continuato la loro lotta contro l’estremismo liberista, per la libertà, l’uguaglianza e la fraternità.
Nonostante l’escalation repressiva del governo, l’accumulo di leggi che aggravano tutte le condizioni di vita, che distruggono diritti e libertà, la mobilitazione si sta radicando per cambiare il sistema incarnato da Macron. Come unica risposta al movimento dei Gilets Jaunes e di altri movimenti di lotta, il governo si è fatto prendere dal panico e ha innescato una deriva autoritaria. Da cinque mesi ormai, ovunque in Francia, nelle rotatorie, nei parcheggi, nelle piazze, ai caselli, nelle manifestazioni e nelle nostre assemblee, abbiamo continuato a discutere e a lottare contro ogni forma di disuguaglianza e ingiustizia e per la solidarietà e la dignità.
Rivendichiamo un aumento generale dei salari, delle pensioni e dei minimi sociali, nonché dei servizi pubblici per tutte e tutti. La nostra solidarietà nella lotta va soprattutto alle nove milioni di persone che vivono al di sotto della soglia di povertà. Consapevoli dell’emergenza ambientale, affermiamo: fine del mondo, fine del mese, stessa logica, stessa lotta.
Leggi tutto
comidad: Perchè il FMI adotta la lotta al riscaldamento globale
Perchè il FMI adotta la lotta al riscaldamento globale
di comidad
Il Fondo Monetario Internazionale è un’istituzione benemerita che lavora instancabilmente da settantacinque anni per la salvezza dell’Umanità. Purtroppo le solite menti astiose e sospettose attribuiscono al FMI ogni genere di crimine e nefandezza, accusandolo di essere la maggiore agenzia di lobbying delle multinazionali. Tanta ingenerosità dovrebbe arrendersi di fronte alla constatazione che attualmente la maggiore preoccupazione delle anime belle del FMI è il riscaldamento globale dovuto alle emissioni di CO2. Il FMI ha addirittura svolto un ruolo pionieristico nella segnalazione e nella denuncia di questa emergenza ecologica. È infatti il FMI, dall’alto della sua illuminata preveggenza, a dettare al mondo l’agenda delle emergenze.
Non tutti i climatologi sono d’accordo nel considerare il riscaldamento globale una vera emergenza. Alcuni fanno osservare che i rilevamenti non possono essere ritenuti come attendibili, poiché solo da pochi decenni sono operati con la dovuta accuratezza. Altri ancora ricordano che i cambiamenti climatici, anche drastici, sono frequenti, che ce ne sono stati di rilevanti persino in epoca storica, come nel XIV secolo; quindi non possono essere scientificamente individuati come effetto di attività antropiche.
Comunque stiano le cose, è un fatto che le emissioni di CO2 non possono essere considerate innocue per la salute pubblica, perciò misure per il loro contenimento, o eliminazione, dovrebbero essere bene accette.
Leggi tutto
Robert Tracinski: Perché non “credo” nella “scienza”
Perché non “credo” nella “scienza”
di Robert Tracinski*
Come spiega Robert Tracinski, oggi la politica tenta di accreditare se stessa rendendo un vuoto omaggio alla scienza, nella quale molti politici dichiarano di “credere”, per segnalare la propria superiorità intellettuale. La scienza però non è un dogma in cui credere, ma un metodo di indagine e verifica che serve a studiare la realtà, non a distinguere tra fedeli “buoni” e infedeli “spregevoli”
La scienza non si occupa di “credenze”. Si occupa di fatti, evidenze, teorie ed esperimenti
Da anni ormai, lo slogan preferito della sinistra è la frase “io credo nella scienza”. Elizabeth Warren l’ha detto recentemente in una forma molto tipica: “Io credo nella scienza. E chiunque non ci crede non ha il diritto di prendere decisioni riguardo all’ambiente”. Questa affermazione era data in risposta alla notizia che ad alcuni scienziati, scettici sul riscaldamento globale, potrebbe essere consentito di contribuire a definire la relativa politica pubblica.
Quindi quello che la Warren vuole intendere davvero dicendo “io credo nella scienza” è “io credo nel riscaldamento globale”.
Ma dobbiamo ringraziare Andrew Yang – un candidato democratico alla presidenza che è appena riuscito ad essere ammesso ai dibattiti televisivi delle primarie ottenendo più di 65.000 contributi individuali per la sua campagna – per avere proclamato questo slogan nella maniera maggiormente comica:
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Lo stato della sinistra europea
Lo stato della sinistra europea
[post molto complicato]
di Pierluigi Fagan
Stato come istituzione giuridica comune ad una popolazione di un dato territorio, viene dal latino status che significava “condizione”. Il titolo del post quindi alluderebbe a “la condizione della sinistra europea rispetto al problema dello Stato”.
Il problema è che la sinistra è quella parte politica che storicamente, per lo più proviene dal pensiero marxista e Marx, sebbene figlio di un avvocato ed introdotto all’università proprio a gli studi di diritto, nonché impegnato come prima prova di pensatore-scrittore in una Filosofia del diritto che mai terminerà (terminerà invece la critica di quella hegeliana ma una concezione positiva non si forma di per sé da una negativa per semplice inversione), non sviluppò una significativa visione dello Stato.
La lacuna nel sistema teorico venne avvertita da Lenin che, alle prese con il pragmatico problema di uno Stato reale (quello russo), dovette farci una riflessione meno elusiva in Stato e rivoluzione. Ma poiché l’impianto teorico di Marx era social-economico-filosofico, la natura dello Stato, rimase un imbarazzante punto interrogativo nella parte politica che da lui discese. Sebbene in aperta competizione con gli anarchici ai tempi della Prima Internazionale, un certo alone di critica assoluta dello Stato, era genetica di quei tempi. Lo Stato era avvertito come istituzione borghese ma l’origine dello Stato precede la nascita della borghesia di più di tre millenni.
Leggi tutto
Hits 2752
Hits 2727
Hits 2363
Hits 2311
Hits 2288
Hits 2185
Hits 2143
Hits 2072
Hits 1953
Hits 1907
tonino

Carlo Galli: La nuova edizione spagnola di «Genealogia della politica»
La nuova edizione spagnola di «Genealogia della politica»
Gerardo Muñoz intervista Carlo Galli
Carlo Galli: Genealogía de la política. Carl Schmitt y la crisis del pensamiento político moderno, UNIPE Editorial Universitaria, 2018
 Professor Galli, the Spanish
edition Genealogía de la política (Buenos Aires,
unipe, 2018), a
classic of contemporary political thought, has just been
realized in Argentina after twenty years. We should not
forget that Argentina has always been
a fruitful territory for the reception of Carl Schmitt’s
work. Perhaps my first question is commonplace but
necessary: how do you expect readers
in Spanish to read your classic study?
Professor Galli, the Spanish
edition Genealogía de la política (Buenos Aires,
unipe, 2018), a
classic of contemporary political thought, has just been
realized in Argentina after twenty years. We should not
forget that Argentina has always been
a fruitful territory for the reception of Carl Schmitt’s
work. Perhaps my first question is commonplace but
necessary: how do you expect readers
in Spanish to read your classic study?
Come ci ha dimostrato il compianto Jorge Dotti, la recezione di Schmitt in Argentina è stata imponente e pervasiva, e si è intrecciata con la riflessione filosofica, giuridica e politica sullo Stato e sul suo destino. Ho fiducia che il mio libro, grazie alla traduzione spagnola, possa interessare gli specialisti di Carl Schmitt – giovani e maturi – che sono numerosi e agguerriti, non solo in Argentina ma anche in Europa: dopo tutto, la Spagna stessa ha un lungo e fecondo rapporto intellettuale con Schmitt, che, come ci ha mostrato da ultimo Miguel Saralegui, può anche esser definito «pensatore spagnolo».
This edition comes out in a timely moment, that is, in the wake of the centenary of the Weimar Republic (1919-2019); a moment that Weber already in 1919 referred as a point of entry into a ‘polar night‘. Does Schmitt’s confrontation in the Weimar ‘moment’ still speak to our present?
Schmitt è stato il più grande interprete della Costituzione di Weimar, in un’epoca in cui non mancavano certo i grandissimi costituzionalisti. La sua Dottrina della costituzione è una diagnosi geniale della situazione storica concreta in cui i concetti politici della modernità si trovano a operare. Ed è stato anche il più acuto interprete (nel Custode della Costituzione e in Legalità e legittimità) della rovina di Weimar, causata da uno sfasamento gigantesco fra spirito e strumenti del compromesso democratico weimariano, da una parte, e, dall’altra, la polarizzazione radicalissima in cui la crisi economica aveva gettato il popolo e il sistema politico tedesco. Una democrazia senza baricentro politico funzionante, senza capacità di analizzare le proprie dinamiche e di reagire attivamente, è alla mercé di ogni crisi e di ogni minaccia.
Leggi tutto
Diego Ceccobelli: “Potere digitale” di Gabriele Giacomini
“Potere digitale” di Gabriele Giacomini
di Diego Ceccobelli
Recensione a: Gabriele Giacomini, Potere Digitale. Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la democrazia, Meltemi Editore, Milano 2018, pp. 353, 24 euro (scheda libro)
 L’incontro tra internet
e democrazia ha immediatamente stimolato una corposa
produzione scientifica volta a carpirne
i principali tratti, processi ed effetti concreti, così come
le principali tensioni e conflitti. Sono moltissimi gli
approcci scientifici, gli
ambiti di applicazione e i disegni di ricerca che hanno e
stanno tuttora investigando gli esiti di questo incontro. Tra
i più recenti,
l’ultimo libro di Gabriele Giacomini – Potere Digitale.
Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la
democrazia – merita sicuramente una menzione.
L’incontro tra internet
e democrazia ha immediatamente stimolato una corposa
produzione scientifica volta a carpirne
i principali tratti, processi ed effetti concreti, così come
le principali tensioni e conflitti. Sono moltissimi gli
approcci scientifici, gli
ambiti di applicazione e i disegni di ricerca che hanno e
stanno tuttora investigando gli esiti di questo incontro. Tra
i più recenti,
l’ultimo libro di Gabriele Giacomini – Potere Digitale.
Come internet sta cambiando la sfera pubblica e la
democrazia – merita sicuramente una menzione.
In questo volume, Giacomini si concentra sul rapporto tra democrazia e tecnologie digitali della comunicazione e lo fa in maniera molto innovativa, scientificamente accurata e compiuta. Il suo non è un libro per nulla banale, né una copia o un semplice riassunto di quanto già presente nella letteratura. Piuttosto, questo suo ultimo sforzo scientifico apporta un importante contributo alla nostra conoscenza del modo in cui internet sta co-rimodellando alle fondamenta i processi democratici, la formazione e costruzione dell’opinione pubblica, passando infine per le potenziali soluzioni proposte dagli studiosi e dagli attori politici per ovviare alle potenziali storture indotte dal rapporto tra tecnologie digitali e configurazioni profonde del potere.
Il principale punto di forza di questo volume è forse nella sua metodologia di ricerca. Il contributo di Giacomini prende infatti le mosse dalla realizzazione e analisi di 11 interviste ad esperti di 3 paesi differenti, i quali si occupano del rapporto tra internet e democrazia all’interno di differenti settori scientifico-disciplinari, come la scienza politica, la filosofia politica e la sociologia dei media. A partire da queste interviste, Giacomini struttura il suo ragionamento seguendo varie direttrici tematiche, spaziando da concetti quali neointermediazione, paradosso del pluralismo, “incastellamento” della sfera pubblica e democrazia dialogica imperfetta (Giacomini 2016).
Leggi tutto
Giuliano Spagnul: Le radici di una disputa: ancora su antropocene e/o capitalocene
Le radici di una disputa: ancora su antropocene e/o capitalocene
di Giuliano Spagnul
 Antropocene o
capitalocene è apparentemente una domanda che ricalca vecchie
e classiche dispute
sull’apoliticità o meno di determinate branche del sapere
umano. È la scienza neutrale a qualsivoglia ideologia?[1]
Appunto,
vecchie dispute. Oggi sappiamo[2] che sapere e potere sono
indissolubilmente legati. E allora sostituendo il termine
antropocene con capitalocene
possiamo, probabilmente, evitare lo spettro di un qualsivoglia
risorgente ‘neutralismo’. Ma se capitalocene esprime, senza
equivoci di
sorta, una ben definita visione politica riguardo le
motivazioni che certificano il passaggio da un’era geologica
ad un’altra, per contro
questa stessa visione ha il difetto di oscurare tutta una
serie di punti di vista altrettanto politici ma di differente
prospettiva.
Antropocene o
capitalocene è apparentemente una domanda che ricalca vecchie
e classiche dispute
sull’apoliticità o meno di determinate branche del sapere
umano. È la scienza neutrale a qualsivoglia ideologia?[1]
Appunto,
vecchie dispute. Oggi sappiamo[2] che sapere e potere sono
indissolubilmente legati. E allora sostituendo il termine
antropocene con capitalocene
possiamo, probabilmente, evitare lo spettro di un qualsivoglia
risorgente ‘neutralismo’. Ma se capitalocene esprime, senza
equivoci di
sorta, una ben definita visione politica riguardo le
motivazioni che certificano il passaggio da un’era geologica
ad un’altra, per contro
questa stessa visione ha il difetto di oscurare tutta una
serie di punti di vista altrettanto politici ma di differente
prospettiva.
Ecco così che, in questo contesto, abbiamo Isabelle Stengers come Donna Haraway, per fare qualche esempio, che si sottraggono sia “alla normativa dell’Antropocene che vede in Homo Sapiens (nozione su cui, peraltro, si iscrivono stratificazioni di genere e razziali)[3] la causa e, simultaneamente, il rimedio alla catastrofe ecologica” sia “all’idea sostenuta tra gli altri da Toni Negri, che la crisi climatica è questione subordinata alle politiche industriali, e affrontabile solo sulla base della critica ad esse”[4].
È così che chi si oppone alla logica che vuole l’odierna crisi come l’inevitabile prezzo da pagare per accedere a un superiore stadio dell’evoluzione umana, quell’inevitabile progresso di una natura umana costituitasi al di fuori del dato di natura, si ritrova in due differenti, e forse opposte, prospettive; radicalmente antagoniste entrambe al pensiero globalmente dominante ma da due punti affatto diversi.
L’abbattimento del sistema capitalistico e la costruzione di un nuovo soggetto rivoluzionario da una parte; l’urgenza del chiedersi ora ‘come vivere altrimenti’ e la conseguente produzione di una soggettività differente dall’altra.
Leggi tutto
Claudio Conti: I cinesi d’Europa siamo noi. Conto terzi, però…
I cinesi d’Europa siamo noi. Conto terzi, però…
di Claudio Conti
In calce un articolo di Guido Salerno Aletta
Da tempo cerchiamo di spiegare che “i soldi ci sono”, come paese e come entrate dello Stato. Ci sono per fare politiche sociali e investimenti produttivi, per far sviluppare il paese in modo armonico e senza le attuali diseguaglianze mostruose.
Quei soldi accantonati ogni anno (“saldo primario”) vengono però usati per tutt’altro, in omaggio a un paradigma di pensiero (il mercantilismo ordoliberista) che copre “virtuosamente” interessi materialissimi. Di imprese multinazionali quasi mai italiane. Di una finanza speculativa che solo in parte ha basi nelle nostre città. Di Stati europei che si mantengono grazie ai nostri “sacrifici”.
Il tutto in nome dell’”Europa”, che è tutt’altra cosa rispetto all’Unione Europea (così come “l’Italia” è fortunatamente ben diversa dallo Stato italiano e dalla sua degradata classe dirigente).
Spesso, nello sforzo di farci capire, siamo stati accusati di fare “ideologia”. Anche quando indichiamo meccanismi concreti, niente affatto eterei come i concetti astrusi.
Spesso abbiamo utilizzato materiali e analisi provenienti anche dai media mainstream, o comunque della stampa economica specializzata. Proprio per costringere tutti a guardare la luna (la realtà del paese e dei meccanismi imposti dai trattati europei) invece che il dito(le nostre modeste risorse giornalistiche).
Leggi tutto
Alceste De Ambris: Buonanotte bambine conformiste
Buonanotte bambine conformiste
di Alceste De Ambris
L’ideologia dominante si annida anche nella recente letteratura per l’infanzia. In questo caso mi riferisco a quello pseudo-femminismo contemporaneo, che tanto va di moda (e che ha fatto mostra di sé l’ 8 marzo). In passato la rivendicazione di parità di genere andava di pari passo con istanze sociali e riformiste, ora è diventata perfettamente funzionale al discorso liberal-capitalista.
Mi è capitato sotto mano il libro STORIE DELLA BUONANOTTE PER BAMBINE RIBELLI, che in questi anni è stato un vero e proprio caso editoriale (tanto che ne è stato scritto un seguito). Autrici sono due scrittrici italiane, imprenditrici in California… Si tratta in sostanza di 100 ritratti di donne di tutto il mondo — scienziate intellettuali sportive artiste — proposte come modello per le bambine di oggi. Al posto di Biancaneve, Cenerentola o Raperonzolo, le bambine moderne potranno identificarsi con Ipazia, Frida Kahlo, Serena Williams, Maria Montessori, Coco Chanel, Jane Austin, Maria Callas, Zaha Hadid ecc.
Donne che hanno inseguito i propri sogni e, nonostante gli ostacoli (tipicamente di genere), alla fine ce l’hanno fatta. Come si giustifica l’aggettivo “ribelli” ? Semplicemente perché hanno rifiutato le pressioni familiari e sociali, che le avrebbero relegate a un ruolo subalterno, riuscendo nonostante tutto ad avere successo. Delle "self made woman" in sostanza. L’educazione tradizionale insegnava alle ragazze virtù come l’obbedienza e la morigeratezza, ora si promuovono l’intraprendenza l’ambizione e l’anticonformismo.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Djordje Kuzmanovic, “République souveraine”
Djordje Kuzmanovic, “République souveraine”
di Alessandro Visalli
E’ stato presentato in Francia il nuovo movimento di Djordje Kuzmanovic e degli altri fuoriusciti da France Insoumiseperché in dissenso dalla linea presa per le europee. Ovvero per l'aprirsi della frattura di cui parla Michéa[1] tra un approccio neo-socialista ed uno di “sinistra”, dove per il primo termine sono rintracciabili, come vedremo, anche toni neo-giacobini in linea con la tradizione delle forze popolari francesi e la loro storia che erano propri della posizione presa da Mélenchon alle elezioni presidenziali e politiche e poi in qualche misura abbandonati. Il movimento non intende presentarsi alle imminenti elezioni europee.
A novembre l’ex Consigliere per gli affari internazionali di France Insoumise si dimise da ogni incarico e lasciò il movimento dopo la sua esclusione dalle liste dei candidati alle elezioni europee. Questo era solo l’ultimo atto di mesi di aspro confronto interno tra la linea volta alla difesa della sovranità nazionale come strumento della lotta di classe, di Kuzmanovic, e le più tradizionali linee volte all’intersezionalità delle lotte identitarie proprie delle sinistre comunque raggruppate nel movimento e/o alleate dall’esterno. Ne avevamo parlato in un post: si è trattato di una divergenza sia di linea politica sia di modello organizzativo[2]. La prima si era divaricata a partire dai toni sull’immigrazione e dalla difesa dell’operazione compiuta in Germania da Sahra Wagenknecht, e dallo scontro con un’altra importante esponente del movimento: la Autain.
Leggi tutto
César Méndez: Un diplomatico in trincea
Un diplomatico in trincea
Geraldina Colotti intervista a César Méndez*
César Méndez, da dieci anni ambasciatore del Venezuela in Svizzera, è un ex colonnello della Forza Armata Nazionale Bolivariana. Lo abbiamo incontrato a Bellinzona in occasione del dibattito “Venezuela, un popolo in lotta contro l'imperialismo”, organizzato dall'Associazione Alba Suiza.
* * * *
Da quanto tempo fai parte della rivoluzione bolivariana?
Potrei dire... da piccolo, da quando cioè, ho cominciato a percepire cosa significasse difendere certi ideali. Ti parlo dell'epoca del dittatore Marco Pérez Jimenez. Allora avevo 6-7 anni e la polizia veniva sempre a metterci a soqquadro la casa perché cercava un mio zio, che era del Partito Comunista Venezuelano e che leggeva Tribuna Popolare. Allora, tanto bastava. Tutte le volte che assistevo a un'incursione o a una perquisizione mi chiedevo perché trattassero come un criminale quello zio che mi era molto caro. Poi mi sono accorto di quanta ingiustizia venisse perpetrata contro chi la pensava diversamente. In seguito, durante i governi della Quarta Repubblica ho fatto esperienza diretta del modo in cui le elite politiche manipolavano le coscienze delle venezuelane e dei venezuelani, a partire da quella di mio padre, che era un operaio, inducendolo a votare per una falsa alternativa, costituita da due soli partiti, Acción Democratica (centro-sinistra) e Copei (centro-destra).
Leggi tutto
coniarerivolta: Banca d’Italia e debito pubblico: un matrimonio che non s’ha da fare
Banca d’Italia e debito pubblico: un matrimonio che non s’ha da fare
di coniarerivolta
 La Banca d’Italia ha recentemente
comunicato che trasferirà al Tesoro circa 6 miliardi di
euro derivanti dai suoi utili maturati nel 2018. In un periodo
caratterizzato da
una cronica scarsità di fondi pubblici, con i governi in
perenne affanno nel trovare le risorse e far quadrare i conti,
è davvero
curioso che questa notizia sia passata in sordina: per una
volta che i soldi cadono dal cielo – perché non c’è alcun
italiano che abbia dovuto sborsarli, quei 6 miliardi, che
provengono freschi freschi dal conio della banca centrale –
nessuno sembra volersene
occupare. Nemmeno un
Cottarelli di turno che si prenda la briga di spiegarci
bene da dove arrivino queste risorse
aggiuntive disponibili per la realizzazione di scuole,
ospedali, infrastrutture. Eppure, benché relativamente banale
dal punto di vista
tecnico, la questione, come vedremo, è carica di conseguenze
politiche.
La Banca d’Italia ha recentemente
comunicato che trasferirà al Tesoro circa 6 miliardi di
euro derivanti dai suoi utili maturati nel 2018. In un periodo
caratterizzato da
una cronica scarsità di fondi pubblici, con i governi in
perenne affanno nel trovare le risorse e far quadrare i conti,
è davvero
curioso che questa notizia sia passata in sordina: per una
volta che i soldi cadono dal cielo – perché non c’è alcun
italiano che abbia dovuto sborsarli, quei 6 miliardi, che
provengono freschi freschi dal conio della banca centrale –
nessuno sembra volersene
occupare. Nemmeno un
Cottarelli di turno che si prenda la briga di spiegarci
bene da dove arrivino queste risorse
aggiuntive disponibili per la realizzazione di scuole,
ospedali, infrastrutture. Eppure, benché relativamente banale
dal punto di vista
tecnico, la questione, come vedremo, è carica di conseguenze
politiche.
Indebitarsi costa. Lo Stato si indebita emettendo titoli del debito pubblico (principalmente Buoni del Tesoro Poliennali, BTP) che fruttano ai sottoscrittori (ossia i detentori di quei titoli) un certo tasso di interesse: quel tasso è il costo del debito. Se ci indebitiamo per 300 miliardi di euro ad un tasso del 2%, dovremo pagare ai nostri creditori 6 miliardi di euro ogni anno per il servizio del debito. Considerato che l’Italia ha un debito pubblico di circa 2.300 miliardi di euro, possiamo capire subito per quale ragione ogni anno lo Stato è costretto a pagare circa 65 miliardi di euro di interessi su quel debito. Per cogliere appieno l’ordine di grandezza, è sufficiente riflettere sul fatto che provvedimenti quali il Reddito di Cittadinanza e Quota 100 – le due principali misure economiche varate da questo governo che tanto hanno scandalizzato i puristi del pareggio del bilancio – hanno avuto un costo complessivo per il 2019 di circa 15 miliardi di euro, meno di un quarto delle risorse pagate dallo Stato ai suoi creditori.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Serbia: vittime, carnefici e loro vivandiere
Serbia: vittime, carnefici e loro vivandiere
di Fulvio Grimaldi
Parla il ministro degli Esteri di Milosevic in margine a un convegno a Firenze
 Una Serbia che non muore
Una Serbia che non muore
Zivadin Jovanovic ha 80 anni, ne dimostra venti di meno, da viceministro degli Esteri fino al 1998 e poi ministro fino alla caduta del governo nel 2000, è stato protagonista e testimone serbo, accanto a Slobodan Milosevic, dell’intera vicenda jugoslava e balcanica. Oggi è il protagonista della custodia, rivendicazione e propagazione della memoria di quanto fatto alla Serbia dalla Nato. Contro le turbe di occultatori e mentitori, è anche il combattente della verità sui Balcani e sulla Serbia di oggi e sui complotti che l’Occidente insiste a tessere a danno di sovranità, integrità e autodeterminazione della Serbia. Alto, snello, dritto e determinato, come uno di quegli abeti rossi che nel Sud Tirolo svettano verso la luce del sole, ha appena organizzato, nel XX dell’aggressione Nato e nel LXX della fondazione dell’Alleanza Militare Atlantica, l’ennesimo convegno internazionale del Forum di Belgrado per un Mondo di Uguali, da lui presieduto e al quale ho avuto il privilegio di partecipare. Ve ne ho riferito in www.fulviogrimaldicontroblog.info: Convegno internazionale a vent’anni dall’aggressione - “DIMENTICARE? PERDONARE? MAI !” Inviato sotto le bombe, testimone di oggi.
Ci siamo trovati fianco a fianco, in amicizia e causa comune, grazie al modesto contributo che ho potuto dare da responsabile del “Comitato Ramsey Clark per la Jugoslavia” e poi da portavoce, insieme a Enrico Vigna, del “Comitato Milosevic”, che si batteva per la liberazione del Presidente della Federazione Jugoslava e della Repubblica Serba, e per la demistificazione delle menzogne che ne volevano giustificare l’arresto e il processo da parte di un tribunale-farsa.
Le trombe degli eserciti
Jovanovic mi ha concesso l’intervista sull’oggi dei Balcani, sottoposto a nuove minacce da parte degli stessi criminali di ieri e di sempre. La leggerete più avanti. Prima, mi vorrei soffermare brevemente sul contributo che alla tragedia serba hanno fornito quelli che chiamerei “vivandiere”, o “corifei”, dei carnefici.
Leggi tutto
Valerio Pellegrini: Disoccupazione e altri spettri tecnologici
Disoccupazione e altri spettri tecnologici
di Valerio Pellegrini
Intelligenza artificiale: La forza-lavoro androide è la protagonista della serie televisiva britannica Humans
 L’umanità è sotto
attacco. Nella serie britannica Humans (due stagioni
e
una terza all’orizzonte), ideata da Sam Vincent e Jonathan
Brackley, c’è un gruppo di robot atipici che cerca
un’esistenza
piena al di fuori degli schemi imposti dai creatori; Humans
è stata tratta una precedente serie tv svedese, Real
Humans
(2012-2014), ideata da Lars Lundström. Il contesto è una
società in cui la disponibilità di forza-lavoro androide (i
synth) diventa un dato di fatto con notevoli
conseguenze. L’attualità della serie deriva dalla vicinanza al
mondo dei consumi
reali, ai settori trainanti del mercato tecnologico odierno:
domotica, assistenti a interfacce vocali, software e servizi
basati su algoritmi
predittivi, smartphone sempre più smart,
sensori ovunque e l’internet delle cose che parlano tra loro
senza disturbare
gli umani. Ma l’incontro tra robot e umani oggi sembra davvero
dietro l’angolo e non è più solo uno scenario narrativo.
L’immaginario collettivo influenza il marketing così come il
marketing influenza il design degli artefatti industriali.
Tecnica e
narrazione finiscono con l’associarsi non solo per
rappresentare ma anche per creare. Si prenda ad esempio quella
clamorosa convergenza tra
fantascienza ed elettronica di consumo che è l’automobile a
guida autonoma (cfr. Wikipedia): di “automobili fantasma”
(cfr.
Lafrance, 2016) si comincia a parlare negli anni Venti del
secolo scorso; oggi appare evidente come la nostra percezione
in materia si stia spostando
lentamente ma inesorabilmente dalla finzione alla realtà.
Categorie tecnico-economiche che diventano forme
dell’immaginario. E viceversa.
Allora se, con Erik Davis, possiamo dire che tecnologia e
immaginario si riflettono e alimentano reciprocamente (cfr.
Davis, 2001) la convivenza
conflittuale tra synthe umani è l’ennesima mappa
fantascientifica utile a mostrarci i punti in cui il mostro di
Frankenstein
potrebbe liberarsi generando una nuova umanità con nuovi patti
sociali e nuove forme di convivenza civile. Bene patrimoniale
da preservare o
minaccia per la forza lavoro umana? E, ancora più in
profondità sul versante antropologico, cosa implica il fatto
di affidare mansioni
sempre più importanti alle intelligenze artificiali?
L’umanità è sotto
attacco. Nella serie britannica Humans (due stagioni
e
una terza all’orizzonte), ideata da Sam Vincent e Jonathan
Brackley, c’è un gruppo di robot atipici che cerca
un’esistenza
piena al di fuori degli schemi imposti dai creatori; Humans
è stata tratta una precedente serie tv svedese, Real
Humans
(2012-2014), ideata da Lars Lundström. Il contesto è una
società in cui la disponibilità di forza-lavoro androide (i
synth) diventa un dato di fatto con notevoli
conseguenze. L’attualità della serie deriva dalla vicinanza al
mondo dei consumi
reali, ai settori trainanti del mercato tecnologico odierno:
domotica, assistenti a interfacce vocali, software e servizi
basati su algoritmi
predittivi, smartphone sempre più smart,
sensori ovunque e l’internet delle cose che parlano tra loro
senza disturbare
gli umani. Ma l’incontro tra robot e umani oggi sembra davvero
dietro l’angolo e non è più solo uno scenario narrativo.
L’immaginario collettivo influenza il marketing così come il
marketing influenza il design degli artefatti industriali.
Tecnica e
narrazione finiscono con l’associarsi non solo per
rappresentare ma anche per creare. Si prenda ad esempio quella
clamorosa convergenza tra
fantascienza ed elettronica di consumo che è l’automobile a
guida autonoma (cfr. Wikipedia): di “automobili fantasma”
(cfr.
Lafrance, 2016) si comincia a parlare negli anni Venti del
secolo scorso; oggi appare evidente come la nostra percezione
in materia si stia spostando
lentamente ma inesorabilmente dalla finzione alla realtà.
Categorie tecnico-economiche che diventano forme
dell’immaginario. E viceversa.
Allora se, con Erik Davis, possiamo dire che tecnologia e
immaginario si riflettono e alimentano reciprocamente (cfr.
Davis, 2001) la convivenza
conflittuale tra synthe umani è l’ennesima mappa
fantascientifica utile a mostrarci i punti in cui il mostro di
Frankenstein
potrebbe liberarsi generando una nuova umanità con nuovi patti
sociali e nuove forme di convivenza civile. Bene patrimoniale
da preservare o
minaccia per la forza lavoro umana? E, ancora più in
profondità sul versante antropologico, cosa implica il fatto
di affidare mansioni
sempre più importanti alle intelligenze artificiali?
Leggi tutto
Miguel Martinez: Picco d’Algeria
Picco d’Algeria
di Miguel Martinez
Tutto preso dal mio microcosmo fiorentino, trovo utile pensare un po’ più in grande.
L’Algeria è al 90% deserto.
Il resto è stato coltivato per secoli con metodi tradizionali che rendevano poco, ma conservavano il suolo e i boschi.
L’arrivo degli europei nell’Ottocento ha portato alla distruzione dei boschi e all’erosione del suolo; e oggi il deserto avanza implacabile verso nord.
Però ci sono gas e petrolio, che sono la base degli introiti dello Stato.
Con questi introiti, lo Stato concede la preziosa valuta estera a una clientela di “imprenditori”, cioè di importatori che poi investono i loro guadagni all’estero; e mantiene il bastone – esercito e polizia – e la carota: istruzione e cure mediche gratuite, sovvenzioni ai prezzi dei carburanti e del cibo.
Qualche anno fa, una bottiglia di acqua minerale costava il doppio di un litro di benzina, e l’acqua minerale – con il contorno relativo di bottigliette di plastica – è un bene primario in un paese in cui molti diffidano della qualità dell’acqua che esce dal rubinetto.
La popolazione però è aumentata in mezzo secolo da 10 milioni di abitanti a oltre 40 milioni.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Logopedia liberista
Logopedia liberista
di ilsimplicissimus
Un amico di fb mi ha segnalato proprio questa mattina un gustoso episodio che risale a ieri o all’altro ieri: in un quiz della Rai c’era una domanda definita come di italiano nella quale si domandava che significato avesse in origine la parola inglese “gang” che peraltro è sempre meno usata: era una domanda insomma di filologia germanica che non ha nulla a che vedere con la nostra lingua, ma piuttosto con l’ossessione anglofona di un Paese disperso come nel primo coro dell’Adelchi, che viene perfettamente riprodotta e suggerita dalla televisione di stato e di famiglia, ancora ben lontana da essere una televisione pubblica. Certo ad autori formatisi alla dura scuola dell’uomo ragno e dei puffi, consumati dalla diuturna meditazione su ” forse non tutti sanno che”, è sfuggito che avrebbero potuto porre un quesito corretto e molto più interessante chiedendo se l’italiano ganga e ghenga derivassero dall’inglese gang. La risposta è no derivano tutti dalla radice germanica gangan (tedesco gehen), da noi giunta con i longobardi, ovvero “andare” o camminare che ha acquisito significati diversi nei vari contesti storici e culturali. Bene soddisfatta la mia pignoleria che serve a placare i miei istinti omicidi dopo aver sentito su radio classica citare John Sibastian Bec a testimonianza del fatto che non solo trascuriamo la lingua con cui parliamo o balbettano le generazioni più recenti, ma deformiamo tutti sul calco di quelli che consideriamo i padroni.
Leggi tutto
Silvia Guerini: Xenofemminismo. L’aberrazione è già qui
Xenofemminismo. L’aberrazione è già qui
di Silvia Guerini
Le ideologie del cyborg, del trans-xeno-femminismo queer dalle polverose stanze accademiche dove sono nate si stanno diffondendo in contesti anarchici, antispecisti, femministi.
Ideologie figlie di questi tempi postmoderni, senza memoria, alienati e biotecnologici, fatti di attivismo virtuale, di pornoattivismo accademico e di rivoluzioni a ormoni che passano attraverso la trasformazione delle lavatrici in sex toys per arrivare alla toilette. Idee, pratiche e rivendicazioni che vorrebbero presentarsi alternative e sovversive, quando corrono perfettamente allineate a questo sistema tecno-scientifico abbracciando logiche di dominio e aspirazioni transumaniste.
Dal libro “Xenofemminismo” di Helen Hester emergono molte fobie.
Una fobia del corpo che diventa una “tecnologia da hackerare”, una “piattaforma rielaborabile”, “un’entità malleabile e modellabile” in cui le biotecnologie possono offrire nuove possibilità.
Una fobia della natura, “Se la natura è ingiusta, cambiala!” è il nuovo slogan xenofemminista, quando il problema non è la natura da cambiare, ma un sistema da stravolgere. La crisi ecologica in atto mette in evidenza proprio l’indispensabilità del mondo naturale e l’impossibilità di sostituirne o di artificializzarne i processi.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Bonne Chance, Buona Fortuna al Sahel
![]()
Bonne Chance, Buona Fortuna al Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, marzo 2019. Era fermo da due giorni sulla strada. Il vecchio camion pieno zeppo di legna da ardere ha avuto un guasto meccanico e si trovava in bilico tra due corsie della strada che porta alla rotonda della Francofonia di Niamey. Asfaltata da ambo i lati detta strada è molto frequentata specie nelle ore di punta. Dietro al camion bianco e verde hanno scritto a mano con la vernice rossa ‘Bonne Chance’. Di ‘Buona Fortuna’ nel Sahel ne abbiamo proprio bisogno. I camion che trasportano tonnellate di legna, in primo luogo e le persone in priorità. In attesa della riparazione, come di consueto, i giovani apprendisti, stesi su distinte stuoie sotto il camion, stavano riposando e forse sognando un TIR nuovo di zecca. Bonne Chance ai numerosi e stanchi camion che provvedono i ristoranti e le famiglie della capitale di legna per arrostire la carne lungo le strade, di sera. Il taglio degli alberi favorisce la tanto temuta desertificazione della savana che circonda la città e si avventura verso la frontiera con Burkina Faso. I camion e gli asini, ognuno con la propria identità, assicurano quotidianamente la legna per la sopravvivenza culinaria della città. Ci sarebbe anche il gas, come alternativa possibile ma è caro, spesso introvabile e comunque inadatto alla cottura della carne ovina e bovina. Bonne Chance, così come gli altri camion, viaggia per la pratica e soprattutto perchè conosce le strade della città a memoria.
Leggi tutto
Hits 2776
Hits 2772
Hits 2458
Hits 2380
Hits 2319
Hits 2238
Hits 2150
Hits 2106
Hits 2019
Hits 1987
tonino

Vincenzo Russo: La globalizzazione democratica di Rodrik
La globalizzazione democratica di Rodrik
di Vincenzo Russo
Nel suo nuovo saggio l'economista sviluppa le idee elaborate in questi ultimi anni e formula una serie di proposte per tentare di conciliare il ruolo dello Stato nazionale, che considera tutt'altro che esaurito, con un'economia per cui i confini non hanno più significato
 La tesi principale del libro è che
gli Stati nazionali hanno ancora un ruolo da giocare
specialmente in termini di
giustizia sociale, riduzione delle diseguaglianze e protezione
dei diritti dei lavoratori. Devo dire che prima di leggere il
lavoro di Rodrik ero
convinto del contrario specialmente con riguardo alla
posizione dei paesi membri dell’Unione europea. Dopo attenta
meditazione sulle sue
argomentazioni, tendo a convergere con la sua posizione. Il
motivo è presto detto: intanto la globalizzazione degli ultimi
decenni non è
stata ben governata e la finanza rapace ha fatto il bello e il
cattivo tempo. La globalizzazione implica una
verticalizzazione del processo
decisionale che per funzionare bene comporterebbe una riforma
delle istituzioni sovranazionali. In assenza di detta riforma
non si può contare
su di esse per garantire a livello globale il rispetto dei
diritti fondamentali, un livello essenziale di giustizia
sociale, la libertà di
movimento dei cittadini in cerca non solo delle libertà che
sono loro negate nei paesi dove sono nati ma anche il diritto
a migliorare il loro
benessere emigrando.
La tesi principale del libro è che
gli Stati nazionali hanno ancora un ruolo da giocare
specialmente in termini di
giustizia sociale, riduzione delle diseguaglianze e protezione
dei diritti dei lavoratori. Devo dire che prima di leggere il
lavoro di Rodrik ero
convinto del contrario specialmente con riguardo alla
posizione dei paesi membri dell’Unione europea. Dopo attenta
meditazione sulle sue
argomentazioni, tendo a convergere con la sua posizione. Il
motivo è presto detto: intanto la globalizzazione degli ultimi
decenni non è
stata ben governata e la finanza rapace ha fatto il bello e il
cattivo tempo. La globalizzazione implica una
verticalizzazione del processo
decisionale che per funzionare bene comporterebbe una riforma
delle istituzioni sovranazionali. In assenza di detta riforma
non si può contare
su di esse per garantire a livello globale il rispetto dei
diritti fondamentali, un livello essenziale di giustizia
sociale, la libertà di
movimento dei cittadini in cerca non solo delle libertà che
sono loro negate nei paesi dove sono nati ma anche il diritto
a migliorare il loro
benessere emigrando.
Si tratta quindi di una soluzione di second best che non va condannata come tale ma di prendere atto che allo stato non è disponibile quella di first best. E chi sa quanto tempo bisogna ancora attendere prima di riuscire a costruirla. Come sappiamo, a livello sovranazionale, non ci sono parlamenti regolarmente eletti. E se ci sono come nell’Unione europea, ciò non significa che hanno l’ultima parola in materia di politiche sociali e redistributive. Ci sono tecnocrazie nominate da alcuni governi che non esprimono necessariamente gli interessi delle fasce più deboli dei paesi membri. Per le istituzioni sovranazionali si parla di governance e non di organismi pienamente democratici. Nel massimo organo decisionale delle Nazioni Unite il potere è concentrato nel Consiglio di sicurezza composto da cinque membri permanenti e da dieci temporanei.
Leggi tutto
Damiano Palano: Ernesto Laclau e i misteri del "politico"
Ernesto Laclau e i misteri del "politico"
A cinque anni dalla scomparsa del teorico argentino
di Damiano Palano
A cinque anni dalla morte di Ernesto Laclau, scomparso prematuramente il 13 aprile 2014 a Siviglia, Maelstrom ne ripropone questo ricordo, che allora venne pubblicato sul sito dell'Istituto di Politica
 L’improvvisa scomparsa
di Ernesto Laclau, avvenuta il 13 aprile scorso a causa di un
attacco cardiaco, priva la
teoria politica contemporanea di uno dei suoi più originali
protagonisti. Anche se in Italia la riflessione di Laclau ha
iniziato solo da pochi
anni a essere conosciuta e discussa, le sollecitazioni che lo
studioso argentino ha sottoposto alla discussione teorica
hanno avuto un ruolo
fondamentale nel riportare al centro il nodo del ‘politico’ e
della sua autonomia. E anche se la proposta delineata da
Laclau ha
incontrato nel corso del tempo critiche spesso molto dure, la
sua operazione di ‘decostruzione’ della categorie teoriche del
marxismo
rimane senza dubbio un punto essenziale per la riflessione
contemporanea, così come la teoria del populismo, precisata
nei suoi contorni
nell’ultimo decennio, ma elaborata nel corso di un’intera
carriera di studio.
L’improvvisa scomparsa
di Ernesto Laclau, avvenuta il 13 aprile scorso a causa di un
attacco cardiaco, priva la
teoria politica contemporanea di uno dei suoi più originali
protagonisti. Anche se in Italia la riflessione di Laclau ha
iniziato solo da pochi
anni a essere conosciuta e discussa, le sollecitazioni che lo
studioso argentino ha sottoposto alla discussione teorica
hanno avuto un ruolo
fondamentale nel riportare al centro il nodo del ‘politico’ e
della sua autonomia. E anche se la proposta delineata da
Laclau ha
incontrato nel corso del tempo critiche spesso molto dure, la
sua operazione di ‘decostruzione’ della categorie teoriche del
marxismo
rimane senza dubbio un punto essenziale per la riflessione
contemporanea, così come la teoria del populismo, precisata
nei suoi contorni
nell’ultimo decennio, ma elaborata nel corso di un’intera
carriera di studio.
La carriera accademica di Laclau si svolse quasi esclusivamente all’interno del mondo universitario britannico (e in special modo all’Università di Essex, dove insegnò Teoria politica dal 1973 e dove diresse il Center for Theoretical Studies in Humanities and Social Sciences dal 1990 al 1997), ma lo studioso argentino conservò sempre un legame molto stretto con il paese d’origine. La sua riflessione teorica può infatti essere considerata come un tentativo di comprendere un fenomeno – indecifrabile con le categorie politiche del Vecchio continente – come il «peronismo». Tanto che, per molti versi, tutta la sua ricerca intellettuale può essere considerata come un tentativo di rispondere a quei problemi – teorici e politici – in cui Laclau si era imbattuto negli anni della sua militanza giovanile nel movimento socialista argentino.
Nato nel 1935, Laclau aderì infatti già nel 1958 al Partido Socialista Argentino (Psa), assumendo anche un ruolo di leadership all’interno della componente di sinistra del movimento studentesco dell’Università di Buenos Aires. Nel 1963 entrò nel Partito Socialista de la Izquierda Nacional (Psin), un partito di orientamento trotzkista guidato da Jorge Abelardo Ramos, e proprio all’interno di questo gruppo Laclau assunse un ruolo politico di primo piano, anche perché gli venne affidata la direzione del settimanale «Lucha Obrera», oltre che della rivista teorica, «Izquierda Nacional».
Leggi tutto
Moreno Pasquinelli: La distopia della "Confederazione europea
La distopia della "Confederazione europea
di Moreno Pasquinelli
 Premessa
Premessa
Non fu solo perché il campo del "sovranismo" era oramai saldamente colonizzato dalle destre nazionaliste-xenofobe che noidecidemmo un anno fa di definirci sinistra patriottica — spiegammo quindi cosa ciò significhi per noi.
Un sintagma, quello di sinistra patriottica, dirimente, e non solo dal lato di quelli che ci considerano "rossobruni" (poiché impugniamo la questione della sovranità nazionale), lo è pure nell'area della variopinta sinistra-più-o-meno-no-euro. Questa sinistra, al netto di tutto il resto, è infatti divisa. Ci sono al suo interno, non vi sembri un paradosso, non solo quelli che considerano oramai obsoleta e fuori corso la dicotomia sinistra-destra —avemmo modo anni addietro di spiegare perché non lo fosse affatto—; ci sono coloro che hanno del tutto rimosso la centralità della sollevazione popolare — senza la quale secondo noi non ci si libererà da un bel niente e la riconquista piena della sovranità nazionale e democratica è una chimera. Ci sono infine coloro i quali, alla domanda "cosa proponete al posto dell'Unione europea?", rispondono: "una "Confederazione europea di stati sovrani". Proveremo a spiegare perché quella della "Confederazione europea" è una distopia, un miraggio, quindi uno slogan politico deviante.
Cos'è una confederazione?
Cos'è infatti una Confederazione? ce ne sono mai state? E se sì, che fin han fatto?
Così l'Enciclopedia UTET:
«Confederazione, unione organizzata permanente di stati, avente lo scopo della comune difesa esterna dei membri e del mantenimento della pace fra essi. Questa Unione, a differenza dello stato federale, che è un'unione di diritto interno, è un'unione di diritto internazionale, costituita cioè in base a norme di diritto internazionale, poste da un trattato o patto confederale, il quale costituisce il fondamento dell'unione. Ogni confederazione si costituisce fra un gruppo di stati confinanti, aventi interessi comuni nel campo dell'attività internazionale».
Leggi tutto
Fulvio Scaglione: La Libia è persa: il mondo sta con Haftar e l’Italia è rimasta sola e dalla parte sbagliata
La Libia è persa: il mondo sta con Haftar e l’Italia è rimasta sola e dalla parte sbagliata
di Fulvio Scaglione
Il premier Giuseppe Conte incontra il ministro degli Esteri del Qatar per discutere dell'offensiva del generale Haftar in Libia. Ma non servirà a nulla perché l'Italia non sa qual è il suo posto nel mondo. Oscilla sempre tra velleità e timidezza, ambizione e provincialismo
Oggi il premier Giuseppe Conte, incontra il vicepremier e ministro degli Esteri del Qatar, Bin Abdulrahman al-Thani, per discutere della situazione in Libia e dell’offensiva che il generale Haftar sta conducendo contro il Governo che ha sede a Tripoli ed è guidato da Fayez Al-Sarraj. Quella del nostro governo è una mossa non solo legittima, ma doverosa: il Qatar è uno dei molti Paesi che, come l’Italia, hanno sottoscritto il Piano d’azione per la Libia presentato dall’Onu, sia nella versione originale del settembre 2017 sia in quella arricchita ed emendata in occasione della Conferenza di Palermo del dicembre 2018. Piano a suo tempo approvato anche dagli Usa, dall’Unione Europea e da gran parte dei governi che formano la cosiddetta comunità internazionale. E che poggia su una precisa indicazione: nel gran marasma libico, quella di Al-Sarraj è l’unico governo legittimo. Provvisorio, perché di riconciliazione nazionale, ma legittimo. Tutto bene, quindi? No, tutto male. Gli eventi sul terreno raccontano ben altra storia.
Il generale Haftar continua imperterrito l’offensiva. La sua presa sulla Libia, che già comprende la Cirenaica e il Fezzan, si allarga di giorno in giorno.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Libertà in estradizione
Libertà in estradizione
di ilsimplicissimus
L’ipocrisia è senza fine, così come la menzogna e la capacità di auto assoluzione di un sistema marcio e dei suoi narratori ufficiali. Julian Assange uno dei veri eroi del nostro tempo e non uno dei tanti pupazzi con cui ci tengono artificialmente allo stato infantile, è stato alla fine arrestato con il cavillo di furto di informazioni in un computer che oltre ad essere legalmente efficace permette di eludere il problema della libertà di stampa. La polizia britannica ha invaso il territorio diplomatico dell’Ecuador , pienamente consenziente dopo aver gettato a mare lo status di asilo e ha sbattuto in carcere il fondatore di Wikileaks: due stati vassalli hanno collaborato per obbedire agli ordini di Washington. E’ l’atto con cui culminano sette anni di bugie e di nascondimenti, ma anche quello con cui va in pezzi la pretesa di libertà di informazione che l’occidente custodisce esattamente come una reliquia: qualcosa che ha un valore solo come immaginario.
E del resto il comportamento della stampa fra noi evoluti consumatori di caramelle per poi essere violentati di verità, è stato a suo modo esemplare facendo da megafono alle ridicole accuse sulla presunta violenza in Svezia di due indefinibili ragazzotte a ore, ignorando o minimizzando il fatto che Assange era già stato precedentemente scagionato dall’accusa dagli stessi investigatori che seguivano il caso o che lo stesso si era detto pronto ad essere interrogato dai procuratori svedesi a Londra, come era successo in dozzine di altri casi riguardanti procedimenti di estradizione in Svezia.
Leggi tutto
Viola Di Grado: Dio non risponde, e nemmeno la Storia ci sente troppo bene
Dio non risponde, e nemmeno la Storia ci sente troppo bene
di Viola Di Grado
Città segrete, periferie ai margini del mondo assenti dalle carte geografiche, la cui esistenza deve essere negata. Sono i luoghi dove la Storia ha fallito più che altrove e le catastrofi ecologiche provocate dal sistema impietoso dei profitti che regola i destini dei popoli, producono il loro frutto malato da tenere nascosto. Per vergogna, per ragioni di convenienza politica, per mettere a tacere le coscienze. La storia di questo romanzo racconta un fatto vero di cronaca e si svolge nella Russia siberiana a Musljumovo, un minuscolo ‘villaggio al confine di tutto’ nel cui fiume, il Techla, furono sversate tonnellate di scorie radioattive. Paradigma di ogni luogo in cui scelte non ce ne sono e si crepa così o niente, nel villaggio di Musljumovo lo sguardo di ciascun abitante si adatta all’orrore in modo da non vederlo, una disperata strategia di sopravvivenza dove la fame di vita delle persone resiste a costo di rendersi ‘complici del contagio’. E che cosa può fare Tamara, giovane insegnante di scienze, sguardo razionale e coscienza vigile che invece vede lucidamente tutto quello che per gli altri ‘diventa normalità’? Cosa può fare se non sostituire l’immaginazione alla paura e alla verità, diluire il suo disgraziato bisogno d’amore sballandosi in una discoteca dove ‘ballare è un modo di stare un po’ vivi in mezzo al male’? Anestetizzando ogni desiderio d’amore e di progetto nell’eucaristia del suo corpo offerto a chiunque in occasioni di sesso compulsivo?
Leggi tutto
comidad: La meridionalizzazione avanzante
La meridionalizzazione avanzante
La lobby della deflazione e le sue colonie deflazionistiche
di comidad
Nelle trattative per la cosiddetta “Brexit” l’Unione Europea ha tenuto la faccia feroce per imporre al Regno Unito le più onerose condizioni di uscita. Il risultato è che oggi il gioco delle parti tra il governo ed il parlamento britannico tiene l’UE sotto scacco. Ciò a dimostrazione che il vero “instrumentum regni” dell’UE è la moneta unica e che i Paesi non aderenti all’area-euro possono, in definitiva, fare ciò che gli pare. Ciò vale per l’ancora potente Regno Unito ma anche per le deboli Polonia e Ungheria.
Uno degli effetti della Brexit è l’aver cancellato una delle maggiori prospettive di sbocco migratorio per le giovani generazioni italiane. Ragazzi allevati all’insegna di “Erasmus” e della “cittadinanza europea” avevano visto nell’Inghilterra una meta ideale a cui aspirare, tanto più in un periodo in cui la persistente deflazione è diventata un incentivo a fuggire dall’Italia. Rimane la Germania come meta migratoria, ma non esercita lo stesso fascino dell’Inghilterra e la lingua non è un ostacolo da poco.
A ben vedere, quindi anche i programmi scolastici avevano già incorporato il destino pauperistico e recessivo dell’Italia, molto prima che la deflazione si manifestasse nei termini più virulenti.
Leggi tutto
Gianfranco Greco: La gestione dei flussi migratori come fattore di stabilizzazione al ribasso del valore della forza–lavoro e di divisione del proletariato
La gestione dei flussi migratori come fattore di stabilizzazione al ribasso del valore della forza–lavoro e di divisione del proletariato
di Gianfranco Greco
 “Trattiamo bene la terra perché essa non
ci è stata lasciata dai nostri Padri, ma ci è sta data in
prestito dai nostri Figli“ (proverbio indiano)
“Trattiamo bene la terra perché essa non
ci è stata lasciata dai nostri Padri, ma ci è sta data in
prestito dai nostri Figli“ (proverbio indiano)
L’immigrazione, fenomeno inarrestabile e incontrollabile
Ben al di là di tutte le analisi portate avanti, delle teorizzazioni che sottendono a tali analisi, delle prese di posizione le più variegate, i pregiudizi innalzati come barricate con annesso corollario di xenofobia e razzismo, ad imporsi è un’unica lettura della realtà, quella che parla di una immigrazione incontrollabile e, in quanto tale, di un fenomeno inarrestabile.
Soltanto partendo da questa ineludibile constatazione si può far da argine ad un pensiero mainstream omologato e tarato o sui farfugliamenti di chi elabora soluzioni transitorie che, come tali, non possono che produrre effetti irrisori senza scalfire minimamente le criticità reali o rinfocolare contrapposizioni a carattere nazionalistico, xenofobo, razziale che altro non rappresentano se non quel processo di imbarbarimento e di degrado che accompagnano la crisi del sistema capitalistico internazionale.
Per essere ancor più chiari: finchè il capitalismo non verrà superato e non ci sarà, quindi, un totale ribaltamento di prospettiva il fenomeno dell’immigrazione permarrà come fenomeno inestricabile in quanto generato esso stesso da un sistema criminale che vede, tra le sue tante ed irrefutabili manifestazioni, una povertà sempre più diffusa a livello planetario, ripugnanti forme di schiavitù, la cappa sempre più soffocante di una guerra permanente con la quale milioni di persone condividono la loro quotidianità.
Una emigrazione massiccia e disordinata diventa quindi la sola via di fuga da livelli di violenza – in tutte le sue sfaccettature: guerre, dittature, terrorismo, condizioni climatiche e catastrofi varie - senza precedenti generando quell’afflusso di esseri umani disperati che già dai primi anni 2000 avevano indotto, secondo quanto scrive l’ex diplomatico italiano Enrico Calamai “ i paesi dell’Unione europea e della Nato ad includere l’arrivo in massa di migranti e richiedenti asilo nell’elenco dei pericoli da affrontare, alla pari del terrorismo, proliferazione nucleare e cyberwar, e gli effetti destabilizzanti che possono derivarne.”[i]
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Milosevic, l'ultima intervista prima dell'arresto
Milosevic, l'ultima intervista prima dell'arresto
di Fulvio Grimaldi
Molti, dopo l'ultimo mio post sul XX anniversario dell'aggressione Nato alla Serbia, mi chiedono di ripubblicare l'intervista che feci a Milosevic il 25 marzo 2001, nella sua abitazione, pochi giorni prima del suo arresto e del successivo trasferimento nel carcere dell'Aja. Eccola. L'intervista fu rifiutata da "Liberazione", con il pretesto che avrebbe "appiattito il giornale e il partito (PRC) su Milosevic". La pubblicò poi il Corriere della Sera. E' lunga, ma ne vale la pena ed è per la Storia
 L'appuntamento con Slobodan
Milosevic ricorda quelli che ho avuto ripetutamente con Yasser
Arafat: assoluta incertezza sul luogo e sui
tempi dell'incontro fino alle 19 di venerdì sera, mentre mi
accingevo a partire per Kragujevac per intervistare i
dirigenti del sindacato di
sinistra che hanno appena registrato una sorprendente,
schiacciante vittoria sul sindacato vicino al nuovo potere,
nelle elezioni per il rinnovo dei
dirigenti sindacali della fabbrica automobilistica Zastava. In
quel preciso momento arriva l'ex.ministro degli esteri e oggi
vicepresidente del
Partito Socialista Serbo, Zivedin Jovanovic, del quale pure
era stato annunciato l'arresto, poi smentito, insieme a
quello, effettivo, di otto alti
dirigenti del partito. Vengo portato di gran carriera alla
residenza dell'ex-presidente e nel tragitto Jovanovic esprime
il timore che tutti questi
arresti e una feroce campagna contro Milosevic, allestita dal
movimento giovanile del premier Zoran Djindjic, le "Camicie
Nere", insieme
all'organizzazione Otpor, rivendicata dagli USA come proprio
strumento insurrezionale, stiano cercando di fare il vuoto
intorno a Milosevic, in vista
dell'arresto entro il 31 marzo, intimato da Washington pena il
rifiuto di qualsiasi finanziamento e il mantenimento delle
sanzioni. Passati per la
cancellata della residenza, nella periferia di Belgrado,
attraversiamo un ampio parco, fortemente illuminato e
presidiato da militari dell'esercito e
da carri armati che mi dicono posti a difesa di Milosevic,
contro un qualche colpo di mano che voglia arrivare alla sua
cattura.
L'appuntamento con Slobodan
Milosevic ricorda quelli che ho avuto ripetutamente con Yasser
Arafat: assoluta incertezza sul luogo e sui
tempi dell'incontro fino alle 19 di venerdì sera, mentre mi
accingevo a partire per Kragujevac per intervistare i
dirigenti del sindacato di
sinistra che hanno appena registrato una sorprendente,
schiacciante vittoria sul sindacato vicino al nuovo potere,
nelle elezioni per il rinnovo dei
dirigenti sindacali della fabbrica automobilistica Zastava. In
quel preciso momento arriva l'ex.ministro degli esteri e oggi
vicepresidente del
Partito Socialista Serbo, Zivedin Jovanovic, del quale pure
era stato annunciato l'arresto, poi smentito, insieme a
quello, effettivo, di otto alti
dirigenti del partito. Vengo portato di gran carriera alla
residenza dell'ex-presidente e nel tragitto Jovanovic esprime
il timore che tutti questi
arresti e una feroce campagna contro Milosevic, allestita dal
movimento giovanile del premier Zoran Djindjic, le "Camicie
Nere", insieme
all'organizzazione Otpor, rivendicata dagli USA come proprio
strumento insurrezionale, stiano cercando di fare il vuoto
intorno a Milosevic, in vista
dell'arresto entro il 31 marzo, intimato da Washington pena il
rifiuto di qualsiasi finanziamento e il mantenimento delle
sanzioni. Passati per la
cancellata della residenza, nella periferia di Belgrado,
attraversiamo un ampio parco, fortemente illuminato e
presidiato da militari dell'esercito e
da carri armati che mi dicono posti a difesa di Milosevic,
contro un qualche colpo di mano che voglia arrivare alla sua
cattura.
Sull'uscio di un fabbricato a un piano, l'ex-presidente jugoslavo mi viene incontro e mi saluta con cordialità. Vengo introdotto in un ampio salone di stile neoclassico, con al centro tre divani a ferro di cavallo. Milosevic si siede su quello centrale, con me e Jovanovic ai due lati. Chiede di non utilizzare apparecchi di registrazione e insiste che questa è una conversazione e non un'intervista. Ma mi consente di pubblicarla.
Leggi tutto
Ivan Cavicchi: La sanità, il Movimento 5 Stelle e il rischio privatizzazione
La sanità, il Movimento 5 Stelle e il rischio privatizzazione
di Ivan Cavicchi
 Chi ha votato per questo movimento di certo non
l’ha fatto per fare il
gioco delle assicurazioni e degli speculatori e meno che mai
per farsi rubare da costoro i propri diritti. Da nessuna parte
del programma di governo
sta scritto che bisogna far fuori il Ssn e sostituirlo con il
sistema multi-pilastro di berlusconiana memoria. Eppure…
Chi ha votato per questo movimento di certo non
l’ha fatto per fare il
gioco delle assicurazioni e degli speculatori e meno che mai
per farsi rubare da costoro i propri diritti. Da nessuna parte
del programma di governo
sta scritto che bisogna far fuori il Ssn e sostituirlo con il
sistema multi-pilastro di berlusconiana memoria. Eppure…
Non so se ricordate l’ultimo mio articolo, quello che, per rispondere al prof. Spandonaro, ho scritto la settimana scorsa, sulle mutue (QS 25 marzo 2019).
Sostenevo che sino ad ora la sinistra di governo (Letta, Renzi, Gentiloni) ha esitato a istituire la “seconda gamba” perché tra le varie cose che impedivano tale eventualità, c’era anche un “dilemma morale”, legato al fatto che fare un cambio di sistema avrebbe avuto pesanti conseguenze negative sulle persone più deboli, sull’acceso ai diritti, sulle diseguaglianze.
Una ingenua speranza
In cuor mio speravo, confesso la mia ingenuità, che con un ministro 5 stelle, la possibilità di un ribaltone del genere, fosse improbabile anche se, con un inciso nel mio articolo non escludevo la possibilità, proprio con questo governo, che ciò potesse avvenire:
“Non escludo tuttavia che a un certo punto il “dilemma morale” possa essere superato proprio per disperazione finanziaria. Il rischio a cui andiamo incontro, a causa delle politiche ordinarie di questo anodino ministero della salute, è quello di acuire i problemi di sostenibilità del sistema esponendolo a crescenti gradi di privatizzazione”.
Ebbene questa possibilità, di superare il “dilemma morale”, esattamente per “disperazione finanziaria” in questi giorni è stata messa nero su bianco, da un ministro 5 stelle, nella bozza di Patto per la salute (d’ora in avanti “patto”).
Egli ha di fatto proposto alle regioni una intesa per ridiscutere il sistema universale e istituire la “seconda gamba”.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Rampini, Assange e la notte della sinistra
Rampini, Assange e la notte della sinistra
di Carlo Formenti
Da troppo tempo il capitale mondiale si è affidato ai servigi d’una sinistra che, ripudiato il classico ruolo di tutela degli interessi delle classi subalterne, si è schierata dalla parte dei potenti. Ora è il momento di sbarazzarsi di questi servi sciocchi che, per voler strafare, si sono sputtanati al punto da non poter più garantire legittimità al regime neoliberista. Allertate dal dilagare del populismo (“uno spettro che si aggira per l’Europa” lo ha definito il New York Times, parafrasando un detto di Marx) le élite dominanti sguinzagliano i migliori cervelli per escogitare alternative. Costoro suggeriscono due possibili soluzioni: da un lato, la cooptazione dei populismi di destra per investirli del ruolo di garanti della continuità del sistema, dall’altro, la ricostruzione di una sinistra social-liberale capace di riottenere il consenso popolare.
L’ultimo libro di Federico Rampini, noto corrispondente di “Repubblica” da New York (“La notte della sinistra”, Mondadori), inscrive l’autore fra i promotori della seconda soluzione. Il libro contiene una serie di feroci critiche nei confronti delle sinistre “fighette”, tali da far impallidire quelle che il sottoscritto ha rivolto contro lo stesso bersaglio (Vedi “Il socialismo è morto. Viva il socialismo”, Meltemi).
Leggi tutto
Norberto Fragiacomo: Licenza di informazione
Licenza di informazione
di Norberto Fragiacomo
E’ assurta in questi giorni agli onori della cronaca la preoccupante vicenda delle esplicite minacce rivolte, a mezzo lettera, al giornalista della RAI FVG Giovanni Taormina, “reo” di aver svolto inchieste sui loschi affari di ‘ndrangheta e mafia in regione. La notizia è stata data con grande risalto, scandalo e attestazioni di solidarietà non si sono fatti attendere: in prima fila le associazioni sindacali di categoria, ma pure il Presidente Fedriga e il suo vice Riccardi hanno condannato l’odioso episodio, manifestando la propria vicinanza al cronista.
Reazioni sacrosante e doverose: la libertà di informazione va sempre difesa, specie quando a metterla in pericolo sono organizzazioni criminali ramificate e senza remore a passare dai segnali ai fatti. Un caso, quello di Taormina, che si aggiunge a innumerevoli altri: nomi noti come Saviano e Federica Angeli sono solo la punta di un iceberg, nella cui parte sommersa ritroveremmo coraggiosi pubblicisti e, purtroppo, (per restare in Italia) qualche vittima non adeguatamente protetta in passato dal nostro Stato.
Solidarietà doverosa, dicevo: per molti, ma non per tutti. La foto dell’arresto di Julian Assange, trascinato fuori dall’ambasciata ecuadoregna a Londra da quattro energumeni in borghese sotto lo sguardo ghignante di un poliziotto, non mi risulta aver suscitato particolare indignazione né fra i “colleghi” né fra i politici occidentali – con lodevoli eccezioni, che rimangono però tali.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Poveri ma armati. Il Paese di sabbia si trova a metà classifica
![]()
Poveri ma armati. Il Paese di sabbia si trova a metà classifica
di Mauro Armanino
Niamey, aprile 2019. Siamo ultimi ma non dappertutto. Nel recente rapporto stilato dal sito statunitense Global Fire Power, Potere Globale di Fuoco, il Niger è classificato al numero 25 su 34 Paesi africani esaminati. Il sito americano, che prende in considerazione 50 parametri, classifica la capacità militare dei paesi esaminati, tenendo conto dell’appartenenza al primo, secondo e terzo mondo. Tra le altre cose prende in considerazione la diversità di armi, sospetta presenza di ami nucleari (con un bonus), la capacità logistica, il numero di militari in funzione e le spese militari. In Africa ce la caviamo abbastanza bene e ci troviamo non lontano da metà classifica. Poveri ma armati, consacriamo un buon 25 per cento del nostro bilancio statale per la difesa. Per il Presidente la sicurezza non ha prezzo. L’unico dubbio che permane è quello di sapere per chi è la sicurezza di cui si parla e per la quale si investono miliardi di franchi. In effetti, niente che il mese scorso, secondo un rapporto di OCHA, agenzia ONU che coordina gli aiuti umanitari nel Paese, i morti di civili sono stati 88. A questi si aggiungono i caduti delle Forze Armate e le persone scomparse senza lasciare traccia. Legittima dunque la domanda sul per CHI viene assicurata la sicurezza. Non certo e non sempre per i comuni cittadini o i contadini che vivono alle frontiere. Come per il Paese anche la sicurezza è di sabbia.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Vladimiro Giacché: Fine di un’epoca
Hits 2891
Hits 2827
Hits 2617
Hits 2436
Hits 2425
Hits 2404
Hits 2316
Hits 2288
tonino

Domenico Moro: Le contraddizioni del governo giallo-verde e del suo blocco sociale
Le contraddizioni del governo giallo-verde e del suo blocco sociale
di Domenico Moro
Relazione al convegno Eurexit, Roma 13 aprile
 La situazione politica europea risulta
profondamente mutata rispetto
soltanto a pochi anni fa. Anche se le modifiche sono
particolarmente evidenti in Italia, in quasi tutti i Paesi
dell’area euro si è
assistito alla crisi del sistema bipolare/bipartitico, che ha
caratterizzato l’assetto politico continentale per parecchi
decenni.
La situazione politica europea risulta
profondamente mutata rispetto
soltanto a pochi anni fa. Anche se le modifiche sono
particolarmente evidenti in Italia, in quasi tutti i Paesi
dell’area euro si è
assistito alla crisi del sistema bipolare/bipartitico, che ha
caratterizzato l’assetto politico continentale per parecchi
decenni.
I partiti europei afferenti alle due principali famiglie politiche continentali, quella dei popolari (Partito popolare europeo) e quella dei socialisti (Partito socialista europeo), hanno subito un declino più o meno grave. I voti sono andati in parte all’astensionismo, che è cresciuto a livelli quasi statunitensi, e in parte al cosiddetto populismo. Il termine di populismo, però, è a mio parere poco preciso e direi anche fuorviante, perché al suo interno sono comprese forze politicamente e ideologicamente in alcuni casi diverse tra loro, e con basi di massa e di classe anche diverse. Per questa ragione preferisco usare il termine di terze forze, ad indicare la loro terzietà rispetto al tradizionale bipolarismo/bipartitismo.
La crisi del bipartitismo è il risultato del combinato disposto della cosiddetta “stagnazione secolare” e dell’austerity imposta dall’Ue, che ha distrutto il compromesso tra capitale e classi subalterne che esisteva dal secondo dopoguerra. Va, però, sottolineato che non si tratta di effetti automatici dei rapporti di produzione, perché quella in atto è una riorganizzazione, soprattutto mediante l’integrazione europea, del sistema delle imprese (centralizzazioni proprietarie, riposizionamento su settori più profittevoli e internazionalizzazione della produzione), nonché della struttura sociale e del sistema politico. Queste trasformazioni vanno a colpire pesantemente, trasformandola, anche la composizione di classe della società italiana.
Classi e crisi
Ad essere colpito, si dice, è il cosiddetto ceto medio. Per la verità anche questo termine è ambiguo e portatore di confusione perché comprende al suo interno classi diverse che hanno una diversa collocazione all’interno della divisione del lavoro sociale – criterio cardine dell’appartenenza di classe.
Leggi tutto
Toni Negri: Sull'autonomia del politico di Tronti
Sull'autonomia del politico di Tronti
di Toni Negri
 Debbo
confessare il mio imbarazzo nel discutere questo volume di
scritti di Mario Tronti,
complessivo della sua vita di studioso e militante. Quando ero
giovane, non troppo tuttavia, attorno alla trentina, Mario
m’insegnò a
leggere Marx. Assunse molte responsabilità, facendolo – ed io
gliene sono ancora grato. A partire da questa lettura, mi
dedicai ad una
vita militante. Ma nel 1966, sei o sette anni dopo quell’incipit,
consegnandoci Operai e capitale, Mario ci lasciò
– non dico “mi” ma “ci”, perché nel frattempo erano divenuti
tanti gli “operaisti” presenti non solo
nelle università quanto, soprattutto, nelle grandi fabbriche
del nord Italia. Ci disse, nel 1966, che il decennio dei
Sessanta era finito prima
del suo termine e con esso il tempo dell’autonomia operaia,
che bisognava trovare un livello più alto per le lotte che
avevamo condotto e
conducevamo, che bisognava portare la lotta nel Partito
comunista italiano. Non era quello che già facevamo? Gli
rispondemmo. Non fummo
infatti, né allora né più tardi, insensibili al problema ed al
compito di sviluppare politicamente le lotte operaie. Il fatto
è che il Partito non lo gradiva affatto. Nel crescendo delle
lotte operaia che doveva condurci al ‘68/‘69, non capimmo
dunque
perché lasciare a se stessa l’autonomia delle lotte. Mario
disse allora che il ‘68 ci aveva definitivamente confuso.
Secondo lui,
avevamo preso per un’alba quello che invece era un tramonto.
Ma quale tramonto? Certo, si annunciava la fine dell’egemonia
dell’operaio-massa ma potevamo confonderla con quella della
lotta di classe proletaria? Nel prolungarsi durante tutti gli
anni ‘70 del
lungo ‘68 italiano, quella conversione di Mario non poteva
convincerci. Fu allora che smisi di leggere Tronti. Quando
questo volume mi
arrivò, mi accorsi che ne avevo già letto solo il primo terzo,
due terzi mi restavano da leggere.
Debbo
confessare il mio imbarazzo nel discutere questo volume di
scritti di Mario Tronti,
complessivo della sua vita di studioso e militante. Quando ero
giovane, non troppo tuttavia, attorno alla trentina, Mario
m’insegnò a
leggere Marx. Assunse molte responsabilità, facendolo – ed io
gliene sono ancora grato. A partire da questa lettura, mi
dedicai ad una
vita militante. Ma nel 1966, sei o sette anni dopo quell’incipit,
consegnandoci Operai e capitale, Mario ci lasciò
– non dico “mi” ma “ci”, perché nel frattempo erano divenuti
tanti gli “operaisti” presenti non solo
nelle università quanto, soprattutto, nelle grandi fabbriche
del nord Italia. Ci disse, nel 1966, che il decennio dei
Sessanta era finito prima
del suo termine e con esso il tempo dell’autonomia operaia,
che bisognava trovare un livello più alto per le lotte che
avevamo condotto e
conducevamo, che bisognava portare la lotta nel Partito
comunista italiano. Non era quello che già facevamo? Gli
rispondemmo. Non fummo
infatti, né allora né più tardi, insensibili al problema ed al
compito di sviluppare politicamente le lotte operaie. Il fatto
è che il Partito non lo gradiva affatto. Nel crescendo delle
lotte operaia che doveva condurci al ‘68/‘69, non capimmo
dunque
perché lasciare a se stessa l’autonomia delle lotte. Mario
disse allora che il ‘68 ci aveva definitivamente confuso.
Secondo lui,
avevamo preso per un’alba quello che invece era un tramonto.
Ma quale tramonto? Certo, si annunciava la fine dell’egemonia
dell’operaio-massa ma potevamo confonderla con quella della
lotta di classe proletaria? Nel prolungarsi durante tutti gli
anni ‘70 del
lungo ‘68 italiano, quella conversione di Mario non poteva
convincerci. Fu allora che smisi di leggere Tronti. Quando
questo volume mi
arrivò, mi accorsi che ne avevo già letto solo il primo terzo,
due terzi mi restavano da leggere.
Certo, anche se non lo leggevo, Tronti non era assente dal mio quotidiano. In maniera stizzosa, ad esempio, lessi in quegli anni un saggio di storia del pensiero politico moderno che Mario pubblicò allora e che, ad uno spinozista quale stavo diventando, parve parziale e non certo grato nell’esaltazione senza riserve che ivi era fatta della teoria hobbesiana del potere.
Leggi tutto
Edoarda Masi: Divagazioni intorno al 25° capitolo del I Libro del Capitale
Divagazioni intorno al 25° capitolo del I Libro del Capitale
di Edoarda Masi (1927 – 2011)*
Abstract: This paper deals with Marx’s theory of colonization. It is argued that – in constrast with E.G. Wakefield’s view – Marx proposed a complete a consistent approach to the role of colonization in the dynamics of capital reproduction. In particular, he emphasized the transformation of free men in “underdeveloped” economies into wage workers.
 1. Una lettura
1. Una lettura
Non riassumo il capitolo 25°, che è abbastanza breve e – mi sembra – di facile lettura. Marx è interessato a indagare come il capitale agisca sempre secondo la sua logica interna, e si propone qui di mostrare che nelle colonie si riproducono i suoi meccanismi fondamentali: specificamente, nella trasformazione di uomini liberi in salariati sfruttati. Per semplificare il discorso utilizza polemicamente un testo di E.G. Wakefield, un teorico della colonizzazione. Il discorso è chiaro e coerente, la sua logica incontestabile, una volta che si accettino i presupposti – per la verità non tutti accettabili (come quello che nelle terre da colonizzare il capitale trovi, all’inizio, liberi produttori).
Partire dal massimo livello di astrazione può valere contro la realtà storica? Al di là di questa logica, mi limiterò ad alcune osservazioni in certo senso fuori tema.
Quando Marx scrive queste righe, siamo in pieno Ottocento – il secolo nel corso del quale le terre emerse colonizzate degli europei passano dal 35% all’85%. È quanto meno singolare che un osservatore acuto (diciamo pure, un genio) come lui non si curi di questo evento macroscopico, una volta che abbia deciso di scrivere un capitolo sulla colonizzazione. Né si domandi per quali motivi tale fenomeno sia in corso, da dove parta e quali risultati produca nella madrepatria (cioè nel luogo centrale della sua indagine sul capitale).
Non solo. Come esempio di colonia sceglie gli Stati Uniti d’America, che da un pezzo hanno raggiunto l’indipendenza; anche se – come si precisa in nota – «economicamente parlando […] sono ancora terra coloniale dell’Europa».
Leggi tutto
Aldo Giannuli: La sovranità al tempo della globalizzazione
La sovranità al tempo della globalizzazione
di Aldo Giannuli
Nell’ondata di “politicamente corretto” che ci affligge, alcune parole come “sovranità”, “potere”, “forza”, suonano male e sono impronunciabili senza suscitare reazioni sdegnate nell’uditorio nutrito di pacifismo, non violenza, iper femminismo, ultra ecologismo, pensiero debole o, qualche volta, ultra debole.
Ricordo che durante la prima guerra del Golfo una mia collega di Facoltà se ne uscì con questa frase memorabile: “Dobbiamo pensare ad un uso del diritto non basato sulla forza”, risposi: “Bello! Cosa è il galateo?”. Il Diritto, per definizione è il sistema di norme dotate di potere cogente, piaccia o no. Il resto sono fesserie.
Questa melassa dolciastra ha prodotto il deperimento della cultura politica diffusa, a tutto vantaggio dello strapotere finanziario che, con la politica debole ci va a nozze.
Allora, riprendiamo contatto con la realtà, piedi per terra e recuperiamo le categorie del pensiero politico: “potere” non è una parolaccia, ma è un elemento necessario ed ineliminabile della vista sociale umana. Occorre che qualcuno assuma di volta in volta le decisioni politiche, economiche, giuridiche, sociali, culturali che occorrono alla società.
Produrre, distribuire, difendersi (o, se volete, attaccare), darsi un ordinamento giuridico eccetera, non sono cose che avvengono da sole come la pioggia.
Leggi tutto
coniarerivolta: Organizziamo la solidarietà internazionalista: nasce il Forum Venezuela
Organizziamo la solidarietà internazionalista: nasce il Forum Venezuela
di coniarerivolta
Riportiamo il nostro intervento di sabato 13 aprile in occasione della prima iniziativa pubblica del Forum Venezuela. A questo link un nostro contributo più approfondito sulla situazione economica del Venezuela, pubblicato nel nostro blog nei giorni più caldi del tentato golpe
Il Venezuela è da mesi sotto attacco da parte di varie fazioni della borghesia interna che, con l’evidente appoggio dei Paesi imperialisti (in primo luogo degli USA, in buona compagnia di una gran parte dei Paesi europei), e approfittando di una complessa situazione interna di crisi economica, cerca di dare una spallata al legittimo governo Maduro – democraticamente eletto e più volte confermato dalla maggioranza dei venezuelani. Non è la prima volta che la rivoluzione bolivariana subisce un attacco frontale da parte dei suoi nemici interni ed esterni, alleati in un blocco comune (si ricordi il celebre tentativo di golpe contro il governo Chavez, fallito del 2002). Questa volta però, sebbene il tentativo dell’ascaro Guaidó sembrerebbe ormai non riuscito, la situazione appare più grave e delicata, in particolare per lecritiche condizioni economiche del Paese che minano la stabilità sociale, rischiando di allontanare una parte dei settori popolari dall’appoggio, sinora forte e coriaceo, al processo rivoluzionario.
Oggi non può che essere il tempo dell’espressione schietta e immediata di un’incondizionata solidarietà verso un Paese che da ormai 20 anni sta portando avanti, malgrado tutti i suoi nemici interni e internazionali, un difficile percorso di transizione verso un modo di produzione assai diverso da quel capitalismo parassitario a base neo-coloniale che lo aveva caratterizzato fino alla vittoria dei partiti bolivariani del 1998.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Città e finanza: cosa insegna la vicenda dello stadio della Roma
Città e finanza: cosa insegna la vicenda dello stadio della Roma
di Alessandro Visalli
Partiamo da un dettaglio: la relazione del Dipartimento Trasporti del Politecnico di Torino, a firma del prof. Bruno dalla Chiara, poi integrata con prescrizioni in particolare sui collegamenti ferroviari, sembrerebbe fornire un quadro potenzialmente “catastrofico” (si veda p.35) dell’impatto viabilistico che gli eventi sportivi nello stadio avrebbero su un vasto intorno. Le problematiche, si legge, compaiono appena si consideri l’impatto di “macro area”, ovvero quello che si determina per arrivare o per andare via con mezzi propri dal quartiere di Tor di Valle. La rete primaria esistente, già sovraccaricata, non sarebbe in grado di sopportare senza gravi disfunzioni un nuovo attrattore di traffico di questa importanza e con tali caratteristiche specifiche. I disagi collettivi, ovvero la disfunzionalità urbana indotta, sarebbero quindi “abbondanti, capillari e distribuiti”, come si legge in particolare a pag.28, determinando una situazione “assolutamente non sostenibile da parte della viabilità”. Più in dettaglio, come si legge a pag.34, in assenza di altre azioni, si determinerebbe un “blocco pressoché totale della rete principale di connessione con la location Stadio”, ed anche se il 50% del traffico fosse gestito dal mezzo pubblico. Come affermano tali impatti di tipo “capillare” non possono essere risolti da interventi puntuali come il “Ponte dei Congressi” e dalla viabilità della sola via del mare/ostiense.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: La Regola di Gita porta il Colbertismo Competitivo in Europa
La Regola di Gita porta il Colbertismo Competitivo in Europa
di Giuseppe Masala
In questi giorni l'agenda istituzionale sulla politica economica è monopolizzata da un solo tema: il possibile aumento dell'IVA da parte del governo. Secondo la narrazione dominante la misura è dovuta alla necessità di mantenere i parametri di bilancio italiani nella traiettoria prevista dalle regole europee. Ma la partita potrebbe essere molto più importante rispetto a quanto ci vene raccontato.
In realtà secondo le alchimie degli economisti del FMI (e segnatamente della sua capo economista Gita Gobinath) l'IVA può essere la chiave di volta con la quale si reintroducono - per via fiscale - le svalutazioni monetarie competitive. Tema come si può capire di cruciale importanza all'interno della zona euro dove, per ovvie ragioni (l'introduzione della moneta unica), questo strumento è stato sterilizzato. Inutile sottolineare peraltro che nell'area, stante la mancanza di trasferimenti tra stati, sono di cruciale importanza gli squilibri di bilancia commerciale all'interno dell'area monetaria.
Venendo al dunque il meccanismo sarebbe il seguente: aumentando l'IVA ma contemporaneamente abbassando o il cuneo fiscale sul lavoro o abbassando altre tasse alle imprese si riesce ad evitare un aumento di prezzo dei beni.
Leggi tutto
Quattro interventi sul fenomeno "Greta"
![]()
Quattro interventi sul fenomeno "Greta"
In direzione ostinata e contraria
di Pierluigi Fagan
Sulla questione ecologia-Greta, mi trovo in dissenso profondo con molti amici ed amiche con i quali, di solito, si hanno punti di vista comuni. Che fare? Lasciar perdere per non sfilacciare ulteriormente le già sparute file del pensiero critico, o far di questo dissenso un momento di dialettica interna al nostro stesso pensiero critico? La domanda è retorica in tutta evidenza, la scelta è già fatta. Perché?
Ho l’impressione, forse sbaglio e chiedo in sincerità di dibattere la questione tra noi con la ponderazione ed intelligenza tipica dei frequentatori di questa pagina, che noi si sia finiti in un setting di pensiero la cui matrice per altri versi siamo molto lucidi a criticare. Per ragioni che qui non possiamo affrontare, ad un certo punto del secolo scorso, già ai suoi inizi, si è andata manifestando nel pensiero, uno spostamento di asse. Tra la relazione soggetto – oggetto fatta dal pensiero, è emerso il problema dello strumento che ci fa comporre e scambiare il pensiero: il linguaggio.
Tralasciamo i riferimenti più o meno colti e passiamo al momento successivo, quando un filosofo francese minore, pone all’attenzione la natura narrativa di ogni discorso, narrazioni fatte di linguaggio. Il linguaggio è materia della forma discorsiva che influisce, limita, indirizza il discorso stesso ed in più, tutto è discorso. Penso nessuno possa sottovalutare l’importanza di queste osservazioni ormai patrimonio della nostra conoscenza. Per altro ci era già arrivato anche Eraclito, e non solo lui, qualche secolo fa.
Danno da pensare due cose. La prima è il venirsi a formare di una sorta di monopolio concettuale di questo fatto, tutti ormai parlano più o meno solo di questo, tutto è narrazione e contro-narrazione.
Leggi tutto
coniarerivolta: Il sindacato complice
Il sindacato complice
di coniarerivolta
 Il poeta francese Charles
Baudelaire affermava che “la più grande astuzia del diavolo è
farci credere che non
esiste”. I padroni hanno storicamente fatto tesoro di questa
lezione, tanto da dotarsi di una teoria economica – il
paradigma economico
oggi dominante – che ha tra i suoi principali obiettivi quello
di convincerci che, alla fine della fiera, non c’è alcuna
contrapposizione e inconciliabilità tra gli interessi dei
lavoratori e dei capitalisti. Ora, chiunque abbia
lavorato anche solo una
settimana in vita sua, chi è disoccupato o sottoccupato, sa
benissimo che questa è una menzogna bella e buona,
utile
solamente a tenere al riparo proprio i capitalisti da noiose
rivendicazioni. Una cosa apparentemente così banale e di buon
senso deve essere
sfuggita ai sindacati confederali i quali, dopo tanto parlare
di partito
del PIL
ed armonia sociale, decidono finalmente di fare il grande
passo e lanciano un ‘Appello
per
l’Europa’ insieme alla principale organizzazione
padronale italiana, Confindustria.
Il poeta francese Charles
Baudelaire affermava che “la più grande astuzia del diavolo è
farci credere che non
esiste”. I padroni hanno storicamente fatto tesoro di questa
lezione, tanto da dotarsi di una teoria economica – il
paradigma economico
oggi dominante – che ha tra i suoi principali obiettivi quello
di convincerci che, alla fine della fiera, non c’è alcuna
contrapposizione e inconciliabilità tra gli interessi dei
lavoratori e dei capitalisti. Ora, chiunque abbia
lavorato anche solo una
settimana in vita sua, chi è disoccupato o sottoccupato, sa
benissimo che questa è una menzogna bella e buona,
utile
solamente a tenere al riparo proprio i capitalisti da noiose
rivendicazioni. Una cosa apparentemente così banale e di buon
senso deve essere
sfuggita ai sindacati confederali i quali, dopo tanto parlare
di partito
del PIL
ed armonia sociale, decidono finalmente di fare il grande
passo e lanciano un ‘Appello
per
l’Europa’ insieme alla principale organizzazione
padronale italiana, Confindustria.
Un quadro idilliaco si apre di fronte agli occhi del lettore dell’appello, un universo dove siamo tutti sulla stessa bella barca, padroni e lavoratori, tutti con la fortuna di risiedere in una Unione Europea che viene presentata come “il progetto […] cruciale per affrontare le sfide e progettare un futuro di benessere per l’Europa che è ancora uno dei posti migliori al mondo per vivere, lavorare e fare impresa”.
La premessa dice già tutto. L’architettura europea è un valore di per sé e non necessita di alcuna riflessione critica. Chi ha scritto l’appello, chiaramente, non ha vissuto e non vive come un problema i vincoli di finanza pubblica e le politiche di austerità, che hanno causato il ritorno della disoccupazione di massa e il peggioramento materiale delle condizioni di vita di milioni di lavoratori. In tutto il testo, è presente solo un vago e impersonale riferimento a generiche “politiche di rigore”, senza neanche menzionare chi queste politiche di rigore le ha congegnate e imposte agli Stati membri, in particolare quelli della periferia europea.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: La strategia del caos guidato
![]()
La strategia del caos guidato
di Manlio Dinucci
Tutti contro tutti: è l’immagine mediatica del caos che si allarga a macchia l’olio sulla sponda sud del Mediterraneo, dalla Libia alla Siria. Una situazione di fronte alla quale perfino Washington sembra impotente. In realtà Washington non è l’apprendista stregone incapace di controllare le forze messe in moto. È il centro motore di una strategia – quella del caos – che, demolendo interi Stati, provoca una reazione a catena di conflitti da utilizzare secondo l’antico metodo del «divide et impera».
Usciti vincitori dalla guerra fredda nel 1991, gli Usa si sono autonominati «il solo Stato con una forza, una portata e un’influenza in ogni dimensione – politica, economica e militare – realmente globali», proponendosi di «impedire che qualsiasi potenza ostile domini una regione – l’Europa Occidentale, l’Asia Orientale, il territorio dell’ex Unione Sovietica e l’Asia Sud-Occidentale (il Medio Oriente) – le cui risorse sarebbero sufficienti a generare una potenza globale» [1]. Da allora gli Stati uniti l’Alleanza atlantica sotto loro comando hanno frammentato o demolito con la guerra, uno dopo l’altro, gli Stati ritenuti di ostacolo al piano di dominio globale – Iraq, Jugoslavia, Afghanistan, Libia, Siria e altri – mentre altri ancora (tra cui l’Iran e il Venezuela) sono nel mirino.
Nella stessa strategia rientra il colpo di stato in Ucraina sotto regia Usa/Nato, al fine di provocare in Europa una nuova guerra fredda per isolare la Russia e rafforzare l’influenza degli Stati uniti in Europa.
Leggi tutto
Tom Luongo: Salvini prepara l’Italia allo scontro con l’UE
Salvini prepara l’Italia allo scontro con l’UE
di Tom Luongo
Tom Luongo spiega su Strategic Culture la strategia che intravede nelle mosse del governo italiano. Salvini punta a ottenere un successo alle elezioni europee unendo tutti gli euroscettici sotto la stessa bandiera, per poi sfidare Bruxelles: o cambia o l’Italia se ne va, forte delle sue riserve d’oro, nel frattempo messe al sicuro
Al momento, l’italiano Matteo Salvini naviga a gonfie vele. Dopo avere mandato all’aria un paio di pretestuose azioni legali volte a pregiudicare il suo assalto al Parlamento Europeo del prossimo maggio, Salvini lavora per galvanizzare l’euroscetticismo in tutto il continente, per farne una forza politica rilevante.
Non si tratta di un lavoro facile.
Ma ha perlomeno due importanti alleati. Marine Le Pen del National Rally francese e Viktor Orban, leader ungherese. Salvini e Le Pen si sono incontrati la scorsa settimana per annunciare che faranno campagna elettorale congiunta per le elezioni europee, e per annunciare un grande incontro imminente a Milano.
Tuttavia, questo è solo l’inizio.
Ormai da un anno sostengo che Salvini dovrà essere la persona che pone le basi per una rivolta totale contro l’Unione europea e la partecipazione dell’Italia all’Eurozona.
Leggi tutto
Chris Hedges: Il martirio di Julian Assange
Il martirio di Julian Assange
di Chris Hedges
L’arresto, giovedì scorso, di Julian Assange mette a nudo tutta la finzione del principio di legalità e dei diritti di una stampa libera. Le illegalità commesse dai governi ecuadoriano, britannico e statunitense nel sequestro di Assange sono inquietanti. Sono il presagio di un mondo in cui i meccanismi interni, gli abusi, la corruzione, le menzogne e i crimini, specialmente quelli di guerra, commessi dagli stati corporativi e dall’élite dominante mondiale saranno nascosti al pubblico
Sono il presagio di un mondo in cui quelli che avranno il coraggio e l’integrità per denunciare l’uso improprio del potere verranno braccati, torturati, sottoposti a processi fittizi e condannati a pene detentive in isolamento. Sono il presagio di una distopia orwelliana, in cui le notizie sono sostituite da propaganda, futilità e intrattenimento. L’arresto di Assange, temo, segna l’inizio ufficiale del totalitarismo corporativo che condizionerà tutte le nostre vite.
In base a che legge il presidente ecuadoriano Lenin Moreno ha arbitrariamente posto fine al diritto di asilo di Julian Assange come rifugiato politico? In base a quale legge Moreno ha autorizzato la polizia britannica ad entrare nell’ambasciata ecuadoriana, un legittimo territorio sovrano secondo gli accordi diplomatici, per arrestare un cittadino naturalizzato dell’Ecuador? In base a quale legge il Primo Ministro Theresa May ha ordinato alla polizia britannica di arrestare Assange, che non ha mai commesso alcun crimine? In base a quale legge il presidente Donald Trump ha chiesto l’estradizione di Assange, che non è un cittadino degli Stati Uniti e la cui organizzazione giornalistica non ha sede negli Stati Uniti?
Leggi tutto
Salvatore Perri: Uscire dal sottosviluppo: nuove strategie per l’economia del Mezzogiorno
Uscire dal sottosviluppo: nuove strategie per l’economia del Mezzogiorno
di Salvatore Perri
L’odierno Mezzogiorno. La condizione economica del Mezzogiorno risulta essere preoccupante sotto diversi profili, sia nel rapporto con le altre aree del paese che nel confronto con analoghe realtà europee. Sostanzialmente le regioni del Sud Italia risultano avere un tessuto produttivo debole e frammentato, una forte dipendenza dai trasferimenti pubblici, un tasso di disoccupazione (specie giovanile) più elevato della media nazionale ed europea, una forte emigrazione intellettuale, un ampio settore sommerso, una burocrazia farraginosa ed inefficace ed una presenza pervasiva della criminalità organizzata[1].
La caratteristica di questa situazione non è tanto relativa all’ampiezza dei divari (elevata) quanto alla relativa stabilità nel tempo dei divari stessi, il che suggerisce che un siffatto sistema economico abbia trovato una sua forma di equilibrio, un equilibrio di sottodimensionamento. La debolezza del tessuto produttivo, fatto di piccole e piccolissime imprese che non si mettono in rete non raggiungendo quindi una sufficiente massa critica per diventare distretti industriali, influenza la domanda aggregata condizionandone l’ampiezza a causa del basso valore aggiunto prodotto. La ristrettezza dei margini di profitto, a sua volta, genera un costante ricorso a varie forme di sommerso produttivo, che “integrano” la produzione e consentono agli individui a basso reddito di rifornirsi di merci a basso costo.
Leggi tutto
Vincenzo Russo: La globalizzazione democratica di Rodrik
La globalizzazione democratica di Rodrik
di Vincenzo Russo
Nel suo nuovo saggio l'economista sviluppa le idee elaborate in questi ultimi anni e formula una serie di proposte per tentare di conciliare il ruolo dello Stato nazionale, che considera tutt'altro che esaurito, con un'economia per cui i confini non hanno più significato
 La tesi principale del libro è che
gli Stati nazionali hanno ancora un ruolo da giocare
specialmente in termini di
giustizia sociale, riduzione delle diseguaglianze e protezione
dei diritti dei lavoratori. Devo dire che prima di leggere il
lavoro di Rodrik ero
convinto del contrario specialmente con riguardo alla
posizione dei paesi membri dell’Unione europea. Dopo attenta
meditazione sulle sue
argomentazioni, tendo a convergere con la sua posizione. Il
motivo è presto detto: intanto la globalizzazione degli ultimi
decenni non è
stata ben governata e la finanza rapace ha fatto il bello e il
cattivo tempo. La globalizzazione implica una
verticalizzazione del processo
decisionale che per funzionare bene comporterebbe una riforma
delle istituzioni sovranazionali. In assenza di detta riforma
non si può contare
su di esse per garantire a livello globale il rispetto dei
diritti fondamentali, un livello essenziale di giustizia
sociale, la libertà di
movimento dei cittadini in cerca non solo delle libertà che
sono loro negate nei paesi dove sono nati ma anche il diritto
a migliorare il loro
benessere emigrando.
La tesi principale del libro è che
gli Stati nazionali hanno ancora un ruolo da giocare
specialmente in termini di
giustizia sociale, riduzione delle diseguaglianze e protezione
dei diritti dei lavoratori. Devo dire che prima di leggere il
lavoro di Rodrik ero
convinto del contrario specialmente con riguardo alla
posizione dei paesi membri dell’Unione europea. Dopo attenta
meditazione sulle sue
argomentazioni, tendo a convergere con la sua posizione. Il
motivo è presto detto: intanto la globalizzazione degli ultimi
decenni non è
stata ben governata e la finanza rapace ha fatto il bello e il
cattivo tempo. La globalizzazione implica una
verticalizzazione del processo
decisionale che per funzionare bene comporterebbe una riforma
delle istituzioni sovranazionali. In assenza di detta riforma
non si può contare
su di esse per garantire a livello globale il rispetto dei
diritti fondamentali, un livello essenziale di giustizia
sociale, la libertà di
movimento dei cittadini in cerca non solo delle libertà che
sono loro negate nei paesi dove sono nati ma anche il diritto
a migliorare il loro
benessere emigrando.
Si tratta quindi di una soluzione di second best che non va condannata come tale ma di prendere atto che allo stato non è disponibile quella di first best. E chi sa quanto tempo bisogna ancora attendere prima di riuscire a costruirla. Come sappiamo, a livello sovranazionale, non ci sono parlamenti regolarmente eletti. E se ci sono come nell’Unione europea, ciò non significa che hanno l’ultima parola in materia di politiche sociali e redistributive. Ci sono tecnocrazie nominate da alcuni governi che non esprimono necessariamente gli interessi delle fasce più deboli dei paesi membri. Per le istituzioni sovranazionali si parla di governance e non di organismi pienamente democratici. Nel massimo organo decisionale delle Nazioni Unite il potere è concentrato nel Consiglio di sicurezza composto da cinque membri permanenti e da dieci temporanei.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2934
Hits 2842
Hits 2650
Hits 2486
Hits 2454
Hits 2415
Hits 2342
Hits 2303
Hits 2187
Hits 2136
tonino
tonino

Enrico Grazzini: L’“Appello per l’Europa” di Sindacati e Confindustria è un clamoroso errore storico
L’“Appello per l’Europa” di Sindacati e Confindustria è un clamoroso errore storico
di Enrico Grazzini
 L' “Appello
per l’Europa” firmato qualche giorno fa dai sindacati CGIL,
CISL e UIL e da Confindustria conferma purtroppo la profonda
debolezza di analisi e di capacità propositiva delle
organizzazioni dei lavoratori
e dell'associazione nazionale degli imprenditori nel campo
decisivo delle politiche europee e delle politiche
macroeconomiche. L'Appello, farcito di
enfatica retorica europeista, dimostra che sindacati e
Confindustria – organismi della società civile ovviamente
fondamentali per
l'evoluzione e il progresso della società italiana – sono
purtroppo ancorati a una ideologia vetusta, del tutto
irrealistica e acritica
nei confronti delle politiche della Unione Europea.
L' “Appello
per l’Europa” firmato qualche giorno fa dai sindacati CGIL,
CISL e UIL e da Confindustria conferma purtroppo la profonda
debolezza di analisi e di capacità propositiva delle
organizzazioni dei lavoratori
e dell'associazione nazionale degli imprenditori nel campo
decisivo delle politiche europee e delle politiche
macroeconomiche. L'Appello, farcito di
enfatica retorica europeista, dimostra che sindacati e
Confindustria – organismi della società civile ovviamente
fondamentali per
l'evoluzione e il progresso della società italiana – sono
purtroppo ancorati a una ideologia vetusta, del tutto
irrealistica e acritica
nei confronti delle politiche della Unione Europea.
Siamo nel mezzo di una crisi conclamata della UE e dell'eurozona; l'economia europea è nuovamente sull'orlo di una crisi recessiva. Ma il documento ignora tutto questo. Difende a spada tratta l'Europa, esorta (giustamente) tutti i cittadini ad andare a votare alle elezioni europee di maggio, ma non accenna minimamente ad una analisi critica sulle pesanti conseguenze negative delle politiche di austerità che hanno colpito l'Italia e i Paesi europei negli ultimi dieci anni. L'appello ripropone quelle riforme (eurobond, investimenti pubblici, ecc) già avanzate da almeno due lustri, ma mai accettate dalla UE, e quindi purtroppo velleitarie ed illusorie. Non c'è nessuna analisi critica sulla crisi dei bilanci pubblici causata dal predominio dei mercati finanziari. Nessun accenno al fatto che la UE si sta disintegrando per contraddizioni interne. Solo stupefacenti affermazione sui presunti grandi successi della UE e vaghe proposte consolatorie.
La povertà culturale nell'affrontare gli attuali problemi europei e nazionali è tanto più grave considerando che quasi certamente la crisi dell'eurozona – che è il cuore dell'Unione Europea – è destinata a peggiorare (o a precipitare) già nel prossimo futuro a causa delle crescenti tensioni commerciali tra Europa e Stati Uniti, e soprattutto a causa dei probabili prossimi sgonfiamenti dei mercati finanziari previsti ormai da quasi tutti gli economisti – i mercati finanziari sono infatti da troppi anni drogati dalle politiche monetarie espansive attuate delle banche centrali di tutto il mondo, ma l'”effetto droga” non può durare in eterno! -.
Leggi tutto
Anna Angelucci: INVALSI: adesso è il computer a giudicare gli studenti
INVALSI: adesso è il computer a giudicare gli studenti
Anche per i quesiti aperti!
di Anna Angelucci
 Dal 2018, per effetto di un
decreto delegato della Buona Scuola (62/2017), le prove,
svolte dagli alunni di terza
media al computer nelle scuole, sono corrette automaticamente,
a livello centrale. Il computer dell’Invalsi riceve le prove
appena svolte, poi
corregge, misura e valuta, esprimendo un giudizio di merito in
livelli che descrivono le prestazioni
cognitive del singolo alunno, giudizio che viene
restituito individualmente attraverso la Certificazione delle
competenze di fine primo ciclo.
Cosa significa in pratica? Per allontanare lo spettro della
“copiatura” (cheating) gli alunni non rispondono alle stesse
domande e
l’equità del punteggio finale è affidata a un complesso
modello statistico (i cui limiti e le cui falle sono note). Non solo, ma sulla
base di
questi punteggi il computer redige un esteso giudizio
qualitativo sull’allievo che tocca valutazioni sulla sua
capacità di comprendere il
testo, cogliendone anche il tono, per esempio ironico o
polemico. Che la correzione automatica sia estesa ai “Quesiti
aperti a risposta
articolata” non può che aumentare le perplessità. Ricordiampo
che una analoga certificazione delle competenze è prevista
pure per il secondo ciclo, come avevamo segnalato qui. Nel frattempo,
Invalsi
procede con la sperimentazione della misurazione delle soft skills
delle creature piccole. Alla standardizzazione si stanno
dunque accompagnando l’automazione e la profilazione. A quali principi
educativi, a quale didattica, a quale pedagogia rispondono
queste nuove, inaccettabili, misure?
Dal 2018, per effetto di un
decreto delegato della Buona Scuola (62/2017), le prove,
svolte dagli alunni di terza
media al computer nelle scuole, sono corrette automaticamente,
a livello centrale. Il computer dell’Invalsi riceve le prove
appena svolte, poi
corregge, misura e valuta, esprimendo un giudizio di merito in
livelli che descrivono le prestazioni
cognitive del singolo alunno, giudizio che viene
restituito individualmente attraverso la Certificazione delle
competenze di fine primo ciclo.
Cosa significa in pratica? Per allontanare lo spettro della
“copiatura” (cheating) gli alunni non rispondono alle stesse
domande e
l’equità del punteggio finale è affidata a un complesso
modello statistico (i cui limiti e le cui falle sono note). Non solo, ma sulla
base di
questi punteggi il computer redige un esteso giudizio
qualitativo sull’allievo che tocca valutazioni sulla sua
capacità di comprendere il
testo, cogliendone anche il tono, per esempio ironico o
polemico. Che la correzione automatica sia estesa ai “Quesiti
aperti a risposta
articolata” non può che aumentare le perplessità. Ricordiampo
che una analoga certificazione delle competenze è prevista
pure per il secondo ciclo, come avevamo segnalato qui. Nel frattempo,
Invalsi
procede con la sperimentazione della misurazione delle soft skills
delle creature piccole. Alla standardizzazione si stanno
dunque accompagnando l’automazione e la profilazione. A quali principi
educativi, a quale didattica, a quale pedagogia rispondono
queste nuove, inaccettabili, misure?
Nelle pagine seguenti sono presentati i risultati campionari delle prove INVALSI condotte nella primavera di quest’anno. Mentre è consueta la modalità di presentazione e il periodo in cui questo avviene – il primo giovedì di luglio – quest’anno sono state introdotte e realizzate importanti novità così come previsto dal Decreto Legislativo 62/2017. Si tratta di innovazioni che hanno cambiato notevolmente la prassi delle prove e riguardano 4 aspetti:
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Gilets Jaunes: la vittoria dei vinti
Gilets Jaunes: la vittoria dei vinti
di Giacomo Marchetti
La fine del mondo si annuncia con segni contraddittori
Il movimento iniziato il 17 novembre dell’anno scorso non dà nessun segnale di cedimento.
22 Atti consecutivi di protesta, 2 scioperi generali (il 5 febbraio e il 19 marzo), due “assemblee delle assemblee” che lo stanno strutturando, la prima a Commercy a fine gennaio, la seconda i primi d’aprile a Saint Nazaire…
L’ultimo Atto aveva come appuntamento “nazionale” Tolosa, uno degli epicentri della “marea gialla”, mentre in tutto l’Esagono più di una cinquantina di realtà politico-sociali – tra cui la maggior centrale sindacale francese la CGT tra l’altro co-promotrice dei due scioperi generali – hanno manifestato per “il diritto a manifestare”, pesantemente minato dall’approvazione definitiva della cosiddetta “lois anti-casseurs” l’11 aprile.
Il Consiglio Costituzionale ha solamente rigettato la possibilità arbitraria – prevista dalla legge – da parte del prefetto di vietare l’accesso ad una manifestazione a tutti i cittadini considerati come potenzialmente “violenti”, non obiettando nulla sugli articoli che autorizzano perquisizioni a tappetto in prossimità dei luoghi dove si svolgono le manifestazioni ed introducendo il reato penale di travisamento che comporta fino ad un anno di prigione e 15 mila euro di multa!
Leggi tutto
Dante Barontini: Verso l’uomo solo al comando
Verso l’uomo solo al comando
di Dante Barontini
Non ci interessiamo molto del quotidiano cicaleccio della “politica” italiana. Non ci sembra utile correr dietro a battute via twitter che durano meno del tempo necessario a scriverle, perché sappiamo bene quali siano i limiti entro cui viene esercitata la “sovranità” delle scelte politiche – sia in campo economico che militar-diplomatico.
Ma ogni tanto qualche scontro vero, dentro il governo, c’è. Anche se si fa una certa fatica a distinguerlo dalle normali sciocchezze da campagna elettorale permanente.
Un esempio di questo scontro viene dall’incidente diplomatico senza precedenti tra il ministro dell’Interno e nientemeno che i vertici dello Stato maggiore della Difesa – i militari, insomma – dove al centro del contendere c’è in effetti una direttiva ministeriale, non un tweet.
Si tratta della “terza direttiva sul contrasto all’immigrazione clandestina” firmata da Salvini, scritta di corsa con l’intento esplicito di fermare una nuova missione della nave Mare Jonio, gestista dalla ong Mediterranea. Che è a sua volta una trovata a cavallo tra l’umanitario e l’elettorale, con protagonisti politici – Casarini, Fratoianni, ecc.- che non brillano affatto su altri fronti dello scontro politico e sociale.
Fosse soltanto uno scambio di dispetti tra ministri e ministeri, non varrebbe la pena di occuparsene. Di “scontri tra totani” ce ne sono anche troppi ogni giorno.
Leggi tutto
Giorgio Cremaschi: Lavorare meno, lavorare tutti
Lavorare meno, lavorare tutti
di Giorgio Cremaschi
Ha ragione il presidente dell’INPS Tridico, dagli anni settanta in Italia non ci sono significative riduzioni dell’orario di lavoro. Anzi, aggiungiamo noi, negli ultimi anni chi lavora, lavora sempre di più.
Ridurre l’orario a parità di salario è necessario oggi e non solo per ridurre la disoccupazione, ma per redistribuire davvero la produttività e per migliorare complessivamente le condizioni di vita. Un lavoratore italiano oggi lavora mediamente 350 oreLavorare meno, lavorare tutti
all’anno in più di un collega tedesco, questo significa che la riduzione d’orario è possibile solo con un radicale cambiamento di politica economica e sociale.
Di fronte alla potente innovazione tecnologica della cosiddetta industria 4.0 non dobbiamo ripetere gli errori compiuti con l’invenzione della categoria del post fordismo. Questa categoria ha confuso il progresso tecnico e un grande cambiamento nella organizzazione del lavoro manifatturiero e nella sua distribuzione mondiale, a favore dei paesi di nuova industrializzazione, con un mutamento di sistema: non è così.
Non ci sono mai stati tanti operai nel mondo come da quando si é cominciato a parlare di fine della classe operaia. Non c’è mai stato tanto lavoro salariato come da quando si è proclamato il suo superamento.
Leggi tutto
Carlo Lozito: Intelligenza artificiale: dannazione o liberazione del lavoratore?
Intelligenza artificiale: dannazione o liberazione del lavoratore?
di Carlo Lozito
Si annuncia la rivoluzione dell'IA, peraltro già avviata da oltre 20 anni con lo sviluppo di Internet e del web. Sarà una rivoluzione che peggiorerà le già deteriorate condizioni di vita dei lavoratori aprendo scenari sociali di potenziali conflitti i cui esiti sono al momento imprevedibili. Essa fa intravedere, per la prima volta nella storia, la possibilità concreta di far lavorare le macchine al posto degli uomini e di liberarli dalla dipendenza dal lavoro coatto
 Meno si è meno si esprime la propria
vita;
Meno si è meno si esprime la propria
vita;
più si ha e più è alienata la propria vita.
Karl Marx
Siamo alla quarta rivoluzione industriale. Il capitalismo, finora, è riuscito a dare un impulso senza precedenti allo sviluppo delle forze produttive che, in poco più di due secoli, ha trasformato profondamente la società. Se guardiamo oltre l'apparente progresso, tanto sbandierato dagli apologeti del capitalismo, constatiamo un disastro sociale ed ambientale senza precedenti storici. Oggi le più colpite sono le giovani generazioni addirittura private della possibilità di progettare il loro futuro tanto è precaria la loro condizione lavorativa ed esistenziale. I fenomeni di karoshi e ikikomori, presenti in Giappone e sempre più frequentemente in Occidente, sono un segno dei tempi che viviamo1.
Mentre si realizzano le strabilianti nuove macchine dell'intelligenza artificiale (in seguito IA), rese possibili dallo sviluppo sviluppo scientifico senza eguali, viviamo contraddizioni spaventose. Alcuni uomini, le ricerche ci dicono siano otto (!), possiedono una ricchezza pari a quella della metà della popolazione mondiale più povera mentre la maggior parte dell'umanità vive la condizione di un'esistenza minacciata quotidianamente dalla precarietà, dall'incertezza, dalla faticosa lotta per conquistare il minimo vitale.
Ora si annuncia la rivoluzione dell'IA, peraltro già anticipata da oltre 20 anni con lo sviluppo del mercato globale, di Internet e del web, destinata nel volgere di un paio di decenni a porre sfide decisive all'intera società.
IA: una breve panoramica.
Non possiamo fare un'estesa disamina delle nuove macchine dotate di IA. Diciamo solo che esse incorporano e svolgono molte delle funzioni umane, anche complesse. Ne accenneremo solo, indicando nelle note all'articolo i link ai video in rete che le mostrano.
Leggi tutto
3 - L’abdicazione dello Stato
di Robert Kurz
Pubblichiamo il terzo capitolo della sezione VIII dello Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”) di Robert Kurz
 Se
paragonato all’oggettività della «crisi della società
del lavoro», delineatasi negli ultimi due decenni del XX
secolo, il «consenso globale sull’economia di mercato»,
costituitosi
con forza in quello stesso periodo, andrebbe giudicato solo
come un sintomo della sempre più grave incapacità mentale
delle istituzioni
capitalistiche e dei relativi rappresentanti ideologici.
Questa cecità di fronte alla realtà, un vero e proprio
flagello collettivo,
può essere spiegata in parte con la specifica costellazione
della storia del dopoguerra.
Se
paragonato all’oggettività della «crisi della società
del lavoro», delineatasi negli ultimi due decenni del XX
secolo, il «consenso globale sull’economia di mercato»,
costituitosi
con forza in quello stesso periodo, andrebbe giudicato solo
come un sintomo della sempre più grave incapacità mentale
delle istituzioni
capitalistiche e dei relativi rappresentanti ideologici.
Questa cecità di fronte alla realtà, un vero e proprio
flagello collettivo,
può essere spiegata in parte con la specifica costellazione
della storia del dopoguerra.
Sul piano della teoria economica e su quello politico la dottrina keynesiana era riuscita ad imporsi con forza come reazione alla Grande depressione dell’epoca tra le due guerre; nella contrapposizione tra i sistemi con il blocco orientale essa caldeggiò la concessione di misure sociali. Inoltre perlomeno un settore delle élite funzionali capitalistiche era giunto alla conclusione, collegata più o meno saldamente al keynesismo, che il «consumo di massa di investimento» di beni di consumo durevoli fosse ormai un’architrave del sistema e dovesse quindi essere garantito dallo Stato. per questa via fu certamente possibile procrastinare il boom fordista oltre i suoi limiti interni. Ma come si intervenne allorché divenne chiaro che il sistema monetario iniziava nuovamente ad essere afflitto da un’inflazione drammatica e che quindi anche il keynesismo aveva fallito? Si ritornò al passato definendolo progresso.
Infatti il pensiero capitalistico, accanto al classico liberalismo economico – che risaliva ai fisiocratici, a Smith, Ricardo e Say – aveva prodotto solo la dottrina di Keynes (oltre che, in un ramo collaterale, il capitalismo di Stato integrale della «modernizzazione di recupero») come sintesi delle tendenze verso l’economia controllata dallo Stato a partire dal tardo XIX secolo, e in questo modo aveva esaurito ogni freccia al suo arco. Sul terreno del modo di produzione capitalistico non esiste una terza possibilità.
Leggi tutto
Enrico Galavotti: Le Tesi agrarie di Lenin al II congresso del Komintern
![]()
Le Tesi agrarie di Lenin al II congresso del Komintern
di Enrico Galavotti
 Premessa
Premessa
Rivolte al II Congresso dell'Internazionale comunista, le Tesi agrarie1 furono scritte da Lenin nel giugno 1920, quando ormai gli restavano pochi anni di vita. I destinatari sono quindi i delegati dei partiti comunisti del mondo intero, i quali rappresentavano, in quel momento, gli interessi del proletariato urbano e industriale. La rivoluzione socialista, contro le sue aspettative, era risultata vincente solo in Russia, il Paese più debole di tutti quelli capitalistici.
Lenin non può più considerare il proletariato urbano come una classe che in sé è migliore dei contadini, altrimenti sarebbe difficile spiegare il motivo per cui in Europa occidentale, dopo l'Ottobre, non sono stati compiuti analoghi rivolgimenti contro il sistema dominante (i pochi realizzati furono facilmente travolti dalla reazione borghese). Ormai è in grado di vedere anche i forti limiti di questa classe (almeno di una sua parte) e soprattutto i limiti, ancora più grandi, di chi rappresenta il peggio di questa classe, i parlamentari e i sindacalisti socialdemocratici, politicamente riformisti. Sta cominciando a capire che per realizzare il socialismo non basta appartenere alla classe degli sfruttati: ci vuole anche una forte volontà emancipativa e una chiara consapevolezza dei veri problemi della società. E queste cose possono averle anche i contadini, gli impiegati, gli intellettuali, ecc., i quali, anche se oggettivamente sono piccolo-borghesi, possono elevarsi ideologicamente al di sopra dei limiti della loro classe d'appartenenza.
Sono sfruttati tutti coloro che non dispongono di proprietà privata, ma come distinguere, tra questi nullatenenti, quelli che hanno atteggiamenti davvero rivoluzionari? È sufficiente prendere in considerazione i livelli degli stipendi e dei salari? Più sono bassi, infimi, e più uno dovrebbe maturare uno spirito eversivo? Purtroppo non c'è un nesso logico, oggettivo, tra le due cose. Non è detto che le rivoluzioni socialiste vengano fatte da chi sta peggio economicamente.
Leggi tutto
Fabrizio Poggi: Assange, quello “spione al servizio di Putin”, secondo il Pd!
Assange, quello “spione al servizio di Putin”, secondo il Pd!
di Fabrizio Poggi
Nessuna sorpresa; tutto pienamente prevedibile, ma non per questo meno nauseante. Quel fogliaccio liberal-democristiano che è “Democratica” non poteva mancare all’appuntamento con altre stomachevoli dichiarazioni di intenti.
La consegna, dietro pagamento in contanti, di Julian Assange agli aguzzini britannici e, tramite loro (se non interverrà la mano del MI5 a tacitarne la voce, con qualche “miracolosa” pozione la cui formula può esser mediaticamente attribuita al malefico GRU putiniano) alla “giustizia” yankee, ha incontrato la scontata e vomitevole cantica delle sagrestie del PD.
Andrea Romano: “una spia russa”. Stefano Esposito: “spione al servizio di Putin”. Lia Quartapelle: “tra le reazioni internazionali, destano preoccupazione le molteplici prese di posizione di esponenti del governo russo, Paese che non brilla certo per il rispetto dei diritti dei dissenzienti e per la libertà di stampa”. E pensare che quegli scabrosi estremisti “rosso”-verdi del GUE/NGL lo hanno onorato, lui, quello “spione” di Assange, del premio destinato a giornalisti, whistleblowers e difensori del diritto all’informazione per il 2019, intitolato alla giornalista maltese assassinata Daphne Galizia.
Questo è Julian Assange, come lo rappresentano i democratici atlantisti di via Sant’Andrea della Fratte, 16, a Roma: un inviato del demonio. Peccato che i suoi “mandanti”, l’ambasciata russa a Londra, nel 2012 gli avesse rifiutato rifugio.
Leggi tutto
Federico Dezzani: Caporetto Libia: analisi e rimedi di una sconfitta
Caporetto Libia: analisi e rimedi di una sconfitta
di Federico Dezzani
Il 4 aprile, consolidato il dominio su Cirenaica e Fezzan, il generale Khalifa Haftar ha lanciato l’operazione per la conquista di Tripoli: nonostante si attendesse un ingresso più facile nella capitale, difficilmente il generale desisterà sino alla vittoria totale e difficilmente i suoi sponsor gli negheranno i mezzi necessari all’impresa. Per l’Italia, arroccata sulla difesa del governo di Tripoli, si profila una storica sconfitta: come si è arrivati alla Caporetto libica? Dall’omicidio Regeni all’illusoria speranza del sostegno americano, breve ricostruzione di una disfatta e qualche (superfluo) consiglio per ripartire, spostando il nostro il nostro asse mediorientale.
Addio “posto al sole”?
La Libia ci è cara, non soltanto perché è stata meta di uno dei nostri primi viaggi mediorientali (in epoca gheddafiana), ma anche perché col tema libico “debuttammo” in rete come analisti: correva infatti il novembre 2014 (cinque anni fa!), quando scrivemmo “Libia: sfida Russia-USA?”. È un articolo che merita di essere letto, perché nonostante qualche cambiamento intercorso nel frattempo, resta tuttora valido.
Sul tema, da allora abbiamo scritto più e più volte, anticipando talora gli eventi con capacità quasi medianiche: come non rimanere stupiti, a distanza di due anni, leggendo il titolo “Accordi ONU agli sgoccioli: Parigi e Mosca lanciano l’Opa sulla Libia”?
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Circa Carlo de Benedetti, “La nuova America dei millennial vuole più Stato (e più inflazione)”
Circa Carlo de Benedetti, “La nuova America dei millennial vuole più Stato (e più inflazione)”
di Alessandro Visalli
Un articolo di Carlo De Benedetti davvero significativo, non certo per quel che dice ma per la sua autorevolezza ed il suo ruolo, non ultimo nell’editoria. Oggi che persino Rampini queste cose le scrive e dice in televisione, guadagnandosi in risposta facce da scandalo in chiesa, anche il Sole 24 Ore può permettersele qualche volta.
Per l’ingegnere, ormai ottantenne e presidente del Gruppo Editoriale l’Espresso, proprietario de La Repubblica(dunque datore di lavoro di Rampini), L’Espresso e via dicendo, gli Stati Uniti sono oggi sull’orlo di un cambiamento di ciclo storico. Elaborando uno schematismo piuttosto rozzo, ma efficace, attribuisce questo cambiamento all’insorgenza di una nuova generazione che porta al centro della vita pubblica la propria ‘agenda’.
In base alla sua ricostruzione, come i ‘baby boomers’ (la generazione del ’68 e seguenti) hanno portato al potere il neoliberismo, ovvero un assetto economico rivolto contro l’inflazione, al prezzo di far crescere le ineguaglianze, nella difesa della loro forza vitale individuale, così i “millennials”, disgustati dalle crescenti ineguaglianze e traditi dalla disgregazione della middle class[1], vogliono nuovamente “istituzioni forti, governi forti, un senso di una direzione sociale condivisa, impegno civile e – da un punto di vista dell’economia – un rinnovato desiderio di inflazione”.
Leggi tutto
Ascanio Bernardeschi: Una manovra attendista
Una manovra attendista
di Ascanio Bernardeschi
Il governo vara il Def che, in una situazione economica disastrosa, annuncia nuove ingiustizie e adesione moderata ai dettami europei. Ma le scelte vere sono rinviate al dopo elezioni
“Confermati i programmi di governo: nessuna nuova tassa e nessuna manovra correttiva. Il documento resta in linea con i programmi di governo della legge di bilancio e il rispetto degli obiettivi fissati dalla commissione Ue”. Questa la dichiarazione del governo dopo il varo del Documento di economia e finanza (Def) che dovrebbe illustrare la manovra finanziaria del governo per il prossimo triennio. Una dichiarazione piuttosto reticente visto che l’economia italiana sta cadendo a picco, che questa caduta determinerà minori entrate e che, ciononostante, il governo intende confermare la politica fiscale varata con l’ultima legge di bilancio, contenente tra l’altro la flat tax e il reddito di cittadinanza. Tenuto di conto che dovrebbero essere reperiti anche i soldi per disinnescare le clausole sull’aumento dell’Iva, dove trova il governo le risorse per realizzare questo miracolo nel rispetto dei pesanti vincoli europei? Evidentemente dai tagli alla spesa sociale. Quindi ancora una volta a pagare saranno i più bistrattati. Anche se il Ministero del Tesoro dichiara di “condividere l’enfasi della Commissione europea sulla riduzione del debito” ma “considerazioni di carattere sociale” consigliano di perseguire “un miglioramento del saldo strutturale più graduale” rispetto alle raccomandazioni Ue. Quindi un’adesione con qualche cautela al liberismo delle istituzioni europee.
Leggi tutto
Hits 2977
Hits 2860
Hits 2690
Hits 2556
Hits 2501
Hits 2435
Hits 2371
Hits 2313
Hits 2230
Hits 2217
tonino

Alessandra Ciattini: La NATO non è un’alleanza
La NATO non è un’alleanza
di Alessandra Ciattini
Gli Stati Uniti hanno bisogno delle basi militari per mantenere il loro dominio imperialista sul mondo. L’occupazione dei paesi che ospitano le sue basi si fonda sulla Nato. Cosa sta alla base della smodata ambizione Usa?
 “La NATO non è un’alleanza, costituisce
piuttosto
un’occupazione militare di quei paesi che
furono ‘liberati’ dagli alleati nel corso della Seconda Guerra
Mondiale” (di fatto vinta dallo sforzo
immane dell’Unione Sovietica), il cui scopo è sempre
stato quello di orientare in senso
filostatunitense la politica europea e di impedire il sorgere
nel nostro continente di governi ostili alla superpotenza oggi
in seria crisi.
“La NATO non è un’alleanza, costituisce
piuttosto
un’occupazione militare di quei paesi che
furono ‘liberati’ dagli alleati nel corso della Seconda Guerra
Mondiale” (di fatto vinta dallo sforzo
immane dell’Unione Sovietica), il cui scopo è sempre
stato quello di orientare in senso
filostatunitense la politica europea e di impedire il sorgere
nel nostro continente di governi ostili alla superpotenza oggi
in seria crisi.
Questo concetto è ben spiegato da Manlio Dinucci, il conduttore della contro-celebrazione della NATO, il quale scrive sul Manifesto che la “Nato è un’organizzazione sotto il comando del Pentagono… è una macchina da guerra che opera per gli interessi degli Stati Uniti, con la complicità dei maggiori gruppi europei di potere”, la quale può esser giustamente accusata di essersi macchiata di crimini contro l’umanità.
Da qui ha preso le mosse il recente convegno internazionale sul 70° anniversario della NATO, tenutosi a Firenze lo scorso 7 aprile [1], a cui hanno partecipato circa 600 persone, venute da tutta Italia e mostrando che nel nostro paese non tutti si identificano con la politica supinamente allineata dei nostri governi (di vari colori) ai voleri statunitensi, che – dopo il dissolvimento dell’Unione Sovietica e dei suoi stretti alleati – hanno scatenato sanguinose guerre e conflitti ancora in atto.
Evidentemente, il movimento contro la guerra, che aveva dato vita a formidabili manifestazioni e lentamente spentosi nel 2003, ha ancora una qualche vitalità, che il convegno si augura di poter ravvivare, costruendo un fronte internazionale contro la NATO (NATO EXIT); la quale è in continua espansione non solo in Europa, ma anche negli altri continenti (si pensi all’avvicinamento della Colombia a questo camuffato trattato militare).
Gli interventi al convegno (filmati anche assai crudi, foto, tavole rotonde, interviste) non hanno fatto altro che dimostrare la tesi enunciata ed espressa dalle parole summenzionate, facendoci comprendere a fondo che la politica internazionale non è altro che lo svolgersi inevitabilmente brutale dei rapporti di forza tra le varie potenze che si fronteggiano nello scenario contemporaneo.
Leggi tutto
Pietro Carlo Lauro: Th.W.Adorno: Per la dottrina della storia
Th.W.Adorno: Per la dottrina della storia
di Pietro Carlo Lauro
 Il secondo capitolo della terza
parte di Dialettica negativa ha per titolo Spirito
universale e storia naturale. Con
ciò sono già fissati gli autori di riferimento per la
filosofia adorniana della storia: Hegel e Benjamin. Esiste
un progresso, una
tendenza storica, progressiva o regressiva che sia, ed
esistono d’altra parte le vittime del progresso, che poi non
sono altro che gli stessi
agenti della grande trasformazione. Ecco perché Hegel e
Benjamin. A partire dalla seconda guerra mondiale o, per
essere più precisi,
dopo le purghe staliniane contro gli oppositori, lo spirito
del mondo ha svoltato. La rivoluzione non è più all’ordine
del giorno
e al suo posto è subentrata su scala mondiale la diffusione
dell’economia capitalista, l’occidentalizzazione del mondo.
Ancor prima
del crollo del regime sovietico Heidegger diagnostica una
obiettiva convergenza, al di là dei sistemi politici, tra
Unione Sovietica e Stati
Uniti d’America sotto il segno del dominio planetario della
Tecnica. Horkheimer e Adorno, che nel frattempo hanno
maturato una prospettiva da
Oltreoceano, rispondono con il capovolgimento
dell’illuminismo. Quindi critica della Tecnica in Heidegger
e critica dell’illuminismo in
Horkheimer e Adorno. Forse che convergono non solo i sistemi
politici , ma anche le filosofie? Per niente. Che la critica
dei francofortesi converga
in ultima analisi con la critica di Heidegger è una
mistificazione messa in giro da coloro che per decenni si
sono rifiutati di prendere atto
della grande trasformazione. Ma allora la differenza qual è?
Mentre Heidegger chiude il discorso sulla tecnica, dicendo
che l’essenza
della tecnica non è nulla di tecnico1, quindi
riproponendo ancora una volta la separazione tra essenza e
fatto, Odisseo, che nella
Dialettica dell’illuminismo è il prototipo del soggetto
dell’autoconservazione, è insieme soggetto e oggetto del
rischiaramento, perché è parte stessa di ciò che è da
rischiarare. Questa è una differenza ums Ganze, che cambia
tutto. Nella misura in cui Odisseo demistifica le potenze
della natura o, che è lo stesso, del mito, si modifica anche
la comprensione che egli
ha di se stesso, perché lui stesso fa parte della natura. A
differenza della metafisica classica il pensiero dialettico
non teme la
contaminazione dell’esperienza, perché sa di essere per
costituzione compromesso con essa. La questione è soltanto,
se e come sia
possibile rendere l’esperienza fruttuosa per
l’autocomprensione che l’io ha di se stesso.
Il secondo capitolo della terza
parte di Dialettica negativa ha per titolo Spirito
universale e storia naturale. Con
ciò sono già fissati gli autori di riferimento per la
filosofia adorniana della storia: Hegel e Benjamin. Esiste
un progresso, una
tendenza storica, progressiva o regressiva che sia, ed
esistono d’altra parte le vittime del progresso, che poi non
sono altro che gli stessi
agenti della grande trasformazione. Ecco perché Hegel e
Benjamin. A partire dalla seconda guerra mondiale o, per
essere più precisi,
dopo le purghe staliniane contro gli oppositori, lo spirito
del mondo ha svoltato. La rivoluzione non è più all’ordine
del giorno
e al suo posto è subentrata su scala mondiale la diffusione
dell’economia capitalista, l’occidentalizzazione del mondo.
Ancor prima
del crollo del regime sovietico Heidegger diagnostica una
obiettiva convergenza, al di là dei sistemi politici, tra
Unione Sovietica e Stati
Uniti d’America sotto il segno del dominio planetario della
Tecnica. Horkheimer e Adorno, che nel frattempo hanno
maturato una prospettiva da
Oltreoceano, rispondono con il capovolgimento
dell’illuminismo. Quindi critica della Tecnica in Heidegger
e critica dell’illuminismo in
Horkheimer e Adorno. Forse che convergono non solo i sistemi
politici , ma anche le filosofie? Per niente. Che la critica
dei francofortesi converga
in ultima analisi con la critica di Heidegger è una
mistificazione messa in giro da coloro che per decenni si
sono rifiutati di prendere atto
della grande trasformazione. Ma allora la differenza qual è?
Mentre Heidegger chiude il discorso sulla tecnica, dicendo
che l’essenza
della tecnica non è nulla di tecnico1, quindi
riproponendo ancora una volta la separazione tra essenza e
fatto, Odisseo, che nella
Dialettica dell’illuminismo è il prototipo del soggetto
dell’autoconservazione, è insieme soggetto e oggetto del
rischiaramento, perché è parte stessa di ciò che è da
rischiarare. Questa è una differenza ums Ganze, che cambia
tutto. Nella misura in cui Odisseo demistifica le potenze
della natura o, che è lo stesso, del mito, si modifica anche
la comprensione che egli
ha di se stesso, perché lui stesso fa parte della natura. A
differenza della metafisica classica il pensiero dialettico
non teme la
contaminazione dell’esperienza, perché sa di essere per
costituzione compromesso con essa. La questione è soltanto,
se e come sia
possibile rendere l’esperienza fruttuosa per
l’autocomprensione che l’io ha di se stesso.
Leggi tutto
Michele Franco: L’unità della sinistra non produce risultati. Il dibattito in corso
L’unità della sinistra non produce risultati. Il dibattito in corso
di Michele Franco*
Con decine e decine di incontri in ogni parte del paese ha preso corpo nei mesi scorsi la campagna della Rete dei Comunisti “Unità della Sinistra: Un falso problema”.
Una discussione a cui hanno partecipato, nei vari incontri, attivisti politici e sindacali, esponenti dei “partiti comunisti”, compagni dei movimenti di lotta territoriali e rappresentanti di associazioni indipendenti.
Un dibattito ricco di argomenti e suggestioni ma anche aspro e senza formalismi.
Una vivace dialettica che è venuta fuori quando il confronto ha affrontato temi e questioni che attengono alle vicende politiche degli ultimi anni dove – a fronte delle sconfitte accumulatesi e del palese arretramento dei rapporti di forza tra le classi – si è concretamente materializzata la sciagurata azione politica della “sinistra” (in tutte le sue salse). Una linea di condotta la quale è stata “parte del problema” che i settori popolari della società hanno dovuto affrontare nel quotidiano calvario della crisi economica e dei dispositivi di governanceche – sia sul piano continentale che su quello nazionale – hanno attaccato e mortificato le condizioni di vita e di lavoro e l’intero arco della riproduzione sociale.
Leggi tutto
Alfredo Jalife-Rahme: Vendetta di Lenín Moreno per lo scandalo “Ina Papers”
Vendetta di Lenín Moreno per lo scandalo “Ina Papers”
di Alfredo Jalife-Rahme
Le gravi accuse dell’Ecuador a Julian Assange sono inverificabili. Le rivelazioni di Julian Assange sulla corruzione del presidente ecuadoriano Lenín Moreno sono invece verificate. Alfredo Jalife-Rhame ritorna sul sistema di arricchimento personale dell’America Latina
Consegnare un rifugiato al Paese che ospita la propria ambasciata significa farsi beffe delle tradizioni millenarie di qualsiasi civiltà, significa disonorare l’America Latina.
La consegna di Julian Assange agli Stati Uniti era già stata decisa nel 2017, quando Donald Trump inviò il proprio rappresentante speciale Paul Manafort, oggi in prigione, per negoziarla con Lenín Moreno, in cambio di accordi commerciali e ricompense in denaro [1].
Si attendeva l’elemento catalizzatore. L’occasione è stata la pubblicazione dei cosiddetti Ina Papers, uno scandalo che vede coinvolti il presidente Moreno, il fratello Edwin e le figlie in un’operazione di riciclaggio per 18 milioni di dollari nel paradiso fiscale del Belize, in America centrale.
La consegna ignominiosa di Assange, emblematico fondatore di Wikileaks, mette in pericolo la libertà di espressione in un’epoca di totalitarismo orwelliano-cibernetico e rimette in discussione il primo emendamento della Costituzione degli Stati Uniti [2].
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Salviamo le cattedrali dalle fiamme del plusvalore
Salviamo le cattedrali dalle fiamme del plusvalore
di Salvatore Bravo
«Tutti gli occhi si erano alzati verso il sommo della chiesa, ciò che vedevano era straordinario. In cima alla galleria più elevata, più in alto del rosone centrale, c’era una grande fiamma che montava tra i due campanili, con turbini di scintille, una grande fiamma disordinata e furiosa di cui il vento a tratti portava via un limbo nel fumo».
Victor Hugo, Notre Dame de Paris, (1831)
Lo scrittore francese criticava aspramente lo stato di degrado della cattedrale di Parigi nel romanzo che gli avrebbe dato il successo eterno, con l’obiettivo di riuscire a far partire i necessari restauri per fermarne la rovina. «Il tempo è cieco e l’uomo è stolto», scrisse. E come monito aggiunse: «Se avessimo il piacere di esaminare una ad una le diverse tracce di distruzione impresse sull’antica chiesa, quelle dovute al tempo sarebbero la minima parte, le peggiori sarebbero dovute agli uomini».
La manipolazione finanziaria
I totalitarismi – pur nelle loro differenze di genere, di fini e di contesti – si eguagliano in taluni comportamenti: anzi, l’attenzione al dettaglio ne svela la processualità cannibalica. L’agire totalitario non tollera le differenze: ne tollera la presenza solo se sono organiche al potere.
L’incendio della cattedrale di Notre Dame ha certamente infuocato un dibattito, ma eludendo sistematicamente i contenuti cui rimanda la struttura architettonica, spazio dello spirito, luogo interiore della cristianità, il cui fine è il raccoglimento della comunità cristiana.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Modi di stare al mondo
Modi di stare al mondo
di Pierluigi Fagan
L’articolo allegato in fondo parla della faccenda dell’antropocene, partendo da un film documentario di Rudy Gnutti In the same boat (con Bauman, Atkinson, Latouche,Mazzucato, Gallegati, Brynjolffson e Mujica) a cui fa eco un libro di S. L. Lewis e M. A. Maslin Il pianeta umano. Come abbiamo creato l'Antropocene (Einaudi), comprato l’altro giorno ma finito in lunga lista d’attesa.
La metafora della società = nave è antica, c’è in Platone come equiparazione tra nave e polis, gubernator (pilota da kibernets da cui cibernetica) e potere politico. Per la prima volta, sia per questioni esogene quali il problema ambientale, sia per quelle endogene quali la demografia, la globalizzazione, le migrazioni etc., si va formando la sensazione noi si sia sulla stessa nave-Terra e che la nave navighi in brutte acque.
Ma demografia, globalizzazione ed ambiente, sono problemi declinati diversamente nelle diverse part che compongono la Terra. In breve, se l’Occidente è stato storicamente ed in buona parte è ancora in termini di apporto pro-capite, il maggior inquinatore della storia, la sua demografia si sta velocemente contraendo (in termini percentuali) mentre quella del Resto del mondo sale e con essa, cresce anche la fame di sviluppo economico e conseguente pressione ambientale, che finisce col sommarsi con quella prodotta da noi dal 1850 (allego chart).
Leggi tutto
Salvatore Bravo: La pedagogia del coding
![]()
La pedagogia del coding
di Salvatore Bravo
 Gli oratores sono al
capezzale del capitalismo assoluto: la pedagogia ed i
pedagogisti sono parte
essenziale della sovrastruttura che contribuisce ad
eternizzare il capitale. Il pensiero computazionale è l’ultima
strategia per
introdurre l’intelligenza di Stato attraverso una serie di
pratiche metodologiche. Si vuole orientare l’intelligenza, che
notoriamente
è al plurale nelle sue forme, verso un modello organico al
capitalismo. Il pensiero computazionale è molto più che una
procedura
di analisi, esso struttura, standardizza la personalità, la
quale deve procedere e muoversi nel quotidiano secondo le
procedure algoritmiche.
L’introduzione-imposizione è organizzata con un artificio
ideologico, ovvero si afferma di voler affinare la creatività,
che il
pensiero computazionale è imprescindibile per rivoluzionare in
senso creativo la didattica e le personalità. Naturalmente è
il
cavallo di Troia, con cui riaffermare le pratiche del mercato
all’interno della scuola e ridimensionare, fino a rendere
complementare la
formazione dell’essere umano, in sua vece vi è l’addestramento
al mercato. Se fosse stato autentico l’intento di sollecitare
la creatività, la scuola per tradizione ha innumerevoli
potenzialità già in atto in tal senso: la lettura del
classici, la
traduzione, il dialogo quale buona pratica, le discipline
artistiche.
Gli oratores sono al
capezzale del capitalismo assoluto: la pedagogia ed i
pedagogisti sono parte
essenziale della sovrastruttura che contribuisce ad
eternizzare il capitale. Il pensiero computazionale è l’ultima
strategia per
introdurre l’intelligenza di Stato attraverso una serie di
pratiche metodologiche. Si vuole orientare l’intelligenza, che
notoriamente
è al plurale nelle sue forme, verso un modello organico al
capitalismo. Il pensiero computazionale è molto più che una
procedura
di analisi, esso struttura, standardizza la personalità, la
quale deve procedere e muoversi nel quotidiano secondo le
procedure algoritmiche.
L’introduzione-imposizione è organizzata con un artificio
ideologico, ovvero si afferma di voler affinare la creatività,
che il
pensiero computazionale è imprescindibile per rivoluzionare in
senso creativo la didattica e le personalità. Naturalmente è
il
cavallo di Troia, con cui riaffermare le pratiche del mercato
all’interno della scuola e ridimensionare, fino a rendere
complementare la
formazione dell’essere umano, in sua vece vi è l’addestramento
al mercato. Se fosse stato autentico l’intento di sollecitare
la creatività, la scuola per tradizione ha innumerevoli
potenzialità già in atto in tal senso: la lettura del
classici, la
traduzione, il dialogo quale buona pratica, le discipline
artistiche.
Pensare come una macchina
Le macchine informatiche per risolvere problemi scompongono, analizzano le varie fasi, per individuare la soluzione finale. Si tratta di problemi empirici che presuppongono un orientamento lineare. L’azione della scomposizione, astrazione, generalizzazione sostanzializzano la logica del problem solving, per cui il soggetto macchina è interno alla realtà empirica, il suo l’orizzonte deve limitarsi ad una gittata limitata, deve agire all’interno di un cono poietico. L’essere e la macchina si avvicinano, la differenza qualitativa si assottiglia in favore della differenza quantitativa sempre più limitata.
Leggi tutto
Giacomo Gabellini: Crisi del dollaro?
Crisi del dollaro?
di Giacomo Gabellini
Il Dollaro con gli aspetti che non vengono raccontati, la crisi attuale, la vicenda dello sganciamento dall’oro (e l’aggancio all’oro nero) e molto altro in un articolo di Giacomo Gabellini
 In appena un anno, la Banca Centrale russa si
è
liberata dei circa 90 miliardi di dollari di Treasury Bond
(T-Bond) statunitensi di cui era in possesso per incrementare
le riserve in yuan da 0 a
qualcosa come il 15% del totale. Percentuale sbalorditiva, che
supera di molto la media – prossima al 5% – delle riserve in
yuan di cui
dispongono i 55 Paesi interessati dal mega-progetto della Belt
and Road Initiative (Bri), ma che potrebbe essere eguagliata
da un numero ben
più consistente di Paesi in un futuro non troppo remoto. Lo
suggeriscono i dati relativi alla composizione
delle riserve
valutarie detenute dalle Banche Centrali di tutto il mondo
pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi), da cui
emerge che nel quarto trimestre
del 2018 lo yuan è arrivato a rappresentare l’1,89% del
totale, pari a 202,79 miliardi di dollari. Di per sé, la quota
può
apparire insignificante, se raffrontata a quella del dollaro
(61,69%, pari a 6.617,84 miliardi di dollari), dell’euro
(20,69%, pari a 2.219,34
miliardi di dollari), dello yen (5,20%, pari a 558,36 miliardi
di dollari) e della sterlina (4,43%,pari a 475,45 miliardi di
dollari). Il discorso
cambia però radicalmente se si considera che la moneta cinese
ha registrato aumenti della propria quota in cinque degli
ultimi sei trimestri e
che, nel quarto trimestre del 2016, le Banche Centrali di
tutto il mondo detenevano yuan per appena 84,51
miliardi di
dollari: un incremento di 2,5 volte nell’arco di un biennio.
Il tutto a spese del dollaro, che pur mantenendo saldamente il
primato, nel quarto
trimestre del 2018 ha conosciuto un calo di ben 14,31 miliardi
di dollari. E lo stesso fatto di rappresentare il 61,69% delle
riserve valutarie
globali assume un significato assai meno rassicurante se
raffrontato alla situazione del 2000, quando qualcosa come il
72% delle scorte monetarie in
possesso delle Banche Centrali era costituito da dollari.
In appena un anno, la Banca Centrale russa si
è
liberata dei circa 90 miliardi di dollari di Treasury Bond
(T-Bond) statunitensi di cui era in possesso per incrementare
le riserve in yuan da 0 a
qualcosa come il 15% del totale. Percentuale sbalorditiva, che
supera di molto la media – prossima al 5% – delle riserve in
yuan di cui
dispongono i 55 Paesi interessati dal mega-progetto della Belt
and Road Initiative (Bri), ma che potrebbe essere eguagliata
da un numero ben
più consistente di Paesi in un futuro non troppo remoto. Lo
suggeriscono i dati relativi alla composizione
delle riserve
valutarie detenute dalle Banche Centrali di tutto il mondo
pubblicati dal Fondo Monetario Internazionale (Fmi), da cui
emerge che nel quarto trimestre
del 2018 lo yuan è arrivato a rappresentare l’1,89% del
totale, pari a 202,79 miliardi di dollari. Di per sé, la quota
può
apparire insignificante, se raffrontata a quella del dollaro
(61,69%, pari a 6.617,84 miliardi di dollari), dell’euro
(20,69%, pari a 2.219,34
miliardi di dollari), dello yen (5,20%, pari a 558,36 miliardi
di dollari) e della sterlina (4,43%,pari a 475,45 miliardi di
dollari). Il discorso
cambia però radicalmente se si considera che la moneta cinese
ha registrato aumenti della propria quota in cinque degli
ultimi sei trimestri e
che, nel quarto trimestre del 2016, le Banche Centrali di
tutto il mondo detenevano yuan per appena 84,51
miliardi di
dollari: un incremento di 2,5 volte nell’arco di un biennio.
Il tutto a spese del dollaro, che pur mantenendo saldamente il
primato, nel quarto
trimestre del 2018 ha conosciuto un calo di ben 14,31 miliardi
di dollari. E lo stesso fatto di rappresentare il 61,69% delle
riserve valutarie
globali assume un significato assai meno rassicurante se
raffrontato alla situazione del 2000, quando qualcosa come il
72% delle scorte monetarie in
possesso delle Banche Centrali era costituito da dollari.
Leggi tutto
Servaas Storm: Italia: come rovinare un paese in trent’anni
Italia: come rovinare un paese in trent’anni
La crisi italiana causata dall’austerità è un campanello d’allarme per l’Eurozona
di Servaas Storm
 Sul sito dell’Institute for New
Economic
Thinking appare un articolo di un certo rilievo sul
lungo declino dell’economia italiana, che perdura da
trent’anni ormai, e sulle
cause che ci hanno portato a questo punto. Sono cose ben
note da chi segue il dibattito sulla lunga notte italiana, e
tuttavia l’articolo ci
è parso di un certo impatto e di un certo valore didattico
riassuntivo per chi si approccia ora a questi temi. Per quel
che riguarda la
valutazione delle mosse del nuovo governo italiano, stretto
tra le richieste impossibili dei vincoli europei e la
necessità di rilanciare il
Paese, e le varie proposte di via d’uscita formulate dagli
economisti, il dibattito è aperto. Ci ha solo sorpreso,
senza nulla togliere
agli economisti italiani citati, che l’economista olandese
autore dell’articolo ignori completamente quelle che sono
state le voci
più significative e più seguite che hanno dato vita al
dibattito italiano, in primo luogo quella di Alberto Bagnai, autore di due
notissimi libri
e di varie pubblicazioni su siti accademici, ma anche di
altri, ben noti ai nostri lettori
Sul sito dell’Institute for New
Economic
Thinking appare un articolo di un certo rilievo sul
lungo declino dell’economia italiana, che perdura da
trent’anni ormai, e sulle
cause che ci hanno portato a questo punto. Sono cose ben
note da chi segue il dibattito sulla lunga notte italiana, e
tuttavia l’articolo ci
è parso di un certo impatto e di un certo valore didattico
riassuntivo per chi si approccia ora a questi temi. Per quel
che riguarda la
valutazione delle mosse del nuovo governo italiano, stretto
tra le richieste impossibili dei vincoli europei e la
necessità di rilanciare il
Paese, e le varie proposte di via d’uscita formulate dagli
economisti, il dibattito è aperto. Ci ha solo sorpreso,
senza nulla togliere
agli economisti italiani citati, che l’economista olandese
autore dell’articolo ignori completamente quelle che sono
state le voci
più significative e più seguite che hanno dato vita al
dibattito italiano, in primo luogo quella di Alberto Bagnai, autore di due
notissimi libri
e di varie pubblicazioni su siti accademici, ma anche di
altri, ben noti ai nostri lettori
* * * *
La terza recessione italiana in 10 anni
Mentre la Brexit e Trump guadagnavano gli onori della cronaca, l’economia italiana è scivolata in una recessione tecnica (un’altra). Sia l’OCSE che la Banca centrale europea (BCE) hanno abbassato le previsioni di crescita per l’Italia a numeri negativi e, con quella che gli analisti considerano una mossa precauzionale, la BCE sta rilanciando il suo programma di acquisto di titoli di Stato, abbandonato solo cinque mesi fa.
«Non sottovalutate l’impatto della recessione italiana», ha dichiarato il ministro dell’economia francese Bruno Le Maire a Bloomberg News (Horobin 2019). «Si parla molto della Brexit, ma non della recessione italiana, che avrà un impatto significativo sulla crescita in Europa e può avere un impatto sulla Francia, poiché si tratta di uno dei nostri più importanti partner commerciali». Più importante del fattore commerciale, tuttavia, cosa che Le Maire si guarda bene dal dire, è che le banche francesi detengono nei loro bilanci circa 385 miliardi di euro di debito italiano, derivati, impegni di credito e garanzie, mentre le banche tedesche detengono 126 miliardi di euro di debito italiano (al terzo trimestre del 2018, secondo la Bank for International Settlements).
Leggi tutto
Giorgio Cremaschi: Il triciclo di Zingaretti
Il triciclo di Zingaretti
di Giorgio Cremaschi (Potere Al Popolo)
Guardate i tre simboli qui sotto. Il primo è quello della lista che si autodefinisce di sinistra e ambientalista e che sostiene Chiamparino alle elezioni regionali del Piemonte, la più importante consultazione che in Italia il 26 maggio accompagna il voto per le europee. Il secondo è quello di Sinistra Italiana e Rifondazione che si presentano fieramente in alternativa al PD alle elezioni europee. Il terzo è quello della lista dei Verdi e di Possibile, anch’essi in lista per le europee a sinistra del PD.
Cosa hanno in comune le seconda e la terza lista? La prima.
Sinistra Italiana alle Europee, dove ci si conta e basta e non sono in gioco scelte di governo, fa l’estrema sinistra con la sempre disponibile Rifondazione. Dove però è in gioco un potere immediato come in Piemonte, allora il partito di Fratoianni grida viva il PD. E quale PD. Chiamparino è alfiere del TAV e alleato di Salvini in questa impresa, come nel passato è stato il politico più fedele ed utile a Sergio Marchionne. Chiamparino è stato renziano prima di Renzi e persino Macron potrebbe sembrare di sinistra al suo confronto.
Con la lista Liberi Eguali e Verdi, con così poca fantasia si chiama la chiama la sinistra pro Chiamparino in Piemonte, sta dunque Sinistra Italiana assieme ai Verdi e a Possibile, che a loro volta hanno una propria lista alle europee.
Leggi tutto
comidad: Un occidente meno laico di Hammurabi mette al rogo Assange
Un occidente meno laico di Hammurabi mette al rogo Assange
di comidad
Gli avvenimenti riconfermano puntualmente che il progresso civile è un’illusione. Le brutali modalità dell’arresto nell’ambasciata ecuadoriana di Julian Assange da parte delle autorità britanniche, mostrano un intento vendicativo decisamente sproporzionato rispetto all’effettiva entità dell’offesa ricevuta. Non si tratta solo dello scandalo di vedere il “Paese della Libertà” perseguitare un uomo che ha dedicato la vita alla libertà di informazione, ma soprattutto dell’esibizione oscena e molto poco “british” di una spietata determinazione vendicativa.
Migliaia di anni fa il Codice di Hammurabi introduceva quel principio che per l’epoca poteva essere considerato persino “progressista” e “laico”: “occhio per occhio”, cioè la vendetta doveva essere proporzionata all’offesa e non superarla. A distanza di tanti secoli, la vendetta si ripresenta invece nella sua accezione più sfrenata ed esagerata, facendo riemergere il nocciolo arcaico e superstizioso delle gerarchie sociali, percepite come sacre, tanto che chi le viola, deve essere perseguitato e martirizzato a prescindere da ogni considerazione di misura e di opportunità. Un Occidente meno “laico” di Hammurabi.
Assange è certamente un Robin Hood dell’informazione libera, ha utilizzato metodi di hackeraggio per ottenere informazioni riservate e diffonderle universalmente. Una competenza che avrebbe potuto essere usata a scopi personali, è stata invece messa al servizio di una battaglia civile.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Oui, je suis Quasimodo
Oui, je suis Quasimodo
di ilsimplicissimus
Mi piacerebbe sapere quanti euro sono arrivati dalla Francia per i terremoti che in un decennio hanno sfigurato l’Italia centrale, che hanno aggredito decine di migliaia di persone e distrutto monumenti decisamente più interessanti di Notre Dame; l’unica cosa che è arrivata sono stagli sberleffi assurdi e offensivi di Charlie Hebdo . A quella cattedrale parigina ci sono abbastanza affezionato perché un secolo fa ci sono passato davanti moltissime volte per andare da Rue Tronchet, vicino a Place de la Madeleine, fino al Quai des Orfevre o al Palais de Justice spesso passando sul retro e sulla fiancata della cattedrale quando ancora si poteva fare, ma ogni volta mi veniva da pensare a quanto era pasticciata quella cattedrale e come fosse decisamente meno elegante di tante altre chiese francesi, mille miglia distante dalla Saint Chapelle che si trova a due passi, per non parlare di quelle italiane che sono su un altro pianeta o anche di quel gotico estremo che si trova a Colonia e a Ratisbona. Mi permetto di rammemorare, cosa che non faccio quasi mai, perché sento parlare di collette per aiutare i poveri francesi, orbati del loro simbolo, insomma quelli che ogni giorno ci fottono in Libia o fungono da aiuto boia di Berlino contro i nostri conti.
Leggi tutto
Marta Fana: Beati i popoli che non hanno bisogno di mecenati
Beati i popoli che non hanno bisogno di mecenati
di Marta Fana*
Il coro di applausi per la "generosità" dei miliardari che finanziano la ricostruzione di Notre-Dame segnala la subalternità della politica, che considera un tabù imporre fiscalmente una responsabilità sociale sui diritti e i beni comuni
L’incendio non era ancora stato domato del tutto quando il presidente della Repubblica francese Emmanuel Macron annunciava una colletta per la ricostruzione della cattedrale di Notre-Dame. A distanza di poche ore, i giornali potevano titolare sulle ingenti donazioni che i milionari francesi hanno subito messo a disposizione. Il giorno dopo Le Monde annunciava che le donazioni provenienti da imprese e “fortune” francesi avevano già raggiunto gli 800 milioni di euro, poche ore dopo la cifra è di un miliardo di euro. Un coro di applausi nei confronti della magnanimità e filantropia di questi miliardari a cui è tanto cara la cultura e la storia.
C’è chi titola “Notre-Dame, così il capitalismo salverà la Cattedrale”affermando che «Siamo di fronte all’ennesima dimostrazione che quando le imprese vengono lasciate libere di creare, possono essere anche meglio dello stato». La banalità dell’ideologia neoliberale è racchiusa in questa frase. Lasciare le imprese e i milionari la libertà di decidere dove, come, quanto, quando e come partecipare al benessere collettivo è solo una atto di subalternità della politica al capitale. La storia e la cultura sono beni pubblici, collettivi, la cui cura e promozione non possono essere delegate all’arbitrio privato (si sarebbe donato allo stesso modo se a prendere fuoco non fosse stata una chiesa cattolica, peraltro molto visitata?), ma devono rientrare negli interessi democratici dello Stato.
Leggi tutto
Hits 3006
Hits 2871
Hits 2724
Hits 2617
Hits 2518
Hits 2441
Hits 2385
Hits 2318
Hits 2273
Hits 2237
tonino

Eros Barone: Grandezza, limiti e attualità della Resistenza
![]()
Grandezza, limiti e attualità della Resistenza
di Eros Barone
 1. Da dove viene il termine
“Resistenza”?
1. Da dove viene il termine
“Resistenza”?
Un quesito interessante, da cui può prendere avvìo il presente discorso, è quello riguardante la genesi storica del termine “Resistenza”. Ebbene, con questo termine si intende indicare un’azione armata condotta da formazioni partigiane per frenare l’avanzata dell’invasore nazista, laddove è palese che l’origine del significato della parola “Resistenza” è strettamente collegata con l’aggressione all’Unione Sovietica da parte delle forze armate hitleriane (22 giugno 1941) e con la Grande Guerra Patriottica che fu la risposta data dal popolo e dallo Stato socialista a tale aggressione. L’attacco della Germania nazista all’Unione Sovietica fu infatti la più vasta operazione militare terrestre di tutti i tempi e il fronte orientale fu il più grande e importante teatro bellico della seconda guerra mondiale, ove si svolsero alcune tra le più grandi e sanguinose battaglie di tale guerra.
Nei quattro anni che seguirono (1941-1945) decine di milioni di militari e civili morirono o patirono terribili sofferenze. La Germania schierò 2 milioni e mezzo di uomini, l’Unione Sovietica 4 milioni e 700 mila soldati, di cui 2 milioni e mezzo sul fronte occidentale. Può essere allora opportuno ricordare che durante la seconda guerra mondiale sono state complessivamente soppresse attorno ai 50 milioni di vite umane.
Dal punto di vista meramente comparativo, l’ordine di grandezza dei caduti italiani fra il settembre del 1943 e l’aprile del 1945 è invece piuttosto esiguo: 44.720 partigiani caduti e 9.980 uccisi per rappresaglia, ai quali vanno sommati 21.168 partigiani e 412 civili mutilati e invalidi. In totale dopo l’armistizio si ebbero 187.522 caduti (dei quali 120.060 civili) e 210.149 dispersi (dei quali 122.668 civili). Fra il 10 giugno 1940 e l’8 settembre 1943 le forze armate italiane avevano avuto 92.767 caduti (cui vanno aggiunti 25.499 civili), mentre i dispersi erano stati 106.228. Complessivamente le perdite italiane nel secondo conflitto hanno dunque raggiunto (morti e dispersi, militari e civili, maschi e femmine) le 444.523 unità.
Leggi tutto
Vladimiro Giacché: La nuova via della seta
La nuova via della seta
Un progetto per molti obiettivi
di Vladimiro Giacché
Il progetto di una Nuova Via della Seta, lanciato negli ultimi anni dalla dirigenza cinese, comprende due diverse rotte, una terrestre e l’altra marittima. La prima è indicata nei documenti ufficiali come Silk Road Economic Belt, la seconda come Maritime Silk Road. L’intero progetto è espresso in forma abbreviata come One belt, one road. Esso è stato annun-ciato per la prima volta dal presidente cinese Xi Jinping in un discorso ad Astana (Kazakhstan) nel 2013, ribadito a Giacarta (Indonesia) nel novembre dello stesso anno e di nuovo ad Astana nel giugno 20141
 I precedenti
I precedenti
L’idea non è del tutto nuova: da alcuni è stata posta in continuità con i tentativi di Jiang Zemin di superare le tradizionali dispute sui confini della Cina (1996), nonché con la politica Go West di Hu Jintao2. Ovviamente il precedente storico cui si richiama è molto più illustre e lontano nel tempo: si tratta dell’antica Via della Seta, rotta commerciale che partendo dalla Cina legava Asia, Africa ed Europa. Essa risale al periodo dell’espansione verso Ovest della dinastia Han (206 a.C.-220 d.C.), che costruì reti commerciali attraverso gli attuali Paesi dell’Asia Centrale (Kyr-gyzstan, Tajikistan, Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan e Afghanistan), come pure, in direzione sud, attraverso gli attuali Stati di Pakistan e India. Tali rotte si estesero sino al-l’Europa, facendo dell’Asia centrale l’epicentro di una delle prime ondate di ‘globalizza-zione’, connettendo mercati, creando ricchezza e contaminazioni culturali e religiose. L’importanza massima di questa rotta di traffico si ebbe nel primo millennio dopo Cristo, ai tempi degli imperi romano, poi bizantino e della dinastia Tang in Cina (618-907). Fu-rono le Crociate e l’avanzata dei mongoli in Asia centrale a determinare la fine di questo percorso e la sua sostituzione con le rotte marittime, più rapide e a buon mercato3
L’antica Via della Seta evoca tuttora l’idea di uno sviluppo pacifico, di un interscambio commerciale e culturale in grado di determinare progresso per tutte le parti coinvolte. In quanto tale, il riferimento a essa è consapevolmente adoperato dall’attuale dirigenza cinese, anche in termini propagandistici e polemici. Lo dimostra il passo tratto da un opuscolo del governo cinese del 2014: «Come una sorta di miracolo nella storia umana, l’antica Via della Seta potenziò il commercio e gli interscambi culturali nella regione eurasiatica. In epoche antiche, differenti nazionalità, differenti culture e differenti reli-gioni a poco a poco entrarono in comunicazione tra loro e si diffusero lungo la Via della Seta al tintinnio dei campanacci dei cammelli.
Leggi tutto
Lorenzo Battisti: Trump, la Cina e la globalizzazione
![]()
Trump, la Cina e la globalizzazione
di Lorenzo Battisti*
 Trump viene accusato da
tempo di aver posto fine alla “magica” globalizzazione. In
realtà le sue
politiche sono il risultato dei nuovi equilibri mondiali
generati dall’emersione dei Brics e in particolare dallo
sviluppo economico e politico
della Cina.
Trump viene accusato da
tempo di aver posto fine alla “magica” globalizzazione. In
realtà le sue
politiche sono il risultato dei nuovi equilibri mondiali
generati dall’emersione dei Brics e in particolare dallo
sviluppo economico e politico
della Cina.
La globalizzazione e il neoliberismo: la fase unipolare dell’imperialismo
Molto si è scritto in questi anni sulla globalizzazione, spesso in modo fumoso. Le caratteristiche per descriverla hanno fatto riferimento ad elementi diversi e tutti parziali. Alcuni hanno preso a riferimento l’apertura agli scambi commerciali. Altri la libertà dei capitali di muoversi da un paese all’altro. Altri ancora la diffusione dell’informazione dovuta alle nuove tecnologie digitali che permettono di essere informati su fatti lontani in maniera istantanea e di creare quindi un “villaggio globale”. Tutti questi elementi, pur facendo parte della globalizzazione, non colgono la radice del fenomeno.
Penso che la globalizzazione si possa definire come l’imperialismo nella sua fase unipolare. Se prima della Seconda Guerra Mondiale l’imperialismo aveva dovuto fare fronte a divisioni interne dovute all’emersione della Germania nazista e del Giappone, dopo il ‘45 ci si è trovati in un mondo bipolare, in cui le potenze imperialiste, allineate dietro l’egemonia americana, hanno dovuto affrontare la minaccia comune proveniente dall’Unione Sovietica e dagli stati del blocco socialista. Una minaccia che, dopo il successo contro i nazisti, diventava sempre più pericolosa a causa dei successi dell’avanzata comunista: la Cina, Cuba, il Vietnam, le lotte anticoloniali etc…
Con il 1989 termina il mondo bipolare e non vi sono più limiti all’espansione economica e politica delle potenze capitaliste, Usa in testa. D’improvviso una metà di mondo, una prateria vergine, si apre all’invasione dei capitali stranieri.
Leggi tutto
Guglielmo Forges Davanzati: L’Italia e gli squilibri regionali in Europa*
L’Italia e gli squilibri regionali in Europa*
di Guglielmo Forges Davanzati
La crisi europea – intesa come incapacità dell’Unione di generare processi di convergenza fra i Paesi membri e, dunque, come crisi soprattutto dei Paesi del Sud (Italia inclusa) – viene interpretata sulla base di due tesi.
1. Si ritiene che la crisi dipenda da eccessivo debito pubblico, a sua volta ricondotto a eccessiva spesa pubblica. Si aggiunge che un elevato debito pubblico è un freno alla crescita. Ciò fondamentalmente per la seguente ragione. Se il debito pubblico aumenta, le famiglie si aspettano un aumento della tassazione futura e, per conseguenza, per pagare tasse in aumento aumentano i risparmi. L’aumento dei risparmi riduce i consumi, la domanda aggregata e il tasso di crescita. In più, l’aumento del debito fa crescere i tassi di interesse, dunque le passività finanziarie delle imprese, disincentivando gli investimenti privati e, anche per questo effetto, riduce la domanda e il tasso di crescita.
Questa è stata per molti anni la visione dominante, sulla base della quale sono state messe in atto politiche di austerità: riduzione della spesa pubblica e aumento della tassazione. Si è cioè ritenuto che, per ridurre il debito pubblico, occorreva ridurre la spesa e mettere ‘in ordine’ i conti pubblici. Come diffusamente dimostrato sul piano teorico ed empirico, tuttavia, e come peraltro riconosciuto da importanti istituzioni internazionali (OCSE in primis), le misure di austerità fanno semmai crescere il rapporto debito/Pil (perché la riduzione della spesa pubblica riduce il denominatore più di quanto riduce il numeratore).
Leggi tutto
Pino Arlacchi: Libia: l'intervento NATO che bombardò la ragione
Libia: l'intervento NATO che bombardò la ragione
di Pino Arlacchi
L’attacco alla Libia del 2011 è forse il più lampante esempio dell’inganno che si nasconde dietro gli interventi umanitari e di promozione della democrazia intrapresi di recente e progettati per il futuro.
Come nel Kosovo 12 anni prima, i bombardamenti NATO in Libia furono giustificati con l’urgenza di impedire uno sterminio di innocenti. Secondo l’allarme lanciato dai media e dai governi europei le truppe di Gheddafi stavano per compiere un bagno di sangue a Bengasi, l’ultima roccaforte dei ribelli antigovernativi ispirati dalla Primavera araba. L’intervento militare fu rapidamente autorizzato dal Consiglio di Sicurezza.
Il suo scopo doveva essere quello di salvare le vite di migliaia di dimostranti per la democrazia dalla brutalità delle forze armate di Gheddafi, composte in larga parte da mercenari di pelle scura che si erano macchiati di stupri di massa.
L’aviazione del regime aveva usato elicotteri d’assalto e caccia da combattimento per falciare civili inermi, ed erano già perite migliaia di persone.
Due giorni dopo l’autorizzazione ONU del 17 marzo 2011, fu stabilita la no-fly zone e la NATO iniziò a bombardare. Grazie al martellamento aereo, e al sostegno logistico dei paesi europei, dopo solo sette mesi i ribelli avevano assunto il controllo della Libia ed eliminato fisicamente Gheddafi.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Ti conosco mascherina
Ti conosco mascherina
di Pierluigi Fagan
Premetto subito che su Isis ho un apriori dovuto allo studio specifico del fenomeno condotto a partire da quattro-cinque anni fa. Per me, Isis è uno strumento geopolitico in mano all’Arabia Saudita, niente di più, niente di meno. Scrissi già allora che quando la strategia territoriale ovvero l’improbabile costituzione di uno stato islamico siro-iracheno, fosse fallita, sarebbe rimasta una forte rete attiva di terroristi da usare con precisione chirurgica a fini geo-politici e di egemonia dello strato salafita sparso in tutto l'islam. L’Isis vale molto più che l’atomica per fare geo-politica e che dietro l’Isis ci sia l’Arabia Saudita, ritengo sia tesi incontrovertibile, lo era quattro anni fa, i quattro anni passati non hanno fatto altro che corroborare la tesi che ormai è nota ai più, anche se fanno finta di non saperlo. Veniamo dunque al caso Sri Lanka.
E’ opportuno sapere che la presenza musulmana nell’Asia del Sud, deriva dai continui viaggi dei commercianti arabi durante tutti i secoli addietro. Se ne deduce che troverete presenza musulmana più che altro sulle coste e sulle isole. Saprete anche che coste ed isole del’Asia del Sud, sono obiettivo della strategia Belt and Road Initiative cinese, in cui lo Sri Lanka ha un ruolo privilegiato. Ovviamente è superfluo ricordare che coi cinesi c’è anche il dente avvelenato su gli uiguri.
Leggi tutto
Agostino Spataro: Conflitti e migrazioni, le relazioni fra Italia e Libia
Conflitti e migrazioni, le relazioni fra Italia e Libia
di Agostino Spataro
1… Se il conflitto libico dovesse acuirsi - ha avvertito (o minacciato?) Serraj - migliaia di libici e non solo si riverserebbero in Italia. Ecco, ci risiamo: per spingere l’Italia a entrare direttamente nel conflitto interno libico si continua con il gioco dei ricatti. La politica, la diplomazia, la dignità dei popoli sono state sostituite dal ricatto e, talvolta, dalla corruzione. In Libia e altrove. Anche questo è un segno inquietante dei tempi tristi che stiamo vivendo.
L’Italia non deve ingerirsi, ma agire affinché in Libia cessi il conflitto e vincano la pace e la concordia nazionale. In caso contrario, di fronte alla fuga di profughi, certo, non si potranno chiudere i porti anche se non sta scritto in nessun libro che devono accollarseli tutti l’Italia e l’Europa.
Saremmo di fronte ad una nuova emergenza umanitaria internazionale che, in quanto tale, va affrontata in un quadro di responsabilità internazionale,in ambito Onu e in altri, ripartendone il carico, in misura proporzionata, ai Paesi europei ed arabi, in primo luogo a quelli che hanno provocato e alimentato il conflitto. Poiché deve finire questa storia che ci sono alcuni governi che accendono l’incendio e poi lasciano ad altri l’onere di riparare i danni. Si dovrebbe introdurre una norma che obblighi gli Stati bellicisti a far fronte alle conseguenze derivate in termini di accoglienza dei profughi e di ricostruzione delle città, delle economie distrutte.
Leggi tutto
Epimeteo: Rita Di Leo: la vittoria del "sacro esperimento" sull'"esperimento profano"
Rita Di Leo: la vittoria del "sacro esperimento" sull'"esperimento profano"
di Epimeteo
 Era qualche tempo che non si
leggevano i libri della Di Leo; ci si diceva: “È finita
l’Urss, cos’avrà
da dire di nuovo la Di Leo?” Poi l’anno scorso è uscito L’età
della moneta. I suoi uomini, il suo spazio, il suo
tempo, per i tipi del Mulino, ed è stato davvero una
sorpresa: ne veniva fuori una grande capacità di delineare i
tratti
fondamentali del capitalismo nella sua ultima fase, quella
successiva al crollo dell’Urss e corrispondente al pieno
dispiegamento della
globalizzazione e della finanziarizzazione, ma emergeva anche
la profondità con la quale l’autrice sapeva scavare nei
presupposti
antropologici di quell’”universo degli algoritmi”. Allora
abbiamo deciso di leggere anche due libri editi
precedentemente,
cioè Cento anni dopo: 1917-2017. Da Lenin a Zuckerberg,
uscito nel 2017, e L’esperimento profano. Dal capitalismo
al
socialismo e viceversa del 2012, entrambi editi da
Ediesse.
Era qualche tempo che non si
leggevano i libri della Di Leo; ci si diceva: “È finita
l’Urss, cos’avrà
da dire di nuovo la Di Leo?” Poi l’anno scorso è uscito L’età
della moneta. I suoi uomini, il suo spazio, il suo
tempo, per i tipi del Mulino, ed è stato davvero una
sorpresa: ne veniva fuori una grande capacità di delineare i
tratti
fondamentali del capitalismo nella sua ultima fase, quella
successiva al crollo dell’Urss e corrispondente al pieno
dispiegamento della
globalizzazione e della finanziarizzazione, ma emergeva anche
la profondità con la quale l’autrice sapeva scavare nei
presupposti
antropologici di quell’”universo degli algoritmi”. Allora
abbiamo deciso di leggere anche due libri editi
precedentemente,
cioè Cento anni dopo: 1917-2017. Da Lenin a Zuckerberg,
uscito nel 2017, e L’esperimento profano. Dal capitalismo
al
socialismo e viceversa del 2012, entrambi editi da
Ediesse.
Da quella sorta di trilogia è emerso un quadro unitario in cui viene ricostruita l’intera storia del Novecento alla luce dello scontro globale tra il socialismo sovietico e il capitalismo europeo prima, quello americano poi, una analisi che si riassume in una interpretazione della contemporaneità appunto come “età della moneta”, come quell’arco temporale ormai trentennale in cui si è imposto quell’”equivalente generale” che consente l’universalizzazione dello scambio, in funzione della valorizzazione del capitale, come modalità imprescindibile delle relazioni infra-umane, una universalizzazione attorno alla quale si condensa l’identità antropologica dell’individuo post-economico del “fare per avere”, in cui lo scambio tra il più forte e il più debole non viene subìto dal secondo, ma accettato come un fenomeno naturale.
Tuttavia, prima di ricostruire come l’autrice illustra lo scontro tra “l’esperimento profano” del socialismo e il “sacro esperimento” del capitalismo americano, nella prima parte di questo tentativo di interpretazione unitaria dei tre testi della Di Leo cercheremo di delineare come l’ex “esperta dell’Urss” ha seguito il percorso attraverso il quale l’”uomo della moneta”, muovendo i suoi primi passi nell’Europa feudale, ha saputo acquisire cultura e potere e progressivamente intrecciare il suo destino con quello dell’aristocrazia guerriera e fondiaria, transitando attraverso quell’”epoca moderna” che Epimeteo interpreta come “messianesimo immanentizzato”, un’ipotesi ermeneutica che si è già cercato di argomentare in altri interventi su questo sito.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Appunti sulla questione del partito: oltre il primo populismo
Appunti sulla questione del partito: oltre il primo populismo
di Alessandro Visalli
 In questo testo, forse troppo
lungo (6.700 parole, 25 minuti di lettura), si compie un
esercizio non facile,
decisamente inattuale: quello di provare a ripensare le
condizioni nelle quali si può tentare di oltrepassare
l’impolitico neoliberale a
partire dalla ricostruzione di un collettivo ed insieme di un
umano. Questo tema è limitato alla ‘questione del partito’,
ovvero
dell’agente del politico concepito come trasformazione
dell’esistente e levatore del nuovo, e non come mimesi e
aspirazione al mero
successo. Il discorso connette sistematicamente i mutamenti
nel modo di produzione e della ‘piattaforma tecnologica’ del
capitalismo, e
quindi dell’antropologia dominante e delle forme di
socializzazioni corrispondenti, con le forme-partito di volta
in volta funzionali.
In questo testo, forse troppo
lungo (6.700 parole, 25 minuti di lettura), si compie un
esercizio non facile,
decisamente inattuale: quello di provare a ripensare le
condizioni nelle quali si può tentare di oltrepassare
l’impolitico neoliberale a
partire dalla ricostruzione di un collettivo ed insieme di un
umano. Questo tema è limitato alla ‘questione del partito’,
ovvero
dell’agente del politico concepito come trasformazione
dell’esistente e levatore del nuovo, e non come mimesi e
aspirazione al mero
successo. Il discorso connette sistematicamente i mutamenti
nel modo di produzione e della ‘piattaforma tecnologica’ del
capitalismo, e
quindi dell’antropologia dominante e delle forme di
socializzazioni corrispondenti, con le forme-partito di volta
in volta funzionali.
Dopo alcuni indispensabili cenni storici, per lo più in nota per non appesantire il testo, e l’esplicitazione delle condizioni abilitanti i ‘partiti leggeri’ che hanno molte applicazioni e travestimenti, viene sviluppata una critica del primo populismo, strutturalmente connesso alla ‘contro-democrazia’, a sua volta figlia della ‘accumulazione flessibile’. Anche qui le forme ed i travestimenti sono numerosi.
Viene quindi avanzata l’ipotesi che la crisi del primo populismo, in tutte le sue versioni, non sia episodica ma venga mossa nella profondità da una estremizzazione-mutamento della ‘piattaforma tecnologica’ post-moderna e resti quindi non più allineata con l’estrema polarizzazione, da un lato, e con l’interconnessione molecolare determinata dall’ambiente tecnologico, dall’altra. La tesi è che il nuovo ambiente non si presti più alla strategia “tutta testa e comunicazione” del populismo in stile sudamericano (per quanto questo sia largamente fondato su una socialità popolare vitale) e/o di prima generazione europeo (ben meno vitale), ma renda nuovamente necessaria la presenza di attivisti, influencer, reti di comunicazione diffuse, mobilitazioni politiche e quindi cultura comune e condivisa, ‘simpatia’, coesione, responsabilità e mutuo sostegno.
Leggi tutto
Norberto Natali: Fine della sinistra italiana
Fine della sinistra italiana
di Norberto Natali
I fatti avvenuti nelle scorse settimana a Roma rappresentano un discrimine fondamentale per la sinistra. Ci sono nella storia dei momenti in cui, anche simbolicamente, si determina un cambiamento. Fu così, ad esempio, per la marcia dei 40 mila a Torino. Quello che è successo a Roma ci costringe ad aprire una riflessione. Ringraziamo il compagno Norberto Natali per questo suo contributo
 Appunti
sui fatti di Torre Maura e Casalbruciato. Proposte di
discussione contro i
“monatti” del movimento operaio in Italia
Appunti
sui fatti di Torre Maura e Casalbruciato. Proposte di
discussione contro i
“monatti” del movimento operaio in Italia
1. La verità mediatica
Le forze di sinistra e più conseguentemente antifasciste, la grande stampa e radio tv più democratica (come il gruppo “Repubblica-La Stampa” o “Corsera” o conduttori come Corrado Formigli) mercoledì scorso (10 aprile 2019) si sono scatenati: dure proteste, articoli infuocati e pieni di ardore, cortei e scioperi.
Tutto ciò era giustificato: un povero operaio di 25 anni -Gabriele Di Guida- era morto schiacciato, in una fabbrica della Brianza per colpa del padronato. Il macchinario al quale era addetto, infatti, era difettoso (quindi non è stata una disgrazia accidentale ed imprevedibile) e si può immaginare la paura e la solitudine di questo ragazzo, poiché il suo ultimo atto è stato un sms alla propria fidanzata: “questa macchina non funziona bene”.
Per questo il Presidente del Consiglio è andato a visitare quella ragazza rimasta sola prima di avere una propria famiglia (comprensibilmente si è commosso incontrando la mamma di Gabriele) e il ministro dell’Interno ha tuonato sui social: “gli infami che per guadagnare di più uccidono giovani come Di Guida non devono uscire più di galera”.
Lo sdegno e la mobilitazione della grande stampa e della sinistra -Luca Casarini in testa- per questo fatto sono stati tali che hanno messo in ombra un altro grave avvenimento di quel giorno: a Casalbruciato (Roma) alcune decine di persone, della stessa classe sociale del giovane morto in Brianza, hanno impedito a un rom di accedere ad una casa del comune, sobillati dai fascisti col motivo di voler attribuire quell’alloggio ad una ragazza, madre di un bambino di pochi mesi il cui padre è un operaio precario (forse candidato alla stessa fine orribile che ogni anno tocca a migliaia di lavoratrici e lavoratori).
Leggi tutto
coniarerivolta: Il debito pubblico giapponese e noi
Il debito pubblico giapponese e noi
di coniarerivolta
Vi sono situazioni in cui, immersi in un grosso problema, vediamo plasticamente la sua limpida soluzione, che appare tuttavia subordinata ad una qualche condizione esterna insormontabile. Al realizzarsi di questa, quel problema smetterebbe di esistere. Spesso ci si accorge che siamo noi, in realtà, ad aver prodotto una condizione da cui non riusciamo a liberarci, ed essa diventa così un’artificiale camicia di forza. Particolarmente interessante, anche nella storia dei fenomeni sociali, è il caso in cui l’evidenza di un problema sia tanto chiara quanto quella del vincolo che a priori impedisce di risolverlo. Tuttavia, considerando irrazionalmente quel vincolo come una variabile data e indiscutibile, si resta incagliati in una catena illogica e viziosa. Numerosi ragionamenti della scienza economica spesso finiscono in un simile vicolo cieco argomentativo, che rivela la povertà e l’inconsistenza di molte analisi che si avvitano su sé stesse.
L’appartenenza all’Unione Europea è una di quelle certezze che semplicemente vengono date per scontate. La legittimità di discettare delle possibili opzioni politiche si estende spesso nei consessi pubblici soltanto entro il perimetro prestabilito delle prescrizioni dei Trattati europei. Ogni idea che violi in modo serio quel perimetro viene definita irrealizzabile in taluni casi, derubricata a intemperanza o follia populista/nazionalista in altri, o semplicemente ignorata. Questo modus pensandi costruito sull’esistenza di un vero e proprio tabù lo si coglie continuamente nei dibattiti pubblici o negli articoli di giornale.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: La mezza conversione di Alesina e Giavazzi
La mezza conversione di Alesina e Giavazzi
di Giuseppe Masala
Articolo interessante di Giavazzi e Alesina sul Corriere della Sera di ieri. Interessante perché nella narrazione economara (non crederete di capire davvero di sostenibilità del debito pubblico perché ripetete a pappardella le sciocchezze che vi propinano da trenta anni sul rapporto debito/pil?) finalmente viene introdotto il concetto di "debito estero" ammettendo che l'Italia ha una Posizione Finanziaria Netta in sostanziale pareggio come vado a dire (umilmente) io da qualche anno. Cito testualmente il duo bocconiano: <<L’Italia non ha un debito estero netto perché i prestiti che Stato e aziende private hanno contratto fuori dall’italia sono compensati da altrettanti titoli esteri acquistati dalle famiglie e dalle nostre banche. Basterebbe azzerare queste posizioni — cioè vendere i titoli esteri che possediamo e ricomprarci i Btp detenuti all’estero — per diventare il Giappone. A quel punto potremmo permetterci di aumentare la spesa pubblica e al tempo stesso ridurre le tasse, lasciando crescere il debito.>>. E poi ancora:<<Tutto ciò è possibile, ma vorrebbe dire uscire dall’euro che è nato per fare il contrario: integrare i mercati dei capitali dell’Eurozona e diversificare il rischio distribuendolo nell’area.>>
Leggi tutto
Marco Travaglio:Liberisti coi soldi altrui
Liberisti coi soldi altrui
di Marco Travaglio
Uffa, che barba, che noia. I radicali e i loro seguaci, anche strumentalizzando la scomparsa del nostro carissimo nemico Massimo Bordin, hanno ricominciato a piangere. Il chiagni e fotti è il loro sport preferito, che rende petulante e insopportabile ogni loro battaglia, anche la più nobile.
Sempre lì a lacrimare contro il “regime”, di cui fanno parte integrante da cinquant’anni. Non chiedono mai per favore: pretendono, anzi esigono, come se tutto fosse loro dovuto, dalle amnistie alle svuota-carceri ai soldi per Radio Radicale. E, quel che è bizzarro per dei soi disant “liberisti e libertari”, lo esigono dallo Stato “illiberale e partitocratico” contro cui si scagliano dalla notte dei tempi.
L’ultima loro battaglia meritoria fu il referendum (vinto, anzi stravinto e subito tradito) del 1993 per abolire il finanziamento pubblico dei partiti: noi, ingenuamente, pensavamo che comprendesse il finanziamento pubblico agli organi di partito. Invece no: Radio Radicale fa sempre eccezione. Infatti costa ai cittadini una media di 14 milioni di euro all’anno, in virtù di due diverse fonti di finanziamento: una (circa 4 milioni l’anno) dal Dipartimento editoria di Palazzo Chigi per le “fonti d’informazione di interesse generale”; l’altra (una decina di milioni l’anno) dal ministero delle Poste (ora assorbito dallo Sviluppo economico), in seguito a una convenzione stipulata da Pannella con l’allora ministro Tatarella, sotto il primo governo Berlusconi (regolarmente appoggiato da Pannella, Bonino & C.), poi sempre rinnovata dal centrosinistra (regolarmente appoggiato da Pannella, Bonino & C.).
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Pensare a come pensiamo
Pensare a come pensiamo
di Pierluigi Fagan
L’articolo è pubblicato sul blog del Festival della Complessità (qui) e presenta la prossima edizione (la decima) che si aprirà a Roma, il 10 Maggio. La sessione di apertura e l’intera edizione, verterà su questo duplice invito alla riflessione
“Credo che il sapere,
nelle nostre società, sia diventato attualmente qualcosa
di così ampio e di così complesso da essere ormai il vero
inconscio
delle nostre società. Noi non sappiamo davvero quel che
sappiamo, non conosciamo quali siano gli effetti del
sapere. Per questo mi sembra che
l’intellettuale possa assolvere il ruolo di colui il quale
trasforma questo sapere, che domina come l’inconscio delle
nostre
società, in una coscienza”
M. Foucault
1978
Il pensiero è oggi
più che mai il capitale più prezioso per l’individuo e la
società.
E. Morin, La testa ben
fatta, 1999
E’ questo il titolo della Xa edizione del nostro festival diffuso e sarà questo il titolo dell’apertura della sessione che terremo a Roma, al museo MACRO, il 10 Maggio. Forse avremmo potuto scegliere un titolo meno esoterico, forse avremmo potuto agganciarci a qualche tema della vivace attualità che pullula intorno a noi, ma abbiamo scelto di dar seguito ad un richiamo forte che sentiamo come pensatori di complessità, un tema più attuale di tutti gli altri e che tutti i fatti nuovi che pullulano intorno a noi, comprende.
Leggi tutto
Hits 3052
Hits 2884
Hits 2747
Hits 2667
Hits 2535
Hits 2449
Hits 2396
Hits 2327
Hits 2295
Hits 2255
tonino

Carlo Galli: Apologia della sovranità
Apologia della sovranità
di Carlo Galli
Si presentano qui alcune argomentazioni che sono svolte più largamente in C. Galli, Sovranità, Bologna 2019, il Mulino. La sovranità è condizione dell’esistenza di ogni corpo politico. Compresa l’Italia, che ne è assai carente. I limiti inevitabili del suo esercizio, dettati dal contesto. Le polemiche sul “sovranismo” in nome degli “Stati Uniti d’Europa”, metafora ipersovranista
 1. La sovranità è il modo in cui
un corpo politico si rappresenta (o si presenta) per esistere,
per volere,
per ordinarsi e per agire secondo i propri fini. Va quindi
considerata nella sua complessità: nel fuoco della sovranità
si forgiano i
concetti politici moderni, e i conflitti storici reali.
1. La sovranità è il modo in cui
un corpo politico si rappresenta (o si presenta) per esistere,
per volere,
per ordinarsi e per agire secondo i propri fini. Va quindi
considerata nella sua complessità: nel fuoco della sovranità
si forgiano i
concetti politici moderni, e i conflitti storici reali.
La sovranità è un punto, l’Unità, il vertice del comando, una volontà politica che pone la legge; ma al tempo stesso è una linea chiusa, una figura geometrica, il perimetro dell’ordinamento giuridico e istituzionale vigente, dello spazio in cui la legge si distende; e al contempo è un solido, una sfera di azioni e reazioni sociali, un corpo vivente e plurale che nella sovranità produce sé stesso: un popolo, una cittadinanza. La sovranità è tanto il soggetto collettivo che agisce unitariamente quanto lo strumento istituzionale dell’azione del corpo politico.
Da ciò alcune considerazioni: in primo luogo, come non esiste un’anima senza corpo, né un corpo vivente senz’anima, così non esiste una sovranità senza il corpo politico di cui è l’impulso vitale, né un corpo politico privo di sovranità.
In secondo luogo, la sovranità, rispetto alla sfera pubblica, alla sua esistenza e alle sue dinamiche, è al tempo stesso condizione e risultato. La sovranità rende possibile la distinzione fra pubblico e privato, realizzando la protezione pubblica delle vite e dei beni privati, oltre che l’utilità, il benessere, la prosperità dell’intero corpo politico. E questa sfera pubblica, questo corpo politico, non è necessariamente un’identità tribale, una compatta comunità; è una società complessa, attraversata da tensioni e conflitti, che nella sovranità si esprime politicamente.
In terzo luogo, la dinamica storica della sovranità è data dalle prevalenze politiche che si instaurano fra le tre dimensioni già ricordate: avremo così la sovranità del monarca, dello Stato, della legge, del popolo. La forza sociale e politica di volta in volta egemonica dentro lo spazio della sovranità è portatrice anche della legittimità di cui la sovranità ha bisogno: la legittimità è la ragione per la quale si chiede e si concede obbedienza.
Leggi tutto
Militant: Storia dell’immigrazione straniera in Italia
Storia dell’immigrazione straniera in Italia
Consigli (o sconsigli) per gli acquisti
di Militant
 Un libro da
masticare con attenzione, rispettandone la complessità e
l’articolazione. Riassunto in poche suggestioni, che non ne
rendono merito del carattere esaustivo che offre e forse
neanche della sua
angolazione originale (rispetto all’approccio umanitario che
solitamente ammanta la letteratura progressista sul tema), ci
limitiamo a
ricordare, come premessa logica, che le migrazioni siano state
una costante, nel percorso dell’umanità, e che – dall’inizio
dello sviluppo del capitalismo – non abbiano sempre conosciuto
l’ostilità della classe politica, ma siano state addirittura
incentivate nelle fasi economiche in cui era necessario
disporre di manodopera a basso prezzo. In questi casi,
addirittura, i flussi migratori
“disinnescavano” delocalizzazione delle aziende e
decentramento produttivo, quando questi risultavano meno
profittevoli (come sta
accadendo ai giorni nostri, per dire).
Un libro da
masticare con attenzione, rispettandone la complessità e
l’articolazione. Riassunto in poche suggestioni, che non ne
rendono merito del carattere esaustivo che offre e forse
neanche della sua
angolazione originale (rispetto all’approccio umanitario che
solitamente ammanta la letteratura progressista sul tema), ci
limitiamo a
ricordare, come premessa logica, che le migrazioni siano state
una costante, nel percorso dell’umanità, e che – dall’inizio
dello sviluppo del capitalismo – non abbiano sempre conosciuto
l’ostilità della classe politica, ma siano state addirittura
incentivate nelle fasi economiche in cui era necessario
disporre di manodopera a basso prezzo. In questi casi,
addirittura, i flussi migratori
“disinnescavano” delocalizzazione delle aziende e
decentramento produttivo, quando questi risultavano meno
profittevoli (come sta
accadendo ai giorni nostri, per dire).
Nello specifico del nostro Paese, le migrazioni hanno sempre accompagnato la storia italiana, soprattutto se considerate nella loro complessità e non solo secondo la direttrice Maghreb-Italia, con le modalità inevitabilmente disperanti e disperate dei barconi. Le migrazioni interne dell’Italia del secondo dopoguerra, alla ricerca di opportunità di vita dopo le distruzioni del conflitto, gli ex soldati, i prigionieri di guerra, gli ebrei di passaggio verso la Palestina, gli “esuli” provenienti dalle aree restituite alla Jugoslavia dopo l’italianizzazione forzata del fascismo, i primi spostamenti all’estero per motivi di lavoro… delineano un quadro assai ricco e una estrema vivacità del contesto sociale, più secondo linee di qualità che non di quantità, comunque, dato che le statistiche ufficiali parlano solo dello 0,10% di stranieri sull’intera popolazione italiana ancora nel 1951, in una quota inferiore persino alla percentuale registrata durante l’autarchico fascismo (erano lo 0,20% nel 1930). Già alla metà del XX secolo, quindi, la questione immigrazione in Italia si poneva con una centralità non giustificata dai numeri, quanto da aspetti extra-statistici: la tipologia di chi giungeva nel Paese (con storie politiche spesso assai delicate, come nel caso del grumo di potere reazionario rappresentato dagli esuli giuliano-dalmati), la loro distribuzione sul territorio nazionale, l’incapacità italiana di predisporre un’accoglienza decente anche per gruppi di immigrati tutto sommati numericamente limitati.
Leggi tutto
Dino Greco: Rompere gli schemi
Rompere gli schemi
di Dino Greco
Di seguito l'intervento svolto da Dino Greco del Cpn di Rifondazione comunista, alla tavola rotonda La svolta populista: un anno di governo giallo-verde, con Leonardo Mazzei, Stefano Fassina, Domenico Moro, Bruno Steri, svoltasi a Roma sabato 13 aprile in occasione del convegno “Eurexit, quali strategie per la liberazione”. Il giudizio severissimo sul governo giallo-verde nulla toglie all'alto spessore politico e teorico della prolusione di Greco
 Lo stato
tutt’altro che rassicurante delle cose è ben rappresentato dal
grottesco appello congiunto sottoscritto da Cgil- Cisl-Uil in
vista delle elezioni europee.
Lo stato
tutt’altro che rassicurante delle cose è ben rappresentato dal
grottesco appello congiunto sottoscritto da Cgil- Cisl-Uil in
vista delle elezioni europee.
In esso si legge, testualmente:
“L’Ue è stata decisiva nel rendere lo stile di vita europeo quello che è oggi. Ha favorito un progresso economico e sociale senza precedenti con un processo di integrazione che favorisce la coesione fra Paesi e la crescita sostenibile. Continua a garantire, nonostante i tanti problemi di ordine sociale, benefici tangibili e significativi, nella comparazione internazionale, per i cittadini, i lavoratori e le imprese in tutta Europa”.
E ancora:
“La risposta non è battere in ritirata, ma rilanciare l’ispirazione originaria dei Padri e delle Madri fondatrici, l’ideale degli Stati Uniti d’Europa (…)”.
Per fare cosa? Ecco qua: per contrastare “quelli che intendono mettere in discussione il Progetto europeo, vogliono tornare all’isolamento degli Stati nazionali, alle barriere commerciali, ai dumping fiscali, alle guerre valutarie, richiamando in vita gli inquietanti fantasmi del Novecento”.
Insomma, viene da chiosare: “padroni e lavoratori uniti nella lotta”. Manco a dirlo, “per la competitività internazionale”.
Questo perfetto manifesto della subalternità del sindacato al capitale (giustamente ripreso con enfasi da Il sole 24 ore) che mi autoassolvo dal commentare, dà l’idea di quanto sia esteso il perimetro dentro il quale si è consumato — prima in modo camuffato, ora del tutto esplicito — il consenso alle politiche liberiste, all’ordoliberismo, al quale coerentemente non si oppone lo straccio di una mobilitazione proprio da parte dei soggetti sociali che se la dovrebbero intestare, che ne dovrebbero essere i protagonisti.
Leggi tutto
coniarerivolta: Germania: chi semina sfruttamento raccoglie crisi
Germania: chi semina sfruttamento raccoglie crisi
di coniarerivolta
Secondo la saggezza popolare, l’erba del vicino è sempre più verde. Un caso di scuola di questo luogo comune si dà quando si discute della Germania e del suo modello economico. Quale che sia il tema specifico, il sottotesto ci parla sempre della supremazia tedesca dal punto di vista tecnologico, culturale ed economico, un risultato ottenuto a seguito di taumaturgiche riforme e che permette alla Germania di fare da locomotiva per la crescita di tutta l’Europa. Se questo è il mito, la realtà ci offre tuttavia uno spaccato leggermente diverso. Ai racconti di un’economia vitale e rigorosa, che dovrebbe fungere da esempio terapeutico per tutti i Paesi mediterranei, si stanno pian piano sovrapponendo cronache più nefaste: la Germania starebbe finendo in recessione. Stando alla lettura dei media, la frenata dell’economia tedesca deriverebbe, da un lato, dal rallentamento della domanda internazionale e, dall’altro, dal ‘complesso adeguamento dell’industria dell’auto ai più rigidi standard europei di emissione dei motori diesel’. Come vedremo, però, si tratta di una spiegazione parziale e che nasconde le cause più profonde e sistemiche, che hanno le loro radici in uno scellerato modello di crescita per sua natura insostenibile, basato sulla compressione salariale e sulla disponibilità di altri paesi a continuare comprare le merci prodotte internamente.
Leggi tutto
Federico Dezzani: Sri Lanka: pirateria lungo la Via della Seta
Sri Lanka: pirateria lungo la Via della Seta
di Federico Dezzani
Il giorno di Pasqua l’ex-colonia britannica di Ceylon è stata sconvolta da serie di attentati senza precedenti: a Colombo e in altre due località si contano quasi trecento vittime dopo le violente esplosioni che hanno devastato chiese e alberghi. Le autorità attribuiscono la responsabilità della strage ad un gruppuscolo islamista, ma mettono bene in evidenza le complicità a livello internazionale: in un Paese senza storia di terrorismo islamico alla spalle, è inverosimile che una sigla quasi sconosciuta compia un’impresa così sofisticata. Dietro la strage è leggibile la volontà di indebolire l’industria turistica e destabilizzare la politica cingalese: Colombo, infatti, è tra le nazioni dell’Oceano Indiano più inserite nella Via della Seta Cinese. I precedenti di Malesia e Birmania.
Behemoth cinese contro Leviatano angloamericano
Il giorno di Pasqua è stato un giorno di sangue in Sri Lanka, ex-colonia britannica (21 milioni di abitanti) strategicamente posizionata davanti alle coste indiane: una sofisticata serie di attentati ha colpito la capitale Colombo (almeno 82 morti), la città di Negombo (almeno 104 morti) e la città sulla costa orientale di Batticaloa (almeno 28 morti). Luoghi di culto cristiani (nel Paese a maggioranza buddista, circa l’8% della popolazione professa la religione cristiana ed un 9% è di fede mussulmana) e alberghi sono finiti nel mirino degli attentatori, causando vittime locali e straniere.
Leggi tutto
Mario Gangarossa: Democrazia e fascismo
Democrazia e fascismo
di Mario Gangarossa
Ripubblico questo testo del 25 febbraio 2018 per chi ha voglia di leggere...
Lo scontro non è fra democrazia e fascismo. L'antifascismo è l'anticamera dell'anticomunismo.
Nè Mussolini nè Hitler sono andati al potere per via "rivoluzionaria". La "marcia su Roma" fu poco più di una scampagnata e lo stesso Mussolini era così poco convinto delle capacità golpiste delle sue camicie nere da starsene al confine con la Svizzera, pronto a scappare al primo segno di resistenza democratica. Entrambi usarono la "libere elezioni" per raggiungere i loro obiettivi. Hitler non si prese nemmeno la briga di cambiare o abolire la costituzione democratica di Weimar, si limitò ad applicarne l'articolo 48 che dava al Presidente poteri eccezionali. La democrazia non è stata mai il baluardo della lotta antifascista. Semmai e proprio sul suo terreno che le forze fasciste si sono sviluppate e sono cresciute. La borghesia italiana e tedesca, rimasero fasciste fin quando fu chiaro che, nello scontro fra gli imperialismi, "il fronte del mondo libero" a guida anglo-americana potenzialmente stava vincendo. A quel punto divenne "partigiana" e "antifascista" affrettandosi a mettere il cappello su una guerra che altri avevano subito. La costituzione repubblicana fu il nuovo patto fra i padroni italiani e l'imperialismo vincitore. Fu lo strumento attraverso il quale il capitalismo italiano sconfitto si riposizionò nell'arena mondiale ricostruendo la sua "verginità" e il suo ruolo imperialista.
Leggi tutto
Rick Nagin: Chi ha fallito, il capitalismo o il socialismo?
Chi ha fallito, il capitalismo o il socialismo?
di Rick Nagin
La ripresa della propaganda anticomunista negli USA è la risposta dei media e degli intellettuali organici alle classi dominanti ma gli argomenti utilizzati mostrano le debolezze e le contraddizioni di sempre
Recentemente, quasi ogni numero del Wall Street Journal esce con un tentativo di contrastare il crescente supporto pubblico al socialismo, e questa è la migliore dimostrazione che Marx ed Engels ci avevano visto giusto quando scrissero nel Manifesto del Partito Comunista che lo spettro del comunismo perseguita sempre la classe dominante.
L'ultima incursione nella campagna lanciata dal quotidiano finanziario è un pezzo patetico uscito lo scorso 10 aprile, firmato da Joshua Muravchik, dal titolo: “Il Socialismo fallisce sempre”. Muravchik è un neoconservatore ortodosso che si era già distinto per aver invocato una non provocata guerra aerea americana contro l'Iran. Si guadagna da vivere esercitando la professione di anticomunista e da sedicente “eminente studioso” presso vari think tank aziendali. Evidentemente deve essere mosso da un senso di colpa per aver creduto nel socialismo quando guidò la Lega dei Giovani Socialisti tra la fine degli anni '60 e l'inizio degli anni '70; in seguito fu attivo nelle file dei socialdemocratici statunitensi, virulentemente anticomunisti e strettamente legati alla CIA.
Leggi tutto
Giuseppe Cospito: Senso comune/buon senso
Senso comune/buon senso
di Giuseppe Cospito*
 1. Prima dei Quaderni
1. Prima dei Quaderni
Prima di affrontare il tema nei Quaderni, farò un breve cenno all’uso dei termini che ci interessano negli scritti di Gramsci precedenti la carcerazione e nella cultura italiana ed europea del tempo.
1.1 Gli scritti politici
Negli articoli giornalistici fin dal 1916 troviamo numerose occorrenze dei lemmi buon senso e senso comune . Non si tratta di accezioni particolarmente rilevanti in quanto non si distaccano sostanzialmente dall’uso corrente, che le considera sostanzialmente sinonime. Si possono ricondurre ad alcune tipologie che esemplifico citandone la prima occorrenza significativa, nell’ordine cronologico con cui compaiono negli scritti gramsciani:
a) connessa al comune sentire estetico-morale (intesi rispettivamente come buon gusto e senso del pudore), frequente nelle recensioni della rubrica Teatri: per esempio, di una commedia si dice che «è un’offesa al buon gusto e al senso comune»1;
b) vicina all’accezione invalsa nel lessico filosofico moderno da Descartes in avanti (bon sense, common sense), come quando Gramsci scrive che «la religione è un bisogno dello spirito. Gli uomini si sentono spesso così sperduti nella vastità del mondo, si sentono così spesso sballottati da forze che non conoscono, il complesso delle energie storiche così raffinato e sottile sfugge talmente al senso comune, che nei momenti supremi solo chi ha sostituito alla religione qualche altra forza morale riesce a salvarsi dallo sfacelo»2;
c) contrapposta alle astrusità e ai tecnicismi degli pseudo-saperi scientifici, contro i quali si chiede «meno pseudo-scienza, e più senso comune, e soprattutto più affetto e sincerità»3;
d) ancora più generica e corriva, come quando Gramsci invoca «parole che siano condite di buon senso»4;
A partire dal 1917 si aggiunge alle precedenti (che continuano a ricorrere negli scritti gramsciani) un’ulteriore accezione:
Leggi tutto
Ernesto Screpanti: Prefazione a "Il discorso del potere"
![]()
Prefazione a "Il discorso del potere"
di Ernesto Screpanti
Giacomo Bracci - Emiliano Brancaccio: Il discorso del potere. Il premio Nobel per l’Economia tra scienza, ideologia e politica, Il Saggiatore, Milano 2019
 Nel 1974 l’Accademia delle scienze
di Svezia assegnò il premio Nobel per l’Economia a Friedrich
von
Hayek, per aver scoperto che i fenomeni economici, sociali e
istituzionali sono interdipendenti. Nel 1976 il premio fu
assegnato a Milton Friedman, il
cui principale merito scientifico starebbe nell’aver compreso
che, se si fa l’ipotesi eroica che un’economia di mercato si
trovi in
uno stato di piena occupazione permanente, si può dimostrare
che una politica di espansione monetaria non può fare
aumentare
l’occupazione in modo permanente. Da Lucas a Sargent, passando
per Prescott, negli anni successivi altri padri di analoghe
scoperte hanno
raggiunto la vetta del Nobel.
Nel 1974 l’Accademia delle scienze
di Svezia assegnò il premio Nobel per l’Economia a Friedrich
von
Hayek, per aver scoperto che i fenomeni economici, sociali e
istituzionali sono interdipendenti. Nel 1976 il premio fu
assegnato a Milton Friedman, il
cui principale merito scientifico starebbe nell’aver compreso
che, se si fa l’ipotesi eroica che un’economia di mercato si
trovi in
uno stato di piena occupazione permanente, si può dimostrare
che una politica di espansione monetaria non può fare
aumentare
l’occupazione in modo permanente. Da Lucas a Sargent, passando
per Prescott, negli anni successivi altri padri di analoghe
scoperte hanno
raggiunto la vetta del Nobel.
«Viene da chiedersi se la strada seguita dai più recenti sviluppi degli studi sociali, e avvalorata dall’orientamento dell’Accademia delle scienze, sia quella più adeguata alla comprensione del mondo in cui viviamo» scrivono Emiliano Brancaccio e Giacomo Bracci. Da qui la loro domanda: bisognerebbe abolire il premio Nobel per l’Economia? La risposta contenuta in questo libro è motivata, rigorosa, e niente affatto scontata.
Nonostante tutto, il più prestigioso premio per l’Economia non andrebbe abolito semplicemente perché è stato spesso attribuito a influenti consiglieri del principe che hanno prodotto fake science, cioè teoremi smentiti dalla ricerca empirica. Questo libro ne smaschera diversi: Friedman, Lucas, Sargent, Kydland, Prescott e altri. Ma al tempo stesso ci ricorda che il premio l’hanno ricevuto anche scienziati come Arrow, Samuelson, Sen, Stiglitz, Krugman, Romer, Ostrom, che hanno indubbiamente fatto avanzare la conoscenza in campo economico.
Neanche lo si dovrebbe abolire perché l’economia è una scienza «molle», cioè impregnata di valori e preferenze politiche. Brancaccio e Bracci argomentano che queste caratteristiche sono condivise in maggiore o minore misura anche dalle scienze relativamente «dure»: la fisica, la chimica, la medicina. Basti notare che ci sono fisici che interpretano il big bang come una prova dell’esistenza di Dio. Dunque, se fosse questo il criterio, si finirebbe per abolire tutti i premi Nobel.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Pesce grande mangia pesce piccolo e Greta li mangia tutti
Pesce grande mangia pesce piccolo e Greta li mangia tutti
Green new deal: la nuova accumulazione capitalista
di Fulvio Grimaldi
 Squali e sardine
Squali e sardine
Esemplifichiamo. Il PD, in Umbria (e non solo), viene scoperto a galleggiare in un oceano di fango sanitario? A Roma la sindaca Raggi, per la quale particolare affetto nutre la Procura, viene collegata a un malaffare AMA che lei cercava di impedire? La società liquida innalza la Raggi su cavalloni giganti e fa sparire l’Umbria PD in una dolce risacca. In Sicilia gli intimissimi del trombone in felpa che amministra il paese vengono scoperti a banchettare con coloro che un tempo pasteggiavano con Andreotti e Berlusconi? Il GIP romano indaga Raggi. Il reato più evanescente di tutti: abuso d’ufficio. “Per come ha dato visibilità al progetto dello stadio” (sic). La Raggi, cento volte indagata (altro che Alemanno) e cento volte assolta (altro che Alemanno), annaspa nell’ennesimo maremoto comunale, l’inciampo tangentizio-mafioso del sottosegretario più importante di tutti, scompare, spiaggiato dietro a una duna. La sardina finisce in padella, gli squali se la battono, anzi se la mangiano.
FNSI e gli altri: ma quale Assange, Bordin!
E’ una costante di sistema. A Londra, Assange, un giornalista che, con Wikileaks, ha connesso i crimini del potere alla coscienza dell’umanità, da 7 anni in isolamento nell’ambasciata ecuadoriana, viene trascinato fuori da sette energumeni in divisa e arrestato in vista di estradizione a chi lo vuole bruciare vivo. Il nulla osta l’ha concesso un presidente ecuadoriano ladrone che da Wikileaks era stato scoperto imboscare denari pubblici in paradisi fiscali e che per i suoi meriti di traditore viene compensato con un prestito miliardario Usa che eviti la sua bancarotta. Vendetta farabutta di un potere che, insieme a quella contro Chelsea Manning, universalizza il suo assassinio della libertà d’espressione, informazione, stampa.
Leggi tutto
Mauro Poggi: Greta Thunberg e dintorni
Greta Thunberg e dintorni
di Mauro Poggi
Discussione sulla sempre interessante pagina FB di Pierluigi Fagan a proposito del fenomeno Greta Thunberg.
Il post del padrone di casa e la maggior parte dei successivi commenti fanno bella mostra di erudizione: citazioni, dotti riferimenti, linguaggio tendenzialmente esoterico, incursioni nel territorio della filosia analitica. In breve: un dibattito autoreferenziale.
Fra i tanti, il commento di Giorgio Bianchi (fotogiornalista free-lance autore di splendide immagini sul Donbass che meriterebbero di essere raccolte in un libro) si distingue a mio avviso per la concretezza e la chiarezza con cui mette a fuoco i termini di riferimento cruciali che occorre avere presenti per un giudizio.
Lo trascrivo nelle righe che seguono. Le note in parentesi quadre sono mie.
§
Commento
di Giorgio Bianchi
La cartina di tornasole per giudicare un movimento asseritamente antisistema è la risposta che ad esso rivolge il sistema stesso.
Lasciando l’ironia sul fenomeno Greta, dove è giusto che resti, ciò su cui ci dobbiamo essenzialmente concentrare è la reazione dei cosiddetti poteri forti [i padroni del discorso] al fenomeno.
Leggi tutto
Christian Marazzi: Giovani e politica monetaria
Giovani e politica monetaria
di Christian Marazzi
Del crescente disagio dei giovani all’interno del mondo del lavoro si parla ovunque da tempo.
In Ticino, come già segnalato dall’Ufficio cantonale di statistica, negli ultimi anni è cresciuto il numero di giovani scoraggiati alla ricerca di un lavoro, come pure i cosiddetti Neet (Not in education, employment or training), persone che non studiano, non lavorano e non seguono un percorso formativo .
Si tratta certamente di un fenomeno preoccupante, non foss’altro che per le conseguenze sociali e psicologiche di coloro che si trovano ai margini del mondo del lavoro. Spesso ci si rifugia nella rete fino ad isolarsi completamente, oppure si cade in depressione perché la difficoltà di trovare un lavoro stabile viene vissuta come un fallimento.
Non c’è dubbio che le trasformazioni del mondo del lavoro degli ultimi due decenni rendono sempre più difficile un inserimento professionale stabile e duraturo. Il lavoro a tempo indeterminato è infatti diminuito, mentre sono aumentati i lavori atipici, dal lavoro a tempo determinato a quello interinale e a chiamata, fino ai lavori a tempo parziale, oltretutto con durate sempre più brevi. Sono lavori contingenti e il più delle volte mal pagati, che rendono difficoltoso per i giovani costruirsi un’identità professionale, come pure una forza contrattuale oltremodo necessaria in un mondo spesso indifferente al futuro delle giovani generazioni.
Leggi tutto
Michel Chossudovsky: «Con la Nato dal welfare al warfare»
«Con la Nato dal welfare al warfare»
Manlio Dinucci intervista Michel Chossudovsky
70 anni di Nato. Intervista a Michel Chossudovsky sui 70 anni della Nato: «Non è un’Alleanza, comandano gli Usa, vogliono più spesa militare in tutta Europa, pronti a nuovi conflitti armati, anche nucleari»
Al convegno internazionale «I 70 anni della Nato: quale bilancio storico? Uscire dal sistema di guerra, ora», svoltosi a Firenze la scorsa settimana – più di 600 i partecipanti dall’Italia e dall’Europa -, ha partecipato quale principale relatore Michel Chossudovsky, direttore di Global Research, il centro di ricerca sulla globalizzazione (Canada), copromotore del Convegno insieme al Comitato No Guerra No Nato e ad altre associazioni italiane. A Michel Chossudovsky – uno dei massimi esperti internazionali di economia e geopolitica, collaboratore dell’Enciclopedia Britannica, autore di 11 libri pubblicati in oltre 20 lingue – abbiamo rivolto alcune domande.
Qual è stato il risultato del Convegno di Firenze?
È stato un evento di massimo successo, con la partecipazione di qualificati relatori provenienti da Stati uniti, Europa e Russia. È stata presentata la storia della Nato. Sono stati identificati e attentamente documentati i crimini contro l’umanità. Al termine del Convegno è stata presentata la «Dichiarazione di Firenze» per uscire dal sistema della guerra.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Francia, una fase politica densa di conflitti
Francia, una fase politica densa di conflitti
di Giacomo Marchetti
A circa un mese dall’elezioni politiche europee, la fase politica in Francia è ad un suo snodo fondamentale.
L’ennesimo tentativo di strumentalizzazione politica per chiamare all’Unione Sacrée – in questo caso l’Incendio del tetto di Notre-Dame e la priorità della sua ricostruzione – non ha sortito alcun effetto di smobilitazione, né aumentato la popolarità di Macron.
“Non sarà un incendio a fermarci”, ha dichiarato J. Rodriguez, una delle figure di spicco del movimento.
“Non si ascolta il popolo, e all’improvviso, si tirano fuori milioni per delle pietre”, ha dichiarato un manifestante ai giornalisti di “Mediapart”, sintetizzando il sentimento di una buona parte dei cittadini francesi o, come recitava lo striscione del DAL – che si occupa del diritto all’abitare – “Notre-Dame è senza tetto, anche noi”. Espressioni dure e apparentemente ciniche, ma che colgono il senso politico del tentativo macroniano di coprire con una “emergenza” il conflitto sociale che si è aperto.
L’appeal per l’azione politica di Macron, secondo un sondaggio Opinionway diffuso lo scorso sabato, si attesterebbe a circa un quarto degli intervistati – il 27% per l’esattezza – addirittura un 5% in meno rispetto a marzo.
Leggi tutto
Hits 3082
Hits 2899
Hits 2793
Hits 2711
Hits 2564
Hits 2457
Hits 2409
Hits 2360
Hits 2342
Hits 2274
tonino

Sergio Bologna: Alle radici di una storiografia militante
Alle radici di una storiografia militante
1 maggio 1945 – 1 maggio 2019
di Sergio Bologna
 74 anni. Prendo
spavento a pensare che
c’ero, anzi, che me lo ricordo quel 1 maggio del 1945. E che i
testimoni di quegli avvenimenti non sono rimasti tanti. Non
dico in generale,
dico quelli che hanno visto ciò che ho visto io, a Trieste, in
una casa da dove si vedeva la sagoma del Castello, ultima
roccaforte della
resistenza tedesca all’avanzata dell’esercito di liberazione
yugoslavo. I maschi della mia famiglia, tranne mio padre,
erano tutti sotto
le armi. Mio nonno era prigioniero in Africa, ad Asmara, ma
non se la passava male, mi raccontò qualche anno dopo. Ci era
andato volontario nel
’36 con le truppe italiane. S’era arruolato per ottenere
l’amnistia, aveva una condanna per diserzione. Allora
abbandonare una nave
commerciale era considerato diserzione, come fosse una nave
militare. Lui, elettricista di bordo, toccato un porto degli
Stati Uniti, se l’era
svignata per inseguire il sogno americano. Aveva sbagliato
data, era il 1929. A Trieste s’era lasciato alle spalle una
moglie e quattro figli:
mia madre, la prima, una donna sensibile, bella, sportiva,
s’era ammalata di tubercolosi a 15 anni e avrebbe passato la
vita tra sanatori e
ospedali. Poi tre figli maschi, uno alto, ben piantato,
calciatore semiprofessionista, arruolato nei granatieri, era
prigioniero in Germania,
“internato militare”, per la precisione, preso dai tedeschi
l’8 settembre ad Atene e ficcato in un vagone piombato. Un
altro
più giovane, Giorgio, dolce e tenero ragazzo, era caduto a 21
anni a El Ghennadi in Tunisia, pochi giorni prima della resa
delle truppe
italiane, nel maggio del ‘42. L’ultimo, di cui non ricordo il
nome, era morto di meningite a 4 anni.
74 anni. Prendo
spavento a pensare che
c’ero, anzi, che me lo ricordo quel 1 maggio del 1945. E che i
testimoni di quegli avvenimenti non sono rimasti tanti. Non
dico in generale,
dico quelli che hanno visto ciò che ho visto io, a Trieste, in
una casa da dove si vedeva la sagoma del Castello, ultima
roccaforte della
resistenza tedesca all’avanzata dell’esercito di liberazione
yugoslavo. I maschi della mia famiglia, tranne mio padre,
erano tutti sotto
le armi. Mio nonno era prigioniero in Africa, ad Asmara, ma
non se la passava male, mi raccontò qualche anno dopo. Ci era
andato volontario nel
’36 con le truppe italiane. S’era arruolato per ottenere
l’amnistia, aveva una condanna per diserzione. Allora
abbandonare una nave
commerciale era considerato diserzione, come fosse una nave
militare. Lui, elettricista di bordo, toccato un porto degli
Stati Uniti, se l’era
svignata per inseguire il sogno americano. Aveva sbagliato
data, era il 1929. A Trieste s’era lasciato alle spalle una
moglie e quattro figli:
mia madre, la prima, una donna sensibile, bella, sportiva,
s’era ammalata di tubercolosi a 15 anni e avrebbe passato la
vita tra sanatori e
ospedali. Poi tre figli maschi, uno alto, ben piantato,
calciatore semiprofessionista, arruolato nei granatieri, era
prigioniero in Germania,
“internato militare”, per la precisione, preso dai tedeschi
l’8 settembre ad Atene e ficcato in un vagone piombato. Un
altro
più giovane, Giorgio, dolce e tenero ragazzo, era caduto a 21
anni a El Ghennadi in Tunisia, pochi giorni prima della resa
delle truppe
italiane, nel maggio del ‘42. L’ultimo, di cui non ricordo il
nome, era morto di meningite a 4 anni.
Non so qual è stato il tributo di sangue che i partigiani di Tito hanno versato per conquistare Trieste prima che ci mettessero su le mani gli Alleati. Ma qualche fonte parla di migliaia di caduti sul Carso. Me li ricordo ancora, gli elmi nei boschi. Erano elmi tedeschi, molti foderati di pelle, li raccoglievo e me li ficcavo in testa, subito redarguito da mio padre, potevano averci i pidocchi. I partigiani portavano bustine, copricapi di stoffa, erano un po’ scalcagnati.
Leggi tutto
Claudio Conti: La patrimoniale sbagliata è quella che piace alla Ue
La patrimoniale sbagliata è quella che piace alla Ue
di Claudio Conti
In calce l'articolo di Guido Salerno Aletta sull'argomento
 Patrimoniale,
panacea per tutti i mali economici? Dipende… Quando
– cadendo nella trappola ideologica imposta dalla narrazione
dominante – si prova a rispondere alla domanda “dove si
trovano i soldi
per fare quello che proponete?” (chiunque sia a proporre una
strategia diversa da quella ordoliberista), la mente di tutti
va immediatamente a
due totem: combattere l’evasione fiscale e fare
una patrimoniale.
Patrimoniale,
panacea per tutti i mali economici? Dipende… Quando
– cadendo nella trappola ideologica imposta dalla narrazione
dominante – si prova a rispondere alla domanda “dove si
trovano i soldi
per fare quello che proponete?” (chiunque sia a proporre una
strategia diversa da quella ordoliberista), la mente di tutti
va immediatamente a
due totem: combattere l’evasione fiscale e fare
una patrimoniale.
Non paradossalmente, tutti sono d’accordo a dire che “bisogna combattere l’evasione fiscale” –farlo, è notoriamente tutt’altra cosa – mentre la patrimoniale risulta normalmente più “divisiva”, spesso definendo il campo della destra autentica e quello della presunta “sinistra”.
Non ci dilungheremo qui sulla lotta all’evasione, che richiede la capacità di ricoprire un ruolo di governo con intento e determinazione rivoluzionari. E ragioniamo invece sulle facce nascoste della “patrimoniale”.
Lo facciamo facendoci aiutare – come spesso ci capita – da Guido Salerno Aletta, che ha prodotto l’editoriale di Milano Finanza che qui sotto riproponiamo.
La prima operazione da fare è relativamente semplice: cos’è una patrimoniale? E’ qualunque tipo di tassa calcolata, invece che sul reddito, sul patrimonio del contribuente. Salario, pensione, sussidi, ecc, sono redditi; depositi bancari, investimenti finanziari, immobili, terreni, ecc, sonopatrimonio.
Cosa c’è di più semplice allora che immaginare una tassazione sui secondi? Semplicità che nella realtà non esiste, però. Intanto perché bisogna distinguere i patrimoni mobiliari (che si possono cioè muovere, anche fuggendo all’estero, come soldi, azioni, obbligazioni) da quelli immobiliari, che stanno dove stanno e nessuno li può portare via.
Nel concreto della società italiana, il quadro è particolarmente complicato. Praticamente tutti i lavoratori dipendenti (e i pensionati) sono obbligati ad avere un conto corrente in banca o alle Poste. Quindi praticamente tutti hanno un patrimonio mobiliare, anche se quasi sempre minimo e spesso addirittura negativo (quando “si va in rosso”).
Leggi tutto
Eros Barone: Alcune geniali intuizioni di Alberto Moravia nel romanzo La ciociara
![]()
Alcune geniali intuizioni di Alberto Moravia nel romanzo La ciociara
di Eros Barone
Estetizzazione della guerra, critica sociale in bocca nazionalsocialista e antitesi ‘furbi-fessi’
 Alcuni romanzi contengono pagine di una forza
così intensa e inaspettata che quando il lettore ci
arriva, dopo deve fermarsi. Non può continuare a leggere,
ma sente il bisogno di
chiudere il libro, magari tenendo il segno con l’indice
incastrato fra le pagine, respirare profondamente,
ricacciare indietro le lacrime. Sono
momenti di commozione potente che i grandi scrittori
dosano con parsimonia e che sanno travolgere chi legge con
l’autenticità della vita.
La ciociara contiene più
di un momento del
genere.
Alcuni romanzi contengono pagine di una forza
così intensa e inaspettata che quando il lettore ci
arriva, dopo deve fermarsi. Non può continuare a leggere,
ma sente il bisogno di
chiudere il libro, magari tenendo il segno con l’indice
incastrato fra le pagine, respirare profondamente,
ricacciare indietro le lacrime. Sono
momenti di commozione potente che i grandi scrittori
dosano con parsimonia e che sanno travolgere chi legge con
l’autenticità della vita.
La ciociara contiene più
di un momento del
genere.
Sandra Petrignani
La ciociara, romanzo pubblicato nel 1957 ma iniziato dieci anni prima e poi abbandonato, non solo rappresenta il momento più avanzato, marxista e comunista, della evoluzione ideologica e culturale di Alberto Moravia, ma fornisce anche la chiave per comprendere i diversi aspetti che caratterizzano, in quel periodo, l’opera dello scrittore. 1 L’argomento del libro è noto, grazie anche alla riduzione cinematografica di Vittorio De Sica e all’interpretazione di Sofia Loren (1960): vi si narra la storia di Cesira, una bottegaia romana – una ciociara sposa di un uomo molto più vecchio di lei e ben presto vedova – e di sua figlia Rosetta, entrambe sfollate durante l’ultimo periodo della seconda guerra mondiale, come accadde anche allo stesso autore e ad Elsa Morante, allora sua moglie, nelle montagne vicino a Fondi, comune della provincia di Latina.
Le due donne vivono in quei mesi del 1943 i sacrifici, le ansie, le speranze e le illusioni di tutti coloro che aspettavano la pace e la liberazione, maturando nel contempo anche una nuova consapevolezza attraverso i quotidiani discorsi con un giovane intellettuale antifascista (il dialogato di questo romanzo è uno dei pregi più avvincenti della mossa scrittura moraviana). Michele Festa – questo è il nome dell’intellettuale – viene portato via e ucciso da una delle ultime pattuglie tedesche in ritirata e le due donne, finalmente liberate, s’imbattono in un reparto di marocchini che abusa di loro. Sennonché il trauma dello stupro, tanto più violento in quanto la giovinetta era del tutto semplice e ingenua, spinge Rosetta a perdere ogni pudore e a darsi a tutti gli uomini che incontra, finché, sulla strada del ritorno a Roma, un nuovo trauma (l’assassinio del suo ultimo amante) non le restituisce l’equilibrio perduto.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Operazione conquista delle menti
Operazione conquista delle menti
di Manlio Dinucci
Circa 5.000 bambini e ragazzi di 212 classi hanno partecipato, ieri a Pisa, alla «Giornata della Solidarietà» in ricordo del maggiore Nicola Ciardelli della Brigata Folgore, rimasto ucciso il 27 aprile 2006 in un «terribile attentato» a Nassirya, durante la «missione di pace» Antica Babilonia.
La Giornata, promossa ogni anno dalla Associazione Nicola Ciardelli Onlus creata dalla famiglia, è divenuta, grazie al determinante sostegno del Comune (prima guidato dal Pd, oggi dalla Lega) il laboratorio di una grande operazione – cui collabora un vasto arco di enti e associazioni – per «sensibilizzare i giovani studenti sull’importanza dell’impegno di ognuno verso la costruzione di un futuro di Pace e Solidarietà».
L’esempio da seguire è «l’impegno profuso da Nicola a favore delle popolazioni dilaniate dai conflitti, incontrate in occasione delle numerose missioni cui aveva partecipato», durante le quali aveva «toccato con mano la devastazione delle guerre e le sofferenze di coloro che sono costretti a subirle, primi tra tutti i bambini».
Nessuno però ha raccontato ai 5.000 bambini e ragazzi la vera storia della devastante guerra scatenata nel 2003 dagli Stati uniti contro l’Iraq, paese già da anni sottoposto a un embargo che aveva provocato in dieci anni un milione e mezzo di morti, di cui circa mezzo milione tra i bambini.
Leggi tutto
Francesco Piccioni: Via della Seta, che cambia?
Via della Seta, che cambia?
di Francesco Piccioni
Il mondo sta cambiando velocemente, anche se l’informazione “ufficiale” italiana sembra non accorgersene. E i vettore più importante del cambiamento – per dimensioni economico-finanziarie, visione d’insieme, progettualità, ecc – è da diversi anni la Cina.
Naturalmente ogni cambiamento – come sappiamo noi italiani, alle prese con una fetecchia di “governo del cambiamento” – può esser buono o pessimo, ma è. Non vederlo è l’errore più grande che si possa fare, specie da comunisti.
Nel weekend appena concluso, a Pechino, c’è stato il secondo Forum sulla Belt and Road Initiative (Bri), chiamata anche “Nuova Via della Seta”. Lì persino alcuni tetragoni corrispondenti di media mainstream hanno dovuto ammettere che
“siamo ormai nel pieno di un sempre più probabile spostamento a Est del baricentro del mondo: non è più solo una questione di trend che si scorgono all’orizzonte. Lo sviluppo economico della Cina unito a una sempre più marcata attenzione verso obiettivi di innovazione tecnologica – la Cina investe già oggi più del 2,5% del suo enorme Pil in ricerca e sviluppo – attribuiscono oggi al Regno di Mezzo il ruolo di credibile e unico alter ego rispetto agli Usa nella gestione delle sorti del mondo”.
I numeri del Forum parlano da soli. Presenti i leader di 37 Paesi (otto di più rispetto alla prima edizione), e delegazioni di quasi tutti i Paesi più rilevanti (un centinaio).
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Favole spagnole
Favole spagnole
di ilsimplicissimus
L’energia non si consuma, da qualche parte finisce e in Spagna come del resto altrove, quella che una volta serviva ad alimentare il motore della politica, oggi si limita a creare nuove geometrie e dislocazioni elettorali il cui senso è estremamente limitato vista l’assenza di politica di bilancio: i Paesi della Ue devono pagare il conto che impone Bruxelles e hanno facoltà di intervento solo sulla mancia sociale da lasciare sul tavolo, ovvero su cifre marginali. Se a questo si aggiunge il fatto cHe una consistente parte dell’economia spagnola, dal turismo alla produzione automobilistica è legata alla Germania, ovvero alla protagonista della politica comunitaria si vede che non c’è molto da scegliere. Infatti Podemos scende in favore dei socialisti e della sinistra catalana, il Partito popolare crolla in favore di Ciudadanos e di Vox (espresssione del teapartismo in salsa cattolica) e tutto rimane come prima. Possiamo anche cedere al fascino delle etichette e dire che la sinistra ha vinto come fanno gli ultimi illusi nei loro fortilizi, oppure possiamo delirare come Repubblica all’ultimo stadio sulla sconfitta del populismo (chi sono poi questi populisti?) ma tutto dipende dal sistema di riferimento che prendiamo per dare un senso a queste etichette politiche: in ogni caso il partito socialista oggi al governo si trova a essere ancor più precario di prima e paradossalmente a dipendere ancora più di prima dai separatisti catalani e baschi.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Cattedrali di sabbia nel Sahel
![]()
Cattedrali di sabbia nel Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, aprile 2019. Le vere catttedrali sono di sabbia. Nulla a che vedere con quella di Parigi, messa sù di pietra e di secoli che fingono di non passare invano. Re, principi, papi, imperatori, gente comune, affaristi, fedeli, spettatori e banchieri, tutti sono entrati dalla stessa porta d’ingresso. Nessuna cattedrale, malgrado le velleità di eternità, è destinata a durare nel tempo. Qualche secolo o millennio e poi, inesorabile, la sabbia e la cenere avranno il sopravvento sui restauri mirati a conservare l’originale. Da noi questo si sa e per questo, fin dall’inizio, si costruisce tutto sulla sabbia, pegno di eterna fragilità e contingente perennità. Anche a Niamey, da qualche tempo, si costruisce senza sosta quanto in fondo non serve per nulla alla vita reale della città. Hotel di lusso, ospedali di qualità selezionata, strade di eccellenza e futuristiche università islamiche per sole donne. Questo e altro è quanto il regime attuale propone e propina ai comuni cittadini del Paese che si fonda sulla sabbia. Le nostre cattedrali sono diverse e non sono altro che sabbia messa assieme dal vento. Durano quanto basta e non hanno la presunzione di diventare perenni come quelle di pietra. Sono di gran lunga più aderenti alla realtà, alle stagioni della vita e alla storia, cose tutte che al massimo durano una settimana o poco più.
Leggi tutto
Silvia Guerini: Riflessioni sparse leggendo il libro “Smagliature digitali”
Riflessioni sparse leggendo il libro “Smagliature digitali”
di Silvia Guerini
In occasione dell’iniziativa “Gorgoni – corpi imprevisti” del 5 maggio al FOA Boccaccio a Monza [1].
 Il libro “Smagliature digitali” contiene vari
saggi. Uno di questi
è il manifesto Xenofemminista, recente è la pubblicazione di
“Xenofemminismo” di Helen Hester. È più semplice
criticare questo estremo hi-tech dove tutto è riprogettabile
[2], più difficile scorgere e mettere in luce che siamo già
arrivate
a un punto in cui l’attivismo e le analisi trans-femminista e
queer sono portatrici delle stesse logiche
neoliberali di mercificazione,
di ingegnerizzazione del vivente e di superamento dei limiti
di questo sistema tecno-scientifico. Tendenze figlie di questi
tempi che si presentano
come radicali e sovversive, ma che andranno solo a rafforzare
le fondamenta su cui si regge questa società.
Il libro “Smagliature digitali” contiene vari
saggi. Uno di questi
è il manifesto Xenofemminista, recente è la pubblicazione di
“Xenofemminismo” di Helen Hester. È più semplice
criticare questo estremo hi-tech dove tutto è riprogettabile
[2], più difficile scorgere e mettere in luce che siamo già
arrivate
a un punto in cui l’attivismo e le analisi trans-femminista e
queer sono portatrici delle stesse logiche
neoliberali di mercificazione,
di ingegnerizzazione del vivente e di superamento dei limiti
di questo sistema tecno-scientifico. Tendenze figlie di questi
tempi che si presentano
come radicali e sovversive, ma che andranno solo a rafforzare
le fondamenta su cui si regge questa società.
Senza giri di parole, quello che noi vorremmo distruggere per un mondo altro, chi porta avanti queste analisi lo vorrebbe mantenere. Ci troviamo davanti a un adesione entusiasta al tecno-mondo e a un’ammirazione delle tecnologie.
Già da tempo il personale ha fagocitato il politico, perché è certamente più facile essere in un continuo processo di cambiamento individuale, considerandolo come la chiave per cambiare la società, invece che guardare fuori da sé intraprendendo un percorso di lotta. Ma bisogna intendersi anche su questo. Perchè è di moda pensare che autoprodursi sex-toys sia una pratica sovversiva. Così nascono come funghi laboratori ludici di giocattoli sessuali e di mutande masturbatorie, come se davvero questo possa intaccare in qualche modo questo sistema.
Un saggio di “Smagliature digitali” ci illustra il “pornoattivismo accademico”, un’altro gioco, da chi può permettersi il lusso di giocare mentre tutto attorno precipita sempre di più. Così in questo teatro dell’assurdo basta calarsi le mutande in qualche performans trans-queer per destabilizzare e sovvertire… quanto è lontana e quando è profondamente altra cosa, la tensione che contraddistingue un lottare fino in fondo, fuori dalle stanze accademiche e fuori dai social network, correndo sotto le stelle fino all’ultimo respiro…
Leggi tutto
Davide Cassese: Crescita e PIL potenziale: le stime controverse di Bruxelles
Crescita e PIL potenziale: le stime controverse di Bruxelles
di Davide Cassese
Output gap Italia | Secondo le stime di Bruxelles il PIL italiano è al di sopra del suo potenziale. Si tratta di stime assurde che porteranno a nuove richieste di austerità nel nostro Paese
 Di recente la Commissione
Europea ha rilasciato il Country Report per
l’Italia,
documento che descrive lo stato di salute dell’economia
italiana e, in base ad esso, le raccomandazioni di politica
economica per i Paesi
membri. Dopo aver sottolineato i modesti progressi fatti
dall’Italia nell’attuazione delle riforme strutturali, la
Commissione ha
riassunto i dati più significativi all’interno della tabella
“Key economic and financial indicators”. Più di tutto,
risulta di particolare interesse un dato riferito ad una
variabile chiave per la politica fiscale: l’output gap. Sono
stati diversi i contributi
legati a questo tema pubblicati su questa rivista (Tridico,
Meloni e Bracci, 2018; Tridico e Meloni, 2018; Cassese, 2018).
Di recente la Commissione
Europea ha rilasciato il Country Report per
l’Italia,
documento che descrive lo stato di salute dell’economia
italiana e, in base ad esso, le raccomandazioni di politica
economica per i Paesi
membri. Dopo aver sottolineato i modesti progressi fatti
dall’Italia nell’attuazione delle riforme strutturali, la
Commissione ha
riassunto i dati più significativi all’interno della tabella
“Key economic and financial indicators”. Più di tutto,
risulta di particolare interesse un dato riferito ad una
variabile chiave per la politica fiscale: l’output gap. Sono
stati diversi i contributi
legati a questo tema pubblicati su questa rivista (Tridico,
Meloni e Bracci, 2018; Tridico e Meloni, 2018; Cassese, 2018).
1. L’output gap e il NAWRU
L’output gap è una grandezza statistica stimata dalla Commissione Europea. Si compone di due elementi: il PIL effettivo, che è una grandezza osservata, calcolato dagli uffici nazionali di statistica dei Paesi membri, e il PIL Potenziale, che è una grandezza non osservabile e pertanto stimato dalla Commissione Europea con il metodo della Funzione di Produzione (Havik et al., 2014).
Tralasciando le critiche di teoria economica a cui può essere sottoposto il metodo della funzione di produzione, che si rifanno alla critica di Garegnani (1970) e di Pasinetti (1966) nell’ambito della Controversia sul capitale degli anni ’60, l’output gap corrisponde alla differenza percentuale tra il livello del PIL effettivamente prodotto dall’economia e il livello del PIL potenziale – cioè il massimo livello di PIL che può raggiungere l’economia con le risorse presenti, compatibilmente con la stabilità dei prezzi. Se l’output gap fosse positivo un’economia starebbe sovrautilizzando le risorse disponibili e ciò, nella visione della Commissione europea, dovrebbe portare ad una accelerazione del tasso di inflazione. Al contrario nel caso di un valore negativo. Tutto questo perché, secondo una teoria economica ben consolidata, esisterebbe un tasso di disoccupazione “strutturale” in corrispondenza del quale il tasso di crescita dei prezzi non accelera.
Leggi tutto
Sebastiano Taccola: L’accumulazione originaria: genesi del modo di produzione capitalistico tra storia e struttura
L’accumulazione originaria: genesi del modo di produzione capitalistico tra storia e struttura
di Sebastiano Taccola*

«il capitale
viene al mondo
grondante sangue e sudiciume
dalla testa ai piedi, da tutti i
pori». (Marx 2011)
«Il ‘moderno’:
l’epoca dell’inferno. Le pene dell’inferno
sono
ciò che più di nuovo di volta in volta si
dà in questo ambito.
Non si tratta del fatto che accada
‘sempre lo stesso’, ancora
meno si può qui parlare
di eterno ritorno. Si tratta, piuttosto,
del fatto che il volto del
mondo non muta mai proprio in ciò che
costituisce il nuovo,
che il nuovo, anzi, resta sotto ogni
riguardo sempre lo stesso.
– In questo consiste l’eternità
dell’inferno. Determinare la totalità dei tratti, in
cui il
‘moderno’ si configura, significherebbe
rappresentare l’inferno».
(Benjamin 2002)
«We’re all Frankies
We’re all lying in
hell».
(Suicide, Frankie Teardrop).
1.
Chiunque abbia anche solo un minimo di familiarità con i testi di Marx avrà ben presente quella loro peculiarità di stile che, contaminando la prosa del trattato filosofico o economico con immagini dal gusto letterario, riesce a sedurre il lettore, spesso anche attraverso una pungente ironia antiborghese, in cui è percepibile l’influenza di modelli elevati, come Shakespeare, Goethe e, soprattutto, Heine[1]. Una straordinaria esemplificazione di questo stile la possiamo trovare proprio nella prima pagina del capitolo del primo libro del Capitale che qui ci proponiamo di analizzare – il capitolo ventiquattresimo intitolato La cosiddetta accumulazione originaria:
Nell’economia politica quest’accumulazione originaria gioca all’incirca lo stesso ruolo del peccato originale nella teologia: Adamo dette un morso alla mela e con ciò il peccato colpì il genere umano. Se ne spiega l’origine raccontandola come aneddoto del passato. C’era una volta, in un’età da lungo tempo trascorsa, da una parte una élite diligente, intelligente e soprattutto risparmiatrice e dall’altra c’erano degli sciagurati oziosi che sperperavano tutto il proprio e anche più.
Leggi tutto
Domenico Moro: De Benedetti e L’Europa come unico riferimento possibile
De Benedetti e L’Europa come unico riferimento possibile
di Domenico Moro
Esiste una stretta connessione tra lo strato apicale del capitale, quello più internazionalizzato, e l’Europa dei Trattati e dell’euro, specie nella fase attuale caratterizzata da processi di centralizzazione attraverso le fusioni e le acquisizioni aziendali. L’integrazione europea è funzionale, tra le altre cose, alla centralizzazione in poche mani del potere economico, che ha come necessario corrispettivo la centralizzazione del potere politico in poche mani, cioè negli esecutivi nazionali e negli organismi sovrannazionali non elettivi come la Bce e la Commissione europea.
Recentemente la famiglia De Benedetti, proprietaria di media come la Repubblica e l’Espresso che si sono sempre distinti per l’appoggio al processo di integrazione europea, ha fuso insieme le due holding di famiglia, la Cir e la Cofide, che si occupano, oltre che di editoria, anche di componentistica auto e sanità. Rodolfo de Benedetti, presidente di Cofide e Cir, che per l’occasione è stato intervistato dal Sole24ore, ha espresso chiaramente il suo punto di vista in favore dell’Europa neoliberista dei Trattati:
“Siamo ovviamente preoccupati quando vediamo balenare soluzioni di ripiegamento nazionalistico ai problemi globali di un mondo interconnesso. Un Paese come l’Italia, con 60 milioni di abitanti in un mondo di oltre 7 miliardi, di persone, non può che ragionare in termini di competizione globale. E l’Europa a cui siamo vincolati dai trattati deve essere l’unico riferimento possibile.”
Leggi tutto
Alessandro De Toni: L’idraulico polacco e il camionista bulgaro
L’idraulico polacco e il camionista bulgaro
di Alessandro De Toni
Se l’adesione dei Paesi dell’Est Europa può essere vista come una minaccia concreta per le classi lavoratrici, la ragione è la totale mancanza, nell’architettura dell’Unione, di clausole per l’armonizzazione fiscale e sociale.
È il tema dell'”idraulico polacco”. Tema che ha contribuito ad allargare il numero dei sostenitori della Brexit e a convincere i proletari francesi a votare per Le Pen. Ad oggi diverse centinaia di migliaia di polacchi vivono, infatti, in Gran Bretagna. Quando otto paesi dell’Europa dell’Est sono stati inseriti nello spazio di libera circolazione dell’UE, il Governo Blair non ha imposto nessuna restrizione temporanea. Lo scopo era quello contenere i salari tramite la concorrenza tra lavoratori, in linea con le direttive europee.
La crescita della xenofobia e del rifiuto dei migranti è, almeno in parte, conseguenza di un lungo processo di messa in concorrenza innanzitutto delle stesse popolazioni europee precarizzate, realizzato tramite politiche di dumping sociale, con il fenomeno dei “lavoratori distaccati” e con le migrazioni intracomunitarie permesse nel nome della libertà di circolazione.
Non si tratta di movimenti marginali, ma di importanti flussi migratori che hanno destabilizzato le popolazioni coinvolte, sia quelle dei paesi d’origine che quelle dei paesi di destinazione. Si stima che tra il 2004 ed il 2014 circa 4 milioni di persone si siano spostate dall’Est all’Ovest in Europa, diventando residenti in un altro Pese membro dell’Unione.
Leggi tutto
Anselm Jappe: Il pozzo e il pendolo, e il capitalismo
Il pozzo e il pendolo, e il capitalismo
di Anselm Jappe
Prefazione alla nuova edizione di "Aventures de la marchandise" (La découverte, 2017) di Anselm Jappe
Quando questo libro venne pubblicato, nel 2003, dalle edizioni Denoël, ciò che si proponeva era di riassumere la corrente della critica sociale nota sotto il nome di «critica del valore», soprattutto nella sua forma, elaborata nel corso dei precedenti 15 anni dalla rivista tedesca Krisis. Il libro comincia attuando una rilettura dell'opera di Marx assai diversa da quella che viene fatta dalla quasi totalità dei marxismi storici. Al centro di questa lettura, troviamo delle concezioni radicalmente critiche del valore e della merce, del denaro e del lavoro. A partire da questa base teorica, il libro passa ad analizzare la crisi attuale della società capitalista, ne rilegge la storia e stabilisce dei legami con l'antropologia. Vengono poi esaminate numerose altre forme di critica sociale, a volta con una certa severità. Essenzialmente, la ristampa di questo libro implica delle correzioni formali. Per quel che concerne il contenuto, sono assai poche le cose che ho trovato da cambiare. Ciò non è dovuto ad una mia particolare perspicacia, della quale avrei dato prova al momento della sua prima stesura, ma piuttosto dimostra, spero, quale sia la solidità delle basi teoriche elaborate dalla critica del valore, ed in particolar modo dal suo principale autore, Robert Kurz.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Che tu possa vivere in tempi interessanti
Che tu possa vivere in tempi interessanti
di Pierluigi Fagan
Ad un certo punto è cominciato a circolare questo meme probabilmente propagato da Zizek come una “nota maledizione cinese” ma chissà se è davvero "nota" e "cinese". In modo indiretto, l’augurio sarcastico starebbe a dire che i tempi interessanti sono in realtà complessi e chiunque in quei marosi viene sballottato di qui e di là.
Come vedete dalla chart, sottostante, sul pianeta abbiamo cominciato a crescere in maniera geometrica da un certo punto in poi. Molto dal 1900 ma moltissimo dal 1950. Oggi siamo 7,8 mld circa, solo nel 1971 eravamo la metà. L’indice di riproduzione è in costante calo quindi quella punta tenderà ancora a salire ma si fermerà prima dei 10 mld per poi flettere un po’ o un po’ di più, non si sa.
Ma qui non ci interessa quanti siamo o saremo di per sé, ci interessa solo quanto siamo cresciuti rispetto ad un certo tempo, quanto velocemente/intensamente. Nel secolo che va dal 1950 al prossimo 2050, ci saremo quadruplicati. E’ un secolo interessante questo, sebbene siamo solo ai suoi due terzi, un secolo su cui si scriveranno molti libri nei secoli futuri. Voi non lo sapete, ma siamo protagonisti di una epoca storica eccezionale.
In questo secolo a cavallo tra due, sono successe cose straordinarie e del tutto inedite.
Leggi tutto
Hits 3259
Hits 3174
Hits 2961
Hits 2888
Hits 2837
Hits 2663
Hits 2521
Hits 2489
Hits 2468
Hits 2380
tonino

Carlo Formenti: Come domare gli ‘spiriti animali’ del capitalismo?
Come domare gli ‘spiriti animali’ del capitalismo?
di Carlo Formenti
 Vi sono momenti storici in cui,
come diceva Gramsci, il
vecchio muore ma il nuovo non riesce a nascere. In simili
momenti è un intero apparato concettuale (teorie, visioni,
ideologie, parole) a
entrare in crisi: politici, intellettuali, persone comuni si
rendono conto che tutto quello che hanno imparato attraverso
la loro educazione e le loro
esperienze professionali e di vita non serve più (o almeno
serve sempre meno). Il mondo cambia troppo in fretta perché si
riesca a
descriverlo, né tanto meno a comprenderlo. Al disorientamento
generato da questa incapacità dei linguaggi di aderire alla
realtà,
si tende a reagire aggrappandosi alle rassicuranti categorie
del passato, cercando di adattarle il più possibile
all’attualità,
non ci si rassegna a rinunciarvi, nemmeno di fronte alla loro
palese inutilità di fronte alle sfide economiche, sociali e
politiche che
incombono. In questi frangenti il coraggio dei pochi che
tentano di esplorare nuovi percorsi teorici, di cambiare il
punto di vista sul mondo,
è un dono prezioso che merita riconoscimento. Un esempio di
tale coraggio viene dall’ultimo libro di Onofrio Romano, “La
libertà verticale. Come affrontare il declino di un modello
sociale” (Meltemi), in cui l’autore propone una spiazzante
ricostruzione delle dinamiche e delle cause delle grandi crisi
che la società capitalista ha attraversato nell’ultimo secolo.
Vi sono momenti storici in cui,
come diceva Gramsci, il
vecchio muore ma il nuovo non riesce a nascere. In simili
momenti è un intero apparato concettuale (teorie, visioni,
ideologie, parole) a
entrare in crisi: politici, intellettuali, persone comuni si
rendono conto che tutto quello che hanno imparato attraverso
la loro educazione e le loro
esperienze professionali e di vita non serve più (o almeno
serve sempre meno). Il mondo cambia troppo in fretta perché si
riesca a
descriverlo, né tanto meno a comprenderlo. Al disorientamento
generato da questa incapacità dei linguaggi di aderire alla
realtà,
si tende a reagire aggrappandosi alle rassicuranti categorie
del passato, cercando di adattarle il più possibile
all’attualità,
non ci si rassegna a rinunciarvi, nemmeno di fronte alla loro
palese inutilità di fronte alle sfide economiche, sociali e
politiche che
incombono. In questi frangenti il coraggio dei pochi che
tentano di esplorare nuovi percorsi teorici, di cambiare il
punto di vista sul mondo,
è un dono prezioso che merita riconoscimento. Un esempio di
tale coraggio viene dall’ultimo libro di Onofrio Romano, “La
libertà verticale. Come affrontare il declino di un modello
sociale” (Meltemi), in cui l’autore propone una spiazzante
ricostruzione delle dinamiche e delle cause delle grandi crisi
che la società capitalista ha attraversato nell’ultimo secolo.
L’originalità del lavoro di Onofrio Romano consiste nello sforzo di assumere una postura “laterale” nei confronti dei modelli teorici – economici, politici, sociali - consolidati con cui è stato sviscerato il periodo storico in questione, che è quello fra le due transizioni di secolo XIX-XX e XX-XXI. Pur non rinunciando a confrontarsi con tali modelli e con i loro massimi interpreti, Romano li integra con – o per meglio dire li ingloba in - una visione prevalentemente culturale/antropologica dei fenomeni analizzati. Ne emerge un quadro in cui le classiche categorie oppositive della moderna teoria sociale (progresso/conservazione; democrazia/totalitarismo; capitalismo/socialismo; destra/sinistra, ecc.) passano in secondo piano rispetto all’inedita endiadi orizzontalismo/verticalismo.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Golpe fallito? I media gli fanno la respirazione artificiale...
Golpe fallito? I media gli fanno la respirazione artificiale........
Venezuela:si rompe l'osso o si rompono i denti?
di Fulvio Grimaldi
 “Noi resteremo fermi in difesa
dell’ordine
costituzionale e della pace della Repubblica, assistiti
come siamo da legge, ragione e storia. Leali sempre,
traditori mai!” (Vladimiro
Padrino, Ministero della Difesa della Repubblica Bolivariana
del Venezuela)
“Noi resteremo fermi in difesa
dell’ordine
costituzionale e della pace della Repubblica, assistiti
come siamo da legge, ragione e storia. Leali sempre,
traditori mai!” (Vladimiro
Padrino, Ministero della Difesa della Repubblica Bolivariana
del Venezuela)
Alì Primera, da ascoltare, volendo, in sottofondo.
Com’è che diceva Emilio Fede?
La figura di merda in questione si dà per scontato sia quella dell’ennesimo gaglioffo da avanspettacolo inventato dai servizi Usa su mandato dell’Universal P2, S.p.A., per sostituire a un governo democratico e, magari, emancipatore e sovranista, un fantoccio duro e puro, addestrato al servo encomio alla Cupola e al suo braccio armato statunitense. Già perché, dopo il cazzuto, affidabile e durevole Fuehrer cileno, non si è verificato che un sequel di catastrofici pirla, buoni solo ad accaparrare mazzette imperiali sulla parola. Honduras, Ucraina, Ecuador, Haiti, Afghanistan, Libia, Yemen: reggono solo perché puntellati dall’Impero con le sue basi. Livelli intermedi li conosciamo in Europa. Scelte al massimo ribasso che riflettono fedelmente spessore e qualità dei mandanti.
Più esilarante, per quanto non meno scontata, la figura in oggetto inflittasi dai media, come al solito più italiani che quelli, un tantino avveduti, esteri. Ci si arrampica sugli specchi per mantenere ancora per un po’, almeno a livello mediatico, l’attenzione sul “dittatore” Maduro, sulla disperazione del popolo affamato e sul sacrificio di un’opposizione democratica massacrata. Proprio come si era tentato dopo il megaflop del procuratore Mueller per tenere a galla la ciambella del Russiagate. Uno specchio, liscio quanto può esserlo un vetro smerigliato, è la fola diffusa da Pompeo (uno fuggito dal set di “Gomorra”, o del “Padrino” e sostituito malamente da Marlon Brando) secondo cui i vertici delle Forze Armate avrebbero deciso di deporre Maduro, con tanto di “dimissioni onorevoli”, già pronte, ma poi ci avrebbero ripensato.
Leggi tutto
Luigi Ficarra: Note in merito al libro di Ferrero e Morandi su Marx
![]()
Note in merito al libro di Ferrero e Morandi su Marx
di Luigi Ficarra
Paolo Ferrero, Bruno Morandi: Marx oltre i luoghi comuni, editore Derive Approdi
 “Non esiste vento
favorevole per il marinaio che non sa dove andare ”,
dice Seneca in un passo delle
‘Lettere a Lucilio’ citato da Ferrero (p. 228). Passo che si
può anche leggere così: ‘ Non esiste vento favorevole
per il marinaio che segua una rotta sbagliata’, la quale
in tal caso tale rimane. Citazione su cui tornerò più avanti.
“Non esiste vento
favorevole per il marinaio che non sa dove andare ”,
dice Seneca in un passo delle
‘Lettere a Lucilio’ citato da Ferrero (p. 228). Passo che si
può anche leggere così: ‘ Non esiste vento favorevole
per il marinaio che segua una rotta sbagliata’, la quale
in tal caso tale rimane. Citazione su cui tornerò più avanti.
♦ Da leggere con cura la parte scritta da Morandi , di cui, per chi non ha approfondito la conoscenza della teoria dello Stato in Marx, (come ha fatto chi scrive, sia per motivi personali di studio, che, soprattutto, per impegno politico), consiglio una lettura approfondita, perché fa comprendere l’errore d’impostazione che sul tema commise Engels. Il quale nella sua opera “ L’origine della famiglia, della proprietà privata e dello Stato ”, parla delle caratteristiche dello Stato in generale, affermando in modo astorico una teoria valida per tutti i tempi, e quindi non coglie la natura specifica dello Stato borghese che nasce dalla scissione fra società civile e società politica, determinata dal modo di produzione capitalistico. Scissione, separazione che, ripeto, è - come spiega Marx - la fondamentale caratteristica della società capitalistica e della sua specifica ‘funzionale’ democrazia. Infatti, lo Stato di diritto kantiano, che come diceva Della Volpe, in polemica col revisionismo dei Bernstein e Mondolfo, trova il suo fondamento nel ‘ Contratto sociale ’ di Rousseau, è reso necessario dai rapporti di produzione capitalistici, alla cui gestione esso è funzionale (v. Marx in ‘ Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico ’, in ‘La questione ebraica’, anche ne ‘Le lotte di classe in Francia dal 1848 al 1850, e nella ‘Critica del programma di Gotha’, ed. di Mosca, 1947, p. 37, in cui scrive che ‘la presente radice dello Stato è la società borghese’).
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Repressione in Francia. La verità vittima collaterale…
Repressione in Francia. La verità vittima collaterale…
di Giacomo Marchetti
Questo è ciò che è realmente successo il primo maggio a Parigi.
Delle persone fuggono dalle cariche e salgono sulle scale anti-incendio di un edificio che è un ospedale. Si tratta del reparto di ri-animazione.
Il personale presente chiude la porta, e dice ai presenti di che reparto si tratta e che ci sono dei malati all’interno.
Solo una persona, visibilmente terrorizzata dalle forze dell’ordine arrivate di lì a poco cerca di entrare…
Leggi tutto
Mauro Indelicato: Lo dicono anche gli africani: la solidarietà europea fa male
Lo dicono anche gli africani: la solidarietà europea fa male
di Mauro Indelicato
Pioggia di soldi, miliardi di Dollari spesi negli ultimi anni a favore dello sviluppo, ma i risultati appaiono peggiori rispetto a quelli del punto di partenza: il riferimento è all’Africa ed a tutti il flusso di denaro donato al continente nero, senza che però i paesi più poveri siano usciti dalle condizioni di indigenza e difficoltà. Una circostanza questa, che da anni viene evidenziata in primis proprio in Africa. Eppure, proprio dall’Europa, la tendenza alla “facile carità” non sembra essere messa in discussione.
I danni della solidarietà
I problemi che vive il continente africano sono ben noti: dalla miseria alle guerre, da paesi poco stabili a governi fin troppo stabili. Problemi strutturali dunque, che riguardano l’economia così come la società e le varie popolazioni degli Stati che compongono l’Africa. Su nessuno di questi arrivano segnali positivi, a fronte come detto di fiumi di denaro mandati negli anni tra donazioni private o prestiti da parte di fondi ed enti sovrani. Il continente continua ad avere le stesse negative peculiarità di cui soffre da decenni.
Soldi di cui poi si sa poco circa il reale utilizzo: in molti casi, i miliardi di dollari spediti in Africa fanno arricchire locali lobbisti i politici, senza che la loro destinazione d’uso venga minimamente rispettata.
Leggi tutto
Temps critiques: Gilet gialli: una resistenza alla rivoluzione del capitale
Gilet gialli: una resistenza alla rivoluzione del capitale
di Temps critiques
Quale relazione?
Nel momento in cui troviamo d'accordo nel riconoscere una relazione fra il movimento dei Gilet gialli ed i processi contemporanei di totalizzazione e di globalizzazione del capitale - processo che abbiamo chiamato «la rivoluzione del capitale» - diventa importante caratterizzare una tale relazione facendolo in maniera diversa da quella che parla di un semplice rapporto immediato di causa/conseguenza. È stato prodotto un flusso di discorsi e di scritti i quali affrontano questa determinazione causale: i Gilet gialli sono in rivolta contro ogni genere di disastro causato loro dalla «globalizzazione», i Gilet gialli sono le vittime de «La Finanza», delle aziende multinazionali e dello Stato che li taglieggia. Un'affermazione simile non è per niente falsa, ma rimane sommaria fino al punto di sfiorare la tautologia, dal momento che si potrebbe dire una cosa del genere riferita a qualsiasi rivendicazione categoriale. Inoltre, non tiene assolutamente conto del carattere inatteso ed imprevisto del sollevamento dei Gilet gialli; cosa che lo rende un avvenimento storico singolare.
Perciò, ci sembra più appropriato sostenere che i Gilet gialli hanno svolto la funzione di aver fatto emergere ed analizzare la rivoluzione del capitale. Questo è un effetto di disvelamento, di delucidazione, di rilevazione e di intervento, e ci sembra più giusto parlare in questi termini di quello che, in Francia e nel mondo, è il momento-dei Gilet-gialli.
Leggi tutto
Enrico Grazzini: Debito pubblico, come me anche il Financial Times auspica una moneta complementare per l’Italia
Debito pubblico, anche il Financial Times auspica una moneta complementare per l’Italia
di Enrico Grazzini
“La soluzione più ovvia all’insostenibilità dell’Italia nella zona euro sarebbe la ristrutturazione del suo debito pubblico. Ma i governi della zona euro non sono preparati a questa possibilità. E’ invece più probabile che valute parallele, titoli di debito non convenzionali o addirittura criptovalute offriranno l’opportunità per un’uscita non ufficiale (dell’Italia dai vincoli dell’euro, nda). In tal modo si scoprirà che si può essere dentro l’eurozona e fuori dall’eurozona nello stesso tempo”.
Così Wolfgang Munchau, l’editorialista del Financial Times per l’Europa, conclude il suo articolo del 28 aprile intitolato The unbreakable, unsustainable eurozone. Munchau sottolinea la contraddizione genetica del sistema dell’euro. L’euro infatti ha un’architettura che lo condanna a essere insostenibile, ma è anche strutturato in maniera tale da non permettere a un Paese di uscire prima dello schianto. Come un’automobile con le portiere bloccate che corre inesorabilmente verso il burrone. Munchau fa un’analisi cruda e realistica. Il sistema della moneta unica può sopravvivere solo se viene riformato strutturalmente: altrimenti è destinato a spaccarsi con la prossima prevedibile crisi finanziaria.
Per Munchau la soluzione migliore per uscire dalla crisi sarebbe quella di emettere degli eurobond, ovvero un titolo sovrano comune che dimostri la forza dell’Europa sia sul piano finanziario che su quello geopolitico.
Leggi tutto
Gianni Francioni: L’estensione del concetto di ideologia in Gramsci e la genesi delle sue articolazioni
L’estensione del concetto di ideologia in Gramsci e la genesi delle sue articolazioni
Gianni Francioni (Università di Pavia)
 1. Seguendo il «ritmo del pensiero
in isviluppo»1
nelle pagine dei Quaderni del carcere, vorrei
mostrare come nascono, tra il giugno 1929 e il novembre 1930,
gli elementi costitutivi
della famiglia concettuale dell’ideologia.
1. Seguendo il «ritmo del pensiero
in isviluppo»1
nelle pagine dei Quaderni del carcere, vorrei
mostrare come nascono, tra il giugno 1929 e il novembre 1930,
gli elementi costitutivi
della famiglia concettuale dell’ideologia.
Quella che indico come “famiglia concettuale” è appunto un insieme di concetti correlati fra loro. Come tutte le famiglie, ha una forma ristretta e una allargata, se vi si includono anche i parenti meno vicini. Se limitiamo al massimo le relazioni di parentela, possiamo dire che appartengono certamente alla famiglia concettuale dell’ideologia, oltre al termine che le dà il nome, lemmi come: soprastruttura, filosofia, concezione del mondo (e le sue varianti: concezione del mondo e della vita, concezione della vita o, nell’originale tedesco dell’espressione, Weltanschauung, che però Gramsci usa pochissime volte nei suoi quaderni); e ancora: religione, senso comune, folklore. La famiglia può essere ampliata includendovi egemonia, conformismo, linguaggio, utopia, mito ecc.
Per Gramsci, come per ogni buon marxista, l’ideologia è innanzi tutto una soprastruttura: secondo le notissime espressioni usate da Marx nella Prefazione del 1859 a Per la critica dell’economia politica, l’insieme dei rapporti di produzione costituisce la «struttura economica della società», «base reale sulla quale si eleva una superstruttura giuridica e politica e alla quale corrispondono determinate forme sociali della coscienza»: «forme giuridiche, politiche, religiose, artistiche o filosofiche», definite nella loro generalità «forme ideologiche»2. D’altro canto, come ogni marxista del suo tempo, Gramsci impiega spesso in tutti i quaderni il termine ideologia sia in un’accezione negativa, sia in un’accezione neutra, descrittiva (entrambe erano usuali all’epoca in cui egli scrive).
Leggi tutto
Fernanda Mazzoli: New management, autonomia scolastica ed autonomia differenziata
New management, autonomia scolastica ed autonomia differenziata
di Fernanda Mazzoli
 Nella cornice del New
Public Management trova fertile humus la
richiesta dell’autonomia
differenziata da parte di alcune regioni italiane che
rivendicano il governo diretto di diversi ambiti della vita
pubblica. Sono regioni fra le
più ricche d’Italia che mirano a stabilire legami diretti
con le altre regioni più avanzate d’Europa e ritengono di
poterlo
fare con maggiore successo, se svincolate dal quadro
istituzionale nazionale e dagli obblighi - fiscali in primo
luogo, ma non solo - che
esso comporta. Hanno in primo luogo bisogno di controllare
settori strategici e, fra questi, uno dei più importanti è
rappresentato
dalla scuola. Non è un caso che sulla scia delle più note
Emilia, Lombardia e Veneto, anche Marche e Umbria abbiano
avviato un percorso
in comune di autonomia differenziata limitato a poche
discipline e che riguarda proprio l’istruzione e la
formazione tecnica e professionale,
nonché l’università. La posta in gioco è appetitosa: la
riorganizzazione dell’istruzione in senso regionale comporta
non solo la gestione del personale, ma la possibilità di
intervenire sul curricolo degli studenti e
sull’Alternanza
Scuola-Lavoro. La regionalizzazione del sistema scolastico
(o di parte di esso) punta a costruire in tempi brevi quella
sinergia tra istruzione ed
impresa invocata dagli organismi europei e dalle
associazioni di categoria degli industriali e chiamata a
fare della scuola il luogo
dell’addestramento delle giovani generazioni alle competenze
richieste dalle aziende del territorio.
Nella cornice del New
Public Management trova fertile humus la
richiesta dell’autonomia
differenziata da parte di alcune regioni italiane che
rivendicano il governo diretto di diversi ambiti della vita
pubblica. Sono regioni fra le
più ricche d’Italia che mirano a stabilire legami diretti
con le altre regioni più avanzate d’Europa e ritengono di
poterlo
fare con maggiore successo, se svincolate dal quadro
istituzionale nazionale e dagli obblighi - fiscali in primo
luogo, ma non solo - che
esso comporta. Hanno in primo luogo bisogno di controllare
settori strategici e, fra questi, uno dei più importanti è
rappresentato
dalla scuola. Non è un caso che sulla scia delle più note
Emilia, Lombardia e Veneto, anche Marche e Umbria abbiano
avviato un percorso
in comune di autonomia differenziata limitato a poche
discipline e che riguarda proprio l’istruzione e la
formazione tecnica e professionale,
nonché l’università. La posta in gioco è appetitosa: la
riorganizzazione dell’istruzione in senso regionale comporta
non solo la gestione del personale, ma la possibilità di
intervenire sul curricolo degli studenti e
sull’Alternanza
Scuola-Lavoro. La regionalizzazione del sistema scolastico
(o di parte di esso) punta a costruire in tempi brevi quella
sinergia tra istruzione ed
impresa invocata dagli organismi europei e dalle
associazioni di categoria degli industriali e chiamata a
fare della scuola il luogo
dell’addestramento delle giovani generazioni alle competenze
richieste dalle aziende del territorio.
* * * *
A partire dagli anni ’80 del secolo scorso comincia ad imporsi una corrente di pensiero, destinata ad influire profondamente sulle dinamiche socio-politiche e culturali del nostro tempo, che propone di importare le regole di funzionamento del mercato concorrenziale nel settore pubblico. I principi ispiratori del new management e della public governance affondano le loro radici nell’elaborazione del concetto di “società imprenditoriale”. Peter Drucker, teorico del management, riprendendo certi aspetti dell’imprenditore schumpteriano- l’uomo della “distruzione creatrice”- propugna la costruzione di una nuova società di imprenditori, il cui spirito deve diffondersi in tutta la società.
Leggi tutto
Norberto Fragiacomo: Senza democrazia non può esserci libera informazione (e viceversa)
Senza democrazia non può esserci libera informazione (e viceversa)
di Norberto Fragiacomo
 Ho udito,
non molto tempo fa, un giornalista affermare alla radio che
senza
l’Unione Europea non avremmo in Italia democrazia e diritti –
e che comunque nessuno può fornire prove dell’asserto
contrario
(“non esiste controprova”, mi pare abbia detto).
Ho udito,
non molto tempo fa, un giornalista affermare alla radio che
senza
l’Unione Europea non avremmo in Italia democrazia e diritti –
e che comunque nessuno può fornire prove dell’asserto
contrario
(“non esiste controprova”, mi pare abbia detto).
Più che di una spudorata menzogna potremmo parlare di una smaccata contraffazione della realtà, che assieme all’onere probatorio viene bellamente capovolta: siamo di fronte ad una μυθοποίησις, cioè alla cosciente creazione di un mito – termine che non a caso in greco antico significa “favola”. Giornalisti che anziché descrivere l’esistente ci raccontano favole: ecco il punto di partenza di una breve riflessione dedicata al tema, oggi attualissimo, dei rapporti fra democrazia e comunicazione.
Visto che le astrazioni ci interessano fino a un certo punto, cominceremo la nostra analisi dal dato testuale, partendo non da un’opera qualsiasi, bensì dalla Costituzione del ’48. L’articolo 1 proclama che l’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro, e già dalla scelta del participio possiamo desumere utili informazioni sul significato che i costituenti vollero assegnare ad un sostantivo di per sé ambiguo – o, per meglio dire, non di rado ambiguamente adoperato.
Democrazia non è sinonimo di suffragio universale né di multipartitismo, perché gli articoli 2, 3 e 4 trattano di tutt’altro: di diritti fondamentali, doveri civici, uguaglianza effettiva e promozione della piena occupazione. Secondo chi redasse la Costituzione repubblicana non ci può essere democrazia autentica senza diritti civili, sociali ed economici garantiti alla generalità dei cittadini.
Fra i diritti e doveri in ambito civile figurano quelli ricompresi nei primi due commi dell’articolo 21: la libertà di espressione (e comunicazione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”) e la libertà di informazione (“La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure”).
Leggi tutto
Domenico Moro: Spagna: l’abbraccio pericoloso dei socialisti per Podemos
Spagna: l’abbraccio pericoloso dei socialisti per Podemos
di Domenico Moro
Le ultime elezioni politiche spagnole sono state un test importante, ma da non sopravvalutare. Alcuni hanno tratto dall’esito delle elezioni due conclusioni. La prima è che saremmo davanti all’arresto della crisi del bipolarismo europeista, basata sull’alternanza dei partiti nazionali che fanno rispettivamente riferimento al Partito popolare europeo (Ppe) e al Partito socialista europeo (Pse). La seconda è un rinnovato interesse per la vecchia formula del centro-sinistra. Chi la vagheggia sembra trarre spunto dall’appoggio parlamentare di Podemos al Partito socialista, che ha permesso a quest’ultimo di governare la Spagna negli ultimi due anni. Ma quali sono stati i risultati effettivi delle elezioni?
In primo luogo, non pare che in Spagna la crisi del blocco bipolare si sia arrestata. Insieme i due partiti afferenti a Ppe e Pse hanno raccolto alla Camera dei Deputati appena il 45,4% dei voti contro il 55,6% del 2016, in voti assoluti sono scesi da 13,5 a 11,8 milioni. È vero che l’astensionismo si è ridotto di quasi nove punti, ma ciò è dipeso dall’aumento dell’offerta politica, grazie alla discesa in campo o alla crescita di nuovi partiti, indipendentisti e nazionalisti.
Tra i due principali partiti, il partito socialista e il partito popolare, a vincere le elezioni sono i socialisti che passano dal 22,6% del 2016 al 28,7% del 2019 con un guadagno di poco meno di 2 milioni di voti, mentre i popolari hanno perduto oltre 3 milioni e mezzo di voti, dimezzando addirittura la loro quota dal 33% al 16,7%. Perché questa differenza?
Leggi tutto
Gennaro Carotenuto: Il golpetto di Juan Guaidó. Un altro stress test (fallito?) per il Venezuela
Il golpetto di Juan Guaidó. Un altro stress test (fallito?) per il Venezuela
di Gennaro Carotenuto
Di nuovo tanto rumore per nulla nell’ennesima giornata decisiva in Venezuela? Quello di martedì 30 è stato un fallimento o una prova generale di colpo di stato? Intorno all’autoproclamato Juan Guaidó (affiancato dal leader Leopoldo López) è come se si svolgessero da mesi dei ripetuti “stress test”. Quello che non si vede è ben maggiore di quello che è visibile in superficie e si sottovalutano attori, a cominciare dal Brasile.
Quello di martedì 30 aprile è stato uno stress test sull’esercito per vedere, come già a Cúcuta a fine febbraio, se c’è un punto d’inflessione oltre il quale un numero decisivo di esponenti degli stati maggiori possano rivoltarsi, uscendo dalle caserme dove devono restare, giocando con una guerra civile dietro l’angolo. Ma è stato stress test anche per la società civile. Come per i blackout di marzo, la convocazione di Guaidó e López è servita a misurare chi scende in piazza, chi tra i leader dell’opposizione è coerente e accetta l’attuale leadership. Questa da ieri è tornata ufficialmente a Leopoldo López, al quale Guaidó (anche se la grande stampa fa fatica a capirlo) scaldava il posto. Anche il déjà vu degli scontri di piazza da parte di bande di violenti organizzati, come già nel 2014 e 2017 (da non confondere con la legittima protesta dell’opposizione civile), sono stati limitati e si sono andati esaurendo al calar della notte. Ancora una volta nel 2019 – per fortuna – la società civile, chavista e anti-chavista, polarizzata quanto si vuole, si è tenuta lontana dalla violenza.
Leggi tutto
Roberto Fai: Sul mantra del nostro tempo: “che fine hanno fatto gli intellettuali?”
Sul mantra del nostro tempo: “che fine hanno fatto gli intellettuali?”
di Roberto Fai
L’intervento di Roberto Cotroneo – Intellettuali, ma dove siete finiti? –, pubblicato il 5 aprile scorso su Repubblica, costituisce la spia di umori molto diffusi. Tuttavia, questa domanda rischia di essere fuorviante, elude il nodo reale del problema. Cotroneo sceglie un bersaglio, gli intellettuali, la cui collocazione e il cui peso costituiscono semmai – dire le “vittime”, apparirebbe enfatico – una sorta di “buco nero”, che rende semmai manifesta la grave crisi ideale, politica, culturale e strategica del nostro paese. Non certo per colpa degli intellettuali, di cui Cotroneo lamenta, nella sua riflessione, l’assenza o l’ineffettualità del ruolo, nella scena politico-culturale nazionale. Quasi che lo smarrimento etico-culturale e lo stato di frustrazione che il paese stia vivendo, sia per l’assenza di prospettive ricche di senso sia per l’affermarsi di tonalità emotive regressive – rancore e risentimento diffuso –, possano essere attribuiti agli intellettuali, o possano vedere questi ultimi (filosofi, scrittori, uomini di lettere, di pensiero, di scienza, ecc.) sul banco degli imputati, nella veste di colpevoli. Cotroneo non manca di segnalare l’effervescenza che ha connotato e connota presenza e vivacità degli intellettuali in questi ultimi decenni con l’affermarsi di presenze, rassegne, festival di grande successo e richiamo – Filosofia, letteratura, economia, saperi sociali, arte, ecc. – mentre riconosce l’espansione, specularmente opposta, di un processo di banalizzazione e abbassamento del punto medio di competenza intellettuale, dovuto essenzialmente alla pervasiva diffusione del web e dei social – volto “tecnico” della globalizzazione –, che ha avuto peraltro l’effetto di delegittimare il ruolo “specialistico” delle varie comunità linguistiche dentro cui s’incardina, si svolge e s’inventa sia il lavoro scientifico che quello dei diversi “saperi” e dell’intellettualità in genere.
Leggi tutto
Pasqualina Curcio: L’iperinflazione in Venezuela. Attacco alla moneta o dipendenza dal petrolio?
L’iperinflazione in Venezuela. Attacco alla moneta o dipendenza dal petrolio?
di Pasqualina Curcio*
Ci sono alcuni economisti che tentano di fare analisi con una grande mancanza di conoscenza dell’economia, in particolare della realtà venezuelana, avendo scritto che la situazione iperinflazionistica che esiste attualmente in Venezuela, che è estremamente complessa, sia determinata dalla dipendenza dalle esportazioni di petrolio e anche dall’alta dipendenza dalle importazioni di beni essenziali.
Costoro affermano che di fronte al calo del prezzo del petrolio, e quindi alla diminuzione delle esportazioni, il paese sia entrato in una situazione di deficit della bilancia dei pagamenti che, a sua volta, fa pressioni sulla perdita di valore della moneta bolivar, aumenta il prezzo delle merci importate (da cui, secondo questi, siamo molto dipendenti) con conseguente iperinflazione.
Devono essere fatte diverse precisazioni al riguardo (si vedano ad esempio centinaia di articoli sui siti di Últimas noticias, o di 15 Ultimo, Correo dell’Orinoco, 4 F, etc; ed anche davvero una infinità di disposizioni, circolari, documenti di commissioni economiche e atti governativi venezuelani, e pubblicati inoltre in Italia per esempio i due recenti libri: Pasqualina Curcio, La mano visibile del mercato, guerra economica in Venezuela, Ediz. Efesto 2019; Luciano Vasapollo con Joaquin Arriola, Trattato di critica delle politiche per il governo dell’economia, Vol. 2, Teoria e critica delle politiche economiche e monetarie dello sviluppo, Ediz. Efesto 2019).
Leggi tutto
Hits 3283
Hits 3214
Hits 2972
Hits 2914
Hits 2855
Hits 2721
Hits 2532
Hits 2499
Hits 2473
Hits 2384
tonino

Maurizio Donato: Accumulazione di capitale e ruolo dell’innovazione
Accumulazione di capitale e ruolo dell’innovazione
di Maurizio Donato
La dinamica valorizzazione – svalorizzazione nel rapporto tra innovazione e accumulazione
 Nel primo
trimestre del 2019 il ‘valore’ mondiale delle obbligazioni a
tassi negativi è tornato ad avvicinarsi ai livelli massimi
toccati nell’estate del 2016. Da allora, a riportare in alto i
tassi nominali
spingendo al rialzo anche i rendimenti delle obbligazioni è
stata unicamente la ripresa nelle aspettative di inflazione. Questo obiettivo, una
maggiore
inflazione, è stato al centro dell’impegno delle banche
centraliche dal 2009 hanno iniettato quasi 20mila
miliardi di
dollari attraverso numerose politiche espansive. Ma
evidentemente una politica monetaria pure ultra-accomodante
non serve o non basta: i problemi
dell’economia sono ‘reali’.
Nel primo
trimestre del 2019 il ‘valore’ mondiale delle obbligazioni a
tassi negativi è tornato ad avvicinarsi ai livelli massimi
toccati nell’estate del 2016. Da allora, a riportare in alto i
tassi nominali
spingendo al rialzo anche i rendimenti delle obbligazioni è
stata unicamente la ripresa nelle aspettative di inflazione. Questo obiettivo, una
maggiore
inflazione, è stato al centro dell’impegno delle banche
centraliche dal 2009 hanno iniettato quasi 20mila
miliardi di
dollari attraverso numerose politiche espansive. Ma
evidentemente una politica monetaria pure ultra-accomodante
non serve o non basta: i problemi
dell’economia sono ‘reali’.
Secondo gli economisti del periodo classico, affinché possa ripartire il meccanismo di accumulazione, una parte significativa del capitale in eccesso sulle possibilità medie di valorizzazione deve essere svalutato o distrutto, non solo capitale nella sua forma monetaria, ma capitale costante, merci nella loro duplice natura di valori d’uso e valore tout-court, e capitale variabile, la forza-lavoro pagata al suo valore, la cui svalutazione continua sta comportando conseguenze almeno altrettanto paradossali e ben più tragiche dei tassi di interesse negativi.
Non performing capital
Nel succedersi dei cicli economici è normale che una parte dello stock di capitale esistente resti interamente o parzialmente inattiva, mentre il resto viene valorizzato ad un saggio di profitto inferiore al massimo teorico possibile proprio a causa della pressione del capitale totalmente o parzialmente inattivo. Una parte dei mezzi di produzione, del capitale fisso e del capitale circolante periodicamente cessa di agire come capitale, una parte delle imprese produttive in azione resta inoperosa; la direzione della traiettoria, il segno del rapporto tra valorizzazione e svalorizzazione, dipende dalla forza della concorrenza che decide quale e quanta frazione del capitale globale debba nei diversi casi particolari essere condannata all’inoperosità.
Leggi tutto
Fernanda Mazzoli: L’albero filosofico del Ténéré
L’albero filosofico del Ténéré
di Fernanda Mazzoli
Recensione di Salvatore A. Bravo: L’albero filosofico del Ténéré. Esodo dal nichilismo ed emancipazione in Costanzo Preve, Ed. Pétite Plaisance, 2019
 Dai muri
della città dove abito, i manifesti pubblicitari di una delle
maggiori
catene della grande distribuzione (che si richiama, peraltro,
a valori solidaristici) ammoniscono i passanti che «Siamo
quello che
scegliamo». A chiarimento della scelta in questione,
campeggiano i primi piani di persone di diversa età che covano
con sguardo fra
l’affettuoso e l’orgoglioso chi un vasetto di marmellata
(naturalmente biologica), chi uno spazzolino da denti, chi una
confezione di
caffé macinato. Così, la straordinaria stratificazione
architettonica, paesaggistica, storica e culturale di questa
piccola e bellissima
città si appiattisce improvvisamente nel piano liscio dove a
scorrere sono solo le merci, prodigiosamente inesauribili,
tutte diverse nella
loro sollecitazione alla scelta, tutte interscambiabili
nell’indistinto della bulimia dei consumi. Questo piano liscio
nutre una nuova
antropologia, in cui l’uomo è dato dalla sua relazione
con le merci e la libertà – quella libertà senza la quale
l’esistenza perde senso e valore – diventa libertà di
scegliere il prodotto più confacente alle proprie esigenze.
Dai muri
della città dove abito, i manifesti pubblicitari di una delle
maggiori
catene della grande distribuzione (che si richiama, peraltro,
a valori solidaristici) ammoniscono i passanti che «Siamo
quello che
scegliamo». A chiarimento della scelta in questione,
campeggiano i primi piani di persone di diversa età che covano
con sguardo fra
l’affettuoso e l’orgoglioso chi un vasetto di marmellata
(naturalmente biologica), chi uno spazzolino da denti, chi una
confezione di
caffé macinato. Così, la straordinaria stratificazione
architettonica, paesaggistica, storica e culturale di questa
piccola e bellissima
città si appiattisce improvvisamente nel piano liscio dove a
scorrere sono solo le merci, prodigiosamente inesauribili,
tutte diverse nella
loro sollecitazione alla scelta, tutte interscambiabili
nell’indistinto della bulimia dei consumi. Questo piano liscio
nutre una nuova
antropologia, in cui l’uomo è dato dalla sua relazione
con le merci e la libertà – quella libertà senza la quale
l’esistenza perde senso e valore – diventa libertà di
scegliere il prodotto più confacente alle proprie esigenze.
L’uomo – questo essere su cui la natura e la storia hanno inciso segni tanto profondi quanto quelli che da lui hanno ricevuto – si risolve in un consumatore, responsabile e soddisfatto della nuova leggerezza acquisita: il necessario fardello del suo rapporto con se stesso e con il mondo ha ridotto le sue dimensioni a quelle di un carrello del supermercato.
La centralità della merce è religione che non ammette devoti tiepidi: avendo da tempo travalicato gli argini della sfera economica, ha finito per modellare comportamenti sociali e condotte individuali, per riorientare la percezione che si ha di sè e del mondo, per plasmare menti e corpi, pensieri e sentimenti.
Leggi tutto
Lars T. Lih: ‘Tutto il potere ai Soviet!’. Parte terza
‘Tutto il potere ai Soviet!’. Parte terza
Lettera da lontano, correzioni da vicino: censura o rimaneggiamento?
di Lars T. Lih
Pubblichiamo la parte terza di questo scritto di Lih, l'unica che mancava dei sette che il sito Traduzioni marxiste ha meritoriamente messo in rete e che a suo tempo non eravamo riusciti a reperire. In ogni caso in fondo all'articolo abbiamo inserito l'elenco completo con i link
 L’interpretazione
corrente del bolscevismo nel 1917 basata sul concetto di
“riarmo del
partito” è una narrazione avvincente e altamente drammatica,
che può essere riassunta, grosso modo, nel modo seguente: il
vecchio
bolscevismo era stato reso irrilevante dalla Rivoluzione di
febbraio, i bolscevichi in Russia si trovarono in affanno sino
al ritorno di Lenin, il
quale provvedette al riarmo del partito, e quest’ultimo,
successivamente, si divise riguardo a questioni fondamentali
nel corso di tutto
quell’anno. L’unità del partito venne infine restaurata –
quantomeno in una certa misura – dopo che gli altri
principali esponenti bolscevichi cedettero alla superiore
forza di volontà di Lenin. Solo in tal modo il partito
intraprese quel riarmo che lo
dotò di una nuova strategia, una strategia che proclamava il
carattere socialista della rivoluzione – una condizione
essenziale della
vittoria bolscevica in ottobre.
L’interpretazione
corrente del bolscevismo nel 1917 basata sul concetto di
“riarmo del
partito” è una narrazione avvincente e altamente drammatica,
che può essere riassunta, grosso modo, nel modo seguente: il
vecchio
bolscevismo era stato reso irrilevante dalla Rivoluzione di
febbraio, i bolscevichi in Russia si trovarono in affanno sino
al ritorno di Lenin, il
quale provvedette al riarmo del partito, e quest’ultimo,
successivamente, si divise riguardo a questioni fondamentali
nel corso di tutto
quell’anno. L’unità del partito venne infine restaurata –
quantomeno in una certa misura – dopo che gli altri
principali esponenti bolscevichi cedettero alla superiore
forza di volontà di Lenin. Solo in tal modo il partito
intraprese quel riarmo che lo
dotò di una nuova strategia, una strategia che proclamava il
carattere socialista della rivoluzione – una condizione
essenziale della
vittoria bolscevica in ottobre.
Osservatori con punti di vista politici significativamente contrastanti avevano tutti le loro ragioni per sostenere una qualche versione della narrazione del riarmo [1]. Questa sembrò trovare duplice conferma quando, negli anni Cinquanta, divenne noto che la versione della prima lettera da lontano di Lenin, pubblicata dalla Pravda nel marzo 1917, era stata pesantemente emendata, con la rimozione di circa un quarto del testo. Fatto divenuto la base di un vivido e persuasivo aneddoto su come i bolscevichi di Pietrogrado, esterrefatti e impauriti, avrebbero censurato Lenin, il loro stesso vozhd [guida, leader, n.d.t.].
Ecco come viene generalmente raccontata questa storia: ai primi del marzo 1917, subito dopo la caduta dello zar, Lenin esponeva la propria reazione agli sconvolgimenti russi in quattro cosiddette Lettere da lontano, servendosi delle succinte notizie di cui disponeva in Svizzera. Ma i bolscevichi di Pietrogrado si mostrarono assai scandalizzati da quanto espresso nelle Lettere di Lenin, e questo a causa di audaci innovazioni in fondamentale rottura col vecchio bolscevismo. Il turbamento suscitato dall’audacia di Lenin nei redattori della Pravda fu tale che questi rifiutarono di pubblicare tre delle Lettere da lontano, e anche la sola che venne effettivamente diffusa subì pesanti censure, con tagli che ne sfiguravano l’essenza del messaggio.
Leggi tutto
Sergio Cesaratto: La cura che creò il malato. L’origine della crisi italiana
La cura che creò il malato. L’origine della crisi italiana
La verità viene lentamente a galla
di Sergio Cesaratto
Altro che “mancate riforme”. Dal 1995 la disciplina fiscale e le politiche del lavoro hanno fatto crollare investimenti e produttività
La verità viene lentamente a galla. La narrazione che viene dai paesi d’oltralpe è di un’Italia fiscalmente dissoluta. Tale immagine viene purtroppo condivisa anche da parte dell’establishment nostrano, particolarmente nell’area del centro-sinistra, che vede nel debito pubblico il nemico numero uno. Un post e un articolo di un noto economista olandese, Servaas Storm, appena pubblicati, ci raccontano un’altra storia (“Come rovinare un Paese in tre decadi” e “Perduto nella deflazione", scaricabili dall’Institute for New Economic Thinking).
La sua tesi è che l’Italia sia stata la più ligia alle regole europee sui conti pubblici e, proprio per questo, abbia ottenuto il doppio insuccesso di non sanarli pur al prezzo della mortificazione di domanda interna, occupazione e crescita. La progressiva flessibilizzazione del mercato del lavoro, inoltre, ha influito negativamente sui salari reali; questo, assieme a un tasso di cambio reale sopravvalutato grazie all’euro, ha ulteriormente depresso la domanda per i prodotti italiani. L’Italia, scrive Storm, “può ben essere definita la prima della classe dell’Eurozona, in quanto ha radicalmente trasformato la sua politica economica – abbandonando la sua economia mista, riducendo i suoi sistemi sanitario e pensionistico, liberalizzando i sistemi finanziario e industriale, e limitando il controllo democratico e parlamentare sulle sue politiche macroeconomiche”.
Leggi tutto
Marco Della Luna: I dioscuri ci liberano dall'euro?
I dioscuri ci liberano dall'euro?
di Marco Della Luna
Le mosse di politica economica del presente governo appaiono a molti chiaramente e seriamente dannose e destabilizzanti, direi irresponsabili – ma non lo sono, se hanno lo scopo strategico che suggerirò in fondo a questo articolo. Nel qual caso sarebbero, al contrario, sagge, lungimiranti, meritorie, e ben potremmo acclamare i Dioscuri.
Nella campagna elettorale dell’anno scorso e pure in quella attuale, Salvini e Di Maio hanno impiccato se stessi, e insieme a sé tutta l’Italia, a promesse elettorali demagogiche, incompatibili con la condizione del Paese: reddito di cittadinanza, decreto dignità, quota cento, flat tax – misure fattibili solo in uno Stato poco indebitato e in crescita economica, oppure padrone della propria moneta, come USA e Giappone. Da tali promesse i due non possono smarcarsi prima delle elezioni europee, nonostante che emerga sempre più la loro insostenibilità.
Siccome l’Italia è fortemente indebitata, economicamente bolsa, e deve farsi finanziare da investitori esterni in una moneta che non controlla, l’attuale governo ha dovuto rinviare o ridurre di molto le promesse iniziali, e la parte di esse che ha attuato ha già prodotto effetti sfavorevoli sul piano finanziario (aumento di spread e di rendimenti sul debito pubblico, contrazione del credito, uscita di capitali, sfavore di ampi settori produttivi) e pare avrà effetti negativi pure su quello economico, per giunta in una fase recessiva che li amplificherà, soprattutto se si andrà a sbattere contro il muro delle clausole di salvaguardia, col rialzo dell’Iva che il governo smentisce ma lo ha già iscritto nel DEF.
Leggi tutto
David Insaidi: Iran, gli USA impongono sanzioni…al mondo
Iran, gli USA impongono sanzioni…al mondo
di David Insaidi
Le guerre, oggi più che mai, non si combattono soltanto con le armi e sul fronte. La lotta economica sta assumendo un’importanza, via via, sempre crescente.
D’altronde negli ultimi 18 anni gli Stati Uniti d’America, spesso appoggiati da paesi europei, hanno condotto in Medio Oriente ben tre guerre in modo diretto (Afghanistan, Iraq e Libia) e una in modo indiretto (Siria; anche se vi sono stati pure lì non pochi interventi diretti). È da ricordare, inoltre, che la guerra in Afghanistan, nonostante il silenzio mediatico, non è mai terminata e risulta, quindi, tuttora in corso ed anche quella in Iraq è stata molto più lunga ed ostica di quanto era nelle previsioni.
Logico, dunque, che gli USA ci pensino due volte prima di provare ad attaccare militarmente un paese come l’Iran. Il quale, per giunta, a differenza degli altri paesi citati, si può considerare una vera e propria potenza regionale e, per territorio e popolazione, sovrasta nettamente gli altri.
Scartata – almeno per il momento – l’opzione militare, il neo-presidente USA Donald Trump sta tentando in tutti i modi di indebolire e di far crollare il regime degli ayatollah, attaccandolo sul fronte economico. E di solito quando si parla di attacco economico, si parla di sanzioni.
Per la verità le sanzioni nei confronti dell’Iran esistono da tanti anni. Però nel 2015 si era giunti ad un accordo sul nucleare tra Teheran e i paesi occidentali, per cui le sanzioni erano stato ridotte, in cambio della rinuncia iraniana ai progetti nucleari.
Leggi tutto
Guido Salza: Gilets gialli, neri e rossi
Gilets gialli, neri e rossi
di Guido Salza
Cronaca politica del primo maggio parigino
Parigi - mercoledì Primo Maggio. Le strade della capitale francese sono state ancora una volta testimoni di violenti scontri tra la polizia e i gilets gialli. La loro protesta, partita spontaneamente per opporsi all’aumento delle tasse sul carburante, si è trasformata in una lunga battaglia per le dimissioni di Macron e ieri ha rubato il palcoscenico alla sinistra nella data storica della Festa del Lavoro. I gilets sono simbolo della richiesta istintiva di ampi strati di popolazione per una forte discontinuità con il recente passato politico. La marea gialla ha bloccato la Francia ogni sabato durante le scorse 24 settimane, e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Con loro si sono dovuti confrontare tutti.
Gilets gialli
Partiamo dai nuovi protagonisti del primo maggio parigino, i gilets gialli. Alle 11 del mattino in piazza non ci sono che loro sotto la torre di Montparnasse. La polizia già filtra gli accessi alla piazza, dove è previsto il concentramento. I celerini in cordone aprono zaini, controllano documenti e a mezze parole fanno capire che non c’è da scherzare. Ma con i gilets le minacce non sembrano troppo efficaci.
Leggi tutto
Vincenzo Comito: Unicredit e il destino delle banche europee
Unicredit e il destino delle banche europee
di Vincenzo Comito
Il destino di Unicredit si lega alla crisi delle tedesche Commerzbank e Deutsche Bank e alla possibile fusione con Société Générale. La punta dell’iceberg del riassetto del sistema bancario europeo e mondiale
 Unicredit
al centro dell’attenzione
Unicredit
al centro dell’attenzione
Non capita di frequente che delle banche italiane si parli con molto rilievo nella stampa internazionale, se non in occasione di possibili crisi delle stesse. Ma in queste settimane le vicende di Unicredit sono state al centro dell’attenzione del mondo politico e finanziario europeo ed oltre; e questo, oltre che per la pesante multa comminata dagli Stati Uniti alla banca (alcune delle cui filiali, in particolare quella tedesca, avrebbero infranto le sanzioni all’Iran e ad altri Paesi),anche per il suo interesse all’acquisizione della tedesca Commerzbank e/o (non è chiaro) per una possibile fusione con la francese Société Générale, nonché infine per una possibile multa che potrebbe essere comminata all’istituto dalla Commissione Europea per una supposta violazione delle norme antitrust, sempre da parte della filiale tedesca (la violazione avrebbe peraltro interessato anche altre sette banche del nostro continente).
Partendo in particolare dalle citate ipotesi di fusione, si può cercare di sviluppare qualche ragionamento più ampio intorno allo Stato e alle prospettive delle grandi banche del nostro continente.
L’ipotesi di acquisizione
L’Unicredit, come del resto più in generale il sistema bancario italiano, sono usciti da poco da una grave crisi. A suo tempo l’istituto aveva avviato una strategia di grande espansione all’estero, in Europa e nel resto del mondo, che era arrivata a toccare anche le lontane steppe dell’Asia centrale; tali sviluppi (insieme alla crisi economica del nostro Paese, con i conseguenti grandi strascichi di crediti inesigibili),avevano condotto dei gravi guasti nei bilanci aziendali, mentre l’istituto, solo da poco, è tornato alla normalità attraverso un durissimo piano di ristrutturazione ed un fortissimo aumento di capitale.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Sull'alternanza scuola-lavoro
![]()
Sull'alternanza scuola-lavoro
di Salvatore Bravo
 La
verità del capitalismo assoluto
La
verità del capitalismo assoluto
Il valore di scambio è la sostanza storica del capitalismo, il capitalismo eguaglia in nome del valore di scambio, demofobico per necessità, addestra all’uguaglianza astratta mediante il valore di scambio. L’alternanza scuola lavoro (ASL) è una delle modalità con cui formare al valore di scambio, ovvero attraverso l’addestramento al lavoro nell’istituzione scolastica, si favorisce la cultura dell’astratto sottesa al valore di scambio. In tal modo si struttura la categoria della quantità: non è fondamentale la qualità del lavoro, ma il lavoro in sé, come modalità acquisitiva di un ruolo sociale e di una imprecisa quantità di denaro, obolo per il consumo. La categoria dell’inclusione-gabbia d’acciaio opera fin all’interno della quotidianità scolastica per inibirne l’esodo. In questo frangente storico Marx ci è di aiuto per porre uno sguardo cognitivo nella caverna, sempre più simile ad un fondo di magazzino1 :
”Quello che particolarmente distingue il possessore di merce dalla merce, è il fatto che ogni altro corpo di merce si presenta alla merce stessa solo come forma fenomenica del suo proprio valore. Quindi la merce, cinica ed uguagliatrice dalla nascita, è sempre pronta a fare lo scambio a fare scambio non soltanto dell’anima ma anche del corpo come qualsiasi altra merce, fosse pur questa piena di aspetti sgraditi ancor più di Maritorne. Il possessore di merci con i suoi cinque e più sensi completa questa insensibilità della merce per la concretezza del corpo delle merci”.
L’opera al nero non potrebbe essere più chiara. Il valore di scambio è il paradigma all’interno del quale, si devono leggere le riforme neoliberiste degli ultimi decenni. E’ necessario deviare lo sguardo cognitivo dalle parole della propaganda (buona scuola, via della seta, missione di pace, bombardamento umanitario, riqualificazione urbana) che occultano la verità, per trascendere la certezza sensibile e cogliere la verità del fenomeno storico.
Formare alla plebe
L’integralismo economicistico nella sua corsa all’atomizzazione ed al consumo rende i popoli consumatori, migranti, accelera le disuguaglianze e favorisce la conflittualità orizzontale. La plebe è consegnata alle variazioni del mercato, è così un pulviscolo incapace di comprendere i fenomeni in atto ed ipostatizza il presente.
Leggi tutto
Gianfranco Greco: Venezuela o di un giardino di casa alquanto riottoso
![]()
Venezuela o di un giardino di casa alquanto riottoso
di Gianfranco Greco
 “La corda è sempre più
tesa e può rompersi (o essere rotta) in qualsiasi momento,
trascinandoci in un caos ben più pericoloso di quello
libico.”
(Manlio Dinucci, Il Manifesto 16 aprile 2019)
“La corda è sempre più
tesa e può rompersi (o essere rotta) in qualsiasi momento,
trascinandoci in un caos ben più pericoloso di quello
libico.”
(Manlio Dinucci, Il Manifesto 16 aprile 2019)
Che uno scadente comico da avanspettacolo si possa autoproclamare presidente della “Republica de Venezuela” ci può anche stare. L’area caraibica è stata interessata, nel corso di una storia più che decennale da episodi di tal genere. Guaidò ne è l’ultimo sguaiato esempio. Ci sta invece un po’ meno che a schierarsi col presidente in carica, Maduro, ci sia, oltre alla Cina e Russia, la Turchia di Erdogan. Un po’ di sconcerto lo suscita in quanto oggetto di riferimento è un alleato storico degli Stati Uniti, membro tra i primi della Nato, nonché solerte cane da guardia posto ai confini meridionali dell’ex Unione Sovietica. La crisi dei missili di Cuba – ottobre 1962 – scoppiò in conseguenza del dispiegamento sull’isola caraibica, da parte dell’URSS, di missili balistici proprio in risposta a quelli dispiegati dagli States in Turchia. L’attuale contesto sembra offrirci una riedizione di quella crisi laddove l’arrivo in Venezuela di due aerei militari russi unitamente ad un centinaio di soldati è visto dall’amministrazione Trump come una sorta di attentato alla sempreverde dottrina Monroe. Una dottrina a cui opportunamente riferirsi per contrastare la crescente penetrazione russa e cinese in Venezuela. La criticità della fase attuale può ingenerare un certo comparativismo tra i due eventi anche se, per meglio decifrare questa nuova realtà, interviene un elemento che ha connotato il cinquantennio appena trascorso: i due blocchi in cui allora era diviso il mondo non esistono più.
Se nel 1962 la Turchia si sarebbe mai sognata di schierarsi con Russia e Cina, nel 2019 questo avviene in quanto, nel frattempo, le dinamiche capitalistiche ingenerate da una crisi di sistema, che tuttora perdura, hanno provocato sconquassi tali da sancire la fine del bipolarismo russo-americano, la successiva consunzione dell’unipolarismo a “stelle e strisce” nonché il prorompere di un multipolarismo che ha ridisegnato ruoli e strategie con l’entrata in scena di nuovi attori globali. Ciò comporta conseguenzialmente la messa in discussione ed il progressivo ridimensionamento di egemonie ritenute fino a poco tempo addietro incontestabili.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Complessità o complicazione?
Complessità o complicazione?
L'articolo di Guareschi sul Manifesto
di Pierluigi Fagan
Leggi anche su Guareschi l'articolo di Alessandro Visalli
Prendo questo articolo de “il manifesto” a testimonianza di un modo di porre le questioni che impedisce in via di principio di comprendere le questioni poste, a parte il linguaggio usato. Il giornale che si definisce ancora “quotidiano comunista” infatti, sembra essersi auto-recluso nel segmento dei soli assistenti universitari in materie umanistiche e quindi ecco “l’analitica del potere”, la “microfisica”, il “Grossraum”, il mitico “combinato disposto”, un platonico “triedo”, l’immancabile “reificazione” i problematici “processi di differenziazione, in relazione allo spazio dei flussi e a processi di connessione, deconnessione e scalarità”, assieme ai “dispositivi confinari”, fino alla misteriosa “democrazia cosmopolita” che invoca un accorato “anziché appellarsi a un ritorno alla messa in forma statale non sia preferibile scommettere sulla costruzione di istituzioni correlate alle nuove forme di spazialità politica.”. Il tutto ruotante intorno alla segnalazione di tre libri sul tema del “sovranismo”.
Visto che siamo dalle parti de “il manifesto” val bene citare il Nanni Moretti di “Chi parla male, pensa male e vive male”. In più sia come “comunisti” che come “giornalisti” varrebbe la pensa ricordarsi che la comunicazione ha un emittente ed un ricevente ma se l’emittente emette in copto pre-sceglie come pubblico i soli conoscenti del copto.
Leggi tutto
Damiano Palano: Può esistere una democrazia confuciana?
Può esistere una democrazia confuciana?
Un libro di Sungmoon Kim
di Damiano Palano
Questa recensione al libro di Sungmoon Kim, Democrazia confuciana in Asia Orientale. Teoria e prassi (ObarraO), è apparsa sul quotidiano "Avvenire"
Uno dei corollari della tesi di Samuel Huntington sullo «scontro delle civiltà» riguardava la difficoltà di ‘esportare’ la democrazia al fuori dall’Occidente. Secondo il politologo, la causa di queste resistenze era sostanzialmente culturale: la democrazia, in questa lettura, è infatti un’idea specificamente ‘occidentale’, fondata sui valori del pluralismo, della tolleranza, della libertà individuale, e dunque estranea a gran parte delle tradizioni non occidentali. Sfidando esplicitamente le posizioni di Huntington, Amartya Sen ha invece sostenuto che anche fuori dall’Occidente sono fiorite nel passato esperienze riconducibili agli ideali democratici. Se non ci si concentra solo sul momento elettorale (e dunque sulle elezioni come strumento per assegnare il potere candidati tra loro in competizione), e se si allarga lo sguardo verso una più ampia concezione della discussione politica, si potrebbero infatti rinvenire le tracce di pratiche democratiche anche in altre aree. Secondo Sen, la deliberazione pubblica e la cultura della tolleranza possono essere in particolare riconosciute in molte esperienze estranee all’Occidente, come, per esempio, in alcune specifiche stagioni della storia indiana, cinese, giapponese e coreana, oltre che nel passato dell’Iran, della Turchia, del mondo arabo e di molte regioni africane.
Leggi tutto
Alessandra Algostino: Il diritto del finanzcapitalismo
Il diritto del finanzcapitalismo
di Alessandra Algostino
Scontro tra due concezioni del diritto: da un lato il costituzionalismo, dall’altro il diritto del finanzcapitalismo, che esprime la nuda materialità dei rapporti di forza
«… in mancanza di un valore superiore che orienti l’azione, ci si dirigerà nel senso dell’efficacia immediata. Nulla essendo vero o falso, buono o cattivo, la norma consisterà nel mostrarsi il più efficace, cioè il più forte. Gli uomini allora non si divideranno più in giusti ed ingiusti, ma in signori e schiavi» (Albert Camus, L’homme révolté, 1951)
L’incipit del XXI secolo restituisce sempre più nitida l’immagine di un diritto in trasformazione [1]. È in atto una lotta sul e per il diritto: un conflitto che oggi si concretizza nello scontro fra due orizzonti in senso lato costituzionali, il costituzionalismo e la global economic governance. Da un lato, il diritto della limitazione del potere, dei diritti, dell’emancipazione; dall’altro, il diritto del finanzcapitalismo.
Muta la fisionomia del diritto. Il diritto perde il radicamento territoriale e diviene senza luogo, citando Natalino Irti: «la globalizzazione sradica il diritto dai luoghi antichi, e lo getta dinanzi all’a-topia dei mercati. Le norme sono ormai senza patria…» [2].
Sono sempre meno il Campidoglio, Westminster o il nostrano Montecitorio, le sedi nelle quali si discutono e si approvano le norme, e non sono nemmeno (o non solo), la Casa Bianca, 10 Downing Street o Palazzo Chigi [3]: ad essi si sostituiscono sale riunioni [4], che possono essere nel palazzo della World Bank a Washington DC, così come negli uffici delle law firms statunitensi, o presso il Kanko Hotel di Shima, in Giappone, al Palacongressi di Taormina, o al Manoir Richelieu di La Malbaie in Canada (sedi, rispettivamente, delle riunioni del G7 nel 2016, 2017 e 2018).
Leggi tutto
Pasquale Vecchiarelli, Angelo Caputo, G. M.: Lavoro e intelligenza artificiale
Lavoro e intelligenza artificiale
di Pasquale Vecchiarelli, Angelo Caputo, G. M.
Quale impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo del lavoro? Faranno tutto le macchine prendendo il sopravvento sull’uomo?
Rispondiamo subito alla domanda posta nel sottotitolo: NO! Non faranno tutto le macchine e non prenderanno il sopravvento sull’uomo, anzi c’è sempre più bisogno d’intelligenza naturale, non fosse altro per capire chi siamo e dove stiamo andando.
L’espressione intelligenza artificiale (AI) identifica una classe molto variegata di algoritmi di inferenza statistica: dato un compito specifico, essi hanno in comune la capacità di apprendere tramite esempi e di classificare gli eventi forniti in input secondo opportune categorie. Sebbene questi algoritmi siano stati sviluppati nel corso degli ultimi 50 anni, solo negli ultimi 5 hanno trovato applicazioni pratiche: questo tipo di algoritmi, infatti, necessita sia di una grande potenza di calcolo, resasi disponibile solo con l’introduzione di nuovi tipi di processori (GPU e, più recentemente, TPU), sia di una grande mole di dati affinché i risultati siano statisticamente significativi.
I dati vengono usati nella fase di “addestramento” dell’algoritmo durante la quale vengono calcolati una serie di parametri che specializzano l’algoritmo per una determinata classe di problemi: si usa spesso paragonare questa fase con quella che caratterizza l’apprendimento nei bambini.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3002
Hits 2973
Hits 2927
Hits 2804
Hits 2594
Hits 2555
Hits 2511
Hits 2414
Hits 2323
tonino

Romeo Orlandi: La sinistra, la Cina, la globalizzazione
La sinistra, la Cina, la globalizzazione
di Romeo Orlandi*
Riproponiamo dal numero dell’autunno 2018 di Critica marxista il saggio di Romeo Orlandi ‘La sinistra, la Cina, la globalizzazione’, con due note redazionali
 Lo scontro USA Cina
dentro questa globalizzazione si fa sempre più complesso e
rischioso. L’ottimismo
ideologico del libero mercato si era spinto
irragionevolmente, coinvolgendo anche tutte le sinistre
compresa la nostra, a pensare che la
globalizzazione sarebbe stata di segno occidentale e che la
bandiera della democrazia sarebbe sventolata a Pechino e a
Shanghai. E’ successo
invece il contrario, la Cina è tutto fuorché democratica ma
produce sempre di più e meglio mentre l’Italia punta ancora
sul
fascino antiquato del made in Italy piuttosto che
sull’innovazione.
Lo scontro USA Cina
dentro questa globalizzazione si fa sempre più complesso e
rischioso. L’ottimismo
ideologico del libero mercato si era spinto
irragionevolmente, coinvolgendo anche tutte le sinistre
compresa la nostra, a pensare che la
globalizzazione sarebbe stata di segno occidentale e che la
bandiera della democrazia sarebbe sventolata a Pechino e a
Shanghai. E’ successo
invece il contrario, la Cina è tutto fuorché democratica ma
produce sempre di più e meglio mentre l’Italia punta ancora
sul
fascino antiquato del made in Italy piuttosto che
sull’innovazione.
I fatti mostrano la loro proverbiale ostinazione anche quando registrano gli spostamenti dei container. Sette dei primi otto porti al mondo per tonnellaggio movimentato sono in Cina; Singapore (4°) costituisce l’eccezione. Il porto europeo più trafficato è Rotterdam, confuso al nono posto tra altre posizioni asiatiche e qualche intromissione australiana e statunitense. Alcuni decenni fa la lista era molto diversa, con un predominio delle due sponde dell’Atlantico. Spuntava ancora Genova. La classifica attuale è la fotografia più nitida della trasformazione della Cina in Fabbrica del Mondo. Si potrebbe obiettare che le merci movimentate siano destinate anche al mercato locale, così da ridurre l’impatto internazionale, come se i consumi interni assorbissero questa eclatante supremazia. In realtà, la grande maggioranza delle merci cinesi si dirige verso lidi stranieri. La Repubblica popolare è infatti dal 2009 il più grande esportatore al mondo, dopo avere insidiato e poi superato agevolmente il primato della Germania e degli Stati Uniti.
La sequenza logica che se ne ricava rasenta la banalità espositiva: i porti movimentano i container, che trasportano le merci, prodotte dalle fabbriche, generate dagli investimenti, stimolati dalle opportunità. Sembra di assistere alla famosa cantilena Alla fiera dell’Est.
Leggi tutto
La nuova via della seta
di Giovanna Baer
 Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il
presidente cinese XI Jinping
hanno firmato a Roma il 23 marzo scorso un importante
Memorandum d'intesa tra Italia e Cina sulla Belt and Road
Initiative (BRI), un enorme programma
di investimenti cinesi in infrastrutture lungo la cosiddetta
Via della Seta: una definizione che comprende diverse antiche
rotte commerciali,
terrestri, marittime e fluviali di circa 8.000 chilometri,
lungo le quali fin dai tempi di Erodoto si sono snodati gli
scambi culturali e commerciali
tra Oriente e Occidente. La firma del Memorandum ha reso la
visita di Xi particolarmente attesa e rilevante. I media ne
hanno ampiamente seguito la
cronaca e discusso, per la magnitudine del progetto - in
termini di portata economica e di durata temporale - ma
soprattutto perché l'Italia
è il primo Paese del G7 a partecipare ufficialmente alla BRI,
e questa partnership potrebbe modificare la politica estera e
mettere in crisi la
storica alleanza con gli Stati Uniti - lasceremo da parte in
questa analisi la questione della rete 5G perché articolata e
meriterebbe un
articolo a sé.
Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte e il
presidente cinese XI Jinping
hanno firmato a Roma il 23 marzo scorso un importante
Memorandum d'intesa tra Italia e Cina sulla Belt and Road
Initiative (BRI), un enorme programma
di investimenti cinesi in infrastrutture lungo la cosiddetta
Via della Seta: una definizione che comprende diverse antiche
rotte commerciali,
terrestri, marittime e fluviali di circa 8.000 chilometri,
lungo le quali fin dai tempi di Erodoto si sono snodati gli
scambi culturali e commerciali
tra Oriente e Occidente. La firma del Memorandum ha reso la
visita di Xi particolarmente attesa e rilevante. I media ne
hanno ampiamente seguito la
cronaca e discusso, per la magnitudine del progetto - in
termini di portata economica e di durata temporale - ma
soprattutto perché l'Italia
è il primo Paese del G7 a partecipare ufficialmente alla BRI,
e questa partnership potrebbe modificare la politica estera e
mettere in crisi la
storica alleanza con gli Stati Uniti - lasceremo da parte in
questa analisi la questione della rete 5G perché articolata e
meriterebbe un
articolo a sé.
One Belt One Road
Nel settembre del 2013 Xi Jinping ha tenuto un discorso in Kazakistan, all'università di Nazarbaev, dal titolo suggestivo: "Promuovere l'amicizia fra i nostri popoli e lavorare insieme per creare un luminoso futuro" (1). Vi sottolineava che "per forgiare legami economici più stretti, migliorare il livello di cooperazione ed espandere lo spazio di sviluppo nella regione euroasiatica, dovremmo scegliere un approccio innovativo e unire gli sforzi per costruire una cintura economica lungo la Via della Seta. Potremmo iniziare con investimenti in singole aree e congiungerle nel tempo per connettere l'intera regione".
Leggi tutto
Carlo Clericetti: Robin contro l’output gap
Robin contro l’output gap
di Carlo Clericetti
 Altro che Robin Hood, il nostro
eroe è Robin Brooks. Che non è un ribelle che vive nascosto,
anzi: è – pensate un po’ – un economista mainstream. Laurea a
Yale, master alla London school, poi Fondo monetario (8 anni)
e
Goldman Sachs. E ora è capo economista all’Iif, Institute
of
International Finance, che magari non è molto conosciuto
dal grande pubblico, ma è tra le più importanti lobby della
finanza:
basti sapere che ha rappresentato le banche nei negoziati sul
regolamento di Basilea 3 e i creditori in quelli sul debito
greco del 2011-12. Insomma,
un personaggio che si muove nelle stanze del potere, il potere
vero.
Altro che Robin Hood, il nostro
eroe è Robin Brooks. Che non è un ribelle che vive nascosto,
anzi: è – pensate un po’ – un economista mainstream. Laurea a
Yale, master alla London school, poi Fondo monetario (8 anni)
e
Goldman Sachs. E ora è capo economista all’Iif, Institute
of
International Finance, che magari non è molto conosciuto
dal grande pubblico, ma è tra le più importanti lobby della
finanza:
basti sapere che ha rappresentato le banche nei negoziati sul
regolamento di Basilea 3 e i creditori in quelli sul debito
greco del 2011-12. Insomma,
un personaggio che si muove nelle stanze del potere, il potere
vero.
E come mai ci piace tanto? Perché ha iniziato una battaglia contro l’utilizzo, da parte della Commissione europea e del Fondo monetario, dell’output gap, che è uno dei meccanismi infernali utilizzati per dare giudizi sull’economia di un paese e decidere i limiti della sua politica di bilancio. Brooks ha persino coniato un acronimo, CANOO, che sta per Campaign against Nonsense Output Gaps, ossia Campagna contro gli insensati output gaps, e produce grafici che mostrano come questo parametro sia completamente sballato e il suo utilizzo abbia effetti devastanti sulle politiche economiche.
Prima di mostrarveli ricordiamo in breve che cosa sia l’output gap. Quando un paese è in recessione, la grande maggioranza degli economisti, sia pure con varie sfumature, concordano sul fatto che la politica di bilancio debba essere espansiva, ossia che lo Stato debba spendere di più per sostenere l’economia. Negli anni passati non c’era questo largo consenso, ma questa è un’altra storia che sarebbe troppo lungo raccontare. Però siamo solo all’inizio del problema, perché, secondo la teoria economica dominante, la maggiore spesa può avere effetto solo quando il paese in questione è al di sotto del suo prodotto potenziale, cioè quello che si otterrebbe se tutti i fattori della produzione – lavoro, capitali – fossero utilizzati al meglio. Altrimenti, quella maggiore spesa non farebbe altro che far aumentare il debito e scatenare l’inflazione.
Leggi tutto
Redazione: Elezioni europee: che fare?
Elezioni europee: che fare?
di Redazione
Il capitale finge di spaccarsi tra il liberismo e il sovranismo mentre i lavoratori massacrati da crisi e austerity assistono passivamente sullo sfondo senza rappresentanti degni
Il 26 maggio si terranno le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, organismo quasi del tutto ininfluente dal punto di vista decisionale – le scelte più rilevanti ricadono sul Consiglio Europeo e sulla Commissione, istituzioni tecnocratiche che riflettono l'equilibrio di potere tra gli Stati nazionali – ma importante per inquadrare il dibattito politico generale. Le elezioni, infatti, esprimono gli orientamenti filosofici complessivi e le opzioni politiche di fondo che si vengono a delineare all'interno della società civile sia in Europa che nei singoli Stati. e rappresentano un banco di prova per comprendere lo stato in cui si trova la lotta per l'egemonia, lo scontro tra le idee all'interno del conflitto tra le classi nella società civile.
Dato che tutte le istituzioni dell'Unione Europea sono state concepite sulla base dei principî ordoliberisti della competizione tra gli Stati, del mercantilismo, dell'austerità economico-finanziaria e del dogma del pareggio di bilancio, con la crisi del 2008 la vera natura dell'Europa si è manifestata in tutta la sua crudeltà e la maschera dell'Europa di pace, di unione tra i popoli, è stata gettata definitivamente.
Leggi tutto
George Musser: Un nuovo modo di pensare lo spazio-tempo
Un nuovo modo di pensare lo spazio-tempo
di George Musser
Fenomeni non locali e ricerche di realtà più profonde in fisica: un estratto da Inquietanti azioni a distanza
Quando la filosofa Jenann Ismael aveva dieci anni suo padre, un professore dell’Università di Calgary di origine irachena, comprò a un’asta un grande mobile di legno. Frugandoci dentro, Jenann trovò un vecchio caleidoscopio, dal quale rimase totalmente rapita e, dopo ore di sperimentazione, riuscì a capire come funzionava. “Non dissi nulla a mia sorella per paura che lo volesse lei” ricorda.
Guardando nel caleidoscopio e ruotandone il tubo, si vedono sbocciare forme multicolori che volteggiano, si fondono e si muovono imprevedibilmente senza un’apparente spiegazione razionale, quasi come se esercitassero un’inquietante azione a distanza le une sulle altre. Ma più le si osserva meravigliati, più si notano delle regolarità nel loro moto. Le forme che si trovano alle estremità opposte del campo visivo cambiano all’unisono, e la loro simmetria ci dà un indizio di ciò che accade in realtà: le forme non sono oggetti reali, sono immagini di oggetti, e in particolare di frammenti di vetro colorato che ruzzolano in un tubo rivestito di specchi. “Un’unica perlina di vetro è rappresentata in maniera ridondante in diversi punti dello spazio” spiega Ismael.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: L’ Antifà
L’ Antifà
di ilsimplicissimus
Si potrebbe pensare che cancellare i diritti del lavoro, aumentare le disuguaglianze sociali, aggredire il welfare e dunque la cittadinanza, ridurre in maniera subdola la libertà di espressione, avere un’informazione che considera cosa normale, come abbiamo appreso in questi giorni, nascondere le notizie scomode e incarcerare chi le rivela, sia l’essenza del fascismo, un distillato velenoso che va oltre le forme storiche in cui si è incarnato nella prima metà del secolo scorso. Invece vediamo con una certa sorpresa che proprio chi ha dato avvio alla post democrazia, alla distruzione del welfare e delle conquiste sociali presentandole come una sorta di lusso che non ci si poteva più permettere, che ha volentieri chiuso gli occhi, ma non la borsa di fronte alla tracotanza di formazioni di chiara marca, come si diceva una volta, adesso vede fascismo dovunque dopo una quasi totale cecità, dando anche uno spettacolo penoso alla fiera del libro di Torino, dove gente da talk show e wuminghiate misura angosciosamente se gli conviene di più restare o disertare in vista delle vendite.
Invece di combattere Salvini con argomenti sensati e con domande che potrebbero facilmente rivelare l’inconsistenza del personaggio oltre le vaghe formulette sul disagio delle periferie e sull’immigrazione, anzi più che l’inconsistenza, la sua adesione al modello neoliberista e ai suoi strumenti cui rimprovera unicamente la carenza di manganelli e manette, ma anche di aree di impunità per chi può, ci si lascia andare a queste sceneggiate pre elettorali di sapore capalbiese.
Leggi tutto
F.S.: Cina: scacco all'Europa?
Cina: scacco all'Europa?
di F.S.
Continuo il mio tentativo di ricerca e analisi di scritti dedicati alle conseguenze geopolitiche dell’affermazione planetaria del "Socialismo confuciano Han" di Xi Jinping. In questo caso, sviluppo, in estrema sintesi, riflessioni basate sulla lettura di Taino: Scacco all’Europa.
Provo a sintetizzare in tre punti il pensiero dell’autore per poi arrivare a una conclusione finale.
a) Dal 1989 l’Europa ha perduto la centralità geopolitica. Come mai la nascita della moneta unica e dell’Unione Europea hanno rappresentato la fine della centralità europea? In quanto la moneta unica, che è stata per il Nostro una decisione politica unilaterale dell’elite socialdemocratica parigina, non si è accompagnata ad un progetto politico di lungo respiro, non è stata quindi frutto di un ideale né di un disegno sociale, ma una forzatura ideologica ed antistorica del nazionalismo “massonico” neo-illuminista francese.
L’epoca attuale, dice Taino parafrasando Lenin, è l’epoca del conflitto interimperialista dispiegato su scala mondiale e il vuoto politico e geopolitico europeo finisce per fare il gioco di Cina e Russia. Per il Nostro, l’unico destino europeo è quello transatlantico, non ve ne sarebbe un altro che non emargini i popoli europei a insignificante periferia – quale del resto già in parte sarebbe – di una Grande Cina Globale, del nuovo Regno di Mezzo del socialismo di mercato planetario.
Leggi tutto
Francesco Piccioni: Osare dichiarare la morte del capitalismo, prima che ci trascini tutti con sé
Osare dichiarare la morte del capitalismo, prima che ci trascini tutti con sé
di Francesco Piccioni
 Questo fulminante
articolo di George Monbiot, apparso sul Guardian qualche giorno fa, pone
il problema
del superamento del capitalismo in termini ultimativi. E’
apparentemente paradossale che sia un pensatore liberal a
porre la questione in
termini tanto drammatici, ma a noi sembra invece assolutamente
normale.
Questo fulminante
articolo di George Monbiot, apparso sul Guardian qualche giorno fa, pone
il problema
del superamento del capitalismo in termini ultimativi. E’
apparentemente paradossale che sia un pensatore liberal a
porre la questione in
termini tanto drammatici, ma a noi sembra invece assolutamente
normale.
Se “è l’essere sociale a determinare la coscienza, non viceversa”, allora si può arrivare a conclusioni identiche pur partendo da premesse totalmente differenti. Naturalmente bisogna pensare con coerenza ed onestà intellettuale, senza cercare “soluzioni ad hoc” che riducano la difficoltà di far coincidere andamento oggettivo del mondo e desideri individuali o collettivi. Il “princìpio speranza”, insomma, è l’anticamera della disperazione.
Monbiot parte dall’ambiente, mentre noi comunisti siamo storicamente sempre partiti dallo sfruttamento del lavoro. Entrambi i termini – lavoro umano e natura – si pongono allo stesso tempo come risorse e limiti del capitale. Il capitalismo usa questi fattori per crescere, ma arrivaoggettivamente al punto in cui un ulteriore salto di qualità nello sfruttamento di queste risorse diventa fisicamente impossibile e quindi si apre la crisi del sistema di produzione capitalistico.
Sul piano dello sfruttamento del lavoro umano – unica fonte da cui è possibile estrarre plusvalore– il limite viene approssimato proprio in questi anni con lo sviluppo dell’automazione. Un robot fa le stesse cose di un operaio o di un impiegato, lo fa in modo più veloce e preciso, non sciopera e non protesta mai (basta fare la manutenzione…), non va retribuito. Peccato che non compri nulla. Il massimo di capacità produttiva coincide dunque con la tendenziale distruzione dei consumatori.
Salta qui una delle contrapposizioni ideologiche che hanno fatto la fortuna del neoliberismo negli ultimi 40 anni, quella tra consumatori e lavoratori; per cui bisogna(va) ridurre al minimo il costo del lavoro (salario, contributi previdenziali, stato sociale, diritti, ecc) per abbassare al massimo i prezzi, conquistare i consumatori e battere la “concorrenza”.
Leggi tutto
Carlo Scognamiglio: L’insegnamento non è una missione, ma un compito sociale
L’insegnamento non è una missione, ma un compito sociale
di Carlo Scognamiglio
 Nutro il sospetto che
siano molti, moltissimi, gli insegnanti disorientati
dall’imprevedibile dinamica trasformativa delle linee guida
ministeriali o delle raccomandazioni europee, in merito al
significato pubblico
dell’istruzione. Uno smarrimento comprensibile, perché a
tratti la nostra scuola appare resistente a ogni cambiamento,
mentre in altre
fasi tutto sembra correre, sebbene in modo scomposto. Mi
interessa solo in parte, adesso, l’individuazione delle
ragioni di un simile
disorientamento. È però vero che sempre più, nella società a
frammentazione attentiva in cui siamo immersi, è
necessario fermarsi a riflettere, analizzare documenti e
normative in costante aggiornamento, formarsi e confrontarsi e
– come raccomanda Werner
Herzog – bisogna leggere, leggere, leggere.
Nutro il sospetto che
siano molti, moltissimi, gli insegnanti disorientati
dall’imprevedibile dinamica trasformativa delle linee guida
ministeriali o delle raccomandazioni europee, in merito al
significato pubblico
dell’istruzione. Uno smarrimento comprensibile, perché a
tratti la nostra scuola appare resistente a ogni cambiamento,
mentre in altre
fasi tutto sembra correre, sebbene in modo scomposto. Mi
interessa solo in parte, adesso, l’individuazione delle
ragioni di un simile
disorientamento. È però vero che sempre più, nella società a
frammentazione attentiva in cui siamo immersi, è
necessario fermarsi a riflettere, analizzare documenti e
normative in costante aggiornamento, formarsi e confrontarsi e
– come raccomanda Werner
Herzog – bisogna leggere, leggere, leggere.
Sono importanti le connessioni tra passato e presente, tra politica e pedagogia, tra ragione ed emozione. Il lavoro dell’intellettuale è proprio quello di annodare i fili isolati, di approfondire e poi recuperare una visione d’insieme. E l’insegnante, mi piace ricordarlo, è – e deve rimanere – un intellettuale.
Giuseppe Benedetti e Donatella Coccoli, un docente e una giornalista, hanno recentemente deciso di riaprire un discorso pubblico sulla pedagogia gramsciana, con un libro intenso, edito da “L’asino d’oro” (Gramsci per la scuola. Conoscere è vivere, 2018), impreziosito da una breve ma bella prefazione di Marco Revelli.
Lavorare sui testi di Gramsci non è facile, e non è sbagliata l’idea di liberarsi dallo smarrimento di cui scrivevo in apertura, attraverso l’ancoraggio a un solido pilastro della tradizione culturale italiana, che fu egli stesso maestro, e molta cura dedicò al tema dell’educazione. È del tutto evidente l’intenzione dei due autori di ridefinire un orizzonte categoriale e ideale noto (sebbene dimenticato) per fronteggiare alcune superficialità del dibattito pedagogico contemporaneo. L’operazione, in tal senso, riesce e non riesce, nonostante la bellezza del libro. Proverò a soffermarmi su tre passaggi-chiave del testo, per poi provare a raccogliere in sintesi l’effetto.
Leggi tutto
Thomas Meyer: Capitale e Fascismo
![]()
Capitale e Fascismo
di Thomas Meyer
Editoriale [*1] del n°16 della rivista Exit!, maggio 2019
 «Se, come è purtroppo possibile, noi
dobbiamo perire, facciamo almeno in modo di non scomparire
senza essere prima esistiti. Le forze considerevoli che
dobbiamo combattere si apprestano
ad annientarci; e certo esse possono impedirci di esistere
pienamente, cioè di imprimere al mondo il suggello della
nostra volontà. Ma
c'è un settore in cui esse sono senz'altro impotenti. Esse
infatti non possono impedirci di sforzarci a comprendere con
chiarezza l'oggetto dei
nostri sforzi. Se non ci sarà dato di realizzare ciò che
vogliamo, potremo almeno averlo voluto, e non solo
desiderato alla cieca.
D'altra parte, la nostra debolezza può certo impedirci di
vincere, ma non di comprendere la forza che ci schiaccia.»
«Se, come è purtroppo possibile, noi
dobbiamo perire, facciamo almeno in modo di non scomparire
senza essere prima esistiti. Le forze considerevoli che
dobbiamo combattere si apprestano
ad annientarci; e certo esse possono impedirci di esistere
pienamente, cioè di imprimere al mondo il suggello della
nostra volontà. Ma
c'è un settore in cui esse sono senz'altro impotenti. Esse
infatti non possono impedirci di sforzarci a comprendere con
chiarezza l'oggetto dei
nostri sforzi. Se non ci sarà dato di realizzare ciò che
vogliamo, potremo almeno averlo voluto, e non solo
desiderato alla cieca.
D'altra parte, la nostra debolezza può certo impedirci di
vincere, ma non di comprendere la forza che ci schiaccia.»
(Simone Weil, da "Oppressione e Libertà", 1934) [*2])
«Chi non vuole parlare del capitale dovrebbe tacere sul fascismo». Oggi, questa frase di Horkheimer è ancora valida, e dovrebbe essere ampliata dell'altro: chi non vuole parlare della costituzione feticista della società della dissociazione-valore, dovrebbe tacere anche a proposito delle lotte sociali. Non c'è dubbio che la «costituzione sociale» si trova sempre più al centro dell'attenzione, soprattutto vista nel contesto della vittoria elettorale di Donald Trump avvenuta due anni fa. Sono molti quelli che, in questo processo, hanno criticato il fatto che la «classe operaia» avesse smesso da tempo d'occupare un posto centrale, e che ora ci fosse una classe media di sinistra concentrata sulla «politica identitaria» e sulle «questioni LGBT», ragion per cui i lavoratori e le lavoratrici avrebbero optato per Trump. Queste critiche possono essere corrette nella misura in cui la borghesia di sinistra si è, di fatto, poco interessata alla «sotto-classe sociale», ai lavoratori poveri, la cui miseria è diventata ormai da tempo innegabile (i senzatetto, gli anziani che raccolgono bottiglie per convertirle in pochi euro fanno ormai parte del quotidiano) ed ha raggiunto anche la classe media. Tuttavia, sono fuori strada coloro che pretendono che il razzismo abbia la sua vera causa nell'impoverimento di questi ultimi anni, come a più riprese ha sottolineato la nazional-sociale Sarah Wagenknecht.
Leggi tutto
Lucio Columella: USA e UE: lo smantellamento dello stato sociale
USA e UE: lo smantellamento dello stato sociale
di Lucio Columella
La battaglia del sistema finanziario internazionale per il controllo della gestione del bilancio degli stati sovrani e per l’estrazione del valore contenuto nei programmi di welfare si combatte in maniera parallela ma con meccanismi diversi nelle due sponde dell’Atlantico. Il momento centrale di questa battaglia è, però, sempre rappresentato dal controllo della politica degli Stati, avendo come obbiettivo il reddito e il patrimonio di cittadini, famiglie e lavoratori. Negli Stati Uniti lo smantellamento dello stato sociale e la progressiva deregulation del mercato finanziario risalgono all’inizio degli anni ’80, con la Reaganomics. Essi causarono un aumento della diseguaglianza tra le varie fasce sociali e un progressivo deterioramento della domanda aggregata che cominciò ad avvertirsi già negli anni ’90.
La possibilità di una crisi da carenza di domanda venne attenuata e alla fine evitata grazie alla creazione di due bolle finanziarie: il boom legato ad Internet negli anni ’90 seguito nel primo decennio del nuovo secolo dalla bolla dei mutui subprime molto più estesa sia in termini di ammontare sia in termini di soggetti coinvolti. Per cercare di reagire alla diminuzione di domanda creatasi grazie alla progressiva diminuzione dei salari negli Stati Uniti, la Fed seguì una politica di abbassamento dei tassi di interesse e, quindi, di espansione monetaria, accompagnata, durante l’amministrazione Bush, da una significativa riduzione delle imposte sui dividendi delle imprese e sui capital gains[1].
Leggi tutto
Franco Bartolomei: L’aggressione agli spread come strumento di distruzione della sovranità politica degli stati
L’aggressione agli spread come strumento di distruzione della sovranità politica degli stati
di Franco Bartolomei
L’aggressione agli spread dei Titoli del Debito Pubblico degli stati europei, e la finta neutralità dei mercati finanziari, come strumento chiave della distruzione della sovranità politica degli stati costituzionali.
E’ necessario chiarire a tutti un punto fondamentale del modo in cui il sistema finanziario mondiale tiene sotto scacco un governo di un paese sviluppato che imposta politiche economiche e sociali non compatibili con gli indirizzi di sistema :
L’attacco speculativo agli spread delle emissioni obbligazionarie del debito pubblico ( BTP) di uno stato del sistema monetario Euro.
La crescita dello spread (differenziale tra i tassi di interessi dei bond di uno stato con quelli dello stato tedesco preso a parametro base ), oltre ad incrementare direttamente i tassi di rifinanziamento delle imprese nazionali di uno stato con conseguente diretta perdita di competitivita’, riduce il valore dei BTP a tasso costante che le grandi banche possiedono ed accumulano come forma privilegiata di immobilizzazione a risparmio del capitale, e conseguentemente taglia i livelli di patrimonializzazione bancaria richiesti dagli accordi interbancari internazionali (cosidetto accordo Basilea 3) e abbassa i ” ratios ” finanziari richiesti da quegli accordi per i ratings finanziari delle banche.
Leggi tutto
Giovanni Zibordi: Dove trovano i soldi i cinesi ?
Dove trovano i soldi i cinesi ?
di Giovanni Zibordi
“Senza che ci siano stati annunci, il premier Li Keqiang sta implementando quello che ai vertici di China Development Bank (una banca statale), chiamano uno “stimolo economico ufficioso”, in cui si iniettano fondi nei governi locali tramite le banche, invece di aumentare i deficit del governo centrale” (Forbes, agosto 2013) ”la provincia del Sichuan ha stanziato 4,300 miliardi di yuan per autostrade, ferrovie, aereporti nei prossimi due anni, una cifra pari a due volte il suo PIL e dieci volte le sue entrate fiscali dei prossimi due anni…” (Skynews.Sina.com, 23 ottobre 2013)
Dove hanno “trovati i soldi” i cinesi per industrializzarsi negli anni ’80 e ‘90, visto che il loro paese non aveva materie prime da esportare, non aveva riserve in valuta o oro da cui partire, era estremamente povero con livelli di risparmio elevati in percentuale, ma marginali in valore assoluto e non si è mai indebitato sui mercati internazionali?
Come ha fatto la Cina in venti anni (dal 1992 ad esempio) ad aumentare il PIL da 2.600 miliardi a 51.000 miliardi di Yuan e in dollari da 488 miliardi a 8.200 miliardi, come ha finanziato in venti anni questo incremento di 20 volte del PIL, misurato in yuan e di 16 volte misurato in dollari, in termini di “trovare i soldi” come dicono Monti, Letta e i capi della UE?
Leggi tutto
Marcello Musto: Karl Marx. Le contraddizioni della società in una riflessione evergreen
Karl Marx. Le contraddizioni della società in una riflessione evergreen
di Marcello Musto*
Il ritorno a Marx, verificatosi dopo la crisi economica del 2008, è stato contraddistinto dalla riscoperta della sua critica dell’economia. Da allora in poi, in numerosi quotidiani, riviste, libri e volumi universitari, è stato da più parti osservato quanto l’analisi di Marx risultasse ancora indispensabile per comprendere le contraddizioni del capitalismo e i suoi meccanismi distruttivi.
Negli ultimi anni, però, sta emergendo un nuovo fenomeno: la riesplorazione del Marx politico. La stampa, nell’edizione tedesca MEGA², di manoscritti precedentemente sconosciuti e la pubblicazione di innovative interpretazioni della sua opera hanno aperto nuovi orizzonti di ricerca. Testi inediti e nuovi studi teorici pongono in risalto, con maggiore evidenza rispetto al passato, quanto Marx sia stato un autore capace di esaminare le contraddizioni della società capitalista su scala globale e ben oltre il conflitto tra capitale e lavoro. Non è azzardato affermare che, tra i grandi classici del pensiero politico, economico e filosofico, Marx sia quello il cui profilo è maggiormente mutato nel volgere del XXI secolo.
SMENTENDO QUANTI hanno assimilato la concezione marxiana della società comunista al mero sviluppo delle forze produttive, le ricerche intraprese hanno evidenziato la rilevanza che Marx assegnò alla questione ecologica.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3361
Hits 3015
Hits 2994
Hits 2952
Hits 2837
Hits 2611
Hits 2587
Hits 2527
Hits 2419
Hits 2338
tonino

Thomas Fazi: Euro: una questione di classe
Euro: una questione di classe
di Thomas Fazi
Ringraziando Stefano Tancredi, Robin Piazzo e Domenico Cerabona Ferrari per il bell'incontro di ieri a Settimo Torinese, riporto il testo del mio intervento, in cui rispondevo alla seguente domanda: «Un singolo Stato può “reggere” dal punto di vista economico l’uscita dalla realtà economica neoliberista dell’UE? Se “no” perché? È più opportuno un processo di riforme economiche nel contesto europeo? Come rapportarsi ai vincoli economici imposti dall’UE? Se si può “reggere” questa uscita come? Quali strategie adottare? Si deve ritornare alla propria moneta? È possibile un’alleanza economica con altri Stati dalla struttura economica più simile alla nostra?»
 La prima
cosa da dire è che c’è poco da scegliere. O meglio, la scelta
non è se uscire dall’UE o se riformare l’UE, per
il semplice fatto che quest’ultima opzione non è praticabile.
La prima
cosa da dire è che c’è poco da scegliere. O meglio, la scelta
non è se uscire dall’UE o se riformare l’UE, per
il semplice fatto che quest’ultima opzione non è praticabile.
L’UE è strutturata in maniera tale da non essere riformabile, perlomeno non nel senso che auspicano gli integrazionisti di sinistra, cioè nella direzione di una riforma dell’UE in senso democratico e progressivo/sociale, men che meno nella direzione di un vero e proprio Stato federale sul modello degli Stati Uniti o dell’Australia.
Come disse il compianto Luciano Gallino poco prima di morire: «Nessuna realistica modifica dell’euro sarà possibile», in quanto esso è stato progettato «quale camicia di forza volta a impedire ogni politica sociale progressista, e le camicie di forza, vista la funzione per cui sono state create, non accettano modifiche “democratiche”».
Basti pensare che per “riformare i trattati” è necessaria l’unanimità di tutti e 28 gli Stati membri dell’UE. In altre parole, sarebbe necessario che in tutti e 28 i paesi dell’UE salissero al potere dei governi progressisti che condividono le stesse prospettive di riforma “di sinistra” dell’euro. Ora, non bisogna essere particolarmente pessimisti per capire perché questo non accadrà mai.
E non accadrà mai innanzitutto perché le condizioni economiche, politiche, sociali, ecc. che si registrano nei diversi Stati sono estremamente eterogenee: ci sono paesi che registrano tassi di disoccupazione estremamente bassi (come la Germania) e paesi come il nostro che registrano tassi di disoccupazione altissimi; ci sono paesi che crescono e paesi che non crescono, ecc.
Leggi tutto
Francesco Ciafaloni: Come ci siamo ridotti così? Risvegliamoci!
Come ci siamo ridotti così? Risvegliamoci!
di Francesco Ciafaloni
 Mi è capitato di recente di leggere o rileggere
alcuni
testi sulla riduzione e la redistribuzione dell’orario di
lavoro scritti più o meno un quarto di secolo fa, quando si
discuteva di 35
ore, di autori che mi sono familiari, come Giovanni Mazzetti (Teoria
generale della necessità di redistribuire l’orario di
lavoro) o Giorgio Lunghini (Introduzione a L’ABC
dell’economia, di Ezra Pound).
Mi è capitato di recente di leggere o rileggere
alcuni
testi sulla riduzione e la redistribuzione dell’orario di
lavoro scritti più o meno un quarto di secolo fa, quando si
discuteva di 35
ore, di autori che mi sono familiari, come Giovanni Mazzetti (Teoria
generale della necessità di redistribuire l’orario di
lavoro) o Giorgio Lunghini (Introduzione a L’ABC
dell’economia, di Ezra Pound).
Mi sono reso conto che alcune delle tesi sostenute dagli autori, che avevo ben presenti venti anni fa, erano come sparite dal mio orizzonte mentale negli ultimi tempi. Avevo smesso di fatto di usarle per cercare di capire quello che succede tutti i giorni. Mi sono accorto di essermi come addormentato, intontito dall’eterna ripetizione delle tesi correnti: l’eccesso di spesa pubblica, la necessità di puntare sull’innovazione tecnica e sull’industria 4.0, la possibilità che si crei, all’interno del sistema produttivo, occupazione sostitutiva di quella distrutta dall’automazione, l’ossessione e la necessità della crescita del PIL.
Venti anni fa erano vivi De Cecco, Graziani, Gallino, non c’era la resa culturale che ci sommerge ora. C’erano economisti, sociologi, storici autorevoli, che non si rifugiavano nel silenzio e avevano modo di esprimersi sui giornali maggiori. Oggi prevale l’imbarazzante ripetizione di parole senza senso, come “mercato”, inteso come il dispensatore di giudizi inappellabili di adeguatezza, positività, efficienza di qualsiasi iniziativa; “crescita” intesa come la tendenza naturale di tutti i Paesi del mondo, a meno di colpe gravi dei loro cittadini, ad aumentare il PIL più o meno del 3% l’anno; “equilibrio”, inteso come la naturale, automatica, tendenza all’equilibrio tra domanda e offerta («l’equilibrio è un caso», avrebbe ribattuto Lunghini citando Marx).
Eravamo abituati a distinguere tra economisti ortodossi ed eterodossi. Gli ortodossi avevano un bel sistema ma negavano l’evidenza della disoccupazione involontaria, della concentrazione della ricchezza, dell’uso del denaro per arricchirsi senza produrre.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: La cultura nel capitalismo assoluto

La cultura nel capitalismo assoluto
di Salvatore Bravo
 Con la cultura non si mangia
Con la cultura non si mangia
La parola cultura ha subito un processo di deflazione del suo significato, al punto che nel 2010 il ministro dell’economia Tremonti affermò che con la cultura non si mangia. La verità torna sempre a galla malgrado i raggiri ideologici, e Tremonti ha espresso la verità del liberismo postborghese nel quale non vi è posto per il pensiero, per la formazione, ma solo per il calcolo, per il consumo dell’essere e dell’esserci.
Il giudizio ideologico di Tremonti non esaurisce i significati della parola cultura, per nostra fortuna, ma esprime l’imbarbarimento della condizione attuale. La cultura fine a se stessa o al servizio della persona è uno scandalo (dal greco skàndalon inciampo) da respingere, non si può inciampare e fermare il consumo, essa è un’ insostenibile trasgressione alla struttura economica che sta consumando l’intero pianeta (su otto milioni di specie di viventi un milione è a rischio estinzione secondo i calcoli dell’ONU).
In verità La cultura è radicale ed antitetica rispetto al capitalismo assoluto: in primis essa è portatrice di valori universali ed in quanto tali, non vendibili, in secundis l’etimologia della parola ci suggerisce il suo essere altro rispetto al tempo del capitalismo cultura (dal lat. cultura, der. di colĕre «coltivare»), essa è attività e temporalità della formazione, il tempo della cultura tesse il presente nel suo ordito, nella sua distensione riannoda ella continuità teleologica ciò che era disperso. Il capitalismo assoluto si esaurisce nell’immediatezza, è sciolto da ogni legame temporale e comunitario, pertanto è estraneo alla domanda sul senso, sostituita dal calcolo, dal silenzio degli enti che devono corrispondere al solo utile immediato.
Una difficile definizione
La cultura è una parola polisemica, nel corso della storia le sono stata attribuite innumerevoli significati, ciò malgrado ogni definizione si attuava in tensione con altre configurazioni simboliche.
Leggi tutto
Gianfranco Pala: “Socialismo di mercato”
“Socialismo di mercato”
Valore, classi e pianificazione
di Gianfranco Pala
Si sa che Marx – fin dall’inizio dell’analisi del Capitale – ripete tante volte che “produzione delle merci e circolazione delle merci sono fenomeni che appartengono insieme a differentissimi modi di produzione, sia pure in mole e con portata differenti”. Sembra, dunque, inevitabile che una società di produttori associati, la quale voglia iniziare a porre sotto un controllo cosciente e pianificato la produzione stessa non possa fuoriuscire immediatamente da questa forma di merce. Deve, tuttavia, mutarne i caratteri sociali conservandone la base materiale “in quantoforma universalmente necessaria del prodotto” che “si esprime tangibilmente nella produzione su grande scala e nel carattere di massa del prodotto”.
Tale carattere può essere conservato – mentre può essere soppressa, insieme alla soppressione della non proprietà del lavoro, l’unilateralità che il capitalismo gli impone – trascendendo così il modo capitalistico stesso di produrre, affinché esso non ripresenti anacronisticamente i caratteri privati (non socializzati) della merce semplice. Si ricordi fin d’ora che la forza-lavoro è l’unica merce che, già nel sistema capitalistico, appare nella sua forma semplice, ovvero non prodotta capitalisticamente, il che dimostra come praticamente possibile l’esistenzaimmediata di merce semplice con caratteri di massa in antitesi alla forma capitalistica.
Leggi tutto
Piemme: Come non si combatte il fascismo
Come non si combatte il fascismo
di Piemme
Due sono i fatti che oggi balzano alla cronaca. Lo smantellamento, al Salone del libro di Torino, della casa editrice neofascista Altaforte, e la dura contestazione di Virginia Raggi nel quartiere di Casal Bruciato a Roma.
Due fatti distanti e di diversissima natura e tuttavia il circo mediatico ha avuto facile gioco e connettere ad un unico filo conduttore: l'antifascismo.
Nel primo caso, quello di Torino è stato tolto lo stand ad una piccola casa editrice legata ai "fascisti del terzo millennio". Nel secondo caso ancora Casa Pound protagonista perché si è fiondata sulla protesta di alcuni abitanti di Casl Bruciato contro l'assegnazione di un alloggio ad una famiglia rom italiana (sottolineo italiana).
Per la cronaca: CP è riuscita a presentare liste alle europee saltando l'improba raccolta di firme grazie alla cortesia di un parlamentare ungherese, quindi, sempre per la cronaca, CP, tanto per non smentirsi, va in alleanza con la lista almirantiana e finta pro-Forconi "Destre Unite".
Sul primo caso c'è poco da dire: si tratta di una sciatta operazione di censura politica e ideologica, compiuta in nome dell'antifascismo di regime. Un antifascismo con cui la sinistra patriottica non ha nulla a che spartire, e non solo perché si è risolta in uno spettacolare spot a favore di una minuscola casa editrice di cui basta guarda i titoli per capirne il penoso livello culturale.
Leggi tutto
Giancarlo Liviano D’Arcangelo: Perché la polemica sul Salone del Libro allontana il pubblico della cultura
Perché la polemica sul Salone del Libro allontana il pubblico della cultura
di Giancarlo Liviano D’Arcangelo
Se un tempo ogni moto spirituale dell’uomo era una tensione a elevarsi, ad arricchirsi, ad accedere a strali di conoscenza più alti, oggi la trascendenza è tutta di senso contrario, votata verso il basso. Il risultato è la caduta nella banalità. Immensamente rappresentato in ogni suo dettaglio, e freneticamente illuminato di secondo in secondo in migliaia di microporzioni, il mondo è divenuto iper-reale, fonte di una soffocante valanga di informazioni che si negano a vicenda, e dunque del tutto inintelligibile. La realtà, così violentata da continue rappresentazioni soggettive, infinite e in opposizione tra loro, anche sul piano più istintivo finisce per mostrare la sua vera essenza, che è quella dell’illusione. Ecco cos’è la realtà, quando l’ampiezza di percezione del mondo supera la portata dei sensi: una grande illusione radicale. E cosa c’è di più insopportabile per l’uomo del sospetto di vivere nell’illusione? Niente. Così attecchiscono i simulacri, che di volta in volta, nel profondo, non servono a imporre una verità parziale, ma hanno lo scopo opposto: negare l’assenza di verità generale.
Ecco perché, traslati nel dibattito pubblico così come si sviluppa oggi, i concetti di fascismo e antifascismo divulgati dai rispettivi cantori dalle retoriche zoppicanti, non sono altro che simulacri, purtroppo utilizzati come rappresentazioni.
Leggi tutto
Michael Roberts: Capitalismo progressista: un ossimoro
Capitalismo progressista: un ossimoro
di Michael Roberts
Joseph Stiglitz è premio Nobel (o meglio, premio Riksbank, la banca centrale svedese, ndT) in economia ed ex capo economista presso la Banca Mondiale, nonché consigliere della direzione laburista di sinistra nel Regno Unito. Si pone a sinistra nello spettro di tendenze dell'economia mainstream
Joseph Stiglitz ha appena pubblicato un nuovo libro intitolato People, Power, and Profits: Progressive Capitalism for an Age of Discontent [Popolo, potere e profitti: il capitalismo progressivo per un’era di malcontento], in cui proclama che “possiamo salvare il nostro disfunzionante sistema economico da se stesso”. Stiglitz è molto preoccupato per la crescente disuguaglianza di redditi e ricchezza nelle principali economie, specialmente negli Stati Uniti. “Circa il 90% dei cittadini ha visto i propri redditi ristagnare o diminuire negli ultimi 30 anni. Ciò non sorprende, dato che gli Stati Uniti hanno il più alto livello di disuguaglianza tra i paesi avanzati e uno dei più bassi livelli di opportunità - con le fortune dei giovani americani più dipendenti dal reddito e dall'istruzione dei loro genitori che altrove”.
Vedete, secondo Stiglitz il capitalismo era “progressista” in quanto sviluppava l'economia e innalzava la condizione umana, usando la conoscenza scientifica e l'innovazione; e andava bene, con lo stato di diritto e controlli democratici sugli “eccessi”.
Leggi tutto
Ernesto Screpanti: La natura sociale dell’Unione Europea
La natura sociale dell’Unione Europea*
di Ernesto Screpanti
 Il secondo appuntamento del Maggio filosofico
2019 è per Giovedì 16 maggio alle ore 21:00, presso la
Biblioteca comunale Don Milani di Rastignano e ha per oggetto
l’Europa nella storia: gli Stati Uniti (capitalistici) di
Europa. Infatti
l’attuale Unione Europea è l’unità asimmetrica di nazioni con
un “centro” e una “periferia” dove il
centro esporta merci e acquista titoli pubblici “periferici”
rendendosi creditore di una periferia che si indebita. Ma
nell’interesse di chi? Non pare proprio in quello dei
salariati sia del centro che della periferia…
Il secondo appuntamento del Maggio filosofico
2019 è per Giovedì 16 maggio alle ore 21:00, presso la
Biblioteca comunale Don Milani di Rastignano e ha per oggetto
l’Europa nella storia: gli Stati Uniti (capitalistici) di
Europa. Infatti
l’attuale Unione Europea è l’unità asimmetrica di nazioni con
un “centro” e una “periferia” dove il
centro esporta merci e acquista titoli pubblici “periferici”
rendendosi creditore di una periferia che si indebita. Ma
nell’interesse di chi? Non pare proprio in quello dei
salariati sia del centro che della periferia…
L’Unione Europea non è un’unione politica con una costituzione approvata dai popoli. È un’entità statale (di fatto se non di diritto) costituita con trattati internazionali che si sovrappongo alle costituzioni nazionali tentando di demolirle (Russo, 2017). Gli organismi politici che determinano le sue politiche monetarie e fiscali sono la Banca Centrale Europa e il governo tedesco, e nessuno dei due è responsabile verso i popoli europei.
Il ruolo del governo tedesco merita di essere chiarito. Il predominio della Germania sull’economia europea si era affermato già dagli anni ’70, e divenne ingombrante dopo l’unificazione tedesca del 1990. Con la fondazione dell’Unione è accaduto che i governi di quel paese sono riusciti a conquistare per la sua industria vantaggi competitivi senza precedenti. Con le riforme Hartz (2003-2005) e le politiche fiscali restrittive, la crescita salariale è stata posta sotto controllo, completando un processo avviato già negli anni ’90. Inoltre le imprese tedesche hanno esteso le loro catene del valore verso i paesi dell’Est europeo (e in parte del Sud), dove i salari sono più bassi che in Germania. In questa maniera l’industria tedesca ha avuto un costo del lavoro che è cresciuto sistematicamente di meno rispetto a quello dei principali concorrenti, in particolare Francia, Italia e Spagna. Ciò ha permesso alla Germania di mantenere un elevato e crescente surplus commerciale, spingendo i paesi del Sud Europa verso il deficit del conto corrente (l’Italia e la Spagna fino al 2012, la Francia ancora oggi).
Leggi tutto
Giovanna Sissa e Giulio De Petra: Luoghi comuni. Smart city a chi?
Luoghi comuni. Smart city a chi?
di Giovanna Sissa e Giulio De Petra
Articolo pubblicato (pp. 59 – 66) sul primo numero di “Luoghi Comuni” (Castelvecchi Editore). Qui disponibile l’intero numero
 Smart
Smart
L’aggettivo smart è stato associato a qualunque sostantivo, dal frigorifero alle reti elettriche, per indicare un miglioramento, un superamento di qualche limite. Ma se il sostantivo che diventa smart non è più un oggetto fisico, il significato ammiccante dell’aggettivo qualificativo – paradigmatico dell’innovazione digitale – diviene rarefatto. Un telefono smart si può supporre che abbia più funzioni di uno normale, così come un termometro o un palo della luce, ma che cosa è il lavoro smart, e soprattutto, che cosa è una città smart? Nessuno si permetterebbe di dire che la Roma antica, la Firenze rinascimentale o la Parigi della Belle Époque fossero città stupide, dunque erano città intelligenti: così una smart city dovrebbe per definizione essere qualcosa di più. Ma cosa?
Se cercate una definizione di smart city ne troverete moltissime, nessuna precisa e dunque troppe. Si parla di smart city da molto tempo. Possiamo datare l’introduzione del termine alla fine degli anni Novanta ed attribuirla a IBM. Nei primissimi anni 2000 il termine smart city si afferma a partire dagli USA e si diffonde sia nel nord che nel sud del mondo, dove lo sviluppo di mega metropoli, in Cina come India, dà un forte impulso alla creazione, talvolta ex novo – di nuove città smart. In Europa si impone a cavallo dei primi due decenni del nuovo millennio. Nel report Mapping smart cities in the EU (2014) la smart city è definita «una città che cerca di affrontare le sue emergenze più significative attraverso l’utilizzo intenso e innovativo delle tecnologie digitali». La città smart, a seconda dell’ambito di utilizzo che si intende promuovere, diventa Knowledge city, sustainable city, talented City, wired city, digital city, eco-city. Le smart cities europee sono inizialmente identificate come città con almeno una iniziativa rivolta a una fra le seguenti sei caratteristiche: smart governance, smart people, smart living, smart mobility, smart economy e smart environment.
Leggi tutto
I gilets jaunes e la stampa italiana. Lettera aperta a “il Manifesto”
I gilets jaunes e la stampa italiana. Lettera aperta a “il Manifesto”
 Gentile Redazione de
“il Manifesto”,
Gentile Redazione de
“il Manifesto”,
siamo un gruppo di italiane/i che risiedono a Parigi per ragioni di studio o di lavoro e che partecipano da ormai più di cinque mesi al movimento dei Gilet Gialli. Vi scriviamo per manifestarvi il nostro sdegno a fronte del trattamento riservato nelle pagine del vostro giornale, nella penna di Anna Maria Merlo, vostra corrispondente a Parigi, al sollevamento in atto – e in Atti – dei Gilet Gialli, nonché alla questione politica e sociale che, con inedita forza, esso continua a porre, in Francia e in Europa – dunque, potrebbe darsi, anche in Italia. Ci rivolgiamo a voi, e non ad altri quotidiani nazionali, perché convinti che “il Manifesto” sia luogo di confronto e diffusione di informazioni critiche, nonché voce delle lotte del presente. Tuttavia, malgrado alcune rare ma felici eccezioni[1], la maniera in cui il vostro quotidiano ha parlato finora del movimento francese, attraverso gli articoli dell’autrice, ha prodotto in noi sconcerto e rabbia.
Prima di entrare nel merito, e per capirci meglio, lasciateci un attimo “contestualizzare”.
Il movimento dei Gilet Gialli continua a manifestare la sua forza nell’insieme del territorio francese e in alcuni territori d’oltremare da ben venticinque sabati consecutivi: ciononostante, quando se ne parla in Italia, lo si fa soltanto basandosi sulle cifre del Ministero dell’Interno francese, dati certamente poco attendibili ad oggi.
Per comprendere come non si tratti di qualcosa di passeggero ma di una profonda trasformazione nella storia sociale e politica del paese, dovrebbe bastare, in controluce, la reazione del potere costituito: da novembre ad oggi il sovrano Macron ha dovuto reagire con due “solenni” discorsi alla nazione, una lettera indirizzata ai francesi, una lettera agli europei, e un “Gran Dibattito Nazionale”, che ha assunto il senso di un confuso rilancio, nella crisi profonda del suo governo, della sua politica “start-up”.
Leggi tutto
Militant: L’egemonia irrazionale
L’egemonia irrazionale
di Militant
Seguendo il filo dei ragionamenti che le destre esprimono nelle recenti vicende legate al trasferimento di famiglie rom nella periferia romana, si scopre una trama di contraddizioni da cui è davvero difficile tirarne fuori una logica. Perché una logica, in politica, è sempre rinvenibile, anche quando esprime una visione del mondo opposta alla nostra. Lo smantellamento dei campi rom è da sempre una bandiera della destra d’ogni risma. Una bandiera sacrosanta, lasciata colpevolmente alla destra per ignavia, codardia, per quel “parlar d’altro” che da tempo la sinistra oppone verso qualsiasi problema immediato della periferia. E invece no, va ribadito con forza che i campi nomadi sono luoghi d’inciviltà e di degrado sociale, che impoveriscono tanto chi ci sopravvive quanto il vicinato residente, sempre residente in periferia peraltro. I nomadi non sono (solo) vittime, quanto corresponsabili della situazione: nei campi si determinano privilegi e servitù coatte che replicano tanto l’asservimento dei più deboli verso i più forti, all’interno, quando l’asservimento del territorio al monopolio della sopraffazione, all’esterno. In altre parole, lo smantellamento dei campi è questione di civiltà, non di razzismo. Il problema, va da sé, è nella modalità di gestione della chiusura dei campi, nelle alternative predisposte. Questo dovrebbe differenziare l’approccio “di sinistra” da uno “di destra”.
Leggi tutto
Patrick Boylan: Trump messo sotto scacco da 20 pacifisti
Trump messo sotto scacco da 20 pacifisti
di Patrick Boylan
Il crepuscolo degli dei davanti all'ambasciata venezuelana a Washington
Il fatto: da un mese, venti pacifisti statunitensi sfidano Trump e occupano l'Ambasciata del Venezuela a Washington per impedirne la consegna all'opposizione venezuelana. Per farli uscire, la polizia, insieme a squadristi dell'opposizione, assediano l'edificio, cercando di impedire la consegna di viveri e di medicine. Ma il Collettivo degli occupanti tiene duro.
I retroscena: il 5 febbraio 2019, per dare maggiore credibilità alle pretese di Juan Guaidò, un politico quasi sconosciuto che si era autoproclamato capo di stato del Venezuela pochi giorni prima (il 23 gennaio), il presidente Trump e il Segretario di Stato Pompeo hanno accolto a Washington, con pompa magna, un suo "sostituto ambasciatore" (chargé d'affaires). Contestualmente, hanno radiato dall'albo degli ambasciatori quello nominato ufficialmente nel 2014 da Nicolas Maduro, eletto presidente del Venezuela nel 2013 e riconfermato l'anno scorso.
Il “sostituto ambasciatore” si chiama Carlos Vecchio. Partecipò al golpe fallito contro l'allora presidente venezuelano Hugo Chavez nel 2002 ed è poi fuggito dal Venezuela negli Stati Uniti dopo aver partecipato ad un golpe contro il suo successore Maduro, fallito anch'esso, in febbraio del 2014.
Leggi tutto
comidad: Se l'assistenzialismo per ricchi lo chiami liberismo
Se l'assistenzialismo per ricchi lo chiami liberismo
di comidad
La vendita di Magneti Marelli da parte di FCA ha suscitato l’indignazione di Romano Prodi che l’ha sfogata in un articolo sul quotidiano “il Messaggero”. Uno dei gioielli del gruppo ex torinese è stato ceduto ad una multinazionale giapponese per un bel pacchetto di miliardi e il dettaglio dispiaciuto a Prodi (e molti altri) è che il malloppo verrà quasi completamente “pappato” dagli azionisti di FCA. Di investimenti nemmeno l’ombra. Qualcuno potrebbe supporre che i valorosi manager abbiano le mani legate dagli avidi azionisti; sennonché nelle multinazionali ormai tra i principali azionisti ci sono proprio i manager.
Nel suo articolo Prodi ha anche trovato il modo di prendersela con l’attuale governo che, a suo dire, non avrebbe una “politica industriale”. Le repliche che perverranno dai sostenitori del governo sono abbastanza scontate, in quanto si baseranno sul rinfacciare allo stesso Prodi i suoi trascorsi di privatizzatore, come il “regalo” dell’Alfa Romero alla FIAT e lo smantellamento dell’IRI.
Più interessante di queste ovvie polemiche, sarebbe però capire cosa si intenda per “politica industriale”. La risposta la diede nel 2012 Sergio Marchionne buonanima in uno scambio di battute con l’allora ministro per lo Sviluppo Economico del governo Monti, il banchiere Corrado Passera.
Leggi tutto
Piccole Note: Iran: la guerra è vicina come mai prima d'ora
Iran: la guerra è vicina come mai prima d'ora
di Piccole Note
Gli Usa inviano la portaerei Abraham Lincon verso i mari iraniani e schierano i B-52nella base di Udeid (Qatar). La guerra contro l’Iran non è mai stata così vicina.
A rilanciare l’opzione militare è stata la vittoria di Netanyahu alle recenti elezioni israeliane: ossessionato da questa guerra da decenni, ha una finestra di opportunità come mai prima.
La guerra e le elezioni Usa
Il premier israeliano reputa di aver poco tempo: la guerra deve iniziare prima delle elezioni Usa del 2020, che potrebbero privarlo dell’alleanza americana, sia che il fido Trump perda sia che vinca, dato che al secondo mondato sarebbe più libero dalle pressioni dei falchi che l’attorniano, da John Bolton a Mike Pompeo, che stanno decidendo la sua politica estera.
Il dispiegamento militare americano è stato infatti voluto da Bolton e motivato con non meglio specificate minacce agli interessi americani.
“Data la lunga esperienza di Bolton nell’esagerare e manipolare le informazioni per giustificare l’uso della forza – scrive Foreign Policy -, si potrebbe essere tentati di liquidare il tutto come fake news”.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3405
Hits 3041
Hits 2978
Hits 2888
Hits 2660
Hits 2604
Hits 2547
Hits 2423
tonino

Hyman Minsky: Vittoria del capitalismo?
![]()
Vittoria del capitalismo?
di Hyman Minsky
"Il 25 ottobre 1990 il Centro culturale Progetto di Bergamo ha organizzato il convegno Vittoria del capitalismo?, relatore Hyman Minsky. Pochi mesi dopo la caduta del muro di Berlino, quando c’era chi preconizzava la fine della storia con la vittoria finale del capitalismo, Minsky contrapponeva una lucida lettura, anticipando le caratteristiche del nuovo fragile sviluppo capitalistico..."[Paolo Crivelli]
 Il collasso delle economie di tipo Sovietico è
stato salutato
come una vittoria del Capitalismo e il crollo simultaneo dei
regimi politici comunisti è stato usato per convalidare
l’identificazione
del Capitalismo con la democrazia.
Il collasso delle economie di tipo Sovietico è
stato salutato
come una vittoria del Capitalismo e il crollo simultaneo dei
regimi politici comunisti è stato usato per convalidare
l’identificazione
del Capitalismo con la democrazia.
Da alcune parti si avanza l’idea che questa vittoria segni la fine della Storia così come noi l’abbiamo conosciuta. Ma le vicende del Golfo, la fragilità della prosperità capitalistica e le pressioni nazionaliste risvegliate dal collasso dell’egemonia Sovietica nell’Europa orientale indicano che la Storia non finisce, ma fluisce come il Mississippi che nella canzone “...continua a scorrere”.
Non c’è dubbio che il Socialismo centralistico autoritario di tipo Sovietico è crollato. Ma questa forma di Socialismo non è la sola possibile. Il modello Sovietico ha sempre avuto la caratteristica di non consentire che le preferenze e i desideri della gente influenzassero la produzione. Segnali effettivi (decisioni) nel Socialismo di tipo Sovietico andavano dall’alto verso il basso, mai dal basso, dalla popolazione verso coloro che avevano il potere di decidere che cosa e come produrre. Esistono modelli teorici alternativi di Socialismo nei quali regna una sovranità del consumatore più ampia rispetto a quella delle economie di tipo capitalistico.
Questo modello autoritario di economia centralizzata non è cattivo quando i compiti assegnati all’economia sono semplici: quando si deve produrre solo pane o carri armati. Un’economia centralistica ha funzionato bene nella trasformazione da una società di tipo contadino ad una economia di produzione di massa limitata nella varietà di beni – quando acciaio, cemento e macchinari sono tutto ciò che deve essere prodotto: questo tipo di economia funziona altrettanto bene per la produzione di materiale bellico. Gli approvvigionamenti militari negli Stati Uniti e nel Regno Unito durante la Seconda Guerra Mondiale seguivano un modello di economia centralistica.
Leggi tutto
Paolo Missiroli: “Capitale, egemonia, sistema. Studio su Giovanni Arrighi” di Giulio Azzolini
“Capitale, egemonia, sistema. Studio su Giovanni Arrighi” di Giulio Azzolini
di Paolo Missiroli
Recensione a: Giulio Azzolini, Capitale, egemonia, sistema. Studio su Giovanni Arrighi, Quodlibet, Macerata 2018, pp. 176, euro 18, (scheda libro)
 Giovanni
Arrighi non è un pensatore troppo valorizzato nel panorama
italiano e sono
pochi i luoghi che dedicano un qualche spazio a riflessioni su
questo storico ed economista. Eppure Arrighi è importante nel
dibattito
internazionale a proposito del capitalismo e della sua storia;
esempio ne sia il suo ruolo nella discussione seguita alla
pubblicazione di Impero
di Toni Negri e Michael Hardt. Dai post-operaisti Arrighi
era considerato, pur nel forte disaccordo, un interlocutore di
prim’ordine.
Giovanni
Arrighi non è un pensatore troppo valorizzato nel panorama
italiano e sono
pochi i luoghi che dedicano un qualche spazio a riflessioni su
questo storico ed economista. Eppure Arrighi è importante nel
dibattito
internazionale a proposito del capitalismo e della sua storia;
esempio ne sia il suo ruolo nella discussione seguita alla
pubblicazione di Impero
di Toni Negri e Michael Hardt. Dai post-operaisti Arrighi
era considerato, pur nel forte disaccordo, un interlocutore di
prim’ordine.
Per questo la pubblicazione di una monografia su Arrighi è una buona notizia. Capitale, egemonia, sistema di Giulio Azzolini, oltre ad essere una novità per il solo fatto di trattare di Arrighi, ha il pregio di trattare la sua opera dall’inizio alla fine, cogliendone i punti salienti in un numero di pagine ammirevolmente ridotto; pone con chiarezza gli elementi di contatto con altri autori, scuole e correnti di pensiero; colloca Arrighi nel suo tempo storico ed anche nella sua dimensione di militante politico all’altezza degli anni Settanta. Fare una recensione di un testo simile significa quindi porsi, non senza un qualche grado di arbitrarietà, l’obbiettivo di riportare alcuni fra tutti questi elementi. L’arbitrio sta, appunto, nel fatto che non tutti potranno essere qui trattati. Il testo che discutiamo, peraltro, si presta con facilità, data anche la buona scorrevolezza che lo contraddistingue, ad essere sfogliato e letto da chiunque lo voglia. Non ci concentreremo eccessivamente sugli esiti più noti del pensiero dell’Arrighi maturo, che sono già stati trattati, su Pandora, in recensioni apposite. Qui è possibile trovare la recensione a Il lungo XX secolo e qui e quiquelle a Adam Smith a Pechino.
Può facilitarci il compito il fatto che in effetti si potrebbe dire che il senso della riflessione arrighiana è quello di dare ragione della crisi all’interno del sistema capitalistico. Questo presuppone, com’è evidente, una definizione di tale sistema, ma non è l’obbiettivo del suo pensiero. Già la formulazione della questione in questi termini “la crisi all’interno del sistema capitalistico” non è affatto scontata, come vedremo.
Leggi tutto
Luca Michelini: Landini, Marx e la cultura economica della CGIL
Landini, Marx e la cultura economica della CGIL
di Luca Michelini
 Un bel convegno organizzato
dall’Università di Pisa sul pensiero di Marx (dal titolo Marx
201.
Ripensare l’alternativa) ha avuto tra gli ospiti
Maurizio Landini, neo-segretario della CGIL. Ero molto curioso
di ascoltare Landini,
perché mi aspettavo che parlasse appunto di Marx e del
marxismo, cioè del ruolo che il pensiero marxiano e marxista
poteva avere, o non
avere, oggi, all’interno della più grande organizzazione del
cosiddetto movimento operaio italiano. Il titolo della
relazione, del resto,
prometteva bene: Il lavoro nel capitalismo
globalizzato. Per una nuova internazionale.
Un bel convegno organizzato
dall’Università di Pisa sul pensiero di Marx (dal titolo Marx
201.
Ripensare l’alternativa) ha avuto tra gli ospiti
Maurizio Landini, neo-segretario della CGIL. Ero molto curioso
di ascoltare Landini,
perché mi aspettavo che parlasse appunto di Marx e del
marxismo, cioè del ruolo che il pensiero marxiano e marxista
poteva avere, o non
avere, oggi, all’interno della più grande organizzazione del
cosiddetto movimento operaio italiano. Il titolo della
relazione, del resto,
prometteva bene: Il lavoro nel capitalismo
globalizzato. Per una nuova internazionale.
I presupposti culturali perché il tema fosse rilevante sono numerosi. Il marxismo è stato per lungo tempo l’ideologia portante del sindacato italiano “rosso”, fin dalle sue origini. Ciò non significa affatto che Marx fosse una sorta di profeta da cui trarre dottrina e pratica del sindacalismo: fin dalle sue origini, la fortuna di Marx in Italia si è intrecciata con continue riletture e re-interpretazioni del suo pensiero, fino ad arrivare a vere e proprie critiche, talune anche radicali, tanto da decretarne l’accantonamento come punto di riferimento teorico e politico. Particolarmente rilevante fu in Italia il cosiddetto “revisionismo”, che ebbe notevole impatto sul pensiero economico socialista, grazie ad Achille Loria; ma ebbe rilievo anche in ambito filosofico e storiografico grazie agli scritti di Benedetto Croce di Giovanni Gentile.
Marx, tuttavia, rimaneva un pensatore con il quale il confronto era ineludibile, se non altro perché la storia del capitalismo italiano e la storia mondiale riproponevano continuamente la sua attualità: ora analitica, con lo svilupparsi degli imperialismi occidentali, lo scoppio del primo conflitto mondiale, la Grande Crisi, lo svilupparsi si sistemi economici socialisti; ora politica, con la Rivoluzione d’Ottobre, la nascita del fascismo e del nazismo, l’instaurarsi di regimi socialisti di ispirazioni marxiana, come la Cina ecc. La tradizione di pensiero che, opponendosi al revisionismo, principia con il filosofo Antonio Labriola ed arriva fino ad Antonio Gramsci, costituirà una delle colonne portanti della cultura del Partito Comunista Italiano, cioè di quel partito che con la CGIL aveva un rapporto privilegiato e di continua osmosi culturale e politica.
Leggi tutto
coniarerivolta: I cattivi maestri: l’austerità non è mai abbastanza
I cattivi maestri: l’austerità non è mai abbastanza
di coniarerivolta
Una delle scene più celebri del cinema italiano è quella in cui Totò e Peppino si cimentano nella preparazione di una lettera da indirizzare alla malafemmina. Nella fattispecie, si trattava di Marisa, l’avvenente fiamma del giovane nipote dei due scriventi, tale Gianni, che, a detta dei due goffi mittenti, oltre a non godere di buona reputazione, era tacciata di distogliere il suo amato dai propri doveri.
Questa comica sceneggiatura si ripropone oggi con un inevitabile cambio di protagonisti e di oggetto del contendere. A scrivere, stavolta, sono 60 economisti appartenenti a ben noti circuiti accademici: si va da Pietro Reichlin della Luiss, passando per Giampaolo Galli dell’Osservatorio sui Conti Pubblici dell’Università Cattolica (per intenderci, quello capitanato da Carlo Cottarelli), fino ad arrivare all’ex ministro Renato Brunetta di Forza Italia e al piddino Tommaso Nannicini, docente all’Università Bocconi di Milano (ancora una volta PD e Forza Italia sulla stessa barca). Il destinatario, oltre al vasto pubblico de “Il Foglio” già avvezzo a questo tipo di letture, è l’attuale esecutivo gialloverde. L’oggetto della missiva è, tanto per cambiare, un monito sull’irresponsabilità in materia fiscale dell’attuale Governo, tacciato, proprio come la malafemmina di Totò e Peppino, di cattiva condotta in quanto non starebbe operando nell’interesse del Paese, facendo lievitare la spesa pubblica e quindi il debito.
Leggi tutto
Federico Lancialonga: Per non morir macronizzati
Per non morir macronizzati
di Federico Lancialonga*
Un road movie di François Ruffin e Gilles Perret offre la parola alle motivazioni di quei francesi invisibili che dallo scorso novembre hanno cominciato a indossare i Gilets Gialli
Un road movie alla scoperta dei Gilets Gialli. J’veux du soleil, documentario girato in meno di una settimana da François Ruffin e Gilles Perret, offre la parola a quei francesi invisibili che dallo scorso novembre hanno cominciato a brillare di giallo fluorescente. Marie, Carine, Corinne, Cindy, Khaled, Rémi, Denis e tanti altri raccontano alla videocamera tutto ciò che Macron e i suoi media (nazionali e internazionali) non vogliono ascoltare.
In Italia stampa e partiti hanno fatto di tutto per occultare il vero volto dei Gilets Gialli e distorcere le ragioni della protesta. Una diffusione italiana di J’veux du soleil sarebbe un primo passo per cominciare a capire ciò che accade in Francia da ormai più di sei mesi.
Una folla composta attende in fila davanti alla biglietteria del cinema Espace Saint-Michel. Parigi, 3 aprile. È il primo giorno in sala del film J’veux du soleil (che in italiano possiamo tradurre letteralmente con “Voglio del sole”) di François Ruffin e Gilles Perret. Gli ultimi spettatori in coda si confondono nel viavai di chi sale e chi scende la rampa di scale del métro Saint-Michel. Un signore se ne sta ritto in piedi dietro a un banchetto colmo di riviste, libri e volantini. Jeans, camicia a scacchi, gilet giallo.
Leggi tutto
Federico Dezzani: Guerra di dazi: globalizzazione e esportatori nel mirino
Guerra di dazi: globalizzazione e esportatori nel mirino
di Federico Dezzani
Dopo un’effimera tregua, i negoziati sino-americani per riequilibrare il disavanzo commerciale degli Stati Uniti si sono arenati: Washington ha esteso i dazi ad altri 200 $mld di merci cinesi, continuando il giro di vite iniziato lo scorso autunno. A distanza di pochi giorni, Pechino ha risposto aumentando i dazi su 60 miliardi merci americane: i mercati finanziari hanno subito incassato il colpo, scontando l’incancrenirsi della guerra commerciale con le pesanti ricadute globali in termini di crescita. Difficilmente Washington rimpatrierà posti di lavoro adottando questa politica: ciò che interessa agli angloamericani è far deragliare l’attuale globalizzazione, per acuire i nazionalismi economici e destabilizzare i grandi produttori/esportatori (Germania compresa). La probabile saldatura con la No Deal Brexit.
“No Deal China”
Il disavanzo commerciale degli USA nei confronti della Cina, pari a un deficit annuo di 500 $mld di dollari (a lungo finanziati dall’acquisto cinese di debito pubblico americano), è sempre stato in cima all’agenda dell’amministrazione nazionalista-populista di Donald Trump. La retorica anti-cinese aveva già contraddistinto la campagna elettorale di Trump nel 2016 e, dopo una serie di lunghe accuse, dalla manipolazione dello yuan al furto della proprietà intellettuale, nell’autunno 2018 si era arrivati al primo round di dazi: su 200 $mld di merci cinesi, le imposizioni fiscali erano saliti dal 10 al 25%.
Leggi tutto
Franca Caffa: Politecnico di Milano, il tempo degli Off Campus
Politecnico di Milano, il tempo degli Off Campus
Il nodo del diritto alla casa, quarant’anni di dibattiti
di Franca Caffa
Milano, mille anni fa. Gli occupanti di Via Tibaldi dopo lo sgombero operato dalla Polizia entrano ad Architettura, occupata dagli studenti con il sostegno di docenti. Scontri violenti con la Polizia. Il Consiglio di Facoltà condanna l’intervento della Polizia e “decreta la riconversione di tutta l’attività accademica in un unico seminario monografico che ha come tema: il problema della casa nell’hinterland milanese. Inoltre reclama la presenza degli occupanti in quanto ‘consulenti scientifici’ di detto seminario”.
6 giugno 1971, “la Polizia invade la Facoltà. Il professor Paolo Portoghesi, Preside della Facoltà di Architettura, sta tenendo il suo intervento sulla ‘questione delle abitazioni’. Non c’è nessuna resistenza. […] Oltre seicento persone vengono trasferite a Via Fatebenefratelli nei locali della Questura di Milano. Ci sono studenti e insegnanti di Architettura e non solo, compagni impegnati nel sostegno della lotta, i membri del Consiglio di Facoltà al gran completo. Nemmeno uno degli occupanti, che sono al sicuro nella sede milanese delle ACLI”. Quando il gruppo dirigente della Polizia prova a rilasciare i membri del Consiglio di Facoltà, trattenendo tutti gli altri fermati, “il decano del Consiglio di Facoltà, capelli bianchi e sguardo dolce ma severo, dichiara fermamente che sarà l’ultimo a lasciare la Questura”. Il Questore cede e sono tutti rilasciati.
Leggi tutto
Domenico Moro: La relazione europeismo-corporativismo nei sindacati
La relazione europeismo-corporativismo nei sindacati
di Domenico Moro
 Da circa
dieci anni
l’austerity europea, combinata con la più grave crisi
economica dal 1929, sta devastando la società europea. I danni
più
gravi sono stati sopportati dal lavoro salariato che ha
registrato importanti balzi all’indietro a tutti i livelli.
Eppure, le mobilitazioni
più importanti contro l’austerity europea sono venute
soprattutto da movimenti extrasindacali sorti fuori dai luoghi
di lavoro, come gli
indignados e i gilet gialli, invece che dalle organizzazioni
tradizionali dei lavoratori. Non sono mancate le eccezioni,
come in Francia, dove negli
ultimi anni si sono avute alcune forti mobilitazioni
sindacali, anche recentemente, come nel caso dei ferrovieri.
Invece, le mobilitazioni contro
l’austerity e le controriforme del mercato del lavoro, delle
pensioni, ecc. sono state particolarmente deboli nel nostro
Paese, dove persino i
provvedimenti del governo Monti, di gran lunga il peggiore
almeno dell’ultimo decennio, sono passati senza alcuna
opposizione da parte dei
sindacati principali. Le ragioni della particolare debolezza
della riposta sindacale in Italia sono molteplici, e vanno
dalle massicce
delocalizzazioni alla estrema frammentazione contrattuale del
lavoro salariato. Ma, almeno in parte, sono da ascriversi alle
scelte politiche del
sindacato stesso, in particolare al connubio di concertazione,
neocorporativismo e filo-europeismo, che ha caratterizzato i
tre principali sindacati
italiani, compreso il maggiore, cioè la Cgil.
Da circa
dieci anni
l’austerity europea, combinata con la più grave crisi
economica dal 1929, sta devastando la società europea. I danni
più
gravi sono stati sopportati dal lavoro salariato che ha
registrato importanti balzi all’indietro a tutti i livelli.
Eppure, le mobilitazioni
più importanti contro l’austerity europea sono venute
soprattutto da movimenti extrasindacali sorti fuori dai luoghi
di lavoro, come gli
indignados e i gilet gialli, invece che dalle organizzazioni
tradizionali dei lavoratori. Non sono mancate le eccezioni,
come in Francia, dove negli
ultimi anni si sono avute alcune forti mobilitazioni
sindacali, anche recentemente, come nel caso dei ferrovieri.
Invece, le mobilitazioni contro
l’austerity e le controriforme del mercato del lavoro, delle
pensioni, ecc. sono state particolarmente deboli nel nostro
Paese, dove persino i
provvedimenti del governo Monti, di gran lunga il peggiore
almeno dell’ultimo decennio, sono passati senza alcuna
opposizione da parte dei
sindacati principali. Le ragioni della particolare debolezza
della riposta sindacale in Italia sono molteplici, e vanno
dalle massicce
delocalizzazioni alla estrema frammentazione contrattuale del
lavoro salariato. Ma, almeno in parte, sono da ascriversi alle
scelte politiche del
sindacato stesso, in particolare al connubio di concertazione,
neocorporativismo e filo-europeismo, che ha caratterizzato i
tre principali sindacati
italiani, compreso il maggiore, cioè la Cgil.
Un appello e una lettura dell’Europa sbagliati
Il recente Appello per l’Europa, firmato congiuntamente da Confindustria e sindacati (Cgil, Cisl e Uil), è la dimostrazione emblematica di questa situazione. L’organizzazione che rappresenta i maggiori beneficiari delle controriforme europee, le grandi imprese internazionalizzate, e le organizzazioni che dovrebbero rappresentare i più penalizzati, i lavoratori salariati dell’industria, firmano insieme un manifesto che riproduce quelle illusioni sull’Europa nelle quali forse si poteva cadere qualche anno fa, ma che ora non ha più senso ripetere.
Leggi tutto
Enrico Grazzini: Moneta fiscale: perchè tocca ai governi attuare misure non convenzionali per rilanciare lo sviluppo
Moneta fiscale: perchè tocca ai governi attuare misure non convenzionali per rilanciare lo sviluppo
di Enrico Grazzini
Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo contributo sulla controversa proposta di moneta fiscale, con l’auspicio che possa contribuire al dibattito pubblico
 L’eurozona è ancora una volta in
crisi e ha urgente bisogno di nuovo ossigeno monetario per
fare ripartire la
domanda aggregata, e quindi la produzione e l’occupazione. La
BCE per bocca di Mario Draghi ha annunciato una nuova serie di
operazioni di
rifinanziamento a lungo termine (T-LTRO 3) per le banche a
partire da settembre 2019 fino a marzo 2021 con scadenza
biennale. L’obiettivo
proclamato è di rifornire le banche a costo (quasi) zero della
liquidità necessaria per alimentare i prestiti all’economia
reale.
L’eurozona è ancora una volta in
crisi e ha urgente bisogno di nuovo ossigeno monetario per
fare ripartire la
domanda aggregata, e quindi la produzione e l’occupazione. La
BCE per bocca di Mario Draghi ha annunciato una nuova serie di
operazioni di
rifinanziamento a lungo termine (T-LTRO 3) per le banche a
partire da settembre 2019 fino a marzo 2021 con scadenza
biennale. L’obiettivo
proclamato è di rifornire le banche a costo (quasi) zero della
liquidità necessaria per alimentare i prestiti all’economia
reale.
L’annuncio dello T-LTRO III segue solamente di pochi mesi la fine (evidentemente prematura) della più importante manovra monetaria anticonvenzionale portata a termine nella storia dell’eurozona e dell’Europa: il Quantitative Easing. Grazie al piano di espansione monetaria la BCE dal marzo 2015 al dicembre 2018 ha fornito 2600 miliardi di euro al sistema bancario in cambio di titoli di stato (comprati dalle banche) e altri titoli. 2600 miliardi sono una cifra enorme, pari a circa il 20% del PIL europeo. Eppure anche il QE non ha ottenuto l’effetto sperato: per molti aspetti è stato un fallimento. L’eurozona è ferma, la domanda aggregata nell’economia reale langue, investimenti e consumi non ripartono, l’inflazione non cresce e la disoccupazione resta elevata. In realtà l’eurozona non è mai uscita dalla crisi, nonostante l’enorme quantità di moneta creata dalla BCE a favore (soprattutto) delle banche in ragione di migliaia di miliardi di euro.
Se i soldi creati dalla BCE fossero stati assegnati non alle banche ma direttamente agli stati, alle famiglie e alle imprese la domanda aggregata (consumi, investimenti, spesa pubblica) e l’inflazione si sarebbero riprese subito e avrebbero trascinato immediatamente al rialzo la produzione e l’occupazione. Basta fare due semplici calcoli: 2,6 triliardi distribuiti ai 340 milioni di abitanti dell’eurozona (neonati e ultraottantenni compresi) avrebbero comportato che ogni abitante poteva percepire oltre 7650 euro, cioè circa 160 euro al mese per i 46 mesi del QE.
Leggi tutto
Amos Pozzi: Cambiare o Perire: la dura Scelta del Bolivarismo venezuelano
Cambiare o Perire: la dura Scelta del Bolivarismo venezuelano
di Amos Pozzi
 Il tentato golpe raffazzonato di
Juan Guaido degli ultimi giorni ha riportato sotto i
riflettori mondiali il
Venezuela. E con esso il solito insieme di cliché
sulla sua situazione economica. I media non ci hanno
risparmiato nulla: dal
socialismo “che rende tutti poveri”, all’aneddoto dei cugini
che “stavano benissimo” e ora “muoiono di
fame”. Ma abbiamo anche sentito la campana di un certo
riduzionismo culturale che attribuirebbe l’intera crisi al
ruolo degli USA o degli
speculatori interni. Ci è sembrato quindi il caso, per quanto
assolutamente non facile, di provare a fare il punto della
situazione economica
dello stato sudamericano, dell’evoluzione della crisi e delle
sfaccettature sociali della stessa.
Il tentato golpe raffazzonato di
Juan Guaido degli ultimi giorni ha riportato sotto i
riflettori mondiali il
Venezuela. E con esso il solito insieme di cliché
sulla sua situazione economica. I media non ci hanno
risparmiato nulla: dal
socialismo “che rende tutti poveri”, all’aneddoto dei cugini
che “stavano benissimo” e ora “muoiono di
fame”. Ma abbiamo anche sentito la campana di un certo
riduzionismo culturale che attribuirebbe l’intera crisi al
ruolo degli USA o degli
speculatori interni. Ci è sembrato quindi il caso, per quanto
assolutamente non facile, di provare a fare il punto della
situazione economica
dello stato sudamericano, dell’evoluzione della crisi e delle
sfaccettature sociali della stessa.
Naturalmente trovare dati economici affidabili sul Venezuela dopo il 2014 è diventata un’impresa. Per quanto possibile ci siamo basati su dati della Banca Mondiale evitando dati governativi o think tank interni di area opposizione in modo da mantenere il più possibile “neutra” la raccolta dei dati di partenza.
Partiamo quindi dall’osservare l’evoluzione del PIL venezuelano dal 1990 fino al 2014, ultimo anno in cui abbiamo dati indiscutibili sullo stesso.
Leggi tutto
Carlo Galli: Senza sovranità non c’è politica
Senza sovranità non c’è politica
di Carlo Galli
La lotta politica in Italia si è semplificata intorno alla contrapposizione fra un male e un bene: il mondialismo, o l’europeismo (che non sono la stessa cosa), l’accoglienza, la democrazia, contro la sovranità, l’autoritarismo, la xenofobia. In questa contrapposizione viene ricompresa quella fra destra e sinistra: la sovranità è la destra, e la lotta contro di essa è la sinistra. Ma la sovranità è una cosa più complessa, e non è possibile sbarazzarsene derivandone un termine ingiurioso – sovranismo –.
La sovranità è un concetto esistenziale. Ha a che vedere col fatto che un corpo politico (un popolo, una nazione) esiste nella storia e nello spazio, e che ha una volontà e di una capacità di agire. C’è esistenza politica se c’è sovranità.
La sovranità è l’ordine giuridico che vige in un territorio: un ordine che, come una prospettiva pittorica, ha un fuoco che ne è l’origine e il vertice. Un ordine che protegge i cittadini, rendendone prevedibile l’esistenza. L’ordine dello Stato.
Ma la sovranità è anche un concetto politico: è energia vitale e proiezione ideale di un soggetto che afferma se stesso, che persegue i propri interessi strategici. E che mentre si afferma, esiste, sia che dica «We the People» – come nella Costituzione degli Usa –, sia che dica «L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro».
Leggi tutto
Dante Barontini: Il libero pensiero secondo i social
Il libero pensiero secondo i social
di Dante Barontini
La chiusura di 23 pagine Facebook italiane – buona parte “tifose” della Lega o dei Cinque Stelle – è una classica “novità” da esaminare con attenzione.
La decisione dei vertici del social fondato a Mark Zuckerberg è arrivata dopo un’inchiesta condotta da Avaaz, una ong internazionale che ha censito con cura una serie di account intestati a nomi improbabili e che “informazioni false e contenuti divisivi contro i migranti, antivaccini e antisemiti”.
Roba da chiudere anche a mazzate, insomma. E, fin qui, nulla da eccepire. Siamo tutti tormentati quotidianamente da centinaia di post “condivisi” – spesso da gente che si fa abbindolare solo da un titolo studiato apposta – che sparano idiozie di ogni tipo. Noi stessi, quasi ogni giorno, segnaliamo ai nostri lettori fake news di grande rilevanza, magari diffuse dai più accreditati media mainstream…
Stiamo parlando qui di pagine abbastanza seguite (un totale di quasi due milioni e mezzo di followers), che contribuivano insomma a creare un pubblico intossicato da “informazioni” false, slogan razzisti, credenze antiscientifiche, ecc. Gente che poi vota in base a quel che crede di “sapere”…
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Europee 2019: la posta in gioco
Europee 2019: la posta in gioco
di Leonardo Mazzei
Qual è la posta in gioco nelle elezioni europee del 26 maggio? Sta qui, nella risposta a questa domanda, la chiave dell'indicazione di voto di Programma 101. Il succo della nostra posizione è semplice: dare un voto contro l'Unione Europea, ma darlo guardando innanzitutto alle sue ricadute in Italia. La qual cosa è l'esatto contrario del provincialismo, dato che nella battaglia contro la gabbia eurista sarà proprio quello italiano il fronte decisivo dei prossimi mesi.
Andiamo allora al sodo, cercando di capire come potrebbe evolvere la situazione politica del nostro Paese a seconda dei diversi esiti elettorali possibili. Attualmente il quadro è alquanto incerto, le due forze di governo litigano su tutto, ed il blocco dominante che gli si oppone sogna la rivincita sul 4 marzo e sulle forze populiste.
Chi non vede questa contraddizione, non può vederne i potenziali sviluppi. Governo e blocco dominante sono a tutt'oggi due mondi distinti e fondamentalmente contrapposti. Ovviamente, distinti non vuol dire impermeabili. La permeabilità c'è eccome. Ed il fatto che essa operi in un'unica direzione - quella dell'influenza del blocco dominante sul governo, non viceversa - mostra dove stia realmente il potere decisivo.
Tuttavia, ecco la novità della fase populista generata dalla crisi, quel potere non produce più consenso, non nella misura che gli sarebbe necessaria. Da qui l'attuale difficoltà dei dominanti ad abbozzare una chiara strategia politica.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Mercanti nel Niger
![]()
Mercanti nel Niger
La via della seta come quella di sabbia
di Mauro Armanino
Niamey, maggio 019. Ad ognuno il commercio che si merita. Quello della seta con l’ambizione tutta cinese di contrastare l’egemonia degli Stati Uniti e poi quella del Sahel, fatto di sabbia o poco più. Adesso nel Niger passano proprio tutti e l’ultima in ordine di tempo è Angela Merkel, arrivata per dare soldi, consigli e confermare la politica europea nella zona. Erano tutti d’accordo con lei. Solo il lavoro e lo sviluppo potranno lottare con successo contro il terrorismo e le migrazioni. Il fatto che le due cose, ormai da tempo, vadano appaiate non fa che confermare che politica, economia e repressione della mobilità umana nel Sahel non siano separabili. In cambio di aiuti sostanziali il Niger si offre come garante della mercanzia: migranti criminalizzati e dunque bloccati ad Agadez e poi venduti in cambio di soldi e progetti di sviluppo. Dalla via della seta, dove tutti si commercia a quella di sabbia il passo è breve. Chiedetelo alla signora Emmanuela Del Re, di visita ad Agadez il martedì 30 aprile scorso. Lei, vice-ministro degli Esteri e della Cooperazione Internazionale, ha tenuto ad assicurare le autorità nigerine dell’azione italiana a sostegno del Paese. L’anno scorso, in cambio della ‘comprensione’ del Niger in ambito migratorio, l’Italia ha assicurato al Paese un aiuto di 80 milioni di euro. Chi credeva che la sabbia non ha valore di scambio si trova apertamente sconfessato. La via della sabbia è altrettanto produttiva di quella della seta, parola della Merkel.
Leggi tutto
Hits 3445
Hits 3112
Hits 2930
Hits 2703
Hits 2625
Hits 2553
Hits 2435
Hits 2367
Hits 2036
Hits 2009
tonino

Redazione: Otto domande (e risposte) sull’Europa
Otto domande (e risposte) sull’Europa
di Redazione
 1. Cosa è in gioco con le elezioni europee? Il
Parlamento europeo
ha veri poteri?
1. Cosa è in gioco con le elezioni europee? Il
Parlamento europeo
ha veri poteri?
Tra meno di due settimane tutti i cittadini dell’Unione europea saranno chiamati alle urne per eleggere i propri rappresentanti nel Parlamento Ue. La data sembra particolarmente carica di significati, si tratta infatti di un appuntamento che cade a 40 anni esatti dalle prime elezioni europee a suffragio universale, nel 1979. Saranno anche le prime senza il Regno Unito. Alle elezioni europee storicamente hanno votato meno persone che nelle elezioni politiche. Negli anni ’80, in un sistema di partiti ancora molto strutturato, la differenza era più contenuta ma già significativa: nelle politiche votava quasi il 90% dell’elettorato, nelle europee circa l’82-83%. Un divario che nei decenni successivi si è progressivamente allargato. 58,69% gli elettori che sono andati a votare alle europee del 2014 in Italia.
Il Parlamento europeo è l’assemblea dell’Unione europea, ad oggi è l’unica istituzione direttamente eletta dai cittadini e dalle cittadine dell’Unione europea. E’ composta da 750 deputati e deputate, più il presidente. Svolge una funzione legislativa con il Consiglio europeo, elegge il Presidente della Commissione e approva o respinge la nomina dell’intera Commissione.
Questo è quanto si può leggere sulla “carta”, ma che cosa accade nella realtà?
Il parlamento nasce come organo consultivo sin dalla nascita della Comunità europea, ma è solo partire dal 1999, con il Trattato di Amsterdam, quello che poi è diventato a tutti gli effetti la Costituzione dell’Unione europea, che i suoi poteri sono stati in parte rafforzati. Sebbene sia intervenuta questa “riforma” attualmente ancora non dispone di reali funzioni legislative, non ha infatti potere di iniziativa legislativa, che spetta invece alla Commissione, se non limitatamente ad alcuni casi.
Di fatto la “Legge Primaria” in Europa rimangono i Trattati, come Maastricht, Lisbona, o il Fiscal Compact, limitando pertanto la sovranità di elettori e elettrici quando vengono chiamati alle urne per indicare l’unica istituzione europea a carattere elettivo.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Lettera aperta a Monica Di Sisto: Passo falso del Movimento No Triv
Lettera aperta a Monica Di Sisto: Passo falso del Movimento No Triv
di Fulvio Grimaldi
Quando parlano i radicali l'ambiente si tappa le orecchie
 In calce alla mia lettera a Monica
Di Sisto, che qui pubblico, c’è una lettera al governo detta
“dei movimenti”. A guardar bene, più che di movimenti, di
movimento al singolare si tratta, per quanto con la firma
autorevolissima
di una grande combattente contro le mostruosità del
neoliberismo, specie in termini di accordi internazionali come
il CETA, o il TTIP (tornati
di attualità), che configurano un pericoloso sbilanciamento a
favore degli Usa, delle multinazionali e della sovranità
popolare e
nazionale, come qui e sul blog ho ripetutamente illustrato.
In calce alla mia lettera a Monica
Di Sisto, che qui pubblico, c’è una lettera al governo detta
“dei movimenti”. A guardar bene, più che di movimenti, di
movimento al singolare si tratta, per quanto con la firma
autorevolissima
di una grande combattente contro le mostruosità del
neoliberismo, specie in termini di accordi internazionali come
il CETA, o il TTIP (tornati
di attualità), che configurano un pericoloso sbilanciamento a
favore degli Usa, delle multinazionali e della sovranità
popolare e
nazionale, come qui e sul blog ho ripetutamente illustrato.
Tra le firme ci sono, oltre a quelle di Fairwatch, protagonista della battaglia di Di Sisto, presieduta da Alberto Zoratti, le firme di Enzo Di Salvatore, costituzionalista di riferimento del movimento No Triv, di Enrico Gagliano, dirigente No Triv, Francesco Masi, portavoce No Triv, più altri di cui si conosce la frequentazione di Radio Radicale. C’è anche un rappresentante di PAP che non sembra badare tanto alle compagnie. Lo stesso Gagliano è stato portatore, nelle comunicazioni al movimento, di apprezzamenti e suggestioni dei Radicali, cosa questa che ha provocato nette espressioni di disaccordo.
Va dunque sottolineato che, a prescindere dalla diffusione della “Lettera al governo del non cambiamento” promossa da Monica Di Sisto, l’iniziativa sia da ricondursi al solo movimento No Triv, i cui responsabili vantano una particolare vicinanza ai Radicali, elemento sconcertante alla vista delle politiche di questa forza politica a sfavore di tutto ciò che conviene alla protezione dell’ambiente, dei diritti sociali e all’autodeterminazione dei popoli. I Radicali rivendicano un ruolo determinante nella costruzione di questa Europa e nella sua difesa appassionata, a dispetto di quanto questa costruzione di burocrati e lobby economiche ha inflitto, in termini di disuguaglianze, impoverimento e austerità, ai paesi dotati di minore potere contrattuale, a partire dalla Grecia e a proseguire con l’Italia.
Leggi tutto
Carlo Scognamiglio: Perché la regionalizzazione della scuola è costituzionalmente borderline
Perché la regionalizzazione della scuola è costituzionalmente borderline
di Carlo Scognamiglio
 1. Genesi e sostanza dell’autonomia
differenziata
1. Genesi e sostanza dell’autonomia
differenziata
L’accelerazione politica del processo di decentramento amministrativo sollecita un ritorno alla discussione sul tema del federalismo, e solleva l’allarme sulla sua compatibilità costituzionale, poiché tra le tante materie su cui si intendono distribuire le competenze, c’è anche l’organizzazione del sistema di istruzione, tradizionalmente legato alla questione unitaria. Questo è un tema difficile, che non può essere affrontato con facili proclami. A poco serve urlare all’incostituzionalità o alla rottura dell’identità nazionale. Occorre ragionare con calma. Altri Stati hanno sistemi di istruzione organizzati regionalmente, e l’Italia stessa ha già delegato agli enti regionali molte funzioni. Bisogna capire, in questo caso, cosa significa e come si sviluppa la questione politica dell’autonomia differenziata. Proviamo a fare un passo indietro, per inquadrare correttamente il tema.
L’Italia ha una tradizione comunale, non regionale. Il Risorgimento aveva condotto all’agognato e difficile obiettivo del superamento di una frammentazione territoriale tradizionalmente percepita come il principale fattore di debolezza dell’Italia. Lo Stato unitario aveva certamente aggregato all’antica istituzione comunale l’amministrazione periferica prefettizia, le Province, con funzioni prevalentemente tecniche. Nel 1865 Minghetti propose la costituzione di Regioni amministrative, ma la proposta venne bocciata. Si trattava di un progetto che – si diceva – metteva a rischio il senso di unità nazionale già fragile. Don Luigi Sturzo e il Partito Popolare, nel primo dopoguerra, ripresero la questione, in vista di un’auspicata autonomia regionale. Ma poi ebbe inizio il ventennio fascista, contrario alle autonomie locali, subordinando anche gli istituti comunali alla tutela dello Stato centrale. Per questa ragione, secondo lo storico Claudio Pavone, “la Resistenza è stata pressoché unanime, nelle sue prese di posizione esplicite, nel rivendicare decentramento e autonomie locali”.
Leggi tutto
Nicolò Pennucci: Gramsci e il populismo
Gramsci e il populismo
Recensione di Nicolò Pennucci
Guido Liguori (a cura di): Gramsci e il populismo, Unicopli, Milano 2019, pp. 173, ISBN: 884002056X
 Gramsci e il populismo ha l’ambizione di
affrontare un
problema fondamentale nel dibattito politico
contemporaneo, quello della relazione del pensiero politico
della sinistra con il populismo e in
particolare il rapporto tra la categoria della classe sociale,
centrale nell’elaborazione marxista, e quella di popolo, che
sembra negare in
toto la portata sociologica e politica dell’unità d’analisi
marxista. Partire da Gramsci è imprescindibile, in quanto la
teoria politica contemporanea che avoca la possibilità di un
populismo di sinistra si riferisce direttamente al suo
pensiero
nell’elaborazione concettuale della propria proposta. Ciò
solleva non pochi problemi alla base dei contributi che si
susseguono nel
volume collettaneo.
Gramsci e il populismo ha l’ambizione di
affrontare un
problema fondamentale nel dibattito politico
contemporaneo, quello della relazione del pensiero politico
della sinistra con il populismo e in
particolare il rapporto tra la categoria della classe sociale,
centrale nell’elaborazione marxista, e quella di popolo, che
sembra negare in
toto la portata sociologica e politica dell’unità d’analisi
marxista. Partire da Gramsci è imprescindibile, in quanto la
teoria politica contemporanea che avoca la possibilità di un
populismo di sinistra si riferisce direttamente al suo
pensiero
nell’elaborazione concettuale della propria proposta. Ciò
solleva non pochi problemi alla base dei contributi che si
susseguono nel
volume collettaneo.
Cercare di analizzare un problema contemporaneo con le lenti di un pensatore di un’altra epoca pone infatti un problema metodologico. Quentin Skinner in un lavoro paradigmatico per la storia del pensiero politico insegna che il pensiero si conosce attraverso i testi che devono essere letti sotto la doppia luce di testo e contesto per evitare distorsioni e imprecisioni ermeneutiche (SKINNER, QUENTIN, 1969: Meaning and Understanding in the History of Ideas, “History and Theory”, Vol. 8, No. 1 pp. 3-53 ). Sradicare completamente un testo dal suo contesto storico-politico è un’operazione che si apre alla possibilità di distorsioni pericolose e all’abuso di categorie che diventano completamente snaturate. Ciononostante un pensatore, soprattutto un pensatore come Gramsci che ha fatto della praxis la nota definitoria del suo progetto filosofico, non può restare relegato all’uso dei filologi. Come conciliare la corretta lettura filologica con l’uso politico del pensiero gramsciano nella contemporaneità è la grande domanda che sottostà all’intero sviluppo del libro e valutare i limiti e le potenzialità di questo sforzo è uno dei compiti del presente lavoro. Che questo doppio filo leghi tutti i contributi è dimostrato dallo stesso curatore. Liguori, infatti, nell’introduzione dichiara «presentiamo i contributi che compongono il volume non nell’ordine nel quale si sono susseguiti nel corso del seminario di Roma, ma cercando di collocarli in una sequenza che, partendo da Gramsci e dalla lettura dei suoi testi, cerchi di interrogare il presente del dibattito sul neopopulismo contemporaneo» (p. 10).
Leggi tutto
Vincenzo Comito: La Germania dubita
La Germania dubita
di Vincenzo Comito
La frenata dell’economia tedesca dipende solo in parte dalla situazione congiunturale della guerra dei dazi Usa-Cina. Serpeggia in Germania un diffuso disagio e anche un fermento politico che mette in dubbio i dogmi dell’austerity
 L’andamento
dell’economia
L’andamento
dell’economia
Come ha sottolineato di recente, tra gli altri, anche il Financial Times (The Editorial Board, 2019), negli ultimi 15 anni la Germania è stata il motore della più o meno elevata crescita europea; vi si sono registrati alti livelli di produttività, relativamente, anche se solo relativamente, bassi livelli di diseguaglianza, ridotti tassi di disoccupazione, pur se non sono mancati a questo proposito altri problemi, quali un’accresciuta precarietà del lavoro. Dalla crisi finanziaria ad oggi la crescita del reddito pro-capite tra i Paesi del G-7 è stata comunque la più elevata dopo quella degli Stati Uniti. Perché dubitare di tale modello, si chiede dal canto suo Le Monde (Editorial, 2019), quando il Paese registra un avanzo annuale di bilancio di 60 miliardi di euro, un debito pubblico inferiore al 60% del Pil, una bilancia commerciale fortemente in surplus?
Ma idati e le valutazioni più recenti disponibili per quanto riguarda quella economianon sembrano piùmolto incoraggianti, o almeno essi appaiono contraddittori e incerti. Il quarto trimestre del 2018 ha registrato così una crescita del Pil pari a zero, mentre per l’intero anno il risultato è stato quello di un aumento dell’1,4%, contro il 2,2% a suo tempo ottenuto nel 2017. Per l’anno in corso poi, le ultime stime di marzo del governo parlano di una possibile crescita dello 0,5%, percentuale che non sarebbe certo vista con molto entusiasmo neanche in un Paese come l’Italia.
Peraltro molti economisti appaiono relativamente più ottimisti del governo, puntando ad uno 0,8%,mentre gli ultimi dati a consuntivo pubblicati nel maggio 2019 mostrano qualche speranza per un miglioramento della situazione anche per il settore industriale, grazie alla resistenza delle esportazioni, mentre in ogni caso il settore dei servizisi comporta abbastanza bene.
Per altro verso, si registra anche, nell’ultimo periodo, un crescente senso di insoddisfazione e di ingiustizia nel Paese (Bramucci, 2019), sul piano economico come su quello sociale e politico. Qualcuno parla, a questo proposito, tra l’altro, di un declino sociale del Paese (Nachtwey, 2019).
Leggi tutto
Mattia Di Pierro, Francesco Marchesi: Immanenza e politica, crisi di un rapporto
Immanenza e politica, crisi di un rapporto
di Mattia Di Pierro, Francesco Marchesi
L’Almanacco di Filosofia e Politica (Quodlibet, 2019), diretto da Roberto Esposito, sarà presentato giovedì 16 maggio alle 17.00 a Villa Mirafiori (via Carlo Fea 2, Aula IV) all’interno del Seminario permanente di Filosofia Teoretica dell’Università di Roma La Sapienza. Intervengono Donatella Di Cesare, Roberto Esposito, Marcello Mustè, Mario Tronti, Elettra Stimilli. Modera Roberto Ciccarelli. Qui anticipiamo un estratto dell’introduzione dei curatori del primo numero, dedicato alla Crisi dell’immanenza
 Perché i conflitti che
ci interessano
significano solo se stessi, perché il Ruanda, la
Jugoslavia, le primavere arabe significano solo se stesse,
sono eventi illeggibili, pure
vittime, mentre la politica comincia quando non esistono
più eventi illeggibili o pure vittime, quando diventa
giusto morire e soprattutto
uccidere in nome di qualcosa, anche se oggi non osiamo più
pensarlo, anche se oggi non oseremmo scriverlo, o lo faremmo
solo in una poesia. Per
questo guardo il viale e passo ad argomenti prossimi, per
questo voglio sentirmi credibile e presente – i miei
problemi, la forma dei suoi
occhiali, la chemioterapia di un amico, la gravidanza di
un’amica, un altro neonato. Ci salutiamo così.
Perché i conflitti che
ci interessano
significano solo se stessi, perché il Ruanda, la
Jugoslavia, le primavere arabe significano solo se stesse,
sono eventi illeggibili, pure
vittime, mentre la politica comincia quando non esistono
più eventi illeggibili o pure vittime, quando diventa
giusto morire e soprattutto
uccidere in nome di qualcosa, anche se oggi non osiamo più
pensarlo, anche se oggi non oseremmo scriverlo, o lo faremmo
solo in una poesia. Per
questo guardo il viale e passo ad argomenti prossimi, per
questo voglio sentirmi credibile e presente – i miei
problemi, la forma dei suoi
occhiali, la chemioterapia di un amico, la gravidanza di
un’amica, un altro neonato. Ci salutiamo così.
(Guido Mazzoni, Angola)
1. Dopo il ’68
Sul piano della teoria la spinta propulsiva del Sessantotto sembra essersi esaurita. L’immanenza, e la ricerca di una politica radicata in essa e solo in essa, hanno visto venire progressivamente meno la loro funzione. Si è consumato così un grande progetto di liberazione. Quello sessantottesco è stato, se colto da questo punto di vista, il tentativo di costruire un pensiero del tutto privo di gerarchie: condizione ritenuta essenziale per la creazione di un mondo radicalmente egualitario. Di qui l’immanenza come, ad un tempo, premessa e fine del lavoro filosofico, depurato di universali sovraordinati o di fondamenti celati sotto la superficie del visibile. Questo tratto complessivo assumeva tuttavia due accezioni in parte divergenti: da un lato riprendeva la sperimentazione delle scienze umane del dopoguerra, tesa nel suo insieme a pensare sistematiche del tutto orizzontali, ma pur sempre sistematiche. Un’eredità modernista ancora persuasa della possibilità di un ordine egualitario, che ordine restasse. Dall’altro si apriva a un processo poi risultato prevalente, almeno in ambito continentale: la distruzione di tutti gli assoluti filosofici che non fossero la singolarità isolata e quasi tribale visibile ancora oggi, in un movimento di pensiero libertario che ha teorizzato la disseminazione e la proliferazione delle differenze, approssimandosi alla decostruzione complessiva dei fondamenti della tradizione filosofica. Su una dotazione di senso egualitaria ha così prevalso la superficie dispersa. Sul piano politico questo è progressivamente divenuto l’ideale regolativo guida ma anche l’obiettivo pragmatico da conseguire.
Leggi tutto
Eros Barone: “Ciò che sta dietro il denaro”
![]()
“Ciò che sta dietro il denaro”
Ancora una postilla sulla Ciociara di Moravia
di Eros Barone
 La realtà vera, nei suoi
complessi rapporti che
la legano alla finzione, si dischiude solo a una coscienza
sviluppata, che non è più in sé, ma è per sé e per gli
altri.
La realtà vera, nei suoi
complessi rapporti che
la legano alla finzione, si dischiude solo a una coscienza
sviluppata, che non è più in sé, ma è per sé e per gli
altri.
György Lukács
-
1. Forza dialettica e oggettività del “realismo critico”
Le pagine centrali della Ciociara sono quelle più vicine alla diretta esperienza dell’autore. 1 E fra le pagine più belle perché più vere vi sono quelle dedicate alle riflessioni sulla natura e sugli scopi della guerra, uno ‘specimen’ delle quali si è scelto qui di riprodurre attraverso la figura e la vicenda di Tommasino, cioè di un personaggio legato alla monomania del negozio e, come accadeva in tempo di guerra, alla pratica della borsa nera: un personaggio quindi ferreamente condizionato dal feticismo del denaro e che pagherà con la perdita del senno e della vita la scoperta di “ciò che sta dietro il denaro”. Si tratterà allora, per un verso, della scoperta di ciò che costituisce la vera sostanza di quell’apparenza spettrale, ossia nel caso la macchina bellica, e, per un altro verso, del fatto che la merce non potrà mai sfamare il mondo, che è proprio quanto dovrà constatare amaramente a sue spese la moglie di Tommasino.
E qui Moravia, ritrovando, potenziata ‘in rebus ipsis’ dalla lezione del marxismo e del leninismo, la forza morale dello scrittore “agro e giansenista” che egli era stato nella sua giovinezza, 2 esprime una piena ed icastica consapevolezza di quale sia la realtà retrostante alla forma-denaro e alla forma-merce, ossia il nocciolo sanguinoso e distruttivo della lotta per il profitto capitalistico e per la supremazia territoriale, la cui logica – suggerisce l’autore – si esplica in tutta la sua dirompente violenza (il bombardamento a tappeto serve, innanzitutto, a terrorizzare la popolazione civile, incrinandone il consenso al governo esistente) nella guerra inter-imperialistica e nelle contrapposte occupazioni militari (quella tedesca che sarà responsabile del sequestro e dell’uccisione di Michele, quella anglo-franco-americana che sarà responsabile dello stupro di Rosetta).
Leggi tutto
Thomas Fazi: Franco CFA
Franco CFA
Tutto quello che avreste sempre voluto sapere e non avete mai osato chiedere
di Thomas Fazi
 Franco CFA. Fino a poco tempo fa
queste due parole non avrebbero significato un granché per la
maggior parte
degli italiani. Oggi, invece, il termine è entrato nel
dibattito pubblico anche da noi, grazie alle dichiarazioni di
alcuni noti politici
italiani, che hanno scatenato un’aspra crisi diplomatica tra
Roma e Parigi. Dunque, chi segue la cronaca politica sa
probabilmente che il franco
CFA è una valuta utilizzata da una serie di paesi africani e
soggetta alla tutela più o meno esplicita e più o meno
disinteressata – a seconda dello schieramento del dibattito a
cui si è scelto di credere – della Francia. Tuttavia per i più
la questione rimane a dir poco fumosa. Vediamo dunque di fare
chiarezza una volta per tutte.
Franco CFA. Fino a poco tempo fa
queste due parole non avrebbero significato un granché per la
maggior parte
degli italiani. Oggi, invece, il termine è entrato nel
dibattito pubblico anche da noi, grazie alle dichiarazioni di
alcuni noti politici
italiani, che hanno scatenato un’aspra crisi diplomatica tra
Roma e Parigi. Dunque, chi segue la cronaca politica sa
probabilmente che il franco
CFA è una valuta utilizzata da una serie di paesi africani e
soggetta alla tutela più o meno esplicita e più o meno
disinteressata – a seconda dello schieramento del dibattito a
cui si è scelto di credere – della Francia. Tuttavia per i più
la questione rimane a dir poco fumosa. Vediamo dunque di fare
chiarezza una volta per tutte.
Tanto per cominciare, quando parliamo di franco CFA, parliamo in realtà di due unioni monetarie: la Comunità economica e monetaria dell’Africa centrale (CEMAC), di cui fanno parte il Camerun, il Gabon, il Ciad, la Guinea Equatoriale, la Repubblica Centrafricana e la Repubblica del Congo; e l’Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA), che comprende il Benin, il Burkina Faso, la Costa d’Avorio, la Guinea-Bissau, il Mali, il Niger, il Senegal e il Togo.
Queste due unioni monetarie usano due franchi CFA distinti, che però condividono lo stesso acronimo: per il franco della zona CEMAC, CFA sta per “Cooperazione finanziaria in Africa centrale”, mentre per il franco dell’EUMOA sta per “Comunità finanziaria africana”. Ad ogni modo, questi due franchi CFA funzionano esattamente alla stessa maniera e sono ancorati all’euro con la stessa parità di cambio. Insieme a un quindicesimo Stato – l’Unione delle Comore, che usa un franco distinto ma soggetto alle stesse regole – formano la cosiddetta “zona del franco”. Complessivamente, più di centosessantadue milioni di persone usano i due franchi CFA (più il franco delle Comore), secondo i dati ONU del 2015.
Leggi tutto
Claudio Conti: Il tabu del debito pubblico nasconde chi ci guadagna
Il tabu del debito pubblico nasconde chi ci guadagna
di Claudio Conti
 Il debito
pubblico, spiegava Marx, è l’unica cosa davvero comune a tutta
la popolazione in una
società divisa in classi. Come per ogni “bene comune”, però –
per quanto “negativo” come il debito –
c’è sempre una modo per avvantaggiare alcuni a scapito di
altri.
Il debito
pubblico, spiegava Marx, è l’unica cosa davvero comune a tutta
la popolazione in una
società divisa in classi. Come per ogni “bene comune”, però –
per quanto “negativo” come il debito –
c’è sempre una modo per avvantaggiare alcuni a scapito di
altri.
Fuori da ogni disputa ideologica – che è “falsa coscienza”, ovvero “narrazione” fasulla per coprire il reale – occorre guardare a questo debito con occhi decisamente diversi da quelli totalmente strabici di un Cottarelli, Giannini, Alesina, Giavazzi, Monti e via cantando sulle note dell’austerità.
Un editoriale di Guido Salerno Aletta per Milano Finanza aiuta – come spesso ci accade – a chiarire alcuni dettagli che svuotano di senso quella narrazione, illuminando su altre soluzioni. Quelle proposte da Carlo Messina, amministratore delegato di Banca Intesa, e riprese da questo editoriale, non sono ovviamente le nostre. Ma mostrano quasi fisicamente che si possono seguire altre strade anche restando in ambito totalmente capitalistico.
Ma, se si possono seguire altre persino garantendo al mondo del business di continuare a far soldi, allora sono possibili anche starde che portano da tutt’altra parte. In entrambi i casi – ed è questo l’interessante – viene distrutta la narrazione per cui “non c’è alternativa”. Un’autentica tortura mediatica (pensiamo solo alla quantità di volte che Carlo Cottarelli viene invitato da Fabio Fazio o Paolo Floris…) che ha anestetizzato le capacità critiche soprattutto della cosiddtta “sinistra”, incapace oggi persino di articolare un pensiero senzato di fronte alla più devastante delle domande: “ma dove si trovano i soldi?”.
La strada dell’a.d. di Banca Intesa, per esempio, rivela che non solo “i soldi ci sono”, e in misura persino eccessiva rispetto allo scopo di abbattere il debito pubblico, ma soprattutto che quella domanda retorica da talk show nasconde gli interessi reali che hanno guadagnato ricchezze colossali:
Leggi tutto
Sergio Cesaratto: La globalizzazione e l’economia
La globalizzazione e l’economia
intervista a Sergio Cesaratto
 Sergio Cesaratto,
professore ordinario nel Dipartimento di Economia Politica e
statistica
dell’Università degli Studi di Siena, da sempre economista
eterodosso e ormai punto di riferimento della divulgazione
dell’economia
classica in Italia. Ha recentemente pubblicato due
importanti libri che hanno fatto molto successo: Chi non rispetta le regole? del
2018 e Sei lezioni di
Economia del 2016, dimostrandosi ancora una
volta come importante voce critica della sinistra e dei
processi di involuzione che la
stanno attraversando.
Sergio Cesaratto,
professore ordinario nel Dipartimento di Economia Politica e
statistica
dell’Università degli Studi di Siena, da sempre economista
eterodosso e ormai punto di riferimento della divulgazione
dell’economia
classica in Italia. Ha recentemente pubblicato due
importanti libri che hanno fatto molto successo: Chi non rispetta le regole? del
2018 e Sei lezioni di
Economia del 2016, dimostrandosi ancora una
volta come importante voce critica della sinistra e dei
processi di involuzione che la
stanno attraversando.
* * * *
Osservatorio Globalizzazione: Ormai a quasi trent’anni dall’inizio del processo di globalizzazione in senso neoliberale, possiamo provare a tracciarne un bilancio, lei cosa ne pensa?
Sergio Cesaratto: Per molti versi il processo di globalizzazione era ineludibile con l’entrata nel capitalismo e nel mercato mondiale di molti Paesi che erano un tempo chiamati del Terzo Mondo. L’espansione dell’esercito industriale di riserva anche attraverso la delocalizzazione delle produzioni in quei Paesi, ha tuttavia comportato l’indebolimento del movimento operaio e delle conquiste nei Paesi di più antica industrializzazione. Quindi il bilancio per noi è negativo sul piano dei diritti sociali.Simmetricamente all’esplosione della globalizzazione vi è stato il crollo del modello socialista. Questo, forse più della globalizzazione, ha fatto crollare l’idea stessa di una alternativa al capitalismo – in un certo senso la traiettoria cinese del capitalismo guidato dallo Stato, esperienza peraltro non nuova, può essere vista anche in questa luce. La crisi verticale della sinistra è tutta qui. Senza un modello socio-economico alternativo, rimangono solo le utopie, le belle parole, i diritti civili, mentre le masse popolari guardano altrove, purtroppo a destra. E questo è naturalmente paradossale, perché a destra non c’è nessuna vera alternativa, anzi.
Leggi tutto
Italo Nobile: Brexit and Exit
Brexit and Exit
di Italo Nobile*
 Abituato a fare appelli a Capi di Stato, Sting
ha esortato il suo paese a
ripensarci sulla Brexit1.
E’ la notizia più frivola su un processo che, dopo le
incertezze ed un dibattito parlamentare fatto di bocciature e
rinvii2, è stato da più
parti derubricato a pasticcio3 e ad errore. Perciò
è necessario analizzarlo un po’ meglio cercando di restituire
ad esso lo spessore che merita.
Abituato a fare appelli a Capi di Stato, Sting
ha esortato il suo paese a
ripensarci sulla Brexit1.
E’ la notizia più frivola su un processo che, dopo le
incertezze ed un dibattito parlamentare fatto di bocciature e
rinvii2, è stato da più
parti derubricato a pasticcio3 e ad errore. Perciò
è necessario analizzarlo un po’ meglio cercando di restituire
ad esso lo spessore che merita.
L’Unione Europea e l’euro sono le forme assunte negli ultimi decenni nel nostro continente dalle politiche neoliberiste, per quanto queste ultime si fossero già parzialmente affermate a livello nazionale in molte parti del mondo negli anni Ottanta (Usa, Gb ma anche Francia e Italia) e Novanta (paesi dell’Est Europa e poi Russia).
La crisi del modello di accumulazione capitalistico degli anni Settanta5 ha portato alla globalizzazione (intesa come strategia liberoscambista di abbattimento delle barriere alla circolazione mondiale di merci e di capitali)6 e dunque ai processi di riorganizzazione capitalistica volti a risolvere (con implicazioni contraddittorie) le crisi mediante l’espansione industriale e/o finanziaria all’esterno e la riduzione del salario e del welfare all’interno7.
Ciò accelerava sia la competizione tra Stati e anche tra intere aree economiche8 sia la creazione di macroregioni che garantissero una sufficiente centralizzazione di capitale per competere al meglio. Non è un caso che la difficile costruzione dell’Unione Europea si è resa necessaria tra nazioni che erano o sconfitte nell’ultima guerra o vincitrici grazie all’intervento di una nazione più forte. Non è un caso che tale costruzione si sia accelerata quando l’unificazione tedesca rischiava di destabilizzarla9 e quando è stato chiaro che il tempo avrebbe giocato a sfavore delle nazioni europee isolatamente considerate.
Non dimentichiamo che la quota del commercio mondiale detenuta dalle singole nazioni europee è costantemente diminuita nel corso di questi anni (la grande Germania è passata dal 9,43% del 1994 al 7,48% del 2014, la Francia dal 7,06 al 3,97, il Regno Unito dal 6,43 al 4,01, l’Italia dal 4,63 al 2,65, i Paesi Bassi e la Spagna sono rimasti allo stesso livello e cioè 3,9 e 1,9)10.
Leggi tutto
Roberto Paura: Benvenuti nel reale antropocene: fase due
Benvenuti nel reale antropocene: fase due
di Roberto Paura
 Il
fondatore del transumanesimo, Max More, pubblicò online, nel
1999, una celebre
Lettera a Madre Natura. Con un tono più ironico e
senza dubbio più diretto di quello usato da Giacomo Leopardi
nel rivolgersi
alla stessa interlocutrice un paio di secoli prima, More
osserva che, pur avendoci la Natura fornito una serie di doni
importanti (“il massimo
controllo del pianeta”, “un’aspettativa di vita fra le più
lunghe del regno animale”, “un cervello
complesso”), al tempo stesso essa si è dimostrata avara su
numerosi aspetti:
Il
fondatore del transumanesimo, Max More, pubblicò online, nel
1999, una celebre
Lettera a Madre Natura. Con un tono più ironico e
senza dubbio più diretto di quello usato da Giacomo Leopardi
nel rivolgersi
alla stessa interlocutrice un paio di secoli prima, More
osserva che, pur avendoci la Natura fornito una serie di doni
importanti (“il massimo
controllo del pianeta”, “un’aspettativa di vita fra le più
lunghe del regno animale”, “un cervello
complesso”), al tempo stesso essa si è dimostrata avara su
numerosi aspetti:
“Ci hai creati vulnerabili alle malattie e alle ferite. Ci hai obbligati a invecchiare e a morire – proprio quando cominciamo a diventare saggi. Sei stata un po’ avara nel darci consapevolezza dei nostri processi somatici, cognitivi ed emotivi. Sei stata poco generosa con noi, donando sensi più raffinati ad altri animali. Possiamo funzionare solo in certe specifiche condizioni ambientali. Ci hai dato una memoria limitata e scarso controllo sui nostri istinti tribali e xenofobici” (More, 1999).
Le accuse di More sono senz’altro giuste, ma d’altronde, a pensarci bene, cosa potrebbero dire gli altri animali, se potessero esprimere qualche critica a Madre Natura? Di sicuro, tra tutti, siamo stati i più fortunati, gli unici a essersi evoluti fino a raggiungere un’autocoscienza complessa e una capacità di modificare noi stessi e il resto della natura. Pensatori come Thomas Ligotti, così come numerosi filosofi del passato, hanno messo in dubbio il fatto che la nostra intelligenza sia un beneficio, dato che comporta, come effetto collaterale, una dose di preoccupazioni non indifferenti. Non è nemmeno da escludersi che molti animali possano considerare i nostri presunti “benefici” come “maledizioni”, qualora potessero spingersi a un simile livello di consapevolezza. Ma, secondo la visione del transumanesimo, che è poi la filosofia alla base dell’accelerazione tecnologica dei nostri tempi, il nostro compito dovrebbe essere quello di potenziare l’essere umano per affrancarlo dal suo determinismo biologico, attraverso la tecnologia.
Leggi tutto
Hits 3470
Hits 3142
Hits 2962
Hits 2729
Hits 2634
Hits 2561
Hits 2441
Hits 2377
Hits 2156
Hits 2046
tonino

Carlo Formenti: Su una campagna elettorale a senso unico
Su una campagna elettorale a senso unico
di Carlo Formenti
 A una settimana dal
voto la campagna elettorale tocca vertici di isteria
parossistici. Il raduno “sovranista”
internazionale indetto da Salvini in Piazza Duomo ha offerto
lo spunto per mettere nello stesso sacco tutte le critiche
radicali nei confronti delle
politiche antipopolari dell’Unione Europea, etichettandole
come neofasciste, razziste, xenofobe, sessiste e quant’altro.
Giornalisti,
opinionisti, intellettuali, “esperti” di economia e politica
internazionale, ex presidenti e presidenti in carica,
esponenti di tutti i
partiti di destra “moderata”, centro e sinistra si sono
mobilitati per invocare la Santa Alleanza contro il pericolo
fascista e chiamare
l’elettorato a respingerlo votando compatto per i partiti
europeisti. Prima di spendere due parole sulla consistenza
reale di questa presunta
minaccia, vorrei analizzare il fondo di Ferruccio de Bortoli
sul Corriere del 19 maggio, per poi accennare a un passaggio
del discorso di Salvini e a
una battuta del leader dell’M5S Di Maio.
A una settimana dal
voto la campagna elettorale tocca vertici di isteria
parossistici. Il raduno “sovranista”
internazionale indetto da Salvini in Piazza Duomo ha offerto
lo spunto per mettere nello stesso sacco tutte le critiche
radicali nei confronti delle
politiche antipopolari dell’Unione Europea, etichettandole
come neofasciste, razziste, xenofobe, sessiste e quant’altro.
Giornalisti,
opinionisti, intellettuali, “esperti” di economia e politica
internazionale, ex presidenti e presidenti in carica,
esponenti di tutti i
partiti di destra “moderata”, centro e sinistra si sono
mobilitati per invocare la Santa Alleanza contro il pericolo
fascista e chiamare
l’elettorato a respingerlo votando compatto per i partiti
europeisti. Prima di spendere due parole sulla consistenza
reale di questa presunta
minaccia, vorrei analizzare il fondo di Ferruccio de Bortoli
sul Corriere del 19 maggio, per poi accennare a un passaggio
del discorso di Salvini e a
una battuta del leader dell’M5S Di Maio.
De Bortoli esordisce notando che in questa campagna di tutto si discute meno che di Europa, dopodiché – fatta la concessione di rito al “riemergere dei fantasmi totalitari del Novecento che solo una Ue più forte può esorcizzare” – ci spiega quali sarebbero i veri temi da affrontare: sottolinea la contraddizione fra Salvini e i suoi alleati stranieri, i quali, in caso di vittoria, si guarderebbero bene dall’accoglierne le richieste in materia di ridistribuzione dei flussi migratori; respinge la “rappresentazione elettorale dell’Europa sorda, austera, a guida tedesca e cuore bancario” (peccato che non sia una “rappresentazione elettorale” ma il volto spietato di quell’Europa che ha ridotto in miseria il popolo greco per salvare gli interessi delle banche francotedesche); invita a non mandare a Bruxelles candidati “inesperti, inadeguati” (si sa che gli unici candidati esperti sono quelli che condividono i principi neoliberisti);
Leggi tutto
Stefano Garroni: Introduzione al Manifesto del Partito Comunista
Introduzione al Manifesto del Partito Comunista
di Stefano Garroni*
 Com'è ben noto Il
Manifesto fu scritto da Marx ed Engels su commissione
della Lega
dei comunisti, organizzazione londinese, che però
raccoglieva anche lavoratori di altri paesi e che aveva una
consistente rete di rapporti
internazionali.
Com'è ben noto Il
Manifesto fu scritto da Marx ed Engels su commissione
della Lega
dei comunisti, organizzazione londinese, che però
raccoglieva anche lavoratori di altri paesi e che aveva una
consistente rete di rapporti
internazionali.
Lo scopo dell'opuscolo - perché di questo si trattava - era di propagandare un unitario orientamento politico, che fosse, nello stesso tempo, capace di rinserrare le file dei più decisi e combattivi rivoluzionari europei, come anche di fornire a quell'orientamento uno spessore storico e teorico. Insomma, si trattava anche - e forse fondamentalmente - di organizzare un effettivo argine contro il dilagare, nel movimento rivoluzionario, di orientamenti utopistici, spesso costruiti su ispirazioni di tipo francamente religioso e, generalmente, tanto roboanti sul piano verbale, quanto inconcludenti su quello effettivamente pratico e politico.
Ricordiamo che tutta la vicenda si ambienta nel 1848, in un'epoca, dunque, ricca di fermenti rivoluzionari, ma pure caratterizzata ancora dal fatto che il movimento proletario e persino gli ambienti rivoluzionari più solidi, mancano di una propria autonomia teorica, non sanno discriminare adeguatamente tra le critiche alla società presente che esprimono i rimpianti delle classi tramontate; e quelle, invece, che rappresentano un nuovo punto di vista, legato al moderno proletariato di fabbrica.
È un'epoca, dunque, di incertezze teoriche, che si esprimono sia in oscillazioni politiche, sia nella proclamazioni di tesi francamente utopistiche e spesso "colorate" - lo ripeto - in senso religioso e sentimentale.
La battaglia per dare al movimento rivoluzionario un orientamento teorico diverso, che fosse fondato dal punto di vista critico-scientifico, già aveva visto nettamente impegnati sia Marx che Engels: l'incarico, dunque, ottenuto dalla Lega dei comunisti era anche una loro personale vittoria. Tuttavia, il compito assegnato era sempre - e solo - quello di scrivere un opuscolo agitatorio. Ricordare ciò può sembrare bizzarro, quasi si insistesse su un'ovvietà.
Leggi tutto
Anonimo: L’ascesa dell’Intelligenza Artificiale
![]()
L’ascesa dell’Intelligenza Artificiale
di Anonimo
 Il 15 e 16 maggio 2019
si terrà a Berlino la fiera annuale “RISE OF AI“
(L’ascesa dell’intelligenza artificiale). Si tratta della più
grande fiera per l’intelligenza artificiale (AI) in Europa.
Oltre alle aziende che operano per la ricerca e lo sviluppo di
AI, ci saranno anche rappresentanti politici che vogliono fare
della Germania il luogo
di sviluppo leader per AI. I politici hanno dichiarato
quest’anno come “l’Anno del l’AI“ e Berlino svolge un ruolo
importante in questo campo a livello mondiale. Questa è
un’altra ragione per affrontare questo attacco tecnologico
contro
l’autodeterminazione, in opposizione alle idee e alle
strutture di aziende leader, istituzioni e le loro masse
sacre. Un punto focale per tutti
coloro che vogliono interrompere il dominio, il controllo e
l’eteronomia. Verso “RISE DI AI“ e oltre.
Il 15 e 16 maggio 2019
si terrà a Berlino la fiera annuale “RISE OF AI“
(L’ascesa dell’intelligenza artificiale). Si tratta della più
grande fiera per l’intelligenza artificiale (AI) in Europa.
Oltre alle aziende che operano per la ricerca e lo sviluppo di
AI, ci saranno anche rappresentanti politici che vogliono fare
della Germania il luogo
di sviluppo leader per AI. I politici hanno dichiarato
quest’anno come “l’Anno del l’AI“ e Berlino svolge un ruolo
importante in questo campo a livello mondiale. Questa è
un’altra ragione per affrontare questo attacco tecnologico
contro
l’autodeterminazione, in opposizione alle idee e alle
strutture di aziende leader, istituzioni e le loro masse
sacre. Un punto focale per tutti
coloro che vogliono interrompere il dominio, il controllo e
l’eteronomia. Verso “RISE DI AI“ e oltre.
Comunque, cos’è l’AI?
Al giorno d’oggi, intelligenza artificiale è una parola d’ordine che attira l’attenzione di aziende start-up tecnologiche, investitori e simili. Nel corso degli anni è diventato una sorta di credenza magica proiettando i sogni e gli incubi sulle macchine che diventano intelligenti e sostituiscono le persone… In realtà, il termine “AI“ descrive molti modi diversi in cui i computer sono programmati (algoritmi) per produrre modelli e informazioni, fare scelte e decisioni.
Un particolare tipo di algoritmo “AI“ è diventato una delle nuove ammiraglie del capitalismo: gli algoritmi “Machine Learning“ (apprendimento automatico). Gli algoritmi di apprendimento automatico sono formati sulla base dei set di dati iniziali per determinare i modelli che saranno utilizzati ulteriormente per identificare e classificare oggetti, immagini, parole, comportamenti, ecc. Tali insiemi di dati di formazione di solito non sono oggetto di indagine e sono formati da persone in base ai loro pregiudizi esistenti. Ad esempio, le donne e le persone colpite dal razzismo sono molto meno presenti nei dati di formazione, in quanto sono spesso invisibili e privi di potere nella società.
Leggi tutto
Carlo Rovelli: La più bella delle teorie
La più bella delle teorie
di Carlo Rovelli
Il presente articolo è tratto da “Sette brevi lezioni di fisica” di Carlo Rovelli
Da ragazzo, Albert Einstein ha trascorso quasi un anno a bighellonare oziosamente. Era a Pavia, dove aveva raggiunto la famiglia, dopo avere abbandonato gli studi in Germania. Se non si perde tempo non si arriva da nessuna parte, fatto che spesso dimenticano i genitori degli adolescenti. Era l’inizio della rivoluzione industriale, e il padre, ingegnere, installava le prime centrali elettriche in Italia. Poi Albert si era iscritto all’Università di Zurigo e si era immerso nella fisica. Pochi anni dopo, nel 1905, aveva spedito tre articoli in un’unica busta alla principale rivista scientifica del tempo, gli «Annalen der Physik». Ciascuno dei tre valeva un Nobel. Il primo mostrava che gli atomi esistono davvero. Il secondo apriva la porta alla Meccanica dei Quanti, di cui spero di dire qualcosa in futuro su questa pagina. Il terzo presentava la Teoria della Relatività (oggi chiamata «relatività ristretta»), che chiarisce che il tempo non passa eguale per tutti: due gemelli si ritrovano di età diversa, se uno dei due ha viaggiato velocemente. Einstein diventa un fisico rinomato e riceve offerte di lavoro da diverse università. Ma qualcosa lo turba: la sua Teoria della Relatività non quadra con quanto sappiamo sulla gravità. Se ne accorge scrivendo un articolo di rassegna sulla nuova teoria, e si chiede se la vetusta e paludata «gravitazione universale» del grande padre Newton non debba essere riveduta anch’essa, per renderla compatibile con la nuova relatività.
Leggi tutto
Claudio Conti: Il gioco rischioso degli Stati Uniti in crisi
Il gioco rischioso degli Stati Uniti in crisi
di Claudio Conti
“S/globalizzare” l’economia non è un gioco da ragazzi. Né per cuori deboli. Se i consiglieri nazionalisti di Trump pensavano di poter imporre facilmente gli interessi statunitensi – ri-localizzare negli States una parte della produzione manifatturiera fuoriuscita negli anni d’oro del Wto, senza però perdere la centralità sui mercati finanziari – la realtà si sta incaricando di mostrare quanto quella pretesa fosse illusoria. E pericolosa.
La “guerra dei dazi” aperta contro la Cina (e la Germania, anche se ne ne parla meno) non è e non poteva essere un blitzkrieg. O meglio: come tutte le “guerre lampo” ha smesso di esser tale quando ha lasciato il tavolo degli “strateghi” per diventare scontro sul campo.
Abbiamo già scritto diverse volte su questo argomento, per cui ci limitiamo ad aggiornare sugli ultimi sviluppi, che stanno mettendo a dura prova anche gli analisti professionali dei giornali specializzati. Al punto che nella stessa testata – IlSole24Ore, per esempio – c’è chi ritiene che stiano vincendo i cinesi, e chi all’opposto vede in vantaggio gli americani.
Le guerre economiche, del resto, sono altrettanto complesse di quelle militari, e spesso le preparano. Ma se a darsele di santa ragione – per ora lavorando più di fioretto che di sciabola – sono due giganti, tutta la cristalleria del capitalismo attuale va in sofferenza.
Leggi tutto
Fabrizio Marchi: De Michelis, ideologo del “craxismo”
De Michelis, ideologo del “craxismo”
di Fabrizio Marchi
Quando qualcuno lascia questo mondo – a parte i casi di criminali o tiranni conclamati e riconosciuti – si tende in molti casi a celebrarlo oppure ad avere parole benevole nei suoi confronti, a dimenticare o alleggerire i suoi torti o i suoi difetti e a ricordare i suoi meriti e i suoi pregi. E in fondo è anche normale che ciò avvenga e non c’è nulla di male. Molto più utile però, a mio parere, è cercare di tracciare un profilo e un’analisi corretta del suo operato, specie quando si tratta di un uomo pubblico come ad esempio un leader politico.
E’ il caso di Gianni De Michelis, ex dirigente e ministro socialista, che è scomparso pochi giorni fa. Ho letto diversi commenti in questi giorni di miei amici e compagni socialisti, alcuni condivisibili, altri meno, però più o meno tutti ispirati a ricordare gli aspetti positivi (anche se non privi di forti accenti critici) della persona.
Mettendo, ovviamente, da parte il lato umano della vicenda (il rispetto nei confronti di chi viene a mancare è sempre doveroso, a parte i casi citati nell’incipit dell’articolo…), il mio giudizio (politico) sull’uomo politico De Michelis (quello umano non sono in grado di darlo non avendolo mai conosciuto di persona) è sicuramente negativo.
De Michelis è stato uno degli affossatori del socialismo italiano insieme al suo capo, Bettino Craxi, di cui sposava in toto la linea e di cui anzi era uno dei principali ispiratori insieme a Claudio Martelli anche se, ovviamente, tra i due c’era un abisso.
Leggi tutto
Gian Marco Martignoni: Lega: quanto scheletri nell'armadio
Lega: quanto scheletri nell'armadio
di Gian Marco Martignoni
Gli indici di lettura della carta stampata nel nostro Paese sono sempre stati molto inferiori rispetto alla media europea. Ora, dopo la crisi economica sviluppatasi nel 2008 e l’esplosione dei social network, il numero delle copie vendute si è praticamente dimezzato, con i riflessi che tutto ciò determina rispetto alla formazione dell’opinione pubblica. Nonostante questo quadro disarmante, i giornalisti che mantengono la schiena diritta sono più che invisi agli esponenti del governo giallo-verde, tanto che il pluralismo informativo rischia di essere azzerato . Segno che quando i giornalisti fanno il loro mestiere – come nel caso delle inchieste promosse dal settimanale “L’Espresso” a proposito della Lega – il materiale che riescono a raccogliere è talmente probante, che per la magistratura si aprono nuove piste di indagine.
Che la Lega avesse scheletri nell’armadio era noto, dopo la vicenda che aveva investito nel 2012 , per appropriazione indebita di denaro pubblico, Umberto Bossi, il tesoriere Francesco Belsito e i colletti bianchi legati ai clan della ‘Ndrangheta. Ora però l’ottimo ed esplosivo «Il Libro Nero della Lega» di Giovanni Tizian e Stefano Vergine (Laterza: pag 318, euro 18 ) – in tre succosi capitoli, a cui è acclusa una sbalorditiva documentazione – affonda ulteriormente i colpi, evidenziando alcune rilevanti novità che gradualmente stanno diventando sempre più di dominio pubblico.
Leggi tutto
Alessandra Ciattini: Vitalità della riflessione marxiana e marxista sull’ideologia
Vitalità della riflessione marxiana e marxista sull’ideologia
di Alessandra Ciattini*
 Premessa
Premessa
In un mondo, nel quale a detta di alcuni, stiamo assistendo al trionfo della cosiddetta post-verità, in cui siamo intrisi sino alle midolla di ideologie invisibili che si presentano come l’effettiva rappresentazione dei fatti, in cui il paese più potente del mondo legge la storia attuale e futura come il dispiegamento del “secolo americano”, in cui trova spazio l’estremismo islamico, in cui risorge il populismo neofascista e neonazista, non possiamo in nessun modo accantonare la nozione di ideologia.
E ciò soprattutto perché si tratta di un’idea pericolosa, come dice il titolo italiano della traduzione del libro dello studioso britannico Terry Eagleton Ideologia. Storia e critica di un’idea pericolosa (2007) (il titolo in inglese invece è Ideology. An Introduction, 1991)[1]. Idea pericolosa perché stabilisce una correlazione, complessa e articolata, tra certe idee e una certa struttura di potere. Oltre a queste considerazioni teniamo in conto che, dopo la caduta del muro di Berlino, alcuni non sprovveduti, cui i mass media hanno dato notevole e continua risonanza, hanno anche osato parlare di fine delle ideologie, evidentemente ignorando che la verità è solo un processo interminabile di paziente studio e ricerca, sul cui sfondo sta il nostro modo di concepire la vita sociale.
Un’altra considerazione che ci consiglia di tornare a riflettere sull’ideologia e le sue molteplici valenze è rappresentata dal fatto che costituisce un nodo problematico del pensiero marxista, sul quale molti si sono divisi, accusandosi di riproporre con l’opposizione struttura / sovrastruttura l’antico dualismo positivistico, di ricadere nel volgare economicismo per l’uso della categoria del riflesso o di finire nell’idealismo per l’accento posto con enfasi sulle idee rispetto alla dimensione materiale.
Ispirandosi a Eagleton, anche due autori latinoamericani sottolineano la necessità di tornare a riflettere sulla nozione di ideologia, la quale a loro parere rappresenta
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Antifascismo come arma di distrazione di massa?.......
Antifascismo come arma di distrazione di massa?.......
di Fulvio Grimaldi
 «Quando i nazisti presero i comunisti,/ io non
dissi nulla/ perché non ero comunista./ Quando rinchiusero
i socialdemocratici/ io non dissi nulla/ perché non ero
socialdemocratico./
Quando presero i sindacalisti,/ io non dissi nulla/ perché
non ero sindacalista./ Poi presero gli ebrei,/ e io non
dissi nulla/ perché
non ero ebreo./ Poi vennero a prendere me./ E non era
rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa» (Martin
Niemoller, pastore protestante. Testo originale, poi
variamente riscritto, erroneamente
attribuito a Bertold Brecht)
«Quando i nazisti presero i comunisti,/ io non
dissi nulla/ perché non ero comunista./ Quando rinchiusero
i socialdemocratici/ io non dissi nulla/ perché non ero
socialdemocratico./
Quando presero i sindacalisti,/ io non dissi nulla/ perché
non ero sindacalista./ Poi presero gli ebrei,/ e io non
dissi nulla/ perché
non ero ebreo./ Poi vennero a prendere me./ E non era
rimasto più nessuno che potesse dire qualcosa» (Martin
Niemoller, pastore protestante. Testo originale, poi
variamente riscritto, erroneamente
attribuito a Bertold Brecht)
https://www.youtube.com/watch?v=94ZJNnYUVQ0 (saltate l’annuncio)
Polacchi e Conte fedeli alle linee. Di Mussolini e Guaidò
Francesco Polacchi, casa editrice Altaforte: “L’antifascismo è il male d’Italia”. Errore. Il male d’Italia è l’antifascismo strumentale, di copertura, arma di distrazione di massa che occulta il totalitarismo post- e neofascista della globalizzazione finanzcapitalista di guerra e di sanzioni.
Il fondo l’abbiamo raggiunto da tempo, lo si sa. Ma fino a che punto noi si sia scavato ci è ancora poco chiaro. Un indizio ce lo dà Matteo Salvini, vicepremier e ministro dell’Interno, tramutatosi in imbonitore tv da far rosicare Vanna Marchi (“Vincisalvini”), per rastrellare qualcuno disposto a farsi un selfie con la sua protuberanza ventrale. Un altro, più in basso se possibile, ce lo spara, con inusitata violenza per un fan di Padre Pio (che per l’appunto, pur santificato dal Bergoglio, era valido picchiatore squadrista di consiglieri comunali socialisti), il premier Conte. Mandando in frantumi la prima presa di posizione dignitosa e autonoma dell’Italia serva e di dolore ostello (non donna di provincie ma bordello) dall’isolata bravata di Craxi a Sigonella (rifiuto di consegnare il palestinese ai Marines), il premier ha inserito il suo governo nella schiera di coloro a cui il padrino statunitense ha ordinato di farsi gangster nei confronti del diritto internazionale, nazionale, domestico, di condominio, umano.
Leggi tutto
Mattia Galeotti: Ripoliticizzare le scienze
Ripoliticizzare le scienze
di Mattia Galeotti
 Dopo anni
di contrapposizione tra scienza e anti-scienza, la questione
ambientale ha
invertito i ruoli sottoponendo i governi a una questione di
verità. Ciò che serve è frammentare il monolite della Scienza
nei
tanti (e conflittuali) sforzi scientifici
Dopo anni
di contrapposizione tra scienza e anti-scienza, la questione
ambientale ha
invertito i ruoli sottoponendo i governi a una questione di
verità. Ciò che serve è frammentare il monolite della Scienza
nei
tanti (e conflittuali) sforzi scientifici
Il tema scientifico è diventato sempre più centrale negli immaginari politici degli ultimi anni. Se per lungo tempo abbiamo visto una contrapposizione che ruotava attorno alla dicotomia tra scienza e anti-scienza, negli ultimi mesi la questione ambientale ha fatto irruzione nel dibattito proponendo una sorta di inversione dei ruoli: sono le popolazioni mobilitate che sottopongono una questione di verità inaggirabile ai governanti. Nel contesto italiano una anomalia si era già prodotta con la firma di Beppe Grillo sul “Patto Trasversale per la Scienza” di Burioni: quelli che sembravano due schieramenti opposti – un leader NoVax e un prof famoso per la frase «la scienza non è democratica» – si sono trovati di fatto alleati senza che questo creasse scompensi politici. Per questo è necessario decostruire l’immaginario del “partito dell’ignoranza” contrapposto alla verità scientifica, e azzardare un’altra lettura.
Una società costruisce innovazione tecnica e analitica in maniera condivisa, ma oggi, quando parliamo di scienza, nominiamo qualcosa di più strutturale: la catena di legittimazione dei saperi attraverso cui uno Stato (o una comunità di Stati) prende le sue decisioni. Si tratta quindi, per lo Stato, di governare ciò che si intende come “progresso”, intercettando i comportamenti individuali e collettivi, i linguaggi e i desideri. Definendo attraverso questa idea di progresso la comunità dei governati: la popolazione. Questa idea governamentale della scienza ha il suo rovescio nella realtà storica delle pratiche scientifiche: linguaggi e gesti che permettono una presa sul mondo senza mai contenerlo, senza cioè che si risolva una volta per tutte la questione, ma lasciando sempre uno spazio alle rotture del punto di vista.
Leggi tutto
Alberto Benzoni: “Sbarrare la strada”? No, grazie
“Sbarrare la strada”? No, grazie
di Alberto Benzoni
Noi, e quando dico noi parlo degli elettori della sinistra radicale, siamo oggetto di un appello che, con l’avvicinarsi del 26 maggio, sta diventando sempre più affannoso e pressante. Occorre “sbarrare la strada ai populisti/sovranisti”; e per farlo, bisogna votare Pd.
Senza offesa, anzi ringraziandovi per il pensiero, è un invito che non possiamo accogliere. E per una serie di ragioni che Vi esponiamo brevemente.
La prima e fondamentale è che, nel Vostro appello, mancano, anzi sono tenute all’oscuro sia la natura dei buoni che quella dei cattivi sia, soprattutto, la materia del contendere. E non a caso.
Tra i buoni, in nome dei quali siamo invitati alla resistenza, accanto a Zingaretti ci sono i sacerdoti del liberismo e dell’austerità di Bruxelles, i governi europei, Macron, tutto l’establishment interno e internazionale. Tutte persone rispettabili per carità; ma anche cultori, tutti insieme appassionatamente, di politiche che, bloccando lo sviluppo e alimentando le ingiustizie e le guerre tra poveri, hanno aperto una strada, che dico, un’autostrada alla protesta popolare. Mentre, nello specifico, la sinistra italiana, cui il Pd, almeno formalmente si richiama, con la sua cieca adesione a queste politiche, ha fatto si che i “cattivi”avessero addirittura la maggioranza dei consensi. Altro che sbarramento…
Leggi tutto
Sandro Iannaccone: Non esiste una realtà “oggettiva”
Non esiste una realtà “oggettiva”
di Sandro Iannaccone
Un articolo uscito su Wired, presenta l’ultimo affascinante esperimento di meccanica quantistica dedicato alla prova sperimentale del principio di indeterminazione di Heisemberg, secondo il quale lo sguardo dell’osservatore, in particolare l’attività di misurazione, modificano ciò che si sta guardando.
La realtà quantistica, spiega Rovelli intervistato in proposito, è sostanzialmente relazionale: ogni elemento esistente appartiene a due sistemi, non ad uno soltanto.
Prendete un pallone. Da calcio, da basket, da pallamano; non importa. Sparatelo con un cannone e riprendete la scena con telecamere ad altissima definizione. Ora riesaminate il video al computer – vi è concessa tutta la potenza computazionale di cui avete bisogno – e provate a determinare, istante per istante, posizione e velocità del pallone.
Se siete stati abbastanza accurati, riuscirete senza dubbio a portare a termine il processo di misura in modo più che soddisfacente: i numeri che otterrete coincideranno, con ottima approssimazione, con quelli previsti dalle equazioni dei modelli teorici che descrivono il moto del pallone.
E potete star certi che il pallone, con o senza telecamere, avrebbe percorso esattamente la stessa traiettoria con le medesime caratteristiche. In altre parole, e generalizzando: ai sistemi macroscopici poco importa chi li sta osservando, e come lo sta facendo.
Leggi tutto
Andrea Fumagalli: È Il rifiuto del lavoro che ci salverà!
È Il rifiuto del lavoro che ci salverà!
di Andrea Fumagalli
Premessa: queste osservazioni sono state sollecitate dalla lettura del contributo di Gianni Giovannelli, pubblicato su Effimera a inizio maggio 2019
Secondo i dati del governo e dell’Inps, al 1 maggio 2019, sono 1.016.000 i cittadini che hanno presentato la richiesta del cosiddetto Reddito di Cittadinanza (RdC), tra quelle compilate on line, sul sito governativo dedicato, e quelle presentate alle Poste o ai Caf. Ricordiamo che il Governo ha previsto stanziamenti per un totale di 1.300.000 domande. Secondo le stime dei tecnici le domande accolte saranno attorno al 70%, quindi 700 mila (poco più della meta, dunque) il che prevedrebbe un esborso complessivo minore di circa due miliardi di euro rispetto a quanto stanziato dal Governo.
Nella conversione del decreto n. 4-2019 nella legge 26-2019, 28 marzo 2019, nuovi vincoli si sono aggiunti. E ciò può spiegare al momento il minor numero di domande rispetto a quelle attese. Essi riguardano, in particolar modo, gli stranieri. Gli immigrati che vorranno accedere al RdC avranno ancora più ostacoli di quanto già previsto in sede di approvazione del Decreto-Legge. Costoro, infatti, dovranno certificare tramite la competente autorità dello Stato estero, il requisito reddituale e patrimoniale e la composizione del proprio nucleo familiare.
Leggi tutto
Mario Gangarossa: La libertà di pensiero
La libertà di pensiero
di Mario Gangarossa
La libertà di pensiero è proprio una bella cosa.
Ti permette di pensare tutto quello che vuoi. Qualsiasi cosa ti passi per la testa, qualsiasi composizione assumano gli scambi di informazioni fra i tuoi pochi o tanti neuroni attivi, qualsiasi idea, puoi ipotizzarla, rimuginarla, ponderarla.
La libertà di pensiero non è un diritto. Non c'è legge che possa limitarla. I limiti semmai nascono dal fatto che pensi ciò che sperimenti, non sei una monade isolata da un contesto sociale e da una miriade di relazioni che costituiscono il tuo mondo materiale. Un mondo materiale che si riflette inevitabilmente sull'idea che di quel mondo te ne fai.
Se poi il tuo libero pensiero è influenzato da altri "liberi pensatori" ben attrezzati a condurre la guerra delle idee, capaci di creare suggestioni e condizionamenti e di modificare la tua stessa percezione della realtà, se il mondo materiale è costruito su contrapposti interessi e su contrapposte visioni che a questi interessi rispondono, va da se che più che di libertà dovremmo parlare di "libertà condizionata".
Intanto e comunque, per pensare bisogna avere il tempo per farlo e gli strumenti che possano stimolare la capacità di pensare. Bisogna aver ben mangiato e non vivere una situazione di precarietà in cui il bisogno di lavorare diventa il principale, se non l'unico, interesse.
Leggi tutto
Hits 3509
Hits 3168
Hits 3001
Hits 2752
Hits 2699
Hits 2659
Hits 2579
Hits 2456
Hits 2412
Hits 2068
tonino

Marco Morra: Le lobby a Bruxelles. Il grande imbroglio del neoliberismo
Le lobby a Bruxelles. Il grande imbroglio del neoliberismo
di Marco Morra (Potere Al Popolo)
 Candidato della France Insoumise
alle prossime elezioni
europee, Gabriel Amard pubblica, nel 2014, Le grand trafic
néolibéral: les lobby en Europe1.
Il
pamphlet denuncia l’ingerenza del lobbismo nelle istituzioni
dell’Unione europea, facendo appello alla disobbedienza
sociale e politica
nei confronti dei trattati europei e di una élite dirigente i
cui membri agiscono spesso entro condizionamenti più o meno
vincolanti dei
grandi gruppi multinazionali e finanziari.
Candidato della France Insoumise
alle prossime elezioni
europee, Gabriel Amard pubblica, nel 2014, Le grand trafic
néolibéral: les lobby en Europe1.
Il
pamphlet denuncia l’ingerenza del lobbismo nelle istituzioni
dell’Unione europea, facendo appello alla disobbedienza
sociale e politica
nei confronti dei trattati europei e di una élite dirigente i
cui membri agiscono spesso entro condizionamenti più o meno
vincolanti dei
grandi gruppi multinazionali e finanziari.
Il libro arriva in Italia, per merito di Salvatore Prinzi, ed è presentato tra il 7 e il 10 maggio a Milano, Napoli, Roma, Firenze, nell’ambito di un ciclo d’incontri con Amard organizzati da Potere al popolo.
All’“ExOpg” di Napoli, il compagno che introduce l’incontro annuncia da subito una presentazione “fuori dalle righe”. Amard vuole mettere in pratica un metodo che ambisce a coinvolgere in prima persona i partecipanti, rifiutando il rapporto tradizionale tra il politico (l’autore) “portatore di verità” e il cittadino (il pubblico) “ricettore passivo”.
La presentazione inizia con un gioco: il photolanguage. Dopo aver disposto a terra delle fotografie, Amard chiede ai partecipanti di soffermarsi sull’immagine che preferiscono e di commentarla. Gli interventi riservano delle sorprese: qualcuno si confessa inquieto rispetto alla diffusione degli psicofarmaci, “utilizzati come anestetici per le sofferenze prodotte da condizioni frustranti di vita e di lavoro, mentre non si fa niente per cambiare la società che ci deprime”; qualcun’altro, invece, osservando l’immagine di una fontana, sostiene che l’acqua “è così fondamentale per la vita che è un delitto, un’assurdità far pagare qualcosa di cui non possiamo fare a meno per vivere”.
Interrogati sui possibili legami tra le lobby e gli oggetti fotografati, i partecipanti evocano, allora, le multinazionali del tabacco, il controllo monopolistico di sementi e fertilizzanti, le grandi catene di fast food.
Leggi tutto
coniarerivolta: Disciplinare le periferie: i fascisti a guardia dell’austerità
Disciplinare le periferie: i fascisti a guardia dell’austerità
di coniarerivolta
 Nel corso
dell’ultimo mese a Roma si sono avvicendati tre episodi
raccapriccianti di tentativo di ‘caccia allo straniero’
nell’ambito dei procedimenti di assegnazione delle case
popolari.
L’ultimo, più mediaticamente esposto, è stato quello del
quartiere della periferia est di Casal Bruciato dove
l’assegnazione
di una casa popolare ad una famiglia di etnia rom e
nazionalità bosniaca ha scatenato un indegno assedio
organizzato dai fascisti di CasaPound
che hanno tentato, peraltro con scarso successo, di impedire
l’accesso all’abitazione della suddetta famiglia,
strumentalizzando il malcontento dei residenti che, in quella
periferia come in
molte altre marginalità romane, versano in condizioni di
pressoché totale abbandono.
Nel corso
dell’ultimo mese a Roma si sono avvicendati tre episodi
raccapriccianti di tentativo di ‘caccia allo straniero’
nell’ambito dei procedimenti di assegnazione delle case
popolari.
L’ultimo, più mediaticamente esposto, è stato quello del
quartiere della periferia est di Casal Bruciato dove
l’assegnazione
di una casa popolare ad una famiglia di etnia rom e
nazionalità bosniaca ha scatenato un indegno assedio
organizzato dai fascisti di CasaPound
che hanno tentato, peraltro con scarso successo, di impedire
l’accesso all’abitazione della suddetta famiglia,
strumentalizzando il malcontento dei residenti che, in quella
periferia come in
molte altre marginalità romane, versano in condizioni di
pressoché totale abbandono.
Questi orribili episodi, oltre a dover mantenere sempre altissima l’attenzione sociale sul rischio di rigurgiti reazionari da parte gruppi organizzati di stampo neofascista, pronti a cavalcare le condizioni di immiserimento delle masse e proletarizzazione dei ceti medi, devono far riflettere anche e soprattutto sulle condizioni sociali da cui questa spaventosa brodaglia reazionaria trae linfa: le condizioni di territori flagellati dalle politiche di austerità che da molti anni devastano il già fragilissimo tessuto sociale delle periferie. Emblematico il caso di Roma, città ricattata da anni di procedure di rientro dal debito accumulato ed afflitta, oltre che da propri problemi di gestione atavici, da un decennio di durissime politiche incentrate su tagli draconiani dei servizi e aumento delle imposte locali.
In questo contesto, le sceneggiate della melma fascista sono il contrappunto di una partita che si gioca su altri tavoli, non troppo lontani da Casal Bruciato: proprio nelle ultime settimane, a causa di scaramucce all’interno della maggioranza gialloverde, si è infatti tornato a parlare del debito di Roma. Il luogo del contendere è stato il ‘Decreto Crescita’ entro cui si situano anche le misure relative al taglio del debito di Roma Capitale.
Leggi tutto
Beniamino Della Gala: Vogliamo tutto, o del coraggio d’immaginarsi compagni
Vogliamo tutto, o del coraggio d’immaginarsi compagni
di Beniamino Della Gala
Nanni Balestrini ha scritto il grande romanzo del lungo Sessantotto italiano. Ha raccontato la forza politica e l'epica dal basso di personaggi che da singoli diventano collettivi
 Sono passati da quando Bompiani pubblicò, a
cura di Aldo Nove,La Grande Rivolta (1999),
volume che
raccoglieva per la prima volta i tre romanzi politici
di Nanni Balestrini, composti tra gli anni Settanta e l’inizio
dei Novanta: Vogliamo tutto (1971),
Gli invisibili (1987),
L’editore (1989).
Prima grande
sistematizzazione in trilogia, in un ciclo epico, delle opere
del poeta milanese, ed esplicitazione di ciò che chiunque
avesse letto i romanzi
già aveva intuito: quello di Balestrini è stato il tentativo
coerente di una grande mitopoiesi dei movimenti del
Sessantotto; dapprima
nel vivo delle lotte e, in seguito, con l’amaro senno di poi
degli anni Ottanta (gli odiati «anni di merda»), senza perdere
in nessun caso né la rabbia né la forza di combattere su quel
campo minato di narrazioni per dare vita a una contro-storia.
Sono passati da quando Bompiani pubblicò, a
cura di Aldo Nove,La Grande Rivolta (1999),
volume che
raccoglieva per la prima volta i tre romanzi politici
di Nanni Balestrini, composti tra gli anni Settanta e l’inizio
dei Novanta: Vogliamo tutto (1971),
Gli invisibili (1987),
L’editore (1989).
Prima grande
sistematizzazione in trilogia, in un ciclo epico, delle opere
del poeta milanese, ed esplicitazione di ciò che chiunque
avesse letto i romanzi
già aveva intuito: quello di Balestrini è stato il tentativo
coerente di una grande mitopoiesi dei movimenti del
Sessantotto; dapprima
nel vivo delle lotte e, in seguito, con l’amaro senno di poi
degli anni Ottanta (gli odiati «anni di merda»), senza perdere
in nessun caso né la rabbia né la forza di combattere su quel
campo minato di narrazioni per dare vita a una contro-storia.
L’esordio politico, però – Vogliamo tutto: l’epopea di Alfonso, anonimo operaio-massa, guappo meridionale che, cercando al Nord la sua fetta della torta del boom economico, scopre la fabbrica, poi un istintivo rifiuto del lavoro, la lotta e la rivolta – mantiene ancora oggi dei caratteri di eccezionalità rivoluzionaria che forse vanno attenuandosi nelle opere successive, distaccate anche cronologicamente di più di un decennio. Per essere stato composto nel vivo delle lotte, appunto, e dunque per costituire un tentativo genuino di agit-prop attraverso una letteratura tanto screditata in quegli anni; e poi, grazie alle innovazioni formali, come la tecnica del cut-up per cui l’autore, registrata la viva voce degli operai della Fiat con il magnetofono, successivamente spezzettava e remixava in forma narrativa le frasi delle registrazioni per comporre un testo scritto.
Proporre Vogliamo tutto come grande romanzo del secondo Novecento – come il grande romanzo del lungo Sessantotto italiano – ha però in sé qualcosa di problematico. Nanni Balestrini qui scardina, corrode, ribalta dall’interno il romanzo.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Rand Corp: come abbattere la Russia
Rand Corp: come abbattere la Russia
di Manlio Dinucci
L’arte della guerra. Il piano elaborato dal più influente think tank Usa
Costringere l’avversario a estendersi eccessivamente per sbilanciarlo e abbatterlo: non è una mossa di judo ma il piano contro la Russia elaborato dalla Rand Corporation, il più influente think tank Usa che, con uno staff di migliaia di esperti, si presenta come la più affidabile fonte mondiale di intelligence e analisi politica per i governanti degli Stati uniti e i loro alleati. La Rand Corp. si vanta di aver contribuito a elaborare la strategia a lungo termine che permise agli Stati uniti di uscire vincitori dalla guerra fredda, costringendo l’Unione Sovietica a consumare le proprie risorse economiche nel confronto strategico. A questo modello si ispira il nuovo piano, Overextending and Unbalancing Russia, pubblicato dalla Rand.
Secondo i suoi analisti, la Russia resta un potente competitore degli Stati uniti in alcuni campi fondamentali. Per questo gli Usa devono perseguire, insieme ai loro alleati, una strategia complessiva a lungo termine che sfrutti le sue vulnerabilità. Vengono quindi analizzati vari modi per costringere la Russia a sbilanciarsi, indicando per ciascuno le probabilità di successo, i benefici, i costi e rischi per gli Usa. Gli analisti della Rand ritengono che la maggiore vulnerabilità della Russia sia quella economica, dovuta alla sua forte dipendenza dall’export di petrolio e gas, i cui introiti possono essere ridotti appesantendo le sanzioni e accrescendo l’export energetico Usa.
Leggi tutto
Claudio Conti: Google toglie Android a Huawei. Fine dell’informatica globale
Google toglie Android a Huawei. Fine dell’informatica globale
di Claudio Conti
S/globalizzare è la parola d’ordine che arriva da Washington. Se fin qui erano state minacce, adesso si passa ai fatti.
La “guerra dei dazi” aveva preparato il terrreno, anche se fin qui con conseguenze minime. La decisione di bandire Huawei dal mercato statutitense, invece, segna l’apertura ufficiale delle ostilità sul terreno industriale. E rompe l’unitarietà dei mercato tecnologico mondiale, forse la più evidente e popolare manifestazione empirica della “globalizzazione”.
L’ukaze di Donald Trump contro il colosso hi-tech cinese ha obbligato Google a bandire Huawei dai propri contratti di fornitura. Significa che i prossimi modelli di smartphone (ma il mercato riguarda comparti anche molto diversi e ancora più complessi) non potranno adottare il sistema operativo Android, creato proprio dalla società di Mountain View.
A cascata, non saranno disponibili per quei modelli tutte le app di fabbricazione Google, come Play Store, Gmail, YouTube, ecc. Di fatto, è la fine di un mondo, delle sue abitudini e di un immaginario comune a tutti. Già nei prossimi giorni il mercato consumer farà vedere le sue reazioni, con il prevedibile crollo delle vendite su tutti i marchi e tutti i modelli. Come si fa a spendere per un device se non si è sicuri che tra pochi mesi non diventerà inservibile?
Leggi tutto
Vox Populi: Roma, periferia e diritto alla casa
Roma, periferia e diritto alla casa
di Vox Populi
Torre Maura, Casalbruciato, Spin Time Labs sono tutti pezzi di un puzzle più grande che se assemblato permette di osservare un quadro d’insieme chiaro.
Gli elementi su cui riflettere sono numerosi ma vanno evidenziati per poter ragionare fuori dal tam tam mediatico che sfrutta certe vicende per poter allungare il brodo dei decotti talk-show che invitano sempre gli stessi personaggi: l’impresentabile del PD o piuttosto nobili che giocano a fare i gilet gialli.
Non si tratta solo banalmente di contrastare la xenofobia montante su cui soffiano le organizzazioni neofasciste.
Per capire come mai organizzazioni come CasaPound hanno un certo seguito in realtà come quelle di Torre Maura o Casalbruciato bisogna prima interrogarsi, e sarebbe bene farlo quanto prima, sul perché le organizzazioni politiche che teoricamente dovrebbero difendere e tutelare i ceti subalterni non svolgono più correttamente questo compito o le poche che lo fanno, penso all’Asia USB, sono ormai sempre più sole. Ricordiamo che USB non è un partito ma un sindacato e quello per cui dobbiamo oggi lottare è un movimento politico di classe capace di orientare correttamente anche le battaglie sindacali verso un orizzonte ben definito: il superamento di questo modo di produzione.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Europa: essere o non essere?
Europa: essere o non essere?
di Pierluigi Fagan
Stamane leggevo l’appello al voto de la Sinistra, contro le destre “nazionaliste, xenofobe, razziste, sessiste” che rischiano di minare il “sogno europeo” non meno di quanto già starebbe facendo la piega (piaga?) neoliberista. “Sogno europeo” è definito in rapporto ad una presunta paternità dell’idea da parte degli “antifascisti di Ventotene fin dal lontano 1941”. Quel “fin dal lontano” mi ricorda molto alcune etichette di marche o negozi inglesi “since …” dove la longevità del tempo fa garanzia di serietà. Allora, visto che siamo alla convocazione degli antenati, perché non il conte Kalergi il cui piano PanEuropa viene adesso radiografato a puntate dal da poco nato Osservatorio della Globalizzazione? Kelergi è addirittura “since 1922”. O perché non l’archeologia dei concetti fatta da Federico Chabod nel 1961 con il suo “Storia dell’idea di Europa” (Laterza)? Ma poi Kant ha mai davvero immaginato e scritto di una Europa unita, cosmopolita e pacificata? E l’Abbé de Saint-Pierre (1658-1743)? E cosa intendeva Victor Hugo proponendo la fatidica analogia de gli “Stati Uniti d’Europa” ed in che senso e contesto usò tale espressione Churchill? Cattaneo e Bakunin cosa intendevano con l’idea di Europa Unita? Einaudi che sembra l’unico che davvero s’era letto Kant (volete la pace in Europa? Facile, mettete in comune gli eserciti e così non avrete lo strumento per farvi guerra né tra voi, -né contro terzi visti che sarà molto improbabile vi metterete d’accordo per una intenzione comune in politica estera-) come si colloca?
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Elezioni UE. Sovranisti e sovranità, populisti e popolo
Elezioni UE. Sovranisti e sovranità, populisti e popolo
E chi ciurla nel manico
di Fulvio Grimaldi
 Cos’è l’UE e che farne
Cos’è l’UE e che farne
In vista delle elezioni europee, manifestazione di democrazia allestita dagli illusionisti Silvan e Forest, si moltiplicano i messaggi che mi chiedono per chi voto e anche per chi votare. Di questo, dopo.
Divertente il Fatto Quotidiano, quando sbertuccia gli ordini di servizio del Grande Fratello mimetizzati da stampa italiana (e occidentale tutta), meno divertente quando compra le sue penne, che dovrebbero illustrarci il mondo là fuori, negli store del Pentagono o dell’intelligence anglosassone. Divertentissimo quando ci squaderna in paginoni su paginoni le facce e i curricula dei candidati: una galleria degli orrori tra pregiudicati, condannati, inquisiti, cambia casacca, riciclati, mummificati: la faccia dell’establishment. E poi i sinistri ci fustigano perché ancora insistiamo sul concetto populista di una guerra tra popolo ed élite.
Certo il panorama dei concorrenti è affascinante. Barnum e il suo circo fanno la figura di un saggio di Terza elementare. C’è tutto un mondo di più o meno grassi o smilzi sopravvissuti al proprio disfacimento. La notte dei morti viventi gli fa un baffo. E quando non sono i guappi, malandrini, mariuoli, preti, camorristi (in senso largo) e busti di gesso dei partitoni gonfi, punzecchiati dagli scugnizzi, prima col referendum renziano del 2016, poi con il voto politico del 2018, sono i detriti di quelli che gli correvano appresso fingendo di volergli mettere il sale sulla coda, mentre si nutrivano delle briciole che ai primi cadevano dal desco. A dare un minimo di serietà alla competizione, ecco ai nastri di partenza una fauna variopinta di correttori di bozze, alcuni che contano di rianimarsi grazie al volenteroso bocca a bocca di qualche elettore inconsapevole, altri che si accontentano di vedersi presi sul serio dai cancellieri che li stampano sulle schede elettorali.
Leggi tutto
Angelo Zaccaria: Venezuela: no a golpe ed invasione militare
Venezuela: no a golpe ed invasione militare
Ma appoggiare Maduro “senza se e senza ma” proprio non si può
di Angelo Zaccaria
Con grande piacere e gratitudine vi propongo questo articolo inviatomi da Angelo Zaccaria, che si trova in Argentina e sul nostro sito ha scritto più volte di Venezuela. Buona lettura! [A.G.]
 Per me
scrivere sul e del Venezuela diventa sempre più difficile. Lo
é
perché pur avendoci trascorso in diverse permanenze quasi 9
mesi, non ci metto più piede da quasi 6 anni, e perché di
fronte alla
complessità raggiunta lì dalla situazione, scrivendone a
distanza si rischia di perdere dei pezzi importanti della
situazione concreta
sul terreno. Proverò lo stesso a fissare alcuni punti, aiutato
forse dal fatto che trovandomi in Argentina, si tratta di una
distanza relativa
che perlomeno apre squarci sulle differenti sensibilità con le
quali da quaggiù si guarda agli eventi in corso.
Per me
scrivere sul e del Venezuela diventa sempre più difficile. Lo
é
perché pur avendoci trascorso in diverse permanenze quasi 9
mesi, non ci metto più piede da quasi 6 anni, e perché di
fronte alla
complessità raggiunta lì dalla situazione, scrivendone a
distanza si rischia di perdere dei pezzi importanti della
situazione concreta
sul terreno. Proverò lo stesso a fissare alcuni punti, aiutato
forse dal fatto che trovandomi in Argentina, si tratta di una
distanza relativa
che perlomeno apre squarci sulle differenti sensibilità con le
quali da quaggiù si guarda agli eventi in corso.
Cominciamo da Juan Guaido’
Che quella da lui incarnata sia una strategia di tipo golpista, mi pare fuori di dubbio. Se non bastassero gli ossessivi richiami alla ribellione delle forze armate, si guardi coloro che ne sono, in nome di democrazia e diritti umani, i principali sponsor nella regione.
Cominciamo dalla Colombia di Ivan Duque. Secondo le stime più ottimistiche, nonostante gli accordi siglati con le Farc, nel solo 2018 in Colombia son stati assassinati quasi 160 attivisti e dirigenti politici e sociali di opposizione. Altre stime invece sempre per il solo 2018, portano questa cifra ad oltre 600. Può quindi un paese, che ancora oggi spicca nel mondo come un terrificante mattatoio di chi non é allineato al potere, ergersi a fustigatore del governo Venezuelano in nome della democrazia…? Direi di no.
Scarse anche le credenziali a riguardo esibite da due altri ”fari della democrazia” nel mondo, distintisi per gli attacchi a Maduro: gli Usa di Trump ed il Brasile di Jair Bolsonaro.
Infine guardiamo all’Argentina di Mauricio Macri, che mentre con una mano si atteggia a restauratore della democrazia in Venezuela, con l’altra promuove il consolidamento di uno stato di polizia nel suo paese, dove le brutali politiche neoliberali promosse dal suo governo, stentano ad imporsi a fronte di una energica e diffusa opposizione politica, sociale e sindacale.
Leggi tutto
Fabrizio Poggi: “La Sinistra” per riformare la UE, i comunisti contro UE e capitalismo
“La Sinistra” per riformare la UE, i comunisti contro UE e capitalismo
di Fabrizio Poggi
 Classi sociali; antagonismi di classe;
sfruttamento del lavoro salariato;
dittatura della borghesia. Lotta di classe; liberazione del
lavoro dal giogo del capitale; rivoluzione; eliminazione dei
rapporti sociali
capitalistici; dittatura del proletariato. Socialismo;
comunismo.
Classi sociali; antagonismi di classe;
sfruttamento del lavoro salariato;
dittatura della borghesia. Lotta di classe; liberazione del
lavoro dal giogo del capitale; rivoluzione; eliminazione dei
rapporti sociali
capitalistici; dittatura del proletariato. Socialismo;
comunismo.
Inutile cercare simili concetti nell'interminabile elenco di buoni propositi con cui il PRC chiama a votare per “La Sinistra” alle elezioni europee del 26 maggio. Inutile cercarveli, perché non ci sono nei programmi del PRC, con o senza elezioni europee.
La questione del voto del 26 maggio è quella che, al momento, incombe sulle scelte sia dei comunisti, sia della sinistra in generale. La questione dei punti presentati dal PRC per “La Sinistra”, in vista di quel voto, è quella che lega il momento contingente dell'atteggiamento dei comunisti nei confronti della “riformabilità” o meno della Unione Europea - che si esprime, tra l'altro, anche nella scelta di partecipare o meno al voto del 26 maggio e, se vi si partecipa, in che forma, con quale visione della UE stessa e con quali obiettivi – a quello più ampio del giudizio su tale “cartello” imperialista di potenze dal peso tra loro disomogeneo e, soprattutto, alla visione strategica del passaggio rivoluzionario dai rapporti sociali antagonistici del capitalismo al socialismo.
Lasciando per un momento in sospeso la questione della partecipazione o meno al voto per il Parlamento di un'istituzione per sua natura espressione del capitale monopolistico - l’Unione Europea, come detto nell'appello comune “per l'astensione attiva” lanciato da alcune organizzazioni comuniste, “non è riformabile a favore dei lavoratori e dei popoli, né si può “emendare”, perché è diretta dal grande capitale e dai centri di potere della finanza” - i punti (ben undici) presentati da “La Sinistra” annunciano il proposito di una “rifondazione democratica dell'Europa”, che “ponga alla sua base i diritti sociali, civili, di libertà, delle persone”, per sviluppare “tutte le forme di espressione e di democrazia diretta dei cittadini su scala europea”.
Leggi tutto
Giovanni Bruno: Ripensare Karl Marx e la lotta di classe, i nuovi movimenti reali
Ripensare Karl Marx e la lotta di classe, i nuovi movimenti reali
di Giovanni Bruno
 “Marx
201. Ripensare l’alternativa” è il titolo del bel
convegno, estremamente ricco e variegato, che si è svolto a
Pisa da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio. Si è trattato di una
tre giorni, con nove sessioni di discussione, organizzata
da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo e professore ordinario
dell’Università
di Pisa, e da Marcello Musto, uno tra i più significativi
studiosi attuali di Marx su scala internazionale: l’idea
fondamentale
è stata quella di ripercorrere e recuperare alcune definizioni
del pensiero di Marx, a partire da categorie e tematiche
fondamentali,
“depurandolo” dalle incrostazioni derivanti dalle
interpretazioni e dalle piegature storico-politiche
novecentesche dei molteplici
marxisti e marxismi, per tornare alle radici del suo pensiero.
L’altro aspetto che ha caratterizzato il convegno è la volontà
di
coniugare la dimensione politica con quella
teorico-scientifica, mettendo in relazione le analisi e la
visione della storia di Marx con alcuni della
variegata galassia dei movimenti e delle forme di resistenza
al dominio del capitale che si sono manifestate in questo
scorcio di inizio XXI
secolo.
“Marx
201. Ripensare l’alternativa” è il titolo del bel
convegno, estremamente ricco e variegato, che si è svolto a
Pisa da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio. Si è trattato di una
tre giorni, con nove sessioni di discussione, organizzata
da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo e professore ordinario
dell’Università
di Pisa, e da Marcello Musto, uno tra i più significativi
studiosi attuali di Marx su scala internazionale: l’idea
fondamentale
è stata quella di ripercorrere e recuperare alcune definizioni
del pensiero di Marx, a partire da categorie e tematiche
fondamentali,
“depurandolo” dalle incrostazioni derivanti dalle
interpretazioni e dalle piegature storico-politiche
novecentesche dei molteplici
marxisti e marxismi, per tornare alle radici del suo pensiero.
L’altro aspetto che ha caratterizzato il convegno è la volontà
di
coniugare la dimensione politica con quella
teorico-scientifica, mettendo in relazione le analisi e la
visione della storia di Marx con alcuni della
variegata galassia dei movimenti e delle forme di resistenza
al dominio del capitale che si sono manifestate in questo
scorcio di inizio XXI
secolo.
È in questo contesto che Alvaro Garcia Linera, intellettuale e sociologo impegnato nei movimenti guerriglieri boliviani, e oggi Vicepresidente della Bolivia di Evo Morales, nonché vera e propria eminenza grigia del governo boliviano e del MAS (Movimiento Al Socialismo), organizzazione con cui insieme a Morales ha vinto le elezioni nel 2005. Al suo attivo numerosi libri teorici e politici, tradotti in inglese ad attestare lo spessore internazionale del suo profilo di intellettuale di sinistra e marxista, tra cui Las Tensiones Creativas De La Revolución, La Potencia Plebeya, A Potência Plebeia. Ação Coletiva e Identidades Indígenas, Operárias e Populares na Bolívia.
L’ampia relazione di Linera, dal titolo: Marx en América Latina. Nuevos caminos al comunismo, ha sviluppato una riflessione sul pensiero rivoluzionario di Marx, a partire dalla sottolineatura della differenziazione tra la società dell’America Latina, a base prevalentemente contadina e rurale, rispetto alle società industriali come quella europea o nordamericana.
Leggi tutto
Sergio Cararo: Elezioni europee? Un sondaggio più pesante del solito
Elezioni europee? Un sondaggio più pesante del solito
di Sergio Cararo
Lo diciamo subito e in premessa. Non daremo indicazioni di voto per le elezioni europee di domenica.
Detto questo, ci interessa piuttosto cercare di evidenziare alcuni dati su una scadenza elettorale che si delinea da un lato come il consuntivo di tutti i sondaggi effettuati fino a quindici giorni fa, dall’altro può rivelarsi uno snodo decisivo per cambiamenti significativi in alcuni paesi, a partire dall’Italia.
Inutile ricordare come il Parlamento europeo non abbia poteri legislativi. Decide poco o nulla, al massimo esprime il gradimento o meno sui nuovi commissari europei, oltre che sulle “direttive” della Commissione (il “governo”). I poteri decisionali dell’Unione Europea sono altrove: nel Consiglio europeo (quello dei capi di stato), nella Commissione Europea e soprattutto nella Banca Centrale Europea. Tutti e tre non sono organismi eletti, ma decisi per cooptazione.
Chi ha in testa o continua a concionare sulla “democratizzazione” dell’Unione Europea si illude, oppure mente consapevolmente. L’apparato costruito e rafforzato in questi ventisette anni (dal Trattato di Maastricht del 1992) non è riformabile dall’interno, non è previsto, non è stato edificato per esserlo.
Leggi tutto
Carlo Galli: “Sovranità è democrazia? Oggi sì”
“Sovranità è democrazia? Oggi sì”
Claudio Ciani intervista Carlo Galli
Sulla quarta di copertina del libro appare questa frase: “Sovranità è democrazia? Oggi sì”. Oggi sì, perché viviamo in un perenne “stato di eccezione” oppure perché l’art. 3, principio fondamentale della nostra Costituzione, che attribuisce al popolo la sovranità, è venuto meno o, nella peggiore delle ipotesi, è stato tradito?
Oggi sì, perché il superamento della sovranità sta avvenendo attraverso l’imposizione dall’esterno di un paradigma politico-economico-sociale anti-popolare, deflativo, tecnocratico. Perché l’esercizio democratico della sovranità è l’unico modo per riportare queste dinamiche sotto il controllo dei cittadini (attraverso la mediazione dei partiti).
Qual è oggi, secondo lei, il modello di sovranità al quale ci si può ispirare: Bodin, Hobbes, Sieyes? Oppure, potrebbe essere utile ripensare il concetto spinoziano di imperium, un concetto che ricorda la proposta del giurista socialdemocratico Heller?
La sovranità democratica è rappresentativa nel caso normale (e dunque deriva dal modello hobbesiano); ma per essere instaurata o restaurata esige un surplus d’energia politica partecipativo-rivoluzionaria (in linea con quanto espresso da Sieyes nel suo libello del 1789). Heller più che spinoziano era debitore a Hegel di un’idea di sovranità come mediazione non solo giuridica ma anche sociale.
Leggi tutto
Enzo Acerenza: Eelezioni europee, per chi votare? Per nessuno
Eelezioni europee, per chi votare? Per nessuno
di Enzo Acerenza
C’è un partito che ha come obiettivo la fine dello sfruttamento operaio? La fine della classe dei padroni che sfrutta gli operai? La risposta è semplice, non c’è. C’è un partito che vuole l’abolizione della produzione fondata sul profitto, che genera da una parte ricchezza per pochi e miseria per la grande maggioranza della popolazione, per primi degli operai, che sono i veri artefici di questa ricchezza? Non c’è nessun partito politico che ha nemmeno lontanamente questo obiettivo. In realtà i loro programmi si differenziano semplicemente su come la ricchezza prodotta dagli operai deve essere divisa fra le classi superiori. Nella migliore delle ipotesi propongono un po’ di elemosina per i poveri per comprarsi qualche voto. Non c’è nessuna ragione per votare chi nemmeno ricorda che tutti i giorni, per una vita intera milioni di operai lavorano per un salario di fame, sotto un padrone dispotico. Nessun partito ha denunciato come la strage di operai sia una questione sociale e dipenda dalla corsa al profitto dei padroni grandi e piccoli. Sono arrivati al punto di sostenere che un lavoro sotto padrone è una ottima condizione, una condizione dignitosa. Hanno confuso l’attività ben pagata di alti impiegati, burocrati di Stato, funzionari di partito con il lavoro da schiavi di chi produce merci sulle linee, di chi le movimenta a ritmi infernali nei magazzini, di chi piega la schiena nelle campagne. Nessun partito è espressione degli operai, nessun partito merita il loro voto.
Leggi tutto
Claudio Conti: Guerra Usa alla Cina? Mica tanto facile…
Guerra Usa alla Cina? Mica tanto facile…
di Claudio Conti
L’impressione è che gli Stati Uniti, come spesso è accaduto alle potenze in crisi di egemonia, abbiano dato il via ad una “guerra” senza fare un calcolo preciso delle forze in campo. Insomma, come la la loro potenza fosse così straripante da non richiedere altro che l’attivazione della catena di comando per eseguire gli ordini.
Con Grenada o Panama te lo potevi permettere, con l’Iraq di Saddam anche. Ma col passare del tempo i problemi aumentano, si fanno più complessi, man mano che il tuo strapotere diventa visibilmente meno totalizzante… Fino al punto che devi fare un passo indietro proprio quando avevi annunciato di volerne fare due avanti.
A sole 24 ore dalla rivelazione dell’agenzia Reuters, poi confermata (“Google rompe il contratto di fornitura con Huawei per il sistema operativo Android e tutte le app proprietarie”), come conseguenza delle sanzioni decise da Trump contro il colosso delle comunicazioni cinese, “il governo americano concede una tregua di 90 giorni”. Parte delle restrizioni vengono per il momento sospese fino al 19 agosto.
Perché?
Sul piano dei rapporti diplomatici tra i due paesi c’è sicuramente in ballo il contenzioso sui dazi commerciali. Per quanto faccia la voce grossa, non è interesse di Trump – più ancora che degli Stati Uniti – andare davvero fino in fondo.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Per chi vota lo spread?
Per chi vota lo spread?
di ilsimplicissimus
Ma guarda guarda, chi mai lo avrebbe immaginato che in vista delle elezioni le oligarchie europee avrebbero ritirato fuori dal cassetto la pistola dello spread e che l’informazione di servizio si sarebbe buttata a pesce sul peggiore allarmismo? “Oddio lo spread è salito a 290 forse arriva a 300, siamo rovinati, lo stiamo perdendo”, facendo intendere che il famoso, intoccabile e inconoscibile “mercato” – formato poi da un centinaio di persone – punisce chi vota coloro che potrebbero anche pensare a un lieve aumento del bilancio e dunque si dimostrano poco ubbidienti all’Europa e ai suoi dicktat di bilancio. Non saprei dire se la ripetitività di questa farsa, che raggiunse l’apice con Monti, sia più noiosa o odiosa, ma di certo questa minaccia a mano armata ha un senso solo nella post democrazia della paura, perché alla fine questo è: ti lasciamo votare se voti per noi, altrimenti sono botte da orbi. Un po’ come il pistolero Trump fa con l’Iran e il Venezuela, perché in definitiva ogni sistema è in qualche modo frattale: ogni forma si ripete nella sua logica ad ogni livello.
Leggi tutto
Hits 3532
Hits 3476
Hits 3210
Hits 3032
Hits 2770
Hits 2682
Hits 2590
Hits 2463
Hits 2431
Hits 2081
tonino

Alessandro Visalli: Circa Roberta De Monticelli, Stati Uniti d’Europa e filosofia
Circa Roberta De Monticelli, Stati Uniti d’Europa e filosofia
di Alessandro Visalli
 Su Il Manifesto, che una
volta era un giornale comunista, è pubblicato un interessante
articolo della filosofa Roberta
De
Monticelli[1] la cui corposa biografia
intellettuale è tutta spesa in direzione dell’approfondimento
della fenomenologia con una chiarissima ispirazione religiosa.
In termini di storia delle idee si tratta di una linea
culturale illustre e pienamente
legittima, come le rivendicazioni che ne conseguono, ma,
altrettanto chiaramente, del tutto aliena alla tradizione
socialista, come la chiusa
dell’articolo esprime con estrema nettezza. L’articolo va
letto quindi come un cartello stradale, si deve scegliere dove
andare.
Su Il Manifesto, che una
volta era un giornale comunista, è pubblicato un interessante
articolo della filosofa Roberta
De
Monticelli[1] la cui corposa biografia
intellettuale è tutta spesa in direzione dell’approfondimento
della fenomenologia con una chiarissima ispirazione religiosa.
In termini di storia delle idee si tratta di una linea
culturale illustre e pienamente
legittima, come le rivendicazioni che ne conseguono, ma,
altrettanto chiaramente, del tutto aliena alla tradizione
socialista, come la chiusa
dell’articolo esprime con estrema nettezza. L’articolo va
letto quindi come un cartello stradale, si deve scegliere dove
andare.
La sinistra storica vi è accusata senza mezzi termini di cecità “all’orizzonte cosmopolitico della società giusta”; la rivendicazione della tradizione cristiana nella costruzione europea (persino citando in posizione strategica il riferimento di Spinelli, molto noto, ad uno dei padri dell’ordoliberalismo tedesco) è netta, perfettamente legittima e storicamente sostenibile. Certo, questa presa di posizione contro l’eurofederalismo di Lelio Basso (che, richiesto, rifiuta di firmare il Manifesto per estraneità al socialismo), di Nenni, Pertini e di Togliatti, ripetuta in modo netto negli anni cinquanta e sessanta, e progressivamente attenuata nei settanta (per essere poi, nei successori, rovesciata a partire dagli ottanta), e quindi di tutte le sinistre socialiste e comuniste, è qualificata dall’autore enfaticamente come “la tragedia”. Certo, svolge una funzione di cerniera essenziale un breve passaggio di una lettera di Spinelli a Ropke, nella quale questi chiarisce sinteticamente il suo abbandono del marxismo in favore del personalismo.
Tutto giusto e logico.
Potrebbe, casomai, sembrare curioso che un giornale che si qualifica “comunista”, e viene da altra tradizione, pubblichi un articolo che starebbe perfettamente a suo agio su “Civiltà cattolica”.
Leggi tutto
Franco Di Giorgi: Cacciari e l'Europa
Cacciari e l'Europa
di Franco Di Giorgi
 I. – A differenza di
quanto si è indotti a credere, a generare
l’euroscetticismo e l’antieuropeismo dei populisti e dei
sovranisti, ossia il fenomeno degli attuali neonazionalismi,
non è affatto
l’eccessiva e invadente presenza dell’Europa, ma, al
contrario, è l’effetto di una sconcertante e deludente assenza
d’Europa. Questa la tesi che il 13 marzo Massimo Cacciari ha
sostenuto e sviluppato in una conferenza tenuta nelle Officine
H di Ivrea. Un
impegno di cui, in vista delle prossime elezioni europee
(certo decisive sotto molti aspetti per gli equilibri non solo
internazionali), non molti
intellettuali in verità si incaricano.
I. – A differenza di
quanto si è indotti a credere, a generare
l’euroscetticismo e l’antieuropeismo dei populisti e dei
sovranisti, ossia il fenomeno degli attuali neonazionalismi,
non è affatto
l’eccessiva e invadente presenza dell’Europa, ma, al
contrario, è l’effetto di una sconcertante e deludente assenza
d’Europa. Questa la tesi che il 13 marzo Massimo Cacciari ha
sostenuto e sviluppato in una conferenza tenuta nelle Officine
H di Ivrea. Un
impegno di cui, in vista delle prossime elezioni europee
(certo decisive sotto molti aspetti per gli equilibri non solo
internazionali), non molti
intellettuali in verità si incaricano.
Questa antinomia dell’Europa unita si deve al fatto che i momenti attuativi di questa «eurotopia» (così l’ha definita l’ex presidente della Camera dei Deputati, Laura Boldrini) hanno coinciso con il pieno sviluppo del neoliberismo. Malgrado la fiducia e le speranze iniziali, sempre più i fatti e la storia hanno purtroppo evidenziato l’inconciliabilità dei due progetti. Non ci può essere infatti né unione né visione europea là dove domina l’ideologia neoliberista. La prima ha come fine la formazione e la nascita dell’individuo europeo, la seconda mira solo all’individuo, sotto qualsiasi emisfero si trovi. L’individuo europeo reca in sé l’idea di cittadinanza europea, riflesso dell’antico ideale cosmopolitico, l’individuo neoliberista, al contrario, è pensato all’interno di un universo monadico in cui ogni legame sociale, solidale e realmente spirituale va dissolto e sostituito con la rete messa a disposizione dalla nuova tecnologia, ossia da una spiritualità virtuale. Nell’idea di cittadino europeo c’è il desiderio di realizzare un vero zoon politikon, frutto di una comunità globale fondata sulle differenze, in quella dell’individuo neoliberista persiste invece (nonostante tutto) l’inclinazione, il vizio identitario. Sicché, mentre il primo viene collocato e trova il proprio posto nella moltitudine, il secondo viene gettato in quella virale solitudine che riesce ad alleviare solo con l’uso di uno smartphone messo subdolamente a disposizione dal sistema.
Leggi tutto
Alessandra Ciattini: Le illusioni del postmodernismo
Le illusioni del postmodernismo
di Alessandra Ciattini
C’è sicuramente un legame tra il postmodernismo e il tardo capitalismo. Vediamo insieme quale
 Sicuramente il lavoro che cercherò di esporre è
qualcosa più
grande di me, nonostante mi sia avvalsa del brillante pamphlet
di Eagleton (Le illusioni del postmodernismo,
1998); ma senza sfide
non si avanza né si migliora.
Sicuramente il lavoro che cercherò di esporre è
qualcosa più
grande di me, nonostante mi sia avvalsa del brillante pamphlet
di Eagleton (Le illusioni del postmodernismo,
1998); ma senza sfide
non si avanza né si migliora.
Molti hanno sottolineato la complessità del pensiero di Marx, mettendo in evidenza che è nello stesso tempo un economista, un filosofo, uno storico, dotato di grande vigore letterario e in questo senso un artista, oltre a richiamarsi a principi di carattere etico-politico, anche se ovviamente non ha parlato in maniera sistematica di etica. Questo suo ultimo aspetto è stato ferocemente criticato da quelli autori che, sulla scia di Max Weber, hanno identificato la scienza con il pensiero avalutativo e che hanno considerato il marxismo per il suo messaggio emancipatorio e per il costante richiamo all’impegno militante una forma di messianismo o di religione.
Con i miei grandi limiti e forse con una certa dose di ingenuo avventurismo ho cercato di ispirarmi a questa impostazione di Marx, che ne fa un autore straordinario, cercando i vari aspetti della fase storica che stiamo vivendo, in alcuni casi certamente da incompetente, ma tentando di sollecitare il vostro contributo ai temi presentati.
Prima di avanzare nel ragionamento vorrei sottolineare alcuni temi e sono sollecitata a questo dalle questioni poste dal nostro dibattito. Primo: la mia impostazione non è quella di affermare come stanno effettivamente le cose, ma quella di descrivere un problema teorico, indicando le varie posizioni per arrivare attraverso argomentazioni a delle conclusioni valide, che facciano luce sull’esistente. Il presupposto di partenza, che cercherò di dimostrare, sta nel fatto che il postmodernismo, corrente culturale trasversale, e l’attuale fase capitalistica sono tra loro connessi, e che il primo, radicato nella rivisitazione di tematiche antiche, nasce dai caratteri propri di quest’ultima.
Leggi tutto
Stefano Kenji Iannillo, Daniela Esposito: Ecco perché la guerra tra Huawei e Google è anche una partita europea
Ecco perché la guerra tra Huawei e Google è anche una partita europea
di Stefano Kenji Iannillo, Daniela Esposito
La notizia non è stata in grado di produrre un dibattito pubblico – nonostante sia riportata dalla maggior parte dei media – così come tutte le notizie importanti di cui facciamo fatica a comprendere la gravità.
Google, in seguito ad un’ordinanza di Trump poi sospesa per due mesi, ha annullato ogni rapporto commerciale con Huawei negando l’accesso al sistema operativo Android al secondo produttore di smartphone al mondo. Ci siamo risvegliati così avendo davanti a noi lo sgretolarsi di un altro piccolo pezzo dell’ideologia neoliberista che ci ha accompagnato negli ultimi 30 anni: una parte di quella che eravamo convinti essere la naturalità della nostra società sta andando in frantumi nelle nostre mani, direttamente sui nostri smartphone.
Dopo l’idea della “crescita continua”, della “meritocrazia”, della “sostenibilità ambientale del sistema” e del “mercato che si regola da solo”, con la decisione di Trump di inserire nella black list Huawei e la conseguente mossa di Google, seguita da Intel e altre aziende di microchip, anche quella che ci veniva raccontata come la “neutralità dello sviluppo tecnologico” va a farsi benedire.
L’effetto di questo cambiamento non rimarrà nell’etere o nei media, ma lo vedremo a breve sui nostri telefoni che potrebbero non avere più accesso alle App di Google, quelle più utilizzate dai consumatori di tutto il mondo.
Leggi tutto
Francesco Gesualdi: Uscire dalla schiavitù della moneta
Uscire dalla schiavitù della moneta
di Francesco Gesualdi
Da mezzo di scambio si è trasformata in strumento di accesso: la moneta è diventata la chiave che permette di alzare la sbarra della cassiera al supermercato e far passare di là tutto ciò che abbiamo buttato nel carrello della spesa. Così il nostro problema è diventato come procurarci quel passepartout capace di aprire lo scrigno di ogni nostro desiderio. Le banche per lo più creano moneta dal niente. Usano i risparmi raccolti come base per moltiplicare di varie volte i prestiti che poi rilasciano. Non si può continuare all’infinito a farci mungere per arricchire banche, assicurazioni e altri investitori. Ormai tutti dicono che l’austerità va abbandonata, ma se non riduciamo la dipendenza dal mercato rimangono solo parole
Moneta: credi di parlare di economia, invece parli di vita. La narrazione ufficiale descrive la moneta come un mezzo di scambio, ma è una rappresentazione un po’ desueta, dei tempi in cui eravamo tutti produttori. Facevi il contadino, coltivavi piselli, li vendevi al mercato e col ricavato ci compravi un cestino. Quel tempo non esiste più: oggi i produttori sono pochi e concentrati, alla moltitudine è riservato solo il ruolo di consumatori. E da mezzo di scambio la moneta si è trasformata in strumento di accesso: la chiave che permette di alzare la sbarra della cassiera al supermercato e fare passare di là tutto ciò che abbiamo buttato nel carrello della spesa.
Leggi tutto
Alessandro Della Corte, Stefano Isola e Lucio Russo: Il ritorno dell’educazione civica?
Il ritorno dell’educazione civica?
di Alessandro Della Corte, Stefano Isola e Lucio Russo
La camera dei deputati ha approvato con un voto plebiscitario (nessun contrario e solo tre astenuti) il progetto di legge intitolato “Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica” [1]. Tutti i commentatori hanno plaudito all’iniziativa, mostrando come, almeno su questo tema, il parlamento rappresenti bene le opinioni prevalenti nel paese.
Esaminiamo le cose un po’ più da vicino.
La “documentazione per l’esame del progetto di legge”, fornita ai deputati come base di discussione, contiene opportunamente una lunga introduzione storica all’argomento che ci ricorda come l’insegnamento dell’educazione civica fosse stato introdotto nella scuola italiana nel 1958 (quando il ministro della pubblica istruzione era Aldo Moro). Si trattava all’epoca di un insegnamento chiaro nei fini e nei contenuti, basato sullo studio della Costituzione della Repubblica Italiana, inquadrato storicamente grazie all’opportuna scelta di affidarlo al docente di storia (storia e filosofia nei licei).
Successivamente vi sono state una serie di modifiche che, senza mai abolire formalmente l’insegnamento, lo hanno sgretolato, fino ad annullarlo di fatto, grazie all’abolizione dei programmi didattici nazionali, la distribuzione dell’insegnamento tra vari docenti, l’annegamento del contenuto iniziale (riguardante i principi costituzionali dello Stato) in un mare di “competenze” riguardanti qualsiasi tipo di partecipazione a comunità di ogni tipo.
Leggi tutto
Massimiliano Romanello: Fridays for Future? Qualche considerazione politica e ambientale
Fridays for Future? Qualche considerazione politica e ambientale
di Massimiliano Romanello
Il 24 Maggio ci sarà il nuovo atto del Fridays for Future, con manifestazioni in numerose città di tutta Europa, in seguito all’appello lanciato dalla giovane attivista svedese Greta Thunberg contro il cambiamento climatico. Di fronte alla più ampia mobilitazione giovanile degli ultimi anni, compito dei comunisti e della sinistra di classe è quello di analizzare limiti e punti di forza del movimento per capire come porsi dinanzi ad esso.
Natura politica e sociale e contesto internazionale
In un periodo storico di continua e incessante produzione ideologica, in cui la comunicazione e il modo di veicolare il messaggio sono preminenti, è lecito domandarsi: Greta è manipolata?
Beh, certamente. Non si spiegherebbe altrimenti come abbia conquistato in modo così fulmineo la prima pagina dei giornali e la vetrina delle librerie, o come abbia avuto la possibilità di tenere discorsi davanti alle più alte cariche europee e mondiali. Ma perché tutta questa risonanza mediatica?
Probabilmente perché la lotta ambientale non è fine a sé stessa ma racchiude anche, in modo più o meno manifesto, una finalità politica.
Leggi tutto
Elezioni europee
Elezioni europee
E' andata peggio
di Norberto Fragiacomo
 Poteva
andar male: è andata peggio.
Poteva
andar male: è andata peggio.
Gli esiti della consultazione europea di ieri ribaltano quelli delle politiche di un anno fa, e non soltanto perché 5Stelle e Lega si sono “scambiati” le percentuali, a tutto vantaggio di quest’ultima: se nella primavera del 2018 gli elettori avevano posto una forte domanda di cambiamento[1] ora sembrano essere ritornati sui propri passi, esprimendo un voto che definirei reazionario.
Non alludo esclusivamente al plebiscito in favore della Lega, che ha sedotto oltre il 34% degli italiani (di quelli votanti, s’intende, ma i dati sull’astensione rientrano nella norma): mi vorrei soffermare anche sull’avanzata di un PD non meno invotabile di quello naufragato nelle urne 14 mesi orsono.
La Lega, anzitutto: è lei il vincitore di giornata. Comincio col fare ammenda: ero convinto – e l’ho detto – che negli ultimi tempi Salvini avesse smarrito il senso della misura, andando “fuori giri”, e che il mix di buffonate sanfediste, smargiassate e difese a oltranza dell’indifendibile gli sarebbe costato non poco in termini di popolarità e consenso.
* * * *
Bandolo di matassa
di Pierluigi Fagan
 Pensierino sul voto per le elezioni europee. Il
tema Europa oggi
è una matassa di fili intrecciati che vanno dal neo-liberismo
al sovranismo, dal cosmopolitismo al nazionalismo, dai
migranti alla geopolitica,
le destre, le sinistre, i non ci sono più né-le-destre-né-le
sinistre, le globalizzazioni, la moneta sovrana, il futuro
federato,
la lenta dissipazione demografica, la democrazia dei pochi o
dei molti, la Cina e Trump, l’euro e la neuro, la paranoia
ambientale e quella
post-umana. In questo universo multidimensionale, ognuno trova
la sua posizione e poi immagina una strada orientandosi a
seconda delle sue immediate
vicinanze. Ogni posizione è auto fondata e contraria ad
un’altra altrettanto auto fondata. Ma a prescindere da tutto
ciò,
“Europa” è un problema di che tipo? fondato dove e da cosa?
Pensierino sul voto per le elezioni europee. Il
tema Europa oggi
è una matassa di fili intrecciati che vanno dal neo-liberismo
al sovranismo, dal cosmopolitismo al nazionalismo, dai
migranti alla geopolitica,
le destre, le sinistre, i non ci sono più né-le-destre-né-le
sinistre, le globalizzazioni, la moneta sovrana, il futuro
federato,
la lenta dissipazione demografica, la democrazia dei pochi o
dei molti, la Cina e Trump, l’euro e la neuro, la paranoia
ambientale e quella
post-umana. In questo universo multidimensionale, ognuno trova
la sua posizione e poi immagina una strada orientandosi a
seconda delle sue immediate
vicinanze. Ogni posizione è auto fondata e contraria ad
un’altra altrettanto auto fondata. Ma a prescindere da tutto
ciò,
“Europa” è un problema di che tipo? fondato dove e da cosa?
Europa è una mera espressione geografica che include una cinquantina di stati per lo più anche nazioni, la più alta concentrazione di stati, circa il 25%, sul solo 3% delle terre emerse. E’ la geo-storia ad averla fatta così spezzettata e ricca di diversità. Purtroppo, questa geo-storia appartiene al passato, un passato in cui Europa o era relativamente autonoma ed isolata dal mondo (fino al XV secolo) o lo dominava (fino al XX secolo).
* * * *
Tutto come prima, niente come prima
di ilsimplicissimus
 Una cosa sembra chiara:
gli europei cominciano a non poterne più dell’Europa
oligarchica,
ma dopo decenni di devastazione politica che ha ucciso i
partiti e creato una enorme confusione intellettuale ed
emotiva, essi non hanno più
gli strumenti per esprimere lucidamente questa volontà
trovandosi in definitiva a scegliere tra un fronte
conservatore o comunque dello status
quo e uno movimentista di natura varia e incerta spesso di
destra o raramente di sinistra come in Portogallo, ma ormai
battezzata come sovranismo:
insomma i votanti debbono accontentarsi di giocare con le
mattonelle di lego a disposizione molte volte create o
deformate dagli stessi poteri che
dominano il continente. Certo è difficile vedere delle linee
di tendenza in questo bailamme, al di là di un a generale
crescita delle
formazioni critiche, ma potremmo cominciare col distinguere
alcune zolle continentali: quella italo francese con annessa
la Gran Bretagna, quella nord
mitteleuropea e quella degli ex Paesi dell’est.
Una cosa sembra chiara:
gli europei cominciano a non poterne più dell’Europa
oligarchica,
ma dopo decenni di devastazione politica che ha ucciso i
partiti e creato una enorme confusione intellettuale ed
emotiva, essi non hanno più
gli strumenti per esprimere lucidamente questa volontà
trovandosi in definitiva a scegliere tra un fronte
conservatore o comunque dello status
quo e uno movimentista di natura varia e incerta spesso di
destra o raramente di sinistra come in Portogallo, ma ormai
battezzata come sovranismo:
insomma i votanti debbono accontentarsi di giocare con le
mattonelle di lego a disposizione molte volte create o
deformate dagli stessi poteri che
dominano il continente. Certo è difficile vedere delle linee
di tendenza in questo bailamme, al di là di un a generale
crescita delle
formazioni critiche, ma potremmo cominciare col distinguere
alcune zolle continentali: quella italo francese con annessa
la Gran Bretagna, quella nord
mitteleuropea e quella degli ex Paesi dell’est.
* * * *
Prima la visione del mondo, poi la coalizione
di Riccardo Paccosi
 Il tracollo
de La Sinistra ma anche, in Francia, la batosta presa da
Melenchon, credo
dimostrino come la sinistra cosiddetta "radicale" sia vittima
di un obnubilamento che precede di molto la definzione di
programmi e strategie,
giacché riguarda i fondamenti logici e cognitivi della
politica.
Il tracollo
de La Sinistra ma anche, in Francia, la batosta presa da
Melenchon, credo
dimostrino come la sinistra cosiddetta "radicale" sia vittima
di un obnubilamento che precede di molto la definzione di
programmi e strategie,
giacché riguarda i fondamenti logici e cognitivi della
politica.
In sintesi, tutti i re-assemblement verificatisi a sinistra nell'ultimo decennio, hanno attribuito priorità al processo coalizionale di gruppi e partiti, rimandando sempre a data da destinarsi il chiarimento dei punti più controversi sull'agenda politica.
All'interno della sinistra "radicale", convive infatti chi aspira allo stato unico europeo e chi invece punta al rilancio delle sovranità costituzionali; chi persegue il deregolazionismo per ciò che riguarda i flussi migratori e chi, al contrario, ritiene tale prospettiva come facente gli interessi delle classi dominanti.
* * * *
Dove va l'UE?
di Pierluigi Fagan
 Lettori e lettrici sanno che qui si rimane
attaccati possibilmente
ai fatti e poi si liberano le opinioni. La premessa è per dire
che con post del 15 aprile, informavo sulle stime dei sondaggi
europei. Alcuni
opinavano che i sondaggi valgono quello che valgono ma
rispondevo che la struttura delle elezioni europee, ripartite
tra diversi gruppi e tra parecchi
stati, annullava di molto i possibili margini di errore.
Lettori e lettrici sanno che qui si rimane
attaccati possibilmente
ai fatti e poi si liberano le opinioni. La premessa è per dire
che con post del 15 aprile, informavo sulle stime dei sondaggi
europei. Alcuni
opinavano che i sondaggi valgono quello che valgono ma
rispondevo che la struttura delle elezioni europee, ripartite
tra diversi gruppi e tra parecchi
stati, annullava di molto i possibili margini di errore.
Nel post si dava conto di tre fatti: 1) popolari e socialdemocratici non avrebbero sicuramente più avuto la maggioranza ed avrebbero dovuto cooptare i liberali (confermato), 2) la somma dei due gruppi che è improprio etichettare entrambi come sovranisti (EFD M5S e Farage + ENF ovvero Salvini-Le Pen), avrebbero raggiunto circa 116 deputati complessivi (pare ne avranno 114); 3) la partita politica più interessante poiché indecisa e potenzialmente quasi clamorosa, sarebbe stato il voto francese dove le previsioni non sapevano dire se la vittoria sarebbe andata a Le Pen o Macron (ha poi vinto Le Pen). Il post ebbe 14, miseri, like.
* * * *
![]()
Il suicidio delle sinistre lemming
di Carlo Formenti
Prima impressione a botta calda sull'esito elettorale. Dovessi scrivere un articolo sul tema lo intitolerei "Il suicidio delle sinistre lemming". Come saprete, i lemming sono dei simpatici roditori che vivono nelle zone artiche e che, periodicamente, si suicidano in massa gettandosi in mare per motivi non del tutto chiari. Secondo alcuni l'evento sarebbe associato a una pulsione istintuale che scatta quando la loro popolazione cresce troppo rapidamente in rapporto alle risorse alimentari disponibili.
* * * *
![]()
A noi Orwell ci fa un baffo
di Andrea Zhok
 Dati alla mano, in UE si formerà un governo
fotocopia del precedente,
solo un po’ più magro e incattivito, un governo formato da
PPE, PSE + i liberaldemocratici di ALDE.
Dati alla mano, in UE si formerà un governo
fotocopia del precedente,
solo un po’ più magro e incattivito, un governo formato da
PPE, PSE + i liberaldemocratici di ALDE.
Sarà questa maggioranza che eleggerà il prossimo presidente
della BCE, e visto lo scampato pericolo sarà finalmente uno
deciso
a mettere in riga i paesi che turbano il guidatore – cioè il
governo della finanza.
E, sappiatelo, ne ha tutti i mezzi,
perché a quel signore eletto sostanzialmente dall’azionista di
maggioranza (Germania) abbiamo consegnato il potere assoluto
sui nostri
conti pubblici, sui nostri investimenti, sulla nostra
solvibilità.
A occhio e croce direi che la propaganda europeista ha vinto nei limiti in cui poteva vincere. Nelle salde mani dei ‘competenti’ l’Europa si avvia ad altri 5 anni di agonia, in cui qualunque iniziativa che non sia ‘market-friendly’ verrà bombardata come indecoroso populismo. In Italia ci verranno ripetute le solite incredibili idiozie sul debito pubblico come debito del ‘buon padre di famiglia’, della necessità di stringere ancora un po’ la cinghia, di svendere ancora quel po’ di patrimonio pubblico rimasto, e ci verrà soprattutto innestata ancora più in profondità l’idea che “non c’è alternativa”.
* * * *
Fuochi d’artificio elettorali. C’è davvero da spaventarsi?
di Francesco Piccioni
 Guardando ai risultati
elettorali europei ed italiani non si sfugge a un’impressione
decisamente contraddittoria. La prima reazione, di fronte al
“trionfo” della Lega e in generale delle destre
xenofobe/razziste, è
chiedersi “dove posso emigrare”? La seconda, altrettanto
immediata, è che tutto ciò non sia del tutto reale.
Guardando ai risultati
elettorali europei ed italiani non si sfugge a un’impressione
decisamente contraddittoria. La prima reazione, di fronte al
“trionfo” della Lega e in generale delle destre
xenofobe/razziste, è
chiedersi “dove posso emigrare”? La seconda, altrettanto
immediata, è che tutto ciò non sia del tutto reale.
Intendiamoci subito: i voti sono quelli, chiarissimi. E non si deve far finta di nulla.
La Lega sbraitante ha superato il 34%, i Cinque Stelle sono stati dimezzati, il Pd ha avuto il classico “rimbalzo del gatto morto” (dopo una caduta da grandi altezze) risalendo al 22,7%, Berlusconi ha rinviato il decesso raccogliendo quasi il 9 (quasi la metà di un anno fa, e pare addirittura un mezzo successo), i nostalgici della Meloni prendono un 6,5% che sembra oro.
Il resto è poca roba, importante solo per le analisi autoconsolatorie che seguono una sconfitta, quando gli zero virgola in più o meno devono essere enfatizzati al massimo per “tenere le truppe” ed evitare la fuga disordinata.
Giovanna Ciaffi, Matteo Deleidi, Enrico Sergio Levrero: I costi economici e sociali del Fiscal Compact
I costi economici e sociali del Fiscal Compact
di Giovanna Ciaffi, Matteo Deleidi, Enrico Sergio Levrero
 Nel corso degli ultimi 20 anni la direzione
seguita a livello
europeo è stata quella di una crescente rigidità nelle regole
fiscali anche oltre quanto già previsto dal Trattato di
Maastricht
del 1992, fino ad arrivare, nel marzo del 2012, al Trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance
dell’Unione
Economica e Monetaria, noto come Fiscal Compact
e
firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, esclusi
il Regno Unito e la Repubblica Ceca. Come è noto, il Fiscal
Compact prevede il rispetto di due regole principali in
materia di finanza pubblica: (i) un sostanziale pareggio di
bilancio, o più
precisamente, il divieto per il deficit strutturale del
settore pubblico di superare lo 0,5% del Pil nel corso di un
ciclo economico; e (ii) che il
rapporto debito pubblico/Pil scenda ogni anno di un ventesimo
della distanza tra il suo livello effettivo e la
soglia-obiettivo del 60% prevista nel
Trattato di Maastricht.
Nel corso degli ultimi 20 anni la direzione
seguita a livello
europeo è stata quella di una crescente rigidità nelle regole
fiscali anche oltre quanto già previsto dal Trattato di
Maastricht
del 1992, fino ad arrivare, nel marzo del 2012, al Trattato
sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance
dell’Unione
Economica e Monetaria, noto come Fiscal Compact
e
firmato da tutti gli Stati membri dell’Unione Europea, esclusi
il Regno Unito e la Repubblica Ceca. Come è noto, il Fiscal
Compact prevede il rispetto di due regole principali in
materia di finanza pubblica: (i) un sostanziale pareggio di
bilancio, o più
precisamente, il divieto per il deficit strutturale del
settore pubblico di superare lo 0,5% del Pil nel corso di un
ciclo economico; e (ii) che il
rapporto debito pubblico/Pil scenda ogni anno di un ventesimo
della distanza tra il suo livello effettivo e la
soglia-obiettivo del 60% prevista nel
Trattato di Maastricht.
Per quanto dal 2012 la Commissione Europea abbia concesso ai diversi Stati, tra cui l’Italia, deroghe alle regole imposte dal Fiscal Compact, ci si può chiedere – anche alla luce di alcune proposte di riforma che ne prospettano un inasprimento in vista di una possibile politica fiscale europea[1] – cosa accadrebbe se si imponesse ai singoli Stati anche solo il puntuale rispetto delle regole fiscali finora previste. In particolare, ci si può chiedere quali effetti diverse regole di politica fiscale potrebbero avere sull’andamento del rapporto debito pubblico/Pil.
Per rispondere a questa domanda va anzitutto notato che a base del Fiscal Compact e delle posizioni della Commissione Europea vi è l’idea che i deficit fiscali si traducano in una riduzione degli investimenti privati ed abbiano un effetto negativo sulle potenzialità di crescita del sistema economico. Diverso è il punto di vista keynesiano: in economie che normalmente funzionano al di sotto dei loro livelli di piena occupazione, la spesa pubblica avrà un effetto espansivo sul reddito sia direttamente che per effetto dell’aumento degli investimenti privati che l’incremento di spesa pubblica e quindi del reddito potrà determinare.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Cosmopolitismo, universalismo e l’Unione Europea
Cosmopolitismo, universalismo e l’Unione Europea
Una risposta a Roberta De Monticelli
di Andrea Zhok
In calce la risposta di Roberta De Monticelli e una replica di Andrea Zhok
 Oggi è
apparso sul Manifesto un articolo della
professoressa Roberta De
Monticelli dall’impegnativo titolo: Stati uniti d’Europa,
un edificio politico architettato dalla filosofia.
Nell’articolo
De Monticelli, dopo aver lamentato la superficialità
dell’attuale dibattito intorno all’Europa, rivendica una
matrice filosofica
alta come ispirazione e viatico del ‘progetto europeo’.
Oggi è
apparso sul Manifesto un articolo della
professoressa Roberta De
Monticelli dall’impegnativo titolo: Stati uniti d’Europa,
un edificio politico architettato dalla filosofia.
Nell’articolo
De Monticelli, dopo aver lamentato la superficialità
dell’attuale dibattito intorno all’Europa, rivendica una
matrice filosofica
alta come ispirazione e viatico del ‘progetto europeo’.
Al netto del condivisibile sconforto per l’attuale campagna elettorale, si potrebbe notare come la contestazione all’odierno ‘europeismo’ non si muova di norma con riferimento a nobili istanze come l’idealità cosmopolita, ma con più prosaico riferimento ad un sistema ha prodotto una crescita europea stagnante, la deindustrializzazione di molti paesi (tra cui l’Italia) e una costante riduzione del potere contrattuale dei lavoratori.
Ma fingiamo che tutto ciò non sia essenziale. Ipotizziamo che il tema siano Kant e Rawls e non la macelleria sociale greca. E continuiamo pure nell’equivoco per cui l’antieuropeismo sarebbe una proterva e irragionevole ostilità all’Europa – e non all’Unione Europea -, accettiamo protempore tutto questo e proviamo ad esaminare gli argomenti specificamente filosofici che vengono sollevati da De Monticelli.
Due argomenti giocano un ruolo centrale.
Il primo vede nell’Unione Europea
“il vero e proprio cantiere di un edificio politico architettato dalla filosofia: cioè dall’anima universalistica del pensiero politico, che è almeno tendenzialmente cosmopolitica.”
Il secondo specifica il carattere di questo ‘universalismo’ in opposizione all’accidentalità della nascita:
“Cosmopolitica è (…) la forma di una civiltà fondata nella ragione (…). La domanda di ragione e giustificazione è quanto di più universale ci sia. (…) Esser nato in un deserto, o in una contrada afflitta da massacri e guerra, è un accidente: l’accidente della nascita. (…) Ogni ingiustizia si lega all’accidente della nascita.”
Leggi tutto
Toni Negri: General Intellect e individuo sociale nei Grundrisse marxiani
General Intellect e individuo sociale nei Grundrisse marxiani
di Toni Negri
Conferenza alla Volkshbühne, Berlino, 29 aprile 2019. Questa conferenza non è stata tenuta per malattia dell’autore. La pubblichiamo qui
 1. Non so
dirvi quanto sia lieto di presentare e commentare alla Volkshbühne
la
traduzione tedesca di Marx oltre Marx per la
prestigiosa casa editrice berlinese Dietz Verlag. È
un libro scritto alla fine
del lungo decennio ’68-’79, nel quale fui immerso nella lotta
di classe in Italia e in Europa, a partire da lezioni tenute
nel 1978 a
Parigi all’École normale supérieure, su invito di
Louis Althusser.
1. Non so
dirvi quanto sia lieto di presentare e commentare alla Volkshbühne
la
traduzione tedesca di Marx oltre Marx per la
prestigiosa casa editrice berlinese Dietz Verlag. È
un libro scritto alla fine
del lungo decennio ’68-’79, nel quale fui immerso nella lotta
di classe in Italia e in Europa, a partire da lezioni tenute
nel 1978 a
Parigi all’École normale supérieure, su invito di
Louis Althusser.
Questo libro nacque da una rilettura dei Grundrisse per mettere Marx all’altezza delle lotte di quegli anni, nella speranza di una rivoluzione di classe operaia. Questo libro ha attraversato le lotte e si è conquistato un destino, riaffermando Marx come sorgente di soggettivazione rivoluzionaria. È il caso di dire: habent sua fata libella.
2. Riprendere questo libro oggi (e con esso questo Marx) che cosa ci dice? O, se vogliamo dirlo in termini meno legati a questo volume e alle vicende che lo ispirarono, che cosa possono dirci i Grundrisse nella/della situazione del capitalismo oggi?
Per rispondere è necessario preliminarmente riconoscere le caratteristiche precipue, fondamentali, del capitalismo nel XXI secolo.
Ricorderemo essenzialmente, in primo luogo, il dominio del capitale finanziario; in secondo luogo, le dimensioni estrattive, logistiche e biopolitiche dell’accumulazione capitalista oggi; e in terzo luogo cercheremo di definire i nuovi spazi della soggettivazione anticapitalista e della lotta di classe oggi.
2.1. Sul primo punto. È chiaro che, integrando la teoria del capitale finanziario che si legge nel III volume del Capitale e il “Capitolo sul denaro” dei Grundrisse, si apre ad un aspetto fondamentale del capitalismo odierno.
Leggi tutto
Domenico Moro: Il confronto tra Giappone e Italia sulla gestione del debito
Il confronto tra Giappone e Italia sulla gestione del debito
di Domenico Moro
Come è noto, il Giappone, pur avendo un debito pubblico molto più grande di quello italiano, paga interessi molto inferiori: sui titoli di stato a dieci anni il tasso è di -0,1% contro il +2,6% dell’Italia[1]. Sul Sole24ore è recentemente apparso un articolo di Alessandro Penati[2], che critica chi pensa che la bassa spesa per interessi dipenda dai massicci acquisti di titoli di stato di investitori pubblici e semipubblici residenti, in particolare della Banca centrale del Giappone (BoJ), e, quindi, dal mantenimento, a differenza dell’Italia, della sovranità monetaria. Secondo Penati, la differenza nei tassi d’interesse tra Italia e Giappone non dipenderebbe dai vincoli posti dai Trattati europei e dalla alienazione della sovranità monetaria alla Bce, ma dalla maggiore crescita del Pil pro capite e della produttività del Giappone.
In primo luogo, bisogna precisare che il debito pubblico italiano ha raggiunto nel 2018 il 132% sul Pil contro il 237% del Giappone[3]. Quindi, la differenza è maggiore di quanto dice Penati, secondo cui il debito italiano sarebbe del 153% contro il 223% del Giappone. Inoltre, anche considerando la spesa per interessi, in valore assoluto il debito italiano è cresciuto meno di quello giapponese, tra 2007 e 2018, del 2,4% medio annuo contro il 2,8% di quello giapponese[4].
Leggi tutto
Sergio Cararo: Il complesso militare-industriale europeo, tra competizione e venti di guerra
Il complesso militare-industriale europeo, tra competizione e venti di guerra
di Sergio Cararo*
Un aspetto inquietante poco indagato e molto sottovalutato della riorganizzazione dell’Unione Europea è quello della politica militare.
Negli ultimi anni, utilizzando il meccanismo delle cooperazioni rafforzate (cioè la convergenza solo di alcuni stati della Ue su un progetto specifico, così come è stato fatto per l’Eurozona), le maggiori potenze hanno avviato un processo di definizione e strutturazione di una politica e di un complesso militare industriale europeo. Questo processo ha subito una accelerazione esplicita con il recente Trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania e con il Fondo Europeo per la Difesa.
L’obiettivo dichiarato è quello della indipendenza tecnologica dal monopolio statunitense in questa materia. Il crescente ricorso a tecnologie dual use (civile e militare) ha permesso di raggiungere risultati ed ha definito progetti inimmaginabili fino ad un ventennio fa. Ad esempio il sistema satellitare europeo Galileo comprende anche i Public Regulated Services (Prs), servizi riservati alle autorità governative per un utilizzo destinato alla difesa e sicurezza nazionale. In questo caso il segnale è criptato e protetto da interferenze ostili (jamming e spoofing).
Sganciarsi o limitare al minimo il monopolio tecnologico e militare degli Stati Uniti sull’Europa, si va definendo via via come priorità per i gruppi capitalisti dominanti in Europa.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Letture atipiche
Letture atipiche
di Pierluigi Fagan
Emmanuel Todd è un demografo (storico-sociologo-antropologo) francese, specializzato in sistemi familiari e sistemi di parentela, noto soprattutto per la sua azzeccata profezia sul crollo imminente dell’URSS, pronunciata nel 1976. L’insieme dei suo interessi d’indagine e competenze lo hanno portato a formarsi un paradigma fortemente anti-economicista nel senso che alla lettura economica della storia e della socio-politica, oppone la dura persistenza e resistenza del sistema familiare-religioso-ideologico proveniente anche dai livelli di educazione formale e dalle tradizioni di lunga durata. A metà tra la scuola delle Annales francese e l’antropologia storica di Cambridge, Todd si definisce un empirista realista. Oggi è decisamente anti-UE ed euro ma nel tempo ha subito qualche oscillazione d’opinione.
Va chiarito un punto. L’antropologia storica di Todd legge la persistenza di codici culturali anche laddove non si registra più l’esistenza attiva di alcune strutture. In Europa, ad esempio, la classificazione dei tipi familiari è oggi molto meno precisa e connotata del passato e tutti sappiamo del processo di secolarizzazione. Tali novità però non sono del tutto registrate nelle mentalità, la mentalità risente ancora, quasi a livello di inconscio collettivo, delle strutture di pensiero corrispondenti a strutture sociali magari oggi meno presenti o apparentemente meno importanti.
Leggi tutto
Christian Marazzi: Debito senza colpa
Debito senza colpa
di Christian Marazzi
Spesso, negli anni della crisi iniziata nel 2008, il filosofo Friedrich Nietzsche è stato citato per render conto delle politiche di austerità perseguite dalla troika, il terzetto composto dalla BCE, dalla Commissione europea e dal Fmi. Politiche, quelle della troika, molto severe volte a costringere i paesi indebitati, come la Grecia, la Spagna, il Portogallo, l’Irlanda e, non da ultimo, l’Italia, a ridurre o a contenere il debito pubblico con pesanti tagli alla spesa pubblica, in particolare a quella sociale. In alcuni casi, e si pensi alla Grecia, le politiche austeritarie hanno avuto effetti umanamente devastanti. In altri, si pensi all’Italia, hanno bloccato la crescita.
Nella Genealogia della morale, laddove Nietzsche spiega l’origine della colpa, utilizza la parola tedesca schuld per dimostrare il nesso molto stretto tra colpa e debito, un rapporto così intimo da autorizzare i forti, cioè i creditori, a infliggere le peggiori pene ai deboli, ossia i debitori. Il riferimento a Nietzsche, bisogna riconoscerlo, è stato pertinente.
In questi anni di stagnazione (secolare), causata ovunque dalla compressione della domanda interna, ossia dalla riduzione dei salari e dalla precarizzazione del lavoro, si è fatto un uso spregiudicato di politiche monetarie espansive per promuovere la crescita economica.
Leggi tutto
Hits 3585
Hits 3581
Hits 3234
Hits 3060
Hits 2804
Hits 2697
Hits 2596
Hits 2442
Hits 2100
Hits 2046
tonino

Collettivo Jaggernaut: “Make Critical Theory Great Again”
“Make Critical Theory Great Again”
di Collettivo Jaggernaut
Pubblichiamo qui la presentazione del primo numero della rivista Jaggernaut, uscito da poco in Francia. La rivista orbita nell’area della Wertkritik (Critica del valore), rispetto alla quale vuole rappresentare un punto di riferimento e un momento di approfondimento. Per maggiori info, invitiamo a visitare la loro pagina web a questo indirizzo
 “Siamo ancora tenuti a creare
il negativo; il positivo ci è già stato dato” (Franz
Kafka, Terzo quaderno dei Diari)
“Siamo ancora tenuti a creare
il negativo; il positivo ci è già stato dato” (Franz
Kafka, Terzo quaderno dei Diari)
“La libertà sarebbe non quella di scegliere tra il bianco e il nero, ma quella di voltare le spalle a questa scelta obbligata” (Adorno, Minima Moralia)
Per decenni, gli algerini soprannominarono il quotidiano governativo del loro paese “Tutto va bene, (madama la marchesa)”. Si assicurava che grazie alla saggezza del governo i cittadini vivevano nel migliore dei mondi possibili, e che presto i problemi residui sarebbero stati risolti. Oggi un simile rapporto con la verità resiste ancora in una parte del mondo. Ma, almeno nel mondo “occidentale e libero”, è considerato arcaico. Non che i governi siano diventati più avveduti e umili. Semplicemente sanno che bugie del genere non reggono più.
In realtà, il cittadino contemporaneo sa di essere circondato da pericoli mortali, ai quali nessuno può promettere di porre rimedio senza scatenare immediatamente le risa. Catastrofi ovunque. Ciascuno può pensare, secondo la sua sensibilità personale, che il peggio sia la disoccupazione di massa o il riscaldamento climatico, il razzismo o l’immigrazione “incontrollata”, la corruzione o la persistenza delle diseguaglianze, l’inquinamento o la perdita del potere d’acquisto. Catastrofi ce ne sono e la prospettiva è negativa, come dicono le agenzie di rating.
Non è necessario essere ferocemente “contro il sistema” per fare ammettere pressoché a chiunque che le cose vanno malissimo. Basta leggere un giornale borghese di media qualità per convincersene ogni giorno che passa di più. Da questo punto di vista, sarebbe fatica inutile fondare una nuova rivista per diffondere la cattiva novella.
Ma se si tratta di accertare le cause dei mali presenti il discorso è ben diverso! Il soggetto contemporaneo si trova di fronte a una miriade di tentativi di spiegazione, il cui fattore comune è quello di non averne nessuno, e di spezzettarsi in un oceano di spiegazioni parziali.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Pantomima UE: esito, cause ed effetti
Pantomima UE: esito, cause ed effetti
di Fulvio Grimaldi
Tutto un paese nel buco nero insieme a 5 stelle?
 Il gioco è, per i
ragazzini come noi, il classico rimedio alla rabbia, al
dolore, alla noia e alla tristezza.
Purchè non sia un videogioco e lo si giochi in tanti. A
rimediare allo scorno inflitto dai risultati a tutti coloro
che non si sono fatti
abbindolare dai monopolaristi dell’ordine imperiale esistente,
né dai pigolii di una Sinistra che insiste a trasformare il
voto in bolle
di sapone, propongo il seguente giochino statistico: su cento,
quali sono le cause in percentuali che assegniamo allo
schianto dei 5 Stelle?
Perché del resto non fa conto occuparci. In Europa è la
conferma di una struttura che incarcera i popoli e non li fa
parlare neanche
dietro al vetro divisorio. Da noi è stato l’apice di una
catastrofe meticolosamente preparata, da almeno trent’anni a
questa parte.
Ma anche da molto prima. Trasformeremo in calcolo le nostre
valutazioni, a prescindere, ovviamente, dalle balle passate,
presenti e future che, sul
trapasso dei Cinque Stelle, verranno sparate dai vincitori,
tutti delegati e commessi viaggiatori del Capitale
Globalizzante, vuoi di marca George
Soros (sinistre farlocche, avanzi di Storia e Verdi), vuoi
tentacoli dello Stato Profondo militarfinanziario
internazionale (tutti i partiti pro
UE-Nato).
Il gioco è, per i
ragazzini come noi, il classico rimedio alla rabbia, al
dolore, alla noia e alla tristezza.
Purchè non sia un videogioco e lo si giochi in tanti. A
rimediare allo scorno inflitto dai risultati a tutti coloro
che non si sono fatti
abbindolare dai monopolaristi dell’ordine imperiale esistente,
né dai pigolii di una Sinistra che insiste a trasformare il
voto in bolle
di sapone, propongo il seguente giochino statistico: su cento,
quali sono le cause in percentuali che assegniamo allo
schianto dei 5 Stelle?
Perché del resto non fa conto occuparci. In Europa è la
conferma di una struttura che incarcera i popoli e non li fa
parlare neanche
dietro al vetro divisorio. Da noi è stato l’apice di una
catastrofe meticolosamente preparata, da almeno trent’anni a
questa parte.
Ma anche da molto prima. Trasformeremo in calcolo le nostre
valutazioni, a prescindere, ovviamente, dalle balle passate,
presenti e future che, sul
trapasso dei Cinque Stelle, verranno sparate dai vincitori,
tutti delegati e commessi viaggiatori del Capitale
Globalizzante, vuoi di marca George
Soros (sinistre farlocche, avanzi di Storia e Verdi), vuoi
tentacoli dello Stato Profondo militarfinanziario
internazionale (tutti i partiti pro
UE-Nato).
Ultradestra? Il bue, l’asino e le corna
Sono quelli che, per esorcizzare il loro fare la spesa al servizio dell’élite, danno a tutti gli altri la qualifica di ultradestra, xenofobi, fascisti, pensando di salvare anima e voti mettendosi dal lato buono di una dicotomia che, dai tempi di Gaber, ha poco senso, ma molto nonsense. E’ la teppa benvestita, ben nutrita e mai sazia dei “da Macron a Tsipras”.
Qualcuno, come i Verdi, è stato rimesso in pista dai manovratori della nuova accumulazione capitalista green mimetizzati da bambina svedese.
Leggi tutto
Giuseppe Montalbano: Europa, le domande mal poste e le risposte da cercare
Europa, le domande mal poste e le risposte da cercare
di Giuseppe Montalbano
Il ritorno alle monete nazionali come soluzione alla crisi dell'Ue si rivela superficiale tanto quanto l'europeismo ingenuo. Il cambiamento passa dall'analisi del modello produttivo e finanziario europeo
 Per dare
risposte alla profonda crisi economica, sociale e democratica
dell’integrazione europea, bisogna innanzitutto farsi le
giuste domande. Al contrario, nel recente dibattito a sinistra
sulla crisi europea e
sulle possibili vie d’uscita si tende ad azzuffarsi sulle
risposte, perdendo di vista proprio le domande. Ci troviamo
così con diverse
risposte ottime e sbagliate, perché formulate a partire da
questioni mal poste.
Per dare
risposte alla profonda crisi economica, sociale e democratica
dell’integrazione europea, bisogna innanzitutto farsi le
giuste domande. Al contrario, nel recente dibattito a sinistra
sulla crisi europea e
sulle possibili vie d’uscita si tende ad azzuffarsi sulle
risposte, perdendo di vista proprio le domande. Ci troviamo
così con diverse
risposte ottime e sbagliate, perché formulate a partire da
questioni mal poste.
L’uscita unilaterale dall’euro come soluzione alla crisi europea è, in questo senso, la «risposta alla domanda sbagliata», come scrivono Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana Mortágua in Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea (Rosenberg e Sellier, 2019). Un libro che mette in discussione gli stessi interrogativi e spiegazioni sulla crisi offerti dagli approcci eterodossi e postkeynesiani che fanno da sfondo al dibattito sull’euro a sinistra. Problematizzando in particolare le premesse di quelle risposte «troppo semplici» di chi propone l’uscita dalla moneta unica e il ritorno a politiche fiscali espansive. Senza offrire facili ricette alternative, ma al contrario complicando il quadro dell’analisi, il problema della moneta unica e della sua crisi viene ridefinito nei termini di una questione più generale: quella delle trasformazioni e contraddizioni dei capitalismi europei contemporanei entro cui ha fatto la sua comparsa l’euro. Una prospettiva di sistema e di lungo periodo particolarmente utile per provare a tirarci fuori, a sinistra, dalle secche di una discussione polarizzata fra euroscetticismo senza appello ed europeismo ingenuo.
Da dove cominciare per porre le domande “corrette” sull’euro e la sua crisi? Per prima cosa allargando la visuale. Da una parte l’Unione economica e monetaria (Uem) è stata il portato di una ristrutturazione dei capitalismi nazionali nel Continente nel quadro della deregolamentazione dei mercati finanziari a livello internazionale, seguita alla rottura degli accordi di Bretton Woods.
Leggi tutto
Militant: Le dure repliche della realtà
Le dure repliche della realtà
di Militant
Si ribaltano i rapporti di forza, ma il quadro rimane pressoché identico allo scorso 4 marzo: il populismo viaggia attorno al 50% dei voti, mentre l’unica alternativa politico-elettorale ad esso continua ad essere rappresentata dalle forze liberali, Partito democratico in primis, minoritarie ma non irrilevanti. Eppure, nonostante il campo continui ad essere sostanzialmente diviso in due, non tutto è perfettamente uguale a se stesso. Valutando i risultati in tutta Europa, appare chiara la ritirata politica del “populismo di sinistra”. Non tanto in Italia, dove questo veniva rappresentato contraddittoriamente dal M5S, quanto nel resto del continente. Nella Francia “sconvolta” dalle proteste dei Gilet Jaune, dove cioè si presentava la situazione migliore per capitalizzare elettoralmente una protesta sociale non predeterminata dentro i confini della reazione, France Insoumise di Mélenchon prende il 6%. A capitalizzare è solo il populismo “di destra” della Le Pen, anche questa volta primo partito transalpino. Nella Gran Bretagna della Brexit a capitalizzare la lotta alla Ue è la destra populista di Farage, col suo 32%, mentre il “compagno” Corbyn si ferma al 14% fallendo totalmente il suo patetico agnosticismo di non appoggiare né la Brexit né il “remain”. In Spagna Podemos si ferma al 10%, superato persino da Ciudadanos. E così via.
Leggi tutto
Domenico Moro: La posizione dei comunisti nei confronti di UE e euro
La posizione dei comunisti nei confronti di UE e euro
di Domenico Moro
Per i comunisti l’uscita dall’euro e dalla Ue non può che essere inserita in un percorso diretto verso il socialismo, rientrando così nella soluzione del problema della Rivoluzione in Occidente
Per i comunisti l’Ue e l’euro hanno a che fare più con il concetto di classe e di lotta di classe che con quello di patria e di nazione. Eppure, spesso i comunisti sono schiacciati tra due posizioni opposte: il cosiddetto sovranismo, che per i media è diventato sinonimo di nazionalismo, e l’europeismo, che per alcuni è diventato sinonimo di internazionalismo.
A sinistra, anche fra la sinistra cosiddetta radicale, troviamo due gruppi di posizioni sull’Europa.
Il primo è costituito da quelli per i quali l’Ue è un fatto positivo. Tra questi ci sono quelli secondo i quali l’Europa unita sancisce la fine della nazione e dello Stato. La fine della nazione sarebbe positiva perché il concetto di nazione sarebbe di per sé borghese e responsabile delle due sanguinose guerre mondiali. Nel giudizio positivo sulla fine dello Stato, invece, possiamo ravvisare una radice anarchica, secondo cui lo Stato è di per sé il male da eliminare. Infine, ci sono quelli per i quali l’Ue rappresenta la possibilità di internazionalizzare le lotte, raggiungendo il capitale al suo livello sovranazionale e dando così maggiore forza al conflitto di classe.
Leggi tutto
Stefano Alì: Radio Radicale, la convenzione statale e il liberismo a convenienza
Radio Radicale, la convenzione statale e il liberismo a convenienza
di Stefano Alì
Salvare Radio Radicale? Ma da chi e da che cosa? Si cessa una convenzione mai sottoposta a gara e mai verificata neppure nella congruità del costo per lo Stato, cioè per noi cittadini.
Reazioni inspiegabili sulla cessazione della convenzione fra lo Stato e Radio Radicale. Domande (mie) e risposte (di David Carretta)
All’interno del Decreto Crescita erano stati presentati emendamenti da parte di tutti i Gruppi Parlamentari, inclusa la Lega ed escluso solo il Movimento 5 Stelle.
Alla modica cifra di 3,5 milioni di fondi pubblici si chiedeva di prorogare la convenzione fra lo Stato e Radio Radicale per sei mesi.
In Commissioni Bilancio e Finanze occorre l’unanimità dei Gruppi, ma il Movimento 5 Stelle ha votato “No”, contro tutti gli altri. Inclusa la Lega, che ha pure presentato ricorso (respinto). Quindi gli emendamenti sono stati dichiarati inammissibili ed essendo già scaduta la convenzione, non la si può rinnovare.
Le reazioni: Salviamo la libertà, salviamo Radio Radicale
La vicenda di Radio Radicale ha suscitato reazioni da parte di tutti i partiti.
Ed ecco l’hastag #SalviamoRadioRadicale. Ecco che Roberto Giachetti ha rispolverato lo sciopero della fame e della sete.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Niamey, una città di sabbia
![]()
Niamey, una città di sabbia
di Mauro Armanino
Niamey, maggio 2019. Non fatevi ingannare dagli edifici a piani e dai cavalcavia dai nomi epici. Niamey è una città immaginata dalla sabbia. Ospiterà tra un paio di mesi l’Assemblea dell’Unione Africana e per questo arrivano in tanti a truccarla da capitale comune. Qualche hotel di lusso, un’università islamica a piani girevoli, snodi stradali che inseguono la direzione e l’ordinanza municipale che impone ai mendicanti di passare all’invisibilità dal primo di maggio. La festa dei lavoratori ha coinciso con la pulizia delle strade, cominciata dagli allievi della Scuola Nazionale della Gendarmeria e poi continuata dai cittadini stranieri suddivisi per nazionalità di provenienza. Alcuni cittadini locali sono assunti ad ore e col ‘gilet- verde-ecologico’, lavorano di notte per liberare le strade dalla sabbia che la mattina seguente rispunta, fresca di giornata, poco lontano. Niamey è in realtà una città di sabbia che passando dai ministeri, aggirando le rotonde e facilitando il digiuno ben prima e ben oltre il mese di Ramadan, si infiamma solo per l’esplosione di una cisterna di benzina. 60 i morti accertati e alcune decine gli ustionati gravi ancora in pericolo di vita. Terminato il lutto nazionale, c’è da giurarlo, sarà ancora la sabbia a coprire le rotaie del treno, anch’esso di sabbia, che mai raggiungerà la città di Dosso con la stazione di arrivo. Solo per attimo, in questa drammatica esplosione, la città reale era apparsa. La città che sopravvive di niente perchè tutto spera dalla clemenza della sabbia divina.
Leggi tutto
di Domenico Moro, Fabio Nobile
 Il periodo attuale è uno dei
peggiori di sempre, sia per il movimento comunista sia per la
classi subalterne, in
Europa e soprattutto in Italia. Le trasformazioni
dell’economia mondiale hanno indebolito la classe lavoratrice
europea occidentale, esponendola
all’aggressione del mercato autoregolato, che ha ridotto
occupazione e salari reali, nel mentre si annullava,
attraverso l’integrazione
europea, la sovranità democratica, sancita dalla Costituzione,
ossia la capacità delle classi subalterne di incidere sulle
decisioni di
politica economica e sociale.
Il periodo attuale è uno dei
peggiori di sempre, sia per il movimento comunista sia per la
classi subalterne, in
Europa e soprattutto in Italia. Le trasformazioni
dell’economia mondiale hanno indebolito la classe lavoratrice
europea occidentale, esponendola
all’aggressione del mercato autoregolato, che ha ridotto
occupazione e salari reali, nel mentre si annullava,
attraverso l’integrazione
europea, la sovranità democratica, sancita dalla Costituzione,
ossia la capacità delle classi subalterne di incidere sulle
decisioni di
politica economica e sociale.
Le profonde trasformazioni economiche hanno avuto come necessario corrispettivo modifiche politiche altrettanto profonde. Il crollo dell’Urss e dei Paesi socialisti ha contribuito pesantemente al peggioramento dei rapporti di forza tra capitale e lavoro, e in Italia ha contribuito a trasformare il Pci, separandolo in due tronconi. Uno, il più grande, si è trasformato in partito liberaldemocratico, che da subito si è collocato a destra, facendosi alfiere dell’integrazione economica e valutaria europea e rappresentante del grande capitale internazionalizzato. Soprattutto, questo troncone è stato fautore del maggioritario, che ha spostato al centro, cioè sugli interessi dello strato superiore del capitale, l’asse della politica. Ciò si è tradotto nella trasformazione profonda del nostro Paese, attraverso massicce privatizzazioni e pesanti controriforme del mercato del lavoro, delle pensioni, e del welfare.
Il Partito della rifondazione comunista (Prc) ha raccolto il più piccolo dei due tronconi in cui si era diviso il Pci, aggregando anche una serie di altre organizzazioni e di individualità, che non accettavano di identificare la fine dell’Urss con la fine della prospettiva socialista. Il nome stesso del partito è significativo del senso originario del progetto: non la riproposizione sic e simpliciter del Pci ma, correttamente, la rifondazione di una teoria e di una pratica comuniste e adatte a un’epoca nuova. In realtà, negli ultimi anni la “Rifondazione” è stata intesa in modo diverso da parte della maggioranza del Partito, cioè come presa di distanza da quella parte del movimento comunista legata alla storia dell’Urss e identificata in quanto tale come “stalinista”.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Sulla giustizia
![]()
Sulla giustizia
di Salvatore Bravo
 La scomparsa delle
parole
La scomparsa delle
parole
Lo stato presente ha la sua verità nella signoria della merci, i tavoli ballano, affermava Marx, come se avessero vita propria, tanto più signoreggiano i dominanti quanto più il controllo del linguaggio, il suo declinarsi nella forma del calcolo o della chiacchiera erode spazi di significato della politica. Vi è comunità solo se vi è politica, il fondamento, la casa della politica come della comunità, parafrasando Heidegger, è il linguaggio. Si assiste al teatrino del nichilismo dei significati, ci si confronta sul nulla, fingendo di essere su posizioni politiche opposte pur governando assieme, il riferimento è alla perenna scenetta tragicomica Di Maio-Salvini. In realtà non si tratta di casi politici, ma del sintomo di una malattia endemica dovuta alla signoria del valore di scambio. L’attuale teatrino, ormai quotidiano, non è che l’espressione di un corpo infetto interno a relazioni politiche segnate dai processo liberistici di mercificazione. Sono venute a mancare le parole-valori della politica, parole che fungono da catalizzatrici per i programmi politici. Tali parole sono scomparse dal linguaggio, al loro posto non vi è che la violenza della pancia, parole-insulti il cui fine è distogliere lo sguardo dalla razionalità dell’accadere per orientarlo verso la violenza, verso obiettivi secondari. Vi sono parole che l’ordine del discorso del turbocapitalismo, mette in circolazione per colonizzare l’immaginario al fine di anestetizzare i significati disfunzionali al sistema capitale.
La parola della politica, della comunità di cui nessuno osa proferire parola, è la parola giustizia. La filosofia politica dell’occidente nella sua storia ha fatto della giustizia la pietra miliare della discussione politica. Giustizia è metron per i Greci, si pensi alla giustizia commutativa-regolatrice e distributiva in Aristotele (Etica Nicomachea libro V). Nel Vangelo il miracolo dei pesci e dei pani, riportatato da tutti gli evangelisti, nell’interpretazione di Massimo Bontempelli e Costanzo Preve significa simbolicamente che se c’è giustizia, c’è razionalità e dunque equa distribuzione, per cui ce n’è per tutti.
Leggi tutto
Luca Micaloni: Dall’anima semovente al ‘soggetto automatico’
Dall’anima semovente al ‘soggetto automatico’
Stratificazioni filosofiche nel concetto di ‘capitale’ e nell’analisi marxiana del sistema di macchine
di Luca Micaloni*
 1.
Introduzione
1.
Introduzione
Nel corso dei capitoli XII e XIII del Libro primo del Capitale l’applicazione delle macchine alla produzione acquisisce una crescente centralità teorica. Se nell’indagine dedicata al “periodo” della manifattura le macchine svolgono un ruolo ancora secondario rispetto al principio “architettonico” della «divisione del lavoro», esse divengono invece elemento decisivo nell’analisi della grande industria, sia ove la si consideri come specifica fase evolutiva del modo di produzione capitalistico, sia quando si abbia di mira una connotazione rigorosa del suo ruolo “sistematico” come tappa dell’esposizione del Capitale.
Il passaggio d’epoca e il mutamento del principio strutturante sono riferiti già dai titoli: Divisione del lavoro e manifattura per il cap. XII, Macchine [Maschinerie] e grande industria per il capitolo XIII. Mentre la funzione economico-politica della Maschinerie (come anche della divisione del lavoro) si annuncia già nella collocazione dei capitoli: entrambi, assieme al capitolo XI sulla Cooperazione, compongono infatti la sezione quarta del Libro primo, che ha per oggetto La produzione del plusvalore relativo. Già capace di sussumere la forza-lavoro “formalmente” attraverso l’anticipazione del salario e di estrarre, mediante l’uso della forza-lavoro, un plusvalore «assoluto» in seguito al prolungamento della giornata lavorativa ripartita in «lavoro necessario» e «pluslavoro», ora il capitale è in grado – in forza di successive ottimizzazioni o “rivoluzioni” tecnologiche – di massimizzare il plusvalore «relativo» (diminuire, cioè, il lavoro necessario attraverso l’intensificazione del lavoro e la maggiore efficienza dei processi, mantenendo costante la durata della giornata lavorativa); il capitale riesce, inoltre, a perfezionare la sussunzione della forza-lavoro sottraendo ai suoi portatori il controllo dell’attività lavorativa, affidandone la regolazione alla quota della sua parte “fissa” costituita dalle macchine, prodotte e impiegate grazie alle «potenze intellettuali [geistige]» che si separano dal lavoro esecutivo e gli si contrappongono come «poteri del capitale sul lavoro» (Marx 1991, 381; trad. it. 462).
Leggi tutto
Aldo Giannuli: Una prima valutazione dei risultati delle europee 2019
Una prima valutazione dei risultati delle europee 2019
di Aldo Giannuli
Ovviamente per una analisi più accurata mancano ancora molti dati a partire da quelli in cifra assoluta e non percentuale e da quelli disaggregati sul territorio, qui possiamo fare solo una prima valutazione sulle tendenze più evidenti, ictu oculi. Il primo dato evidentissimo è che si conferma l’andamento “ciclonico” dei flussi elettorali che si muovono “a valanga”. Nel 2009 il Pdl di Berlusconi ebbe il 35,26% dei voti, ma quattro anni dopo, nelle politiche del 2013, prese solo il 21,56% .
Nel 2014 il Pd ebbe il 40,8%, ma 4 anni dopo, nelle politiche del 2018, ebbe il 18,76% andando oltre il dimezzamento. Nelle stesse politiche del 2018 il M5s ebbe il 32,68% ed oggi, dopo solo un anno (sono stati più bravi degli altri) sono (dovrebbero essere) al 17% stando alle proiezioni dell’ora in cui scriviamo.
Dunque quella di picchi straordinari seguiti da rovinose cadute in pochissimo tempo è ormai una costante che dura da 10 anni. Gli italiani sembrano alla costante ricerca di un nuovo pivot del sistema politico e ci provano prima con Forza Italia poi con il Pd, poi con i 5 stelle per poi ritrarsene subito violentemente. Un susseguirsi velocissimo di illusioni e delusioni.
Con ogni evidenza, i flussi elettorali principali sono stati:
Leggi tutto
Stefano G. Azzarà: Je suis Huawei, il Manifesto è Trump
Je suis Huawei, il Manifesto è Trump
di Stefano G. Azzarà
Nella contraddizione principale la sinistra italiana è sempre dalla parte dell'imperialismo.
L'essere sociale è strutturalmente scisso e dunque il conflitto è la trama ontologica stessa del reale. Tutto è in questo senso conflittuale e esiste una fenomenologia infinita della conflittualità.
Sempre e comunque bisogna prendere posizione in questa miriade di conflitti? No.
In un conflitto non sempre è necessario prendere partito per l'uno o per l'altro perché è possibile che esso non sia che un momento di un conflitto più grande nel quale entrambe le parti sono ricomprese.
Ad esempio, la scelta tra Hillary e Trump, presentata a suo tempo come una scelta epocale che avrebbe cambiato i destini del mondo e inaugurato un'epoca di pace populista, era una scelta fasulla, perché si trattava di una lotta tra due frazioni del capitale statunitense tutta interna al campo delle destre contemporanee e delle compatibilità sistemiche.
Una posizione netta è invece necessario prendere in un solo caso e cioè quando ci si trova di fronte non a un conflitto come tanti ma alla contraddizione principale, che sul piano storico-politico è quella tra l'imperialismo e chi è aggredito dall'imperialismo. Tra chi pretende di dominare il mondo e chi subisce questa dominazione.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Effetto Tsipras
Effetto Tsipras
di Andrea Zhok
Talvolta alcuni amici mi rimproverano di prendermela troppo con la 'sinistra', anche se ci sarebbero forze politiche nella realtà italiana assai più problematiche e impresentabili.
C'è del vero in questo giudizio. Prendersela con chi in qualche modo è, o è stato, più vicino può venire istintivo nella speranza di cambiare il modo di pensare di 'potenziali compagni di strada' (mentre magari criticare i berluscones, per dire, sembra tempo perso).
Tuttavia credo ci siano altre e più importanti ragioni per queste critiche, ragioni che sono insieme di principio e operative.
Per comprendere questo punto è opportuno gettare uno sguardo alla parabola politica di Alexis Tsipras in Grecia.
Domenica Syryza ha subito una drammatica sconfitta da parte di Nea Demokrateia (ND) e si andrà ad elezioni anticipate. E' importante capire cosa rappresentano queste due forze nella storia greca degli ultimi decenni.
ND è il partito che ha truccato i conti e che ha aperto la strada alla crisi e alla macellazione sulla pubblica piazza dell'intero paese; nell'immediatezza della crisi era un partito pressoché finito.
Syryza invece era emerso tumultuosamente da partito dell'estrema sinistra minoritaria a prima forza nazionale proprio perché rappresentava una forza radicale, percepita come 'pulita' e capace di difendere i lavoratori in un momento di grave crisi.
Leggi tutto
Stefano D’Andrea: «Non ci sarà mai retromarcia su trattati UE. Recesso unica via»
«Non ci sarà mai retromarcia su trattati UE. Recesso unica via»
Intervista a Stefano D’Andrea
Stefano D’Andrea, classe 1970, giurista, è il Presidente del Fronte Sovranista Italiano
Siete una formazione relativamente giovane, ma in crescita. Si può dire che raccogliete i delusi dai partiti e movimenti tradizionali?
Forse in parte sarà vero ma in realtà aggreghiamo e non raccogliamo e aggreghiamo soprattutto persone che da lungo tempo sono deluse dai «partiti tradizionali». Quasi nessuno di noi, se non proprio nessuno, ha militato in un partito tradizionale, salvo i più maturi, che vi hanno militato dieci o spesso venti anni fa.
Anche fazioni come Casapound e Partito Comunista hanno una posizione molto critica verso l’UE e la sua gestione politico-economica. Esistono sovranismi di destra e di sinistra? Voi come vi collocate?
Destra e sinistra sono parole che designano soltanto la collocazione nel Parlamento e si colorano di volta in volta di contenuti diversi. I liberali nell’ottocento furono sinistra rispetto ai reazionari ma poi furono destra nei confronti di coloro che cominciarono a porre la questione sociale e ai socialisti.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3609
Hits 3246
Hits 3086
Hits 2816
Hits 2709
Hits 2606
Hits 2455
Hits 2114
Hits 2051
tonino

Alessandro Visalli: Paul Baran, “Il ‘surplus’ economico”
Paul Baran, “Il ‘surplus’ economico”
di Alessandro Visalli
 Il libro di Paul Alexander Baran è
del
1957 ed è un classico del pensiero marxista americano dello
sviluppo. Il sottotitolo in italiano dell’opera è “e la
teoria marxista dello sviluppo” (in inglese “The
political economy of growt”) ed è una delle matrici
intellettuali della teoria dello sviluppo, ripresa da autori
fondamentali come Andre Gunder Frank[1], Samir Amin[2],
ed in parte Giovanni Arrighi[3]. Nel 1966, due anni dopo la
morte, viene
pubblicata l’opera per la quale è più famoso in Italia, ovvero
“Il capitale monopolistico”, con Paul
Sweezy”.
Il libro di Paul Alexander Baran è
del
1957 ed è un classico del pensiero marxista americano dello
sviluppo. Il sottotitolo in italiano dell’opera è “e la
teoria marxista dello sviluppo” (in inglese “The
political economy of growt”) ed è una delle matrici
intellettuali della teoria dello sviluppo, ripresa da autori
fondamentali come Andre Gunder Frank[1], Samir Amin[2],
ed in parte Giovanni Arrighi[3]. Nel 1966, due anni dopo la
morte, viene
pubblicata l’opera per la quale è più famoso in Italia, ovvero
“Il capitale monopolistico”, con Paul
Sweezy”.
Baran è negli anni sessanta l’unico economista di ruolo negli Stati Uniti ad ispirarsi alla teoria marxista, è ordinario a Stanford dal 1951 fino alla morte. Dalla sua biografia si ricava il padre menscevico che lascia la Russia nel 1917, gli studi ed il dottorato a Berlino nel 1933 (quando lui, nato nel 1909 ha 24 anni), quando incontra e discute con Rudolf Hilferding, la fuga a Parigi e poi in Urss. Poco prima dell’invasione tedesca l’arrivo negli Stati Uniti e l’iscrizione ad Harvard, il lavoro con Galbraith e poi al Dipartimento del Commercio ed alla Fed di New York. Dal 1949 è a Stanford e collabora con Monthly Review di Sweezy e Leo Huberman. Nel 1960, dopo questo libro, visita Cuba, poi Mosca, l’Iran e la Jugoslavia. Mentre lavora al “Capitale Monopolistico” muore improvvisamente per un attacco di cuore.
Questo libro, “The political economy of growt” ha esercitato a lungo un’influenza sulle forze anticapitaliste che operavano nei paesi in via di sviluppo, o, come Baran preferisce scrivere “sottosviluppati”, e si inserisce a pieno titolo in una linea genealogica di autori e saggi marxisti sull’imperialismo che vede superare ed inglobare l’analisi marxiana del colonialismo (che pure anticipa molti temi) con le analisi di Lenin, “L’imperialismo, fase suprema del capitalismo”, del 1916, anticipate da John Hobson, “Imperialism, a study”, del 1902, Rudolf Hilferding, “Il capitale finanziario”, del 1910, e Rosa Luxemburg, “L’accumulazione del capitale”, del 1913.
Leggi tutto
Franck Fischbach: Liberare il lavoro, o liberarsi dal lavoro?
Liberare il lavoro, o liberarsi dal lavoro?
Simone Weil lettrice di Marx
di Franck Fischbach
 Nel suo libro scritto nel 1934, le
"Riflessioni sulle cause della libertà e
dell'oppressione sociale",
Simone Weil redige un primo capitolo che
intitola «Critica del marxismo». Mi
propongo qui di
esaminare quel capitolo, al fine di determinare la natura e la
portata delle critiche che Weil rivolge al
«marxismo». Ma indubbiamente bisogna
aggiungere immediatamente che la prima questione che qui si
pone, alla
lettura di questo capitolo e di tutto il libro stesso, è
quella di sapere e determinare a chi sia rivolta la critica, o
piuttosto le critiche
formulate da Weil: se ci si attiene al titolo del capitolo,
appare evidente che l'oggetto della critica sia il
«marxismo», ma, leggendo il testo,
si constata che nessun «marxista»,
nessuna corrente del «marxismo», né
- come direbbe Ètienne Balibar - alcuno
"dei" marxismi viene mai citato, e che alla fine le
critiche di Weil sono tutte rivolte a Marx in persona. Da
parte di Weil, questo
può significare una pura e semplice assimilazione di Marx al
(ai) marxismo(i): pertanto fa uso dell'espressione «Marx
e i
suoi seguaci», senza fare alcuna distinzione
fra gli stessi «seguaci», e,
soprattutto,
inscrivendo tali «seguaci» in
diretta continuità con Marx, sulla base di una qualche sorta
di principio
secondo cui essi sono tutti dei fedeli discepoli del maestro,
ed hanno proseguito l'opera teorica e pratica sulla base dei
principi di Marx stesso.
Insomma, in breve, sembrerebbe che, per Weil, Marx ed il
marxismo siano una sola ed unica cosa. Non la rimprovereremo
qui per questo, considerando che
questo gesto di assimilazione del marxismo allo stesso Marx è
perfettamente comprensibile, essendo la Weil un'autrice che
scrive nel 1934.
Ciò detto, è proprio a partire da questi anni che comincia a
diventare possibile non assimilare più immediatamente Marx ed
il
marxismo, e questo soprattutto proprio grazie alla
pubblicazione nel 1932 dei "Manoscritti del 1844"
e de "L'ideologia
tedesca" - due testi che Simone Weil perciò aveva
potuto conoscere quando aveva scritto le sue "riflessioni".
Nel suo libro scritto nel 1934, le
"Riflessioni sulle cause della libertà e
dell'oppressione sociale",
Simone Weil redige un primo capitolo che
intitola «Critica del marxismo». Mi
propongo qui di
esaminare quel capitolo, al fine di determinare la natura e la
portata delle critiche che Weil rivolge al
«marxismo». Ma indubbiamente bisogna
aggiungere immediatamente che la prima questione che qui si
pone, alla
lettura di questo capitolo e di tutto il libro stesso, è
quella di sapere e determinare a chi sia rivolta la critica, o
piuttosto le critiche
formulate da Weil: se ci si attiene al titolo del capitolo,
appare evidente che l'oggetto della critica sia il
«marxismo», ma, leggendo il testo,
si constata che nessun «marxista»,
nessuna corrente del «marxismo», né
- come direbbe Ètienne Balibar - alcuno
"dei" marxismi viene mai citato, e che alla fine le
critiche di Weil sono tutte rivolte a Marx in persona. Da
parte di Weil, questo
può significare una pura e semplice assimilazione di Marx al
(ai) marxismo(i): pertanto fa uso dell'espressione «Marx
e i
suoi seguaci», senza fare alcuna distinzione
fra gli stessi «seguaci», e,
soprattutto,
inscrivendo tali «seguaci» in
diretta continuità con Marx, sulla base di una qualche sorta
di principio
secondo cui essi sono tutti dei fedeli discepoli del maestro,
ed hanno proseguito l'opera teorica e pratica sulla base dei
principi di Marx stesso.
Insomma, in breve, sembrerebbe che, per Weil, Marx ed il
marxismo siano una sola ed unica cosa. Non la rimprovereremo
qui per questo, considerando che
questo gesto di assimilazione del marxismo allo stesso Marx è
perfettamente comprensibile, essendo la Weil un'autrice che
scrive nel 1934.
Ciò detto, è proprio a partire da questi anni che comincia a
diventare possibile non assimilare più immediatamente Marx ed
il
marxismo, e questo soprattutto proprio grazie alla
pubblicazione nel 1932 dei "Manoscritti del 1844"
e de "L'ideologia
tedesca" - due testi che Simone Weil perciò aveva
potuto conoscere quando aveva scritto le sue "riflessioni".
Leggi tutto
Ufficio Politico Partito Comunista: Per una prima analisi del voto, e prospettiva del Partito Comunista
Per una prima analisi del voto, e prospettiva del Partito Comunista
di Ufficio Politico Partito Comunista
 L’esito delle elezioni
europee in Italia ha segnato un generale avanzamento delle
forze di destra (Lega Nord e
Fratelli d’Italia). I Cinque Stelle escono fortemente
ridimensionati perdendo sia nei confronti del loro alleato di
governo, che cannibalizza i
consensi della coalizione, sia dal recupero del Partito
Democratico, la cui strategia è evidentemente quella di
accreditarsi come unica
alternativa possibile a Salvini nel quadro di un rinnovato
centrosinistra.
L’esito delle elezioni
europee in Italia ha segnato un generale avanzamento delle
forze di destra (Lega Nord e
Fratelli d’Italia). I Cinque Stelle escono fortemente
ridimensionati perdendo sia nei confronti del loro alleato di
governo, che cannibalizza i
consensi della coalizione, sia dal recupero del Partito
Democratico, la cui strategia è evidentemente quella di
accreditarsi come unica
alternativa possibile a Salvini nel quadro di un rinnovato
centrosinistra.
I consensi ottenuti da Lega e Fdi ricalcano comunque l’area di voti per anni tenuta dal centrodestra e dal Pdl ai tempi di Berlusconi. La radicalizzazione a destra di quest’area è frutto della strategia del centrosinistra e del Partito Democratico, frutto delle precise responsabilità del gruppo dirigente renziano e della funzione del Movimento Cinque Stelle che ha traghettato una parte dei suoi voti verso la Lega.
La Lega si è accreditata negli strati popolari con una propaganda anti-sistema, pur rappresentando specifici settori capitalistici. Ha utilizzato il tema dell’immigrazione come strumento di costruzione di un legame identitario, alimentando il nazionalismo con una strategia perfettamente riconducibile agli interessi di quei settori delle imprese italiane maggiormente penalizzate dal mercato unico europeo. Ha cavalcato il tema della sicurezza per introdurre una ulteriore stretta repressiva sulle lotte sociali e gli scioperi utile a colpire i lavoratori e le classi popolari.
Il Movimento Cinque Stelle paga il tradimento degli elementi più radicali della sua proposta che sono caduti ad uno ad uno di fronte alla contraddizione del governo nel sistema di compatibilità capitalistiche e con l’alleanza con la Lega.
La riarticolazione del peso delle forze di Governo spinge a ritenere probabile la futura caduta di questo esecutivo, prossimo a dover affrontare la finanziaria con clausole e politiche lacrime e sangue che i vertici europei e i settori del grande capitale italiano non ritengono più rimandabili per soddisfare le promesse elettorali.
Leggi tutto
Thomas Fazi: Il fallimento delle sinistre
Il fallimento delle sinistre
di Thomas Fazi
Articolo definitivo di Wolfgang Streeck uscito su Jacobin Magazine sulle ragioni del fallimento delle sinistre europee all'ultima tornata elettorale:
«La ragione principale dell fallimento delle sinistre è l’assenza pressoché totale di una realistica strategia anti-capitalistica, o anche solo anti-neoliberale, relativa all’UE. A sinistra non ci si chiede nemmeno se l’UE possa veramente essere un veicolo per una strategia anti-capitalistica.
Piuttosto, continua a prevalere a sinistra un’accettazione ingenua o opportunistica di quell’’"europeismo" buonista così popolare tra i giovani e che viene abilmente sfruttato dai partiti di centro e dai tecnocrati europei per legittimare il regime neoliberista.
A sinistra non si fa menzione di come la costituzione economica dell’Unione europea renda impossibile qualunque programma anti-capitalistico o anche solo pro-labour, in virtù del liberismo incarnato nei trattati (le "quattro libertà"), della dittatura di fatto della Corte europea di giustizia e dell’austerità imposta dall’euro.
Qualsiasi discussione critica sulla principale politica sociale dell’UE – la libera circolazione del lavoro tra paesi economicamente molto diversi tra loro – viene rigorosamente evitata, e anzi viene sostituita da una vaga simpatia per l’idea delle frontiere aperte, anche tra l’UE e il mondo esterno.
Leggi tutto
Stefano Fassina: Basta letture consolatorie. All’Europa serve una svolta nazionale-popolare e keynesiana
Basta letture consolatorie. All’Europa serve una svolta nazionale-popolare e keynesiana
di Stefano Fassina
Amarissimo risultato nelle elezioni europee, purtroppo largamente atteso. Si accentua l’avanzata delle forze nazionaliste, in linea con quanto emerso alla superficie elettorale a partire dal 23 Giugno 2016 (maggioranza pro-Brexit nel Regno Unito, vittoria di Trump negli Usa, travolgente affermazione anti-establishment nel referendum costituzionale in Italia, arretramenti dei partiti mainstream e successi dei partiti “populisti”, in particolare nazionalisti, in un filotto di elezioni politiche: dalla Germania alla Francia, dall’Italia all’Austria, oltre che a Est).
Alla luce degli esiti del voto in Francia, Italia, Regno Unito e in forme diverse in Germania, per rimanere ai Paesi core, è consolatoria e preoccupante la lettura dei grandi media, soddisfatti perché “i sovranisti non hanno sfondato”.
L’incancrenita grande coalizione alla guida da decenni delle istituzioni Ue perde di gran lunga la maggioranza: si ferma a 76 eletti in meno, senza contare i seggi degli Orban dentro il Ppe, mentre la celebrata ascesa dei Liberali e dei Verdi porta i due gruppi allo stesso numero di seggi raggiunto dai 3 gruppi in cui si articola il fronte Salvini-Le Pen-Kaczyński-Farage.
Arretrano non soltanto le sinistre storiche, dentro e fuori la famiglia socialista europea, ma anche i “populisti” di sinistra, come La France Insoumise di Mèlenchon e Podemos di Iglesias, e i “populisti” presunti post-ideologici, come il nostro M5S.
Leggi tutto
Francesco Galofaro: La guerra commerciale tra Huawei e Google
La guerra commerciale tra Huawei e Google
Non tutto il male viene per nuocere
di Francesco Galofaro
Come è noto, il 20 maggio scorso le borse di tutto il mondo hanno conosciuto attimi di panico: in contemporanea, Google, Intel, Qualcomm e Broadcom hanno annunciato di non voler più rapporti con il gigante della telefonia cinese, Huawei. La decisione va inquadrata nella più ampia guerra tra multinazionali – supportate dalle rispettive superpotenze - per fissare lo standard tecnologico della nuova rete 5G. Si tratta di garantire un accesso veloce a Internet non solo per i cellulari, ma anche per la rete fissa, in tutti quei casi in cui è economicamente non conveniente portare la fibra ottica a casa del cliente (finanza.com). In particolare, lo scontro vede in prima linea la Cina, con Huawei, e gli USA, con Qualcomm.
Il boicottaggio di Google è solo l’ultimo atto di una guerra senza esclusione di colpi, che ha visto perfino l’arresto – in Canada – di Meng Wanzhou, dirigente della compagnia e figlia dell’amministratore di Huawei (marx21.it). Gli Stati Uniti stanno ricorrendo ad ogni mezzo, leale o meno, pur di distruggere la compagnia cinese.
Ora: non tutto il male viene per nuocere. Se Google può comportarsi in questo modo è perché in questi anni ha acquisito una posizione di monopolio indiscutibile nel mercato dei cellulari e dell’informazione in genere.
Leggi tutto
F.S.: Cina: dal maoismo al confucianesimo
Cina: dal maoismo al confucianesimo
di F.S.
Come ha più volte dichiarato Xi Jinping, il confucianesimo è l’identità cinese. Di conseguenza, il maoismo distruggendo il confucianesimo nel corso della “grande rivoluzione culturale” ha annientato l’identità cinese, soccorrendo scioccamente la grande borghesia tecnocratica interna, filo-occidentale, avanzante contro il “partito confuciano” di Lin Biao (Cfr. Qiu Jin, Il potere della cultura, Beijing 1999), il fronte dei soldati e dei contadini.
Volgarizzando e semplificando, l’occidente imperialista interpreta tuttora il denghismo come confucianesimo (cfr. Kissinger, La Cina). Si porta, a base ideologica del presunto utilitarismo confuciano di Stato innalzato nella fase postmaoista, la sineddoche denghiana “arricchirsi è glorioso”. Questo è pero un procedimento ermeneutico scorretto. Il confucianesimo non significa utilitarismo né materialismo, ma invece, come spiega correttamente il professor Arena, un idealismo morale e comunitaristico organicistico del “giusto mezzo” e della “armonia”. Il confucianesimo non unicizza assolutisticamente il materialismo (come fanno l’occidente e l’ebraismo) né lo spiritualismo (come fanno talune filosofie orientali). L’ideale dell’Armonia è il fondamento etico della ortoprassi confuciana. 和谐 “héxié” è il termine che noi in italiano traduciamo con “Armonia”.
Leggi tutto
Andrea Zhok: E il Piave mormorò...
E il Piave mormorò...
di Andrea Zhok
Un commento appare necessario, a seguito della proposta di Pino Cabras che ho condiviso ieri.
Qualcuno, meccanicamente, ha sollevato rispetto a quel passo (e a me che lo avevo condiviso) l'accusa di 'altroeuropeismo'.
Con 'altroeuropeismo si intende l'idea, ritenuta illusoria, che l'UE sia riformabile dall'interno e che quella sia la strada giusta da percorrere.
Ecco, a questo proposito una cosa va chiarita.
Personalmente sono convinto dell'irreformabilità dell'UE, tuttavia non posso evitar di constatare che numerosissime persone, pur riconoscendo le criticità degli ordinamenti europei, ad oggi non sono di questo avviso.
Ed è un dato di fatto che senza il consenso di un'amplissima parte degli italiani nessun passo deciso in direzione di un'uscita dalla moneta unica può essere ragionevolmente tentato.
Dunque lamentare che non si chieda una 'decisa spallata', nel momento in cui quella decisa spallata porterebbe solo alla frattura della spalla, non è saggio.
Ora, però, mentre la questione della riformabilità o irreformabilità dell'UE (e dunque della BCE) possono essere oggetto di contesa razionale (dopo tutto si tratta di volontà politiche, in linea di principio mutevoli), su una cosa credo che come italiani ci sia l'obbligo razionale di fare fronte comune.
Leggi tutto
Ancora sulle elezioni europee
Ancora sulle elezioni europee
(Qui il precedente)
Il mea culpa che dovrebbe fare il M5S
di Nicoletta Forcheri
Dove hanno sbagliato i 5s? E’ anni che sbagliano i 5s, è anni che glielo diciamo ma visto che UNO UGUALE UNO per loro non esistono pensatori, intellettuali, persone di cultura, ricercatori, da ascoltare più di altri. Anzi, chiunque abbia criticato, in questi anni, pubblicamente, era assimilato d’ufficio ai nemici del movimento.
Non si può spacciare per democrazia diretta una piattaforma informatica di proprietà di un imprenditore in odore di conflitto di interessi perché piazza i suoi uomini ed emana direttive all’interno del suo partito. O meglio si può, ma allora non è più democrazia diretta, è esattamente il suo contrario, un partito come altri. Lui non è stato votato, quindi perché dovrebbe valere più di uno?
Elezioni europee: cambiare tutto per non cambiare niente
di Alessandro Somma
Le elezioni europee non ci consegnano un Parlamento dell’Unione dominato dai cosiddetti sovranisti: questi trionfano in alcuni Paesi, Italia in testa, ma arretrano in altri e complessivamente non sfondano, anche se incrementano la loro rappresentanza a Bruxelles. Non è però da simili dati che possiamo avere riscontro del peso che la destra xenofoba ha acquisito nel Vecchio continente. Il suo principale successo lo ha infatti ottenuto nel momento in cui è riuscita a cavalcare una particolare caricatura dello scontro politico in atto: quella per cui esso oppone Salvini e i suoi sodali a una composita alleanza che parte dal leader greco Tsipras e arriva sino al francese Macron.
Questa caricatura ha schiacciato il confronto elettorale entro uno schema tipicamente populista: da un lato i rappresentanti del popolo, i sovranisti, e dall’altro i rappresentanti delle élite, Socialisti e Popolari europei in testa.
Euro: tutti si preparano alla rottura per limitare i danni?
di Giuseppe Masala*
Diciamocela tutta. L'Euro come moneta è moribonda dal 2011. Quando saltarono in aria Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda e l'Italia si salvò per il rotto della cuffia.
Da allora, piaccia o non piaccia la politica economica è cambiata: il controllo del saldo della partite correnti è diventato ferreo in tutti i paesi dell'area. Hanno iniziato a rientrare tutti compresa la Spagna che è passata da un 100% di pil di posizione finanziaria netta sull'estero all'85%. La strada è quella, inutile far finta di nulla. Ora, guardiamoci in faccia: non esiste una moneta dove ogni singola area della zona valutaria tenga rigidamente sotto controllo i conti con l'estero (considerando come estero aree che hanno la stessa moneta a corso legale).
Questioni di fede
di Pino Cabras
Perfino il grande vincitore di queste elezioni europee in Italia, Matteo Salvini, non cede per ora alla tentazione di inquadrarle nel solo contesto italiano, dove sarebbe apparentemente più facile passare all’incasso di questo risultato per andare all’arrembaggio degli equilibri di governo. C’è un progetto più vasto e meno contingente.
Quel rosario sfoggiato nella sua conferenza stampa, pur maldestramente brandito con una curiosa simbologia di croce rovesciata (la impugna sempre a testa in giù), allude a un’operazione ideologica più estesa, di portata continentale, a cui Salvini partecipa con la protezione di Steve Bannon, il patrocinatore ideologico della campagna presidenziale di Trump.
Elezioni europee: le rovine dopo la battaglia
di Jacques Sapir
Lucido e dettagliato come sempre, Jacques Sapir analizza i risultati delle elezioni europee in Francia.Per molti aspetti una lezione utile anche alle forze politiche italiane: mostra per esempio l’irrilevanza cui si sono condannate le diverse, microscopiche liste sovraniste, divise tra loro e ferme a percentuali insignificanti, utili solo alla dispersione del voto. Il crollo di La France Insoumise al 6,5% rappresenta inoltre il prezzo da pagare per una linea politica confusa, in cui ci si è voluti separare dai sovranisti di sinistra e ora tentata di condannarsi definitivamente all’ininfluenza se, a fronte della buona affermazione del RN, cederà a quell’antifascismo retorico e farlocco che conosciamo bene, in tutta la sua vacuità, anche in Italia. Nel complesso, la vera forza di Emmanuel Macron, punito dagli elettori, sta nella dispersione e frammentazione delle opposizioni
Successo non pienissimo per il Rassemblement National, sconfitta attenuata per En Marche, una mezza sorpresa per gli ambientalisti e opposizione per il resto atomizzata, sia a destra che a sinistra: ecco il panorama politico che sta emergendo dopo le elezioni europee. Se gli avversari di Macron vogliono contare qualcosa, dovranno avviare cambiamenti radicali.
Sergio Cesaratto: Lettera UE all'Italia
Lettera UE all'Italia
Le mosse da non sbagliare con l’Europa
Marco Biscella intervista Sergio Cesaratto
In arrivo lettera della Commissione sul debito pubblico. L’Italia dovrebbe rispondere con una proposta ragionevole: stabilizzazione del debito/Pil in cambio di tassi bassi
 Lo spread sopra area
280 e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre
Moscovici, che annuncia: “Avrò uno scambio di vedute con il
Governo italiano
su misure aggiuntive che potrebbero essere richieste per
essere in linea con le regole”. Il giorno prima, in
conferenza stampa Matteo Salvini,
forte del suo 34% di voti, aveva commentato così il
risultato di domenica: “È in arrivo una lettera della
Commissione europea
sull’economia del nostro Paese e penso che gli italiani
diano un mandato forte a me e al Governo di ridiscutere in
maniera pacata parametri
vecchi e superati”. Con un’idea ben precisa in testa:
“Proviamo a salvare questa Europa, riportandola alle sue
radici e al suo sogno
originario. Sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e
la Commissione europea saranno amici dell’Italia. È cambiata
la geografia in
Europa”. Sarà davvero così? Come cambieranno i rapporti tra
Italia e Unione europea? E soprattutto, su politiche
espansive, lotta
all’austerity e conti pubblici quali sponde troverà la Lega
nel nuovo Parlamento europeo? Lo abbiamo chiesto a Sergio
Cesaratto,
professore di Economia politica all’Università di Siena, che
si aspetta, per l’Italia, “una fase molto
dura”.
Lo spread sopra area
280 e il commissario europeo agli Affari economici, Pierre
Moscovici, che annuncia: “Avrò uno scambio di vedute con il
Governo italiano
su misure aggiuntive che potrebbero essere richieste per
essere in linea con le regole”. Il giorno prima, in
conferenza stampa Matteo Salvini,
forte del suo 34% di voti, aveva commentato così il
risultato di domenica: “È in arrivo una lettera della
Commissione europea
sull’economia del nostro Paese e penso che gli italiani
diano un mandato forte a me e al Governo di ridiscutere in
maniera pacata parametri
vecchi e superati”. Con un’idea ben precisa in testa:
“Proviamo a salvare questa Europa, riportandola alle sue
radici e al suo sogno
originario. Sono convinto che il nuovo Parlamento europeo e
la Commissione europea saranno amici dell’Italia. È cambiata
la geografia in
Europa”. Sarà davvero così? Come cambieranno i rapporti tra
Italia e Unione europea? E soprattutto, su politiche
espansive, lotta
all’austerity e conti pubblici quali sponde troverà la Lega
nel nuovo Parlamento europeo? Lo abbiamo chiesto a Sergio
Cesaratto,
professore di Economia politica all’Università di Siena, che
si aspetta, per l’Italia, “una fase molto
dura”.
* * * *
Salvini ha stravinto con il 34%. Come verrà preso questo risultato a Bruxelles?
Penso che verrà preso con estrema preoccupazione sull’Italia, visti i programmi, costosi, di sfondamento dei parametri europei propugnati da Salvini. Non sappiamo ancora come sarà la nuova Commissione, su quali equilibri si reggerà, se andiamo – ma non credo – verso un’Europa un po’ più aperta sulla politica economica o un’Europa che in fondo non cambierà. E’ vero, potrebbero entrare i Verdi, ma non sono una forza così progressista e sarebbero comunque in una posizione di debolezza e la loro presenza sarebbe controbilanciata anche dai Liberali. Magari però contano di più in Germania. E con la crisi del modello basato sull’industria automobilistica potrebbero battersi per un modello basato su piani europei di riconversione ecologica e quant’altro. Per ora sono però solo vaghi auspici.
Leggi tutto
Francesco Ciafaloni: Risvegli
Risvegli
di Francesco Ciafaloni
 Mi è capitato di
recente di leggere o rileggere alcuni testi sulla riduzione e
la redistribuzione
dell’orario di lavoro scritti più o meno un quarto di secolo
fa, quando si discuteva di 35 ore, di autori che mi sono
familiari, come
Giovanni Mazzetti1 o Giorgio Lunghini.2 Mi sono reso conto
che alcune
delle tesi sostenute dagli autori, che avevo ben presenti
venti anni fa, erano come sparite dal mio orizzonte mentale
negli ultimi tempi. Avevo smesso
di fatto di usarle per cercare di capire quello che succede
tutti i giorni. Mi sono accorto di essermi come addormentato,
intontito dalla eterna
ripetizione delle tesi correnti: l’eccesso di spesa pubblica,
la necessità di puntare sull’innovazione tecnica,
sull’industria 4.0, la possibilità che si crei, all’interno
del sistema produttivo, occupazione sostitutiva di quella
distrutta
dall’automazione, l’ossessione e la necessità della crescita
del Pil. Venti anni fa erano vivi De Cecco, Graziani, Gallino,
non
c’era la resa culturale che ci sommerge ora. C’erano
economisti, sociologi, storici autorevoli, che non si
rifugiavano nel silenzio e
avevano modo di esprimersi sui giornali maggiori. Oggi prevale
l’imbarazzante ripetizione di parole senza senso, come
“mercato”,
inteso come il dispensatore di giudizi inappellabili di
adeguatezza, positività, efficienza di qualsiasi iniziativa;
“crescita”
intesa come la tendenza naturale di tutti i paesi del mondo, a
meno di colpe gravi dei loro cittadini, ad aumentare il Pil
più o meno del 3%
l’anno; “equilibrio”, inteso come la naturale, automatica,
tendenza all’equilibrio tra domanda e offerta
(“l’equilibrio è un caso”, avrebbe ribattuto Lunghini citando
Marx). Eravamo abituati a distinguere tra economisti ortodossi
ed eterodossi. Gli ortodossi avevano un bel sistema ma
negavano l’evidenza della disoccupazione involontaria, della
concentrazione della
ricchezza, dell’uso del denaro per arricchirsi senza produrre.
Gli eterodossi prendevano atto dello scandalo della
disoccupazione (contro
le tesi dell’equilibrio economico generale), delle altre
emergenze impreviste che preparano la crisi prossima ventura.
Ci si poteva
schierare.
Mi è capitato di
recente di leggere o rileggere alcuni testi sulla riduzione e
la redistribuzione
dell’orario di lavoro scritti più o meno un quarto di secolo
fa, quando si discuteva di 35 ore, di autori che mi sono
familiari, come
Giovanni Mazzetti1 o Giorgio Lunghini.2 Mi sono reso conto
che alcune
delle tesi sostenute dagli autori, che avevo ben presenti
venti anni fa, erano come sparite dal mio orizzonte mentale
negli ultimi tempi. Avevo smesso
di fatto di usarle per cercare di capire quello che succede
tutti i giorni. Mi sono accorto di essermi come addormentato,
intontito dalla eterna
ripetizione delle tesi correnti: l’eccesso di spesa pubblica,
la necessità di puntare sull’innovazione tecnica,
sull’industria 4.0, la possibilità che si crei, all’interno
del sistema produttivo, occupazione sostitutiva di quella
distrutta
dall’automazione, l’ossessione e la necessità della crescita
del Pil. Venti anni fa erano vivi De Cecco, Graziani, Gallino,
non
c’era la resa culturale che ci sommerge ora. C’erano
economisti, sociologi, storici autorevoli, che non si
rifugiavano nel silenzio e
avevano modo di esprimersi sui giornali maggiori. Oggi prevale
l’imbarazzante ripetizione di parole senza senso, come
“mercato”,
inteso come il dispensatore di giudizi inappellabili di
adeguatezza, positività, efficienza di qualsiasi iniziativa;
“crescita”
intesa come la tendenza naturale di tutti i paesi del mondo, a
meno di colpe gravi dei loro cittadini, ad aumentare il Pil
più o meno del 3%
l’anno; “equilibrio”, inteso come la naturale, automatica,
tendenza all’equilibrio tra domanda e offerta
(“l’equilibrio è un caso”, avrebbe ribattuto Lunghini citando
Marx). Eravamo abituati a distinguere tra economisti ortodossi
ed eterodossi. Gli ortodossi avevano un bel sistema ma
negavano l’evidenza della disoccupazione involontaria, della
concentrazione della
ricchezza, dell’uso del denaro per arricchirsi senza produrre.
Gli eterodossi prendevano atto dello scandalo della
disoccupazione (contro
le tesi dell’equilibrio economico generale), delle altre
emergenze impreviste che preparano la crisi prossima ventura.
Ci si poteva
schierare.
Leggi tutto
Alessandro Somma: Elezioni europee: cambiare tutto per non cambiare niente
Elezioni europee: cambiare tutto per non cambiare niente
di Alessandro Somma
Le elezioni europee non ci consegnano un Parlamento dell’Unione dominato dai cosiddetti sovranisti: questi trionfano in alcuni Paesi, Italia in testa, ma arretrano in altri e complessivamente non sfondano, anche se incrementano la loro rappresentanza a Bruxelles. Non è però da simili dati che possiamo avere riscontro del peso che la destra xenofoba ha acquisito nel Vecchio continente. Il suo principale successo lo ha infatti ottenuto nel momento in cui è riuscita a cavalcare una particolare caricatura dello scontro politico in atto: quella per cui esso oppone Salvini e i suoi sodali a una composita alleanza che parte dal leader greco Tsipras e arriva sino al francese Macron.
Questa caricatura ha schiacciato il confronto elettorale entro uno schema tipicamente populista: da un lato i rappresentanti del popolo, i sovranisti, e dall’altro i rappresentanti delle élite, Socialisti e Popolari europei in testa.
I sovranisti hanno scaldato le piazze con i loro slogan tutti incentrati sulla promozione di valori premoderni: dio, patria, famiglia, sangue, terra. Hanno inteso difendere i popoli agitando rosari, invocando la protezione dei Santi, e soprattutto indicando nei migranti la vera minaccia alla pace e alla prosperità europea: è colpa loro se manca il lavoro, se le società sono sprofondate nel disordine e nella violenza, e soprattutto se orde di infedeli stanno insidiando non meglio definite tradizioni europee.
Leggi tutto
Nicoletta Forcheri: Il mea culpa che dovrebbe fare il M5S
Il mea culpa che dovrebbe fare il M5S
di Nicoletta Forcheri
Dove hanno sbagliato i 5s? E’ anni che sbagliano i 5s, è anni che glielo diciamo ma visto che UNO UGUALE UNO per loro non esistono pensatori, intellettuali, persone di cultura, ricercatori, da ascoltare più di altri. Anzi, chiunque abbia criticato, in questi anni, pubblicamente, era assimilato d’ufficio ai nemici del movimento.
Non si può spacciare per democrazia diretta una piattaforma informatica di proprietà di un imprenditore in odore di conflitto di interessi perché piazza i suoi uomini ed emana direttive all’interno del suo partito. O meglio si può, ma allora non è più democrazia diretta, è esattamente il suo contrario, un partito come altri. Lui non è stato votato, quindi perché dovrebbe valere più di uno?
Non si può partire da una base e da punti programmatici in divenire, come è partito, con tematiche come la moneta, l’euro, i vaccini, e poi stravolgere tutto man mano che ci si avvicina al potere, dicendo, come mi hanno continuamente detto, Luigi Di Maio compreso sulle monete complementari comunali, “sono cose che potremo fare quando saremo al potere” pur non mettendoli nei programmi – penso alla moneta fiscale – oppure ai vaccini formulati in modo soft e ambiguo per pescare largo tra l’elettorato e non scontentare troppo Big Pharma, che è una mafia vera e propria, come ci insegnarono gli spettacoli di Grillo.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Euro: tutti si preparano alla rottura per limitare i danni?
Euro: tutti si preparano alla rottura per limitare i danni?
di Giuseppe Masala*
Diciamocela tutta. L'Euro come moneta è moribonda dal 2011. Quando saltarono in aria Grecia, Spagna, Portogallo e Irlanda e l'Italia si salvò per il rotto della cuffia.
Da allora, piaccia o non piaccia la politica economica è cambiata: il controllo del saldo della partite correnti è diventato ferreo in tutti i paesi dell'area. Hanno iniziato a rientrare tutti compresa la Spagna che è passata da un 100% di pil di posizione finanziaria netta sull'estero all'85%. La strada è quella, inutile far finta di nulla. Ora, guardiamoci in faccia: non esiste una moneta dove ogni singola area della zona valutaria tenga rigidamente sotto controllo i conti con l'estero (considerando come estero aree che hanno la stessa moneta a corso legale). Voi ve l'immaginate il Governatore dell'Alabama che rientra il saldo delle sue partite correnti in passivo rispetto alla California? No, è una cosa lunare. Se accadesse non sarebbe un'area monetaria, il dollaro non sarebbe una moneta ma un serpentone monetario a cambio fisso sotto le mentite spoglie di un unico simbolo.
A voler essere pignoli potrei anche ricordare che il Quantitative Easing della BCE non è della BCE ma delle singole banche centrali dell'Eurosistema: la Banca d'Italia acquista BTP, la Bundesbank acquista Bund e via discorrendo. Non si acquista nulla in comune: a ciascuno il suo.
Leggi tutto
Pino Cabras: Questioni di fede
Questioni di fede
di Pino Cabras
Perfino il grande vincitore di queste elezioni europee in Italia, Matteo Salvini, non cede per ora alla tentazione di inquadrarle nel solo contesto italiano, dove sarebbe apparentemente più facile passare all’incasso di questo risultato per andare all’arrembaggio degli equilibri di governo. C’è un progetto più vasto e meno contingente.
Quel rosario sfoggiato nella sua conferenza stampa, pur maldestramente brandito con una curiosa simbologia di croce rovesciata (la impugna sempre a testa in giù), allude a un’operazione ideologica più estesa, di portata continentale, a cui Salvini partecipa con la protezione di Steve Bannon, il patrocinatore ideologico della campagna presidenziale di Trump.
Salvini fino all’altro ieri era religioso quanto io sono esperto di uncinetto norvegese e di apicoltura indonesiana, mentre ora invoca sempre una versione iper-concentrata del classico “Dio Patria e Famiglia” con insistenti riferimenti simbolici. È una questione che si può capire se leggiamo in modo non provinciale il voto del 26 maggio 2019. In Europa si sono rafforzati diversi partiti ideologicamente contrari all’attuale assetto europeo. Una parte di essi continua a scandire la questione delle radici “giudaico-cristiane” dell’Europa. E invoca, come fa Salvini, il nerbo della FEDE. Dietro c’è un progetto, un’identità in fieri. Non mi piace, non ci piace, ma c’è un progetto. Noi dobbiamo far emergere un altro progetto e un’altra visione alternativa all’incubo eurocratico, con una convinzione salda.
Leggi tutto
Jacques Sapir: Elezioni europee: le rovine dopo la battaglia
Elezioni europee: le rovine dopo la battaglia
di Jacques Sapir
Lucido e dettagliato come sempre, Jacques Sapir analizza i risultati delle elezioni europee in Francia.Per molti aspetti una lezione utile anche alle forze politiche italiane: mostra per esempio l’irrilevanza cui si sono condannate le diverse, microscopiche liste sovraniste, divise tra loro e ferme a percentuali insignificanti, utili solo alla dispersione del voto. Il crollo di La France Insoumise al 6,5% rappresenta inoltre il prezzo da pagare per una linea politica confusa, in cui ci si è voluti separare dai sovranisti di sinistra e ora tentata di condannarsi definitivamente all’ininfluenza se, a fronte della buona affermazione del RN, cederà a quell’antifascismo retorico e farlocco che conosciamo bene, in tutta la sua vacuità, anche in Italia. Nel complesso, la vera forza di Emmanuel Macron, punito dagli elettori, sta nella dispersione e frammentazione delle opposizioni
Successo non pienissimo per il Rassemblement National, sconfitta attenuata per En Marche, una mezza sorpresa per gli ambientalisti e opposizione per il resto atomizzata, sia a destra che a sinistra: ecco il panorama politico che sta emergendo dopo le elezioni europee. Se gli avversari di Macron vogliono contare qualcosa, dovranno avviare cambiamenti radicali.
Le elezioni europee in Francia si sono basate principalmente su temi francesi. Questa è la prima lezione che se ne può trarre: erano un voto sul Presidente.
Questo spiega perché il numero di astensionisti è stato molto inferiore rispetto al 2014. Sebbene le classi lavoratrici, e anche i giovani, si siano ampiamente astenuti, il tasso di partecipazione è aumentato di quasi otto punti percentuali rispetto al livello eccezionalmente basso del 2014.
Leggi tutto
Hits 3638
Hits 3636
Hits 3253
Hits 3111
Hits 2829
Hits 2719
Hits 2615
Hits 2462
Hits 2132
Hits 2059
tonino

Claudio Conti: Debito pubblico, alla ricerca di una via di fuga
Debito pubblico, alla ricerca di una via di fuga
di Claudio Conti
 La discussione mainstream intorno al debito
pubblico, lo spread, le
“letterine” che partono da Bruxelles e le “rispostine” –
corrette in corsa – del ministero dell’economia
italiano, soffre da sempre di una distorsione evidente e
sempre più faticosamente nascosta.
La discussione mainstream intorno al debito
pubblico, lo spread, le
“letterine” che partono da Bruxelles e le “rispostine” –
corrette in corsa – del ministero dell’economia
italiano, soffre da sempre di una distorsione evidente e
sempre più faticosamente nascosta.
Se uno legge infatti Repubblica o il Corriere, o peggio ancora ascolta Cottarelli e Giannini in tv, è obbligato a pensare che il debito aumenta perché aumenta la spesa pubblica, con governi che non applicano le indicazioni “sagge” provenienti dall’Unione Europea (e specificamente dalla Commissione, ossia il “governo” Ue).
Chi guarda invece i numeri scopre che la spesa pubblica, negli ultimi venticinque anni è stata costantemente ridotta, al punto che da diversi anni presenta costantemente – e sotto qualsiasi tipo di maggioranza governativa – un consistente avanzo primario. Che significa: lo Stato spende ogni anno meno di quanto incassa con le tasse.
E del resto molti governi degli ultimi anni – ma anche quelli di Berlusconi – hanno obbedito più o meno ferreamente agli ordini provenienti dall’alto. In particolare quello dei ferocissimi Mario Monti ed Elsa Fornero, che sono stati protagonisti anche del più brusco innalzamento del debito pubblico in tempi recenti. Sono infatti entrati a Palazzo Chigi con un fardello pari al 120,1% del Pil e ne sono usciti lasciandocelo a 129% (oggi siamo al 132).
Ci troviamo insomma di fronte a un piccolo mistero: più ci si piega alle prescrizioni inscritte nei trattati europei, ribadite con frequenti bacchettate sulle dita, più peggiora la situazione. Lo stesso, e anche peggio, è accaduto alla martoriata Grecia governata direttamente dalla Troika – con Tsipras a fare la “copertura a sinistra” di politiche ferocemente antipopolari – quindi non si può neppure parlare di anomalia italiana.
Gli scostamenti dal percorso operati dal governo gialloverde – quasi soltanto, e molto limitatamente (come ricorda Tria nella sua contestata lettera a Bruxelles), per “quota 100” e “reddito di cittadinanza” – aggravano un po’ la tendenza, ma senza modificarne eccessivamente la direzione.
Leggi tutto
Roberto Buffagni: Le elezioni e gli eletti
Le elezioni e gli eletti
di Roberto Buffagni
 Che cosa ci
insegnano, o almeno suggeriscono, le elezioni europee testé
concluse?
Che cosa ci
insegnano, o almeno suggeriscono, le elezioni europee testé
concluse?
Anzitutto, direi che ci confermano un fatto noto ma sempre rilevante: le elezioni europee non cambiano l’Unione Europea, che conforme la sua natura e l’intenzione profonda – anche filosofica e spirituale – che la costituisce è (quasi) impermeabile al voto popolare, diciamo almost ballotsproof, salvo un vero e proprio diluvio o maremoto di voti ad essa contrari o favorevoli che non si verificherà, molto probabilmente, mai. L’Unione Europea sta o cade per l’azione degli Stati-nazione che la compongono, e/o per un evento esogeno o endogeno che ne faccia precipitare le gravi disfunzionalità.
Le elezioni europee e il voto popolare cambiano invece gli equilibri politici nazionali, come d’altronde è naturale, visto che l’unico contesto in cui la democrazia rappresentativa sia possibile e vitale è – oggi come ieri – la nazione. Cambiano gli equilibri politici nazionali, anche se le elezioni europee vanno per così dire “fuori tema”, visto che il voto europeo non muta gli equilibri parlamentari nazionali; ma il sistema elettorale proporzionalistico che adottano, e l’emergere sempre più chiaro del consenso/dissenso rispetto alla UE come clivage politico principale, le trasformano in un fattore politico e simbolico di prima grandezza.
Le elezioni europee testé concluse infatti ci insegnano, o almeno ci suggeriscono, che il consenso/dissenso riguardo la UE e alle sue logiche premesse, implicazioni e conseguenze – il mondialismo, l’individualismo, il progressismo, il costruttivismo sociale, l’universalismo politico – emerge con sempre maggiore chiarezza come il principale clivagepolitico, non solo in Europa ma in tutto l’Occidente.
Chi non si schiera di qua o di là, chi esita, chi tiene il piede in due staffe, chi azzarda dei “sì, ma” o dei “ni” è perduto. Il più antico partito d’Europa, il partito conservatore britannico, ha patito la più cocente disfatta di sempre per le sue esitazioni, compromessi e retropensieri in merito alla Brexit.
Leggi tutto
Sergio Marotta: L’economia fondamentale come possibile alternativa al pensiero mainstream
L’economia fondamentale come possibile alternativa al pensiero mainstream
di Sergio Marotta
Cos’è e cosa propone il collettivo per l’economia fondamentale
 Che cos’è l’economia
fondamentale
Che cos’è l’economia
fondamentale
Il Collettivo per l’economia fondamentale è costituito da ricercatori di diverse discipline e di varie nazionalità, molti già noti nel mondo degli studi. Davide Arcidiacono, Filippo Barbera, Andrew Bowman, John Buchanan, Sandro Busso, Joselle Dagnes, Joe Earle, Ewald Engelen, Peter Folkman, Julie Froud, Colin Haslam, Sukhdev Johal, Ian Jones, Dario Minervini, Mick Moran, Fabio Mostaccio, Gabriella Pauli, Leonhard Plank, Angelo Salento, Ferdinando Spina, Nick Tsitsianis, Karel Williams hanno individuato un oggetto di studio che hanno definito “economia fondamentale” e hanno dato vita a una notevole e interessante serie di ricerche che stanno riscuotendo in Europa sempre maggiore attenzione. Così il libro che contiene il manifesto del Collettivo intitolato “Economia fondamentale. L’infrastruttura della vita quotidiana”, appena uscito in Italia per i tipi di Einaudi, è stato pubblicato in inglese da Manchester University Press e in tedesco da Suhrkamp.
Secondo gli studiosi del Collettivo, l’economia fondamentale è costituita da un insieme di attività legate «alla produzione dei beni e servizi indispensabili al benessere generale, come l’edilizia residenziale, l’istruzione, l’assistenza all’infanzia e agli anziani, la sanità, la fornitura di beni e servizi essenziali come l’acqua, il gas, l’energia, la fognatura e le reti telefoniche»[1].
I confini dell’economia fondamentale sono individuati attraverso tre parametri di riferimento: «questi beni e servizi sono necessari alla vita quotidiana, ne usufruiscono ogni giorno tutti i cittadini a prescindere dal reddito, e sono erogati, in funzione della distribuzione della popolazione, attraverso reti e filiali»[2]. Altre caratteristiche delle attività ricomprese nell’economia fondamentale sono quelle di svolgersi spesso al di fuori del mercato; di essere attività in qualche modo protette in quanto soggette a regolamentazione; mentre la loro distribuzione e organizzazione è soggetta alla mediazione politica.
Leggi tutto
Piemme: Debito pubblico: il mistero svelato
Debito pubblico: il mistero svelato
di Piemme
«Era prevista e, puntuale come la morte, è arrivata. Parliamo della lettera con cui la Commissione europea, preso atto che l'Italia non avrebbe mantenuto gli impegni sulla riduzione del debito pubblico, avverte il governo che potrebbe scattare la famigerata "procedura d'infrazione", con tanto di pesanti sanzioni». [SOLLEVAZIONE del 30 maggio]
Da decenni l’imperativo categorico del rimborso del debito, è il mantra assillante con cui i tecnocrati dell’Unione europea ed i pescecani della finanza predatoria giustificano la necessità di tenere l’Italia incatenata al ceppo dell’ortodossia ordoliberista. Ove non vi fosse la certezza del rientro, almeno nei parametri di Maastricht, sarebbe la catastrofe economica, lo sfacelo del paese.
In questa cornice sono cadute le "sorprendenti" dichiarazioni del ministro dell’Economia Giovanni Tria sulla “monetizzazione del debito”:
«Non dobbiamo dimenticare che esiste un secondo modo di finanziare un deficit, che è il finanziamento monetario».
Cosa sia, in ambiente Ue, la “monetizzazione del debito”, è presto detto: la Bce finanzierebbe le politiche fiscali di uno Stato stampando moneta, col che verrebbe meno il problema dello spread poiché i titoli di debito sarebbero acquistati direttamente dall’Istituto di Francoforte
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Del cuore e del coraggio: circa Fratoianni e l’alternativa
Del cuore e del coraggio: circa Fratoianni e l’alternativa
di Alessandro Visalli
Le elezioni europee sono state uno tsunami. Il Movimento 5 stelle ha ceduto, rispetto alle elezioni politiche di marzo oltre sei milioni di elettori, riducendosi a quattro e mezzo, mentre la Lega è cresciuta di tre milioni e mezzo, salendo a nove milioni. Il Partito Democratico ha perso quasi centomila voti, conservando i suoi sei milioni di voti, e Forza Italia oltre due milioni scendendo a duemilionitrecentomila, +Europa è rimasta sulle sue posizioni marginali a circa ottocentomila voti. Fratelli d’Italia ha guadagnato trecentomila elettori, salendo a unmilionesettecentomila. Nel campo frastagliato della sinistra la lista abborracciata (La Sinistra) all’ultimo momento tra Sinistra Italiana, orfana di MdP, e Rifondazione, orfana di PaP, ha preso un deludentissimo 1,7%, pari a quattrocentosessantacinquemilanovantadue voti, il Partito Comunista di Rizzo duecentotrentamila ed Europa Verde ben seicentomila, alle politiche questa area aveva avuto più o meno unmilioneseicentomila voti. Resta l’estrema destra che aveva preso trecentomila voti ed ora ne ha centoventimila in due sigle.
Dunque abbiamo avuto il macrofenomeno di un partito di maggioranza relativo, costruito in modo post-ideologico a partire da un potente discorso populista di natura prepolitica (l’onestà e l’estraneità alla casta) che, dopo essersi per un quinquennio gonfiato dei disillusi di destra e sinistra (rispettivamente da Berlusconi e da Bersani-Letta-Renzi) ha ceduto di schianto quasi due terzi dei consensi verso la Lega e verso l’astensione, restituendo, quindi, l’elettorato orientato a destra che aveva ‘rubato’ negli anni.
Leggi tutto
Piccole Note: Bolton vs Trump: lo scontro nel cuore dell'Impero
Bolton vs Trump: lo scontro nel cuore dell'Impero
di Piccole Note
“Se dipendesse da John, adesso saremmo impegnati in quattro guerre”. Così Trump ha scherzato in una riunione. Una confidenza ripresa oggi dal New York Times, che ha dedicato un articolo importante al rapporto tra il presidente e il Consigliere per la sicurezza nazionale John Bolton.
“I due non hanno mai legato a livello personale – scrive il Nyt -, cosa molto importante in questa amministrazione. Trump non ama Bolton, riferiscono una mezza dozzina di consiglieri e collaboratori, e in privato non ne fa un segreto”.
Quando Trump sondò Adelson
Il giornale della Grande Mela riferisce che il presidente si è più volte vantato di aver frenato l’aggressività del suo Consigliere. E mette in evidenzia come durante il viaggio in Giappone il contrasto tra i due si sia manifestato apertamente.
Trump ha infatti contraddetto Bolton sia sulla pericolosità dei test missilistici nordcoreani che sul regime-change iraniano – che ha rigettato in contrasto con quanto affermato dall’altro.
L’Iran “ha la possibilità di diventare un grande Paese conservando l’attuale leadership”, ha dichiarato Trump. “Non stiamo cercando un regime-change. Voglio chiarirlo. Non siamo alla ricerca di armi nucleari”.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: La nave d’assalto dei nuovi crociati
La nave d’assalto dei nuovi crociati
di Manlio Dinucci
Alla presenza del Capo della Stato Sergio Mattarella, del ministro della Difesa Elisabetta Trenta, del ministro dello sviluppo economico Luigi di Maio, e delle massime autorità militari, è stata varata il 25 maggio nei Cantieri di Castellammare di Stabia (Napoli) la nave Trieste, costruita da Fincantieri.
È una unità anfibia multiruolo e multifunzione della Marina militare italiana, definita dalla Trenta «perfetta sintesi della capacità di innovazione tecnologica del Paese». Lunga 214 metri e con una velocità di 25 nodi (46 km/h), ha un ponte di volo lungo 230 metri per il decollo di elicotteri, caccia F-35B a decollo corto e atterraggio verticale e convertiplani V-22 Osprey.
Può trasportare nel suo ponte-garage veicoli blindati per 1200 metri lineari. Ha al suo interno un bacino allagabile, lungo 50 metri e largo 15, che permette alla nave di operare con i più moderni mezzi anfibi della Nato.
In termini tecnici, è una nave destinata a «proiettare e sostenere, in aree di crisi, la forza da sbarco della Marina militare e la capacità nazionale di proiezione dal mare della Difesa».
In termini pratici, è una nave da assalto anfibio che, avvicinandosi alle coste di un paese, lo attacca con caccia ed elicotteri armati di bombe e missili, quindi lo invade con un battaglione di 600 uomini trasportati, con i loro armamenti pesanti, da elicotteri e mezzi di sbarco.
Leggi tutto
Federico Dezzani: A grandi passi verso la Crisi
A grandi passi verso la Crisi
di Federico Dezzani
Si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Parlamento
europeo: i partiti “sovranisti” aumentano i seggi, ma
restano ininfluenti
nel nuovo emiciclo, dove la grande coalizione di popolari e
socialisti si allargherà ai liberali. Regno Unito e Italia
appaiono però
sempre più distanti dal Continente: l’exploit del partito
Brexit rafforza lo scenario di un’uscita inglese dall’Unione
Europea senza accordo, mentre l’affermazione della Lega
isola ulteriormente l’Italia, incamminata verso una
silenziosa uscita
dall’eurozona. Gli angloamericani lanceranno in autunno
l’assalto decisivo all’Unione “a trazione tedesca”: è
probabile che Berlino cerchi di costruire un cordon
sanitaire attorno all’Italia.
Italexit in corso
All’inizio dell’anno ci eravamo proposti di seguire gli avvenimenti con pochi articoli, che si sarebbero dipanati dalla nostra analisi per il 2019: una scelta indubbiamente felice, perché ci consente di aggiungere soltanto qualche breve e snello articolo, di tanto in tanto, al nostro solido impianto analitico. Quando scrivemmo la nostra analisi di lungo periodo non ci soffermammo sulle elezioni europee svoltesi in questi giorni: il loro impatto in termini (geo)politici sarebbe stato, ed infatti è stato, nullo.
Leggi tutto
Le multinazionali sottraggono all’Africa miliardi di dollari
Le multinazionali sottraggono all’Africa miliardi di dollari
Il problema non è aiutarli a casa loro. È liberare casa loro. E restituire il maltolto
Ecco come le multinazionali sottraggono all’Africa miliardi di dollari
Secondo il nuovo rapporto Oxfam rilasciato in data odierna [2 giugno, ndt], intitolato: “Africa: l’ascesa per pochi”(1), 11 miliardi di dollari sono stati sottratti all’Africa nell’arco dell’anno 2010, grazie all’utilizzo di uno tra i tanti trucchi usati dalle multinazionali per ridurre le imposte. Tale cifra, è sei volte l’equivalente dell’importo che sarebbe necessario a colmare il vuoto di fondi nel sistema sanitario di Sierra Leone, Liberia, Guinea, Guinea Bissau, tutti Stati in cui è presente l’ebola. Le scoperte dell’Oxfam arrivano in corrispondenza dell’imminente partecipazione dei leader politici ed economici al 25° World Economic Forum Africa, che si terrà in Sudafrica.
Il tema principale dell’incontro sarà come assicurare l’ascesa economica dell’Africa e conseguire uno sviluppo sostenibile. E’ necessaria una riforma del sistema di tassazione globale, affinché l’Africa possa pretendere i fondi che le spettano – tra l’altro, è necessaria per affrontare l’estrema povertà e disuguaglianza – e diviene realmente determinante se il continente deve continuare la sua crescita economica.
L’Oxfam ha richiesto a tutti i governi, la presenza dei capi di Stato e dei ministri delle finanze in vista della Financing for Development Conference che si terrà a luglio in Etiopia.
Leggi tutto
Michel Onfray: Il Naufragio dei Gilets Jaunes
Il Naufragio dei Gilets Jaunes
di Michel Onfray
 Il vantaggio con BHL (Bernard Henry-Levy ) [1]
è che si sbaglia continuamente
e basta pensare il contrario di quello che lui scrive o dice,
per essere sicuri e certi di stare nel vero. È una vera
performance
intellettuale, un destino unico nella stessa storia delle
idee, il fatto di essere la bussola che indefettibilmente
indica il Sud! Promuovendo se
stesso e il suo One Man Show in tutte le capitali d’Europa
dove le sale si riempiono di invitati mondani come ce ne sono
in ogni grande
città, spiega che non si esibirà sulla scena di Parigi con il
suo gobbo, senza dire che lì dalle sue parti l’inganno
sarebbe più facilmente smascherato perché basterebbe filmare
l’uscita dalla sua rappresentazione per vedervi tutta la gente
in
capannelli e capire che nessuno di quelli aveva pagato
l’ingresso…
Il vantaggio con BHL (Bernard Henry-Levy ) [1]
è che si sbaglia continuamente
e basta pensare il contrario di quello che lui scrive o dice,
per essere sicuri e certi di stare nel vero. È una vera
performance
intellettuale, un destino unico nella stessa storia delle
idee, il fatto di essere la bussola che indefettibilmente
indica il Sud! Promuovendo se
stesso e il suo One Man Show in tutte le capitali d’Europa
dove le sale si riempiono di invitati mondani come ce ne sono
in ogni grande
città, spiega che non si esibirà sulla scena di Parigi con il
suo gobbo, senza dire che lì dalle sue parti l’inganno
sarebbe più facilmente smascherato perché basterebbe filmare
l’uscita dalla sua rappresentazione per vedervi tutta la gente
in
capannelli e capire che nessuno di quelli aveva pagato
l’ingresso…
In una benevola intervista di Le Figaro del 20 maggio 2018, il nostro Sud-magnetico proclama che il movimento dei Gilets-Jaunes si è auto divorato. Ah che bel modo di dire! Dei Gilets-Jaunes cannibali, autofagi, che mangiano se stessi, ed ecco una tesi che è bella e profonda e non ha che un inconveniente: quello di essere falsa…
Si capisce che questa storia di un movimento che sarebbe la causa della sua propria morte possa essere la sua teoria perché da una parte gli permette di affermare fino alla fine che i Gilets-Jaunes sono dei cretini incapaci e che dunque essi sono all’origine della loro sfortuna – e si sa che la sfortuna dei Gilets-Jaunes é la fortuna di BHL.; d’altra parte questa balla da snob di St.Germain des Près gli permette di nascondere sotto il tappeto le vere ragioni non già di un banchetto di cannibali, ma di un’orgia di Stato.
Perché i Gilets-Jaunes non si sono divorati da soli, sono stati smembrati, spellati, sminuzzati, tagliati, rullati, appiattiti, privati degli occhi, battuti, pestati, pugnalati, frantumati e poi mangiati dall’apparato dello Stato, in questo aiutato contro ogni buon senso dai sindacati e dai partiti politici che apparentemente sono all’opposizione, ma che alla fine, come utili idioti, lavorano con e per questo Stato. E a questo bisogna aggiungere i giornalisti.
Leggi tutto
coniarerivolta: Le Favole di Salvini
Le Favole di Salvini
di coniarerivolta
 Leggenda vuole che molti e molti
anni orsono uno sbruffone si vantasse sguaiatamente delle sue
gesta. In particolare
sosteneva, lo sbruffone, di poter saltare da un piede
all’altro del colosso di Rodi. La leggenda racconta anche che
non ci volle poi molto a
verificare la consistenza delle fanfaronate dello sbruffone.
Bastò infatti che uno degli astanti proponesse all’incauto
millantatore
“Hic Rhodus, hic salta” (fai conto che questa sia
Rodi, facci vedere quello che sai fare), per riportarlo a più
miti
consigli.
Leggenda vuole che molti e molti
anni orsono uno sbruffone si vantasse sguaiatamente delle sue
gesta. In particolare
sosteneva, lo sbruffone, di poter saltare da un piede
all’altro del colosso di Rodi. La leggenda racconta anche che
non ci volle poi molto a
verificare la consistenza delle fanfaronate dello sbruffone.
Bastò infatti che uno degli astanti proponesse all’incauto
millantatore
“Hic Rhodus, hic salta” (fai conto che questa sia
Rodi, facci vedere quello che sai fare), per riportarlo a più
miti
consigli.
Molta acqua è passata sotto i ponti da allora, eppure una vicenda simile si ripete in questi giorni di fronte ai nostri occhi. Secondo un copione già visto, Matteo Salvini ha passato le ultime settimane, non a caso coincidenti con la campagna elettorale, a promettere grandi sconvolgimenti. Basta con l’austerità che ci soffoca! No all’adesione cieca a regole di bilancio che causano disoccupazione e miseria! E se all’Europa non va bene, peggio per lei, ce ne faremo una ragione! Apparentemente il trucco ha funzionato, ancora una volta. Nonostante un anno di governo all’insegna dell’austerità e della continuità totale con i governi che l’hanno preceduto, il leader della Lega è riuscito di nuovo a presentarsi all’elettorato come l’(unica) alternativa ai sacrifici imposti dai Trattati europei e a capitalizzare un impasto esplosivo di rabbia e rancori di una piccola e media borghesia sempre più incattivita. Nelle ore immediatamente successive alle elezioni, Salvini ha rincarato la dose, promettendo una rivoluzione fiscale quantificabile in 30 miliardi di euro di tagli alle tasse, sotto forma di flat tax per i redditi delle imprese e delle famiglie con un reddito fino a 50.000 euro. Il tutto infarcito dal campionario standard con cui Salvini ha mascherato il suo nulla negli ultimi 12 mesi: “non sto a impiccarmi a un parametro, un numero o una regoletta”, “l’era della precarietà e dell’austerità si è conclusa”, non ci importa di “rispettare gli zero virgola”.
Leggi tutto
Francesco Galofaro: Considerazioni sul voto europeo
Considerazioni sul voto europeo
di Francesco Galofaro*
 Il
panorama
Il
panorama
Il voto italiano alle ultime elezioni va inquadrato nel più ampio contesto europeo. E’ possibile individuare delle dinamiche di fondo, posto che in ciascuno Stato o macroregione esistono peculiarità locali. Nel 2014, le elezioni si risolsero in un derby tra popolari e socialisti: tra una destra e una sinistra entrambe liberali, destinate a governare insieme l’Unione, convinte che il laissez-faire fosse la risposta più adeguata alla crisi e alla recessione economica, prive di un progetto all’altezza dei tempi, destinate al ruolo di amministratori del condominio europeo. Il 2019 consegna una mappa ben diversa:
- Il PPE (cui fa capo Forza Italia) scende da 221 a 179 seggi;
- I Socialisti (cui fa capo il PD) scendono da 191 a 150 seggi;
- Cala anche il gruppo ECR (Conservatori e Riformisti, da 70 a 58 seggi), cui fanno capo forze vincenti come Fratelli d’Italia o il polacco PiS, ma anche i tory inglesi, in fortissima crisi per lo scontro interno connesso alla Brexit;
- Perde consensi la sinistra radicale del GUE (da 52 a 38 seggi);
In crescita troviamo tanto forze europeiste tanto posizioni euroscettiche o ‘sovraniste’:
- EFDD, il gruppo dei 5 Stelle, cresce soprattutto per merito di Farage e del suo partito pro-Brexit (da 48 a 56 seggi);
- I Liberali dell’ALDE passano da 67 a 107 seggi – la crescita si deve in gran parte a Macron, non presente alle scorse elezioni;
- Crescono i Verdi: da 50 a 70 seggi;
- Si afferma l’ENL, non presente alle scorse elezioni (è il gruppo di Salvini, della Le Pen, di Alternative für Deutschland, con 58 seggi);
La formula di governo PPE/Socialisti è ormai logora: la crisi dei socialdemocratici perdura tutt’ora, privi come sono di un progetto che li differenzi dai liberali e dai conservatori.
Leggi tutto
Sergio Cesaratto: Reazioni all'intervista
Reazioni all'intervista*
di Sergio Cesaratto
Visto il putiferio che ha scatenato la mia intervista letta come una retromarcia (tranquilli, nessuna retromarcia pro-europeista), provo a chiarificare il mio pensiero (riprendo da una mail di risposta ad alcuni amici, xxx è un economista a voi ben noto):
1) quello che dico è che la polemica da anni contro i "parametri di Maastricht" (3% e 60%) è sbagliata in quanto questi in un'unione monetaria completa han perfettamente senso, il punto è dunque quello di battersi per un bilancio federale ciò che, assieme a una banca centrale cooperativa, comincerebbe a far avvicinare l'Europa a un'unione monetaria feasible. Questo significa che sono diventato federalista e che ritengo questo possibile, o addirittura macroniano? No. Però se decidi di fare politica in Europa ti devi dare obiettivi corretti e agire negli interstizi possibili, inclusa la attuale spaccatura franco-tedesca. Abbaiare contro obiettivi sbagliati in un profondo isolamento mi sembra velletario e ci può condurre alla Troika. Non è un caso che Savona se ne sia andato dal governo (read my lips: andato). Era l'unico ad aver avanzato delle proposte articolate.
2) Può invece darsi che il governo via il rifiuto delle sanzioni a cui potremmo andare dritti (e via il salasso degli spread che con questi chiari di luna potrebbero crescere a livelli insostenibili) ritenga di portarci all'uscita. Può darsi che xxx abbia informazioni su questo.
Leggi tutto
Fabio Nobile: Elezioni europee. Chi vince, chi perde e chi sta a guardare
Elezioni europee. Chi vince, chi perde e chi sta a guardare
di Fabio Nobile
Le elezioni europee fotografano una situazione piuttosto chiara in tutto il continente. Nonostante ogni Paese abbia la sua specificità e la maggioranza del Parlamento sia ancora in mano a popolari e socialisti (con il supporto di liberali e/o verdi), il trend complessivo vede un’affermazione delle forze che hanno sostenuto, da destra, la necessità di ostacolare il predominio di Bruxelles.
Questo è avvenuto in Francia, in cui il primo partito risulta con il 22% dei voti il Front National della Le Pen, in Inghilterra, dove ha prevalso il partito filo Brexit di Farage con il 32%. Così come Orban in Ungheria, i nazionalisti in Polonia e la Lega in Italia. Gli unici Paesi in cui i socialisti reggono sono la Spagna, dove è fresca la vittoria alle politiche di Aprile, ed in Portogallo dove, però, bisogna registrare un dato altissimo dell’astensionismo, avendo votato solo il 30% degli aventi diritto. Tranne in pochi Paesi, come Italia ed appunto il Portogallo, il dato dell’affluenza aumenta, seppure di poco, ed in generale sembra essere proprio a favore dell’ondata di destra. In generale, però, il dato che il 45% in media degli elettori non abbia partecipato al voto manifesta il distacco popolare profondo e diffuso dalla Ue.
In Germania, dove la Cdu si mantiene primo partito con il 28,9%, la Spd arriva appena al 15,8%, i nazionalisti dell’Afd salgono all’11% e i Verdi europei riscuotono una grande affermazione, raggiungendo il 20,5%.
Leggi tutto
Mauro Gallegati: La trappola del debito-PIL
La trappola del debito-PIL
di Mauro Gallegati
Anni di liberismo hanno prodotto una disuguaglianza mai vista prima, il blocco della mobilità sociale, salari reali stagnanti, precarietà, scomparsa del ceto medio, working poor, fino alla teorizzazione di effetti benefici di una flat tax e crescita a seguito di politiche di austerità fiscale
Giorgio Lunghini ha scritto che il neoliberismo è riuscito laddove anche le scienze fisiche hanno fallito: presentare le proprie “leggi” come verità inconfutabili, come se fossero una pura e diretta espressione della verità oggettiva e immodificabile della natura. In questo modo però l’economia “mainstream” è diventata sempre più un gioco intellettuale fine a se stesso senza conseguenze pratiche per la comprensione del mondo economico. Gli economisti hanno trasformato l’economia in una sorta di matematica sociale in cui il rigore analitico è tutto e la rilevanza pratica nulla.
Anni di liberismo hanno prodotto disuguaglianza mai vista prima, blocco della mobilità sociale, salari reali stagnanti, precarietà, scomparsa del ceto medio, working poor, fino alla teorizzazione di effetti benefici per tutti prodotti da una flat tax e crescita a seguito di politiche di austerità fiscale. La teoria economica viene costruita in modo assiomatico senza verificabilità empirica. Questo dà luogo a conclusioni di politica economica paradossali e giustifica – col criterio della ricerca del profitto – una visione dell’economia che Danovaro in Condominio Terra definisce “predatoria”, a scapito dell’ambiente e della società.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Perchè siamo contro l'euro
Perchè siamo contro l'euro
di Leonardo Mazzei
Strano ma vero: nella campagna elettorale per le europee non si è parlato dell'euro. Forse che la crisi della moneta unica è finita? Forse che gli squilibri che ha prodotto sono stati nel tempo risolti? Forse che paesi come l'Italia non ne pagano più il prezzo? La risposta è un triplice e cubitale NO.Il bello è che non c'è persona informata dei fatti che non sappia che così stanno le cose. Ma, per un motivo o per l'altro, fan tutti finta che così non sia. In questo modo, mentre le élite gongolano per la scomparsa di ogni dibattito sul tema, chi gli si vorrebbe opporre oscilla tra il balbettio ed il parlar d'altro, come se in questo modo il problema potesse essere esorcizzato.
Proprio per questa gigantesca rimozione, per questo (si spera momentaneo) trionfo dell'ipocrisia, ci pare necessario ricordare le ragioni del nostro NO all'euro. E ci pare utile farlo proprio nel giorno delle elezioni.
Contro l'euro per tre motivi
Rammentare le ragioni del NO all'euro, ribadire dunque l'assoluta necessità di uscirne quanto prima per tornare alla lira, non serve tanto a ricordare le nostre posizioni, quanto a ristabilire la giusta gerarchia dei problemi del Paese, rimettendo al centro la questione da cui tutto dipende in questa fase storica.
Leggi tutto
Voxpopuli: Il capitalismo gangster secondo Trump
Il capitalismo gangster secondo Trump
di Voxpopuli
Gli USA hanno scelto con quale approccio affrontare la transizione al mondo multipolare: il gangsterismo.
L’Impero progressivamente vede crollare le possibilità di alimentare il proprio potere globale, che sognò di perpetuare dopo il collasso dell’URSS, e sta reagendo in maniera pericolosa per la pace nel mondo. Nella quasi totalità dei fronti caldi sul pianeta avanza senza un briciolo di intelligenza dritto all’obiettivo, con la mano pronta sulla pistola carica e la solita arroganza yankee.
In Medio Oriente vengono assecondati i piani del criminale governo israeliano, a cui, dopo il riconoscimento di Gerusalemme capitale del paese, è stata riconosciuta la sovranità sulle Alture del Golan, sotto occupazione dal 1967. Nel breve periodo dovrebbe essere riconosciuta anche la sovranità di Tel Aviv sulla Cisgiordania, come promesso da Netanyahu in campagna elettorale, con tanti saluti al diritto del popolo palestinese ad avere una patria. Israele trova un’intesa con gli USA anche sulla questione Iran.
Trump ha ritirato il proprio paese dal trattato sul nucleare firmato da Obama nel 2015 e sostiene, attraverso anche i paesi dell’islam sunnita ostili all’Iran, una guerra per procura contro un paese piegato dalle sanzioni.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Sulle nostre teste
Sulle nostre teste
Post un po' orwellian-cyberpunk-philipdickiano
di Pierluigi Fagan
Riassumo qui una serie di notizie a sfondo tech, lette ultimamente. La prima è il fantastico trenino di satelliti spedito nello spazio da Elon Musk. Sono sessanta, avanguardia di un progetto di “nuova costellazione” che ne prevede, a regime, 12.000 nel 2027 ma forse già 4000 nel 2020. Ma c’è anche un costellazione di mr. Virgin (Branson) con 700 sat ed un progetto in rampa di lancio dell’immancabile Amazon con altri 3200 sat, nonché un’ipotesi Samsung con altri 4600 apparecchi in orbita. A regime, lo spazio dell’immediato futuro, assomiglierà ad una spiaggia romagnola al 15 agosto.
Queste nuove infrastrutture spaziali (c'è chi fa le vie della Seta e c'è chi fa la via delle Stelle) costano bei soldi e ci si domanda da dove prenda i soldi Musk che altri davano praticamente per fallito, di recente. Lo stesso Musk che di recente è finito su i giornali per essersi fumato un cannone d’erba durante una intervista radio, ha accompagnato il primo lancio con dichiarazioni pessimistiche del tipo “lo faccio, ma non sono convinto”. Lo stesso Musk che imperversa in lungo ed in largo nelle conferenze sulla nuova rivoluzione tecnologica, allarmando tutti con cupe profezie sull’AI che si emanciperà diventando potenzialmente dannosa per noi tutti. Strano personaggio, sembra quasi che non sia lui a fare ciò che gli si addebita e che voglia dirci qualcosa, ma non scivoliamo nel complottismo.
Leggi tutto
Hits 3667
Hits 3652
Hits 3266
Hits 3141
Hits 2847
Hits 2735
Hits 2628
Hits 2486
Hits 2160
Hits 2066
tonino

Carla Filosa: Sul Salario minimo
Sul Salario minimo
di Carla Filosa*
Di seguito un breve intervento di Carla Filosa sulle ipotesi di Salario minimo. La questione è stata affrontata con Carla nella trasmissione domenicale di Radio onda rossa 87.9 a Roma – http://www.ondarossa.info – proprio al ridosso della sua iniziale pubblicazione su La Città Futura. Qui il podcast
 Per leggere anche i disegni di legge sul
salario minimo (PD: n. 310 ; 5Stelle: ddl
n. 658; LEU: ddl n. 862) non è sufficiente conoscere il
significato comune o apparente delle parole ivi
contenute: è necessario
riconoscerne il significato, sempre sottinteso se non
ignorato, per comprenderne il contenuto reale o
scientificamente concreto. Per la
corretta individuazione di quest’ultimo si accolgono qui le
categorie dell’analisi marxiana della critica dell’economia
politica,
alla luce della quale soltanto è possibile cogliere la forma
attuale, ma celata, di questo sistema di uso profittevole del
lavoro,
inconsapevolmente destinato, lui, all’immiserimento
progressivo. Per forma è da intendere la sostanza,
l’organizzazione,
l’edificio interno ed esterno entro il quale prende vita e si
racchiude di necessità ogni relazione sociale, nelle sue
modalità
altrimenti inconoscibili perché queste non evidenziano la
natura, le cause reali del loro apparire, come
fossero sufficienti a
sé stesse, senza rinvio ad altro che non sia l’essere così
come sembrano. Comprendere la concretezza dei rapporti
sociali, delle
cose e delle parole è possibile allora solo conoscendo in
quale forma storica e logica essi si presentano e
vengono usati. Ad esempio
il lavoro salariato è la forma
specifica in cui bisogna comprendere cosa sia il lavoro
in questo sistema
capitalistico, in cui si presenta libero e separato
dai mezzi di produzione.
L’accesso al
salario è qui finalizzato alla produzione di un valore
(tempo di lavoro erogato) eccedente (che non viene pagato) il
necessario
(pagato) per vivere. Il salario insomma non ripaga tutto il
lavoro contrattato ma solo una parte e questa viene
continuamente ristretta, compressa. Il
lavoratore oggi incarna una forma di proprietà
privata nel senso che questa lo esclude, lo priva del prodotto
del suo lavoro come
della maggior parte della ricchezza sociale appropriata da una
minoranza di espropriatori.
Per leggere anche i disegni di legge sul
salario minimo (PD: n. 310 ; 5Stelle: ddl
n. 658; LEU: ddl n. 862) non è sufficiente conoscere il
significato comune o apparente delle parole ivi
contenute: è necessario
riconoscerne il significato, sempre sottinteso se non
ignorato, per comprenderne il contenuto reale o
scientificamente concreto. Per la
corretta individuazione di quest’ultimo si accolgono qui le
categorie dell’analisi marxiana della critica dell’economia
politica,
alla luce della quale soltanto è possibile cogliere la forma
attuale, ma celata, di questo sistema di uso profittevole del
lavoro,
inconsapevolmente destinato, lui, all’immiserimento
progressivo. Per forma è da intendere la sostanza,
l’organizzazione,
l’edificio interno ed esterno entro il quale prende vita e si
racchiude di necessità ogni relazione sociale, nelle sue
modalità
altrimenti inconoscibili perché queste non evidenziano la
natura, le cause reali del loro apparire, come
fossero sufficienti a
sé stesse, senza rinvio ad altro che non sia l’essere così
come sembrano. Comprendere la concretezza dei rapporti
sociali, delle
cose e delle parole è possibile allora solo conoscendo in
quale forma storica e logica essi si presentano e
vengono usati. Ad esempio
il lavoro salariato è la forma
specifica in cui bisogna comprendere cosa sia il lavoro
in questo sistema
capitalistico, in cui si presenta libero e separato
dai mezzi di produzione.
L’accesso al
salario è qui finalizzato alla produzione di un valore
(tempo di lavoro erogato) eccedente (che non viene pagato) il
necessario
(pagato) per vivere. Il salario insomma non ripaga tutto il
lavoro contrattato ma solo una parte e questa viene
continuamente ristretta, compressa. Il
lavoratore oggi incarna una forma di proprietà
privata nel senso che questa lo esclude, lo priva del prodotto
del suo lavoro come
della maggior parte della ricchezza sociale appropriata da una
minoranza di espropriatori.
All’esame del disegno del PD si evidenzia immediatamente, nelle finalità della proposta, l’ambiguo obiettivo di fornire al lavoratore “una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente….”, richiamando l’art. 36 della Costituzione.
Leggi tutto
Eros Barone: Contro le ideologie del monopolio e contro il neopositivismo
![]()
Contro le ideologie del monopolio e contro il neopositivismo
Problemi e alternative della critica marxista in Italia (1955-1960)
di Eros Barone
 Sdegno e tenacia, scienza e ribellione, rapido
impulso, meditato consiglio, fredda pazienza, perseveranza
infinita, intelligenza del particolare e intelligenza del
tutto: solo ammaestrati dalla
realtà potremo cambiare la realtà.
Sdegno e tenacia, scienza e ribellione, rapido
impulso, meditato consiglio, fredda pazienza, perseveranza
infinita, intelligenza del particolare e intelligenza del
tutto: solo ammaestrati dalla
realtà potremo cambiare la realtà.
Bertolt Brecht, La linea di condotta.
1. Analisi della risoluzione Contro le ideologie del monopolio
Il documento in parola 1 costituisce senza dubbio una tappa essenziale della politica culturale del PCI durante gli anni Cinquanta del secolo scorso. Lo sforzo di aggiornamento e di affinamento degli strumenti di analisi e di elaborazione teorica, mutuati dal ‘laboratorio’ dello storicismo gramsciano, si colloca su un terreno largamente ignoto alla tradizione retorico-umanistica che per diversi anni, durante il periodo post-Liberazione, aveva condizionato gli stessi intellettuali comunisti; sul terreno, cioè, di una serrata critica delle ideologie tecnocratiche, aziendaliste e interclassiste sorte nel quadro della espansione dei monopoli e delle innovazioni organizzative introdotte nei moderni processi produttivi, particolarmente in alcuni grandi complessi industriali del Nord-Italia.
La parola d’ordine che illuminava le finalità politico-culturali della risoluzione riprendeva l’appello alla storica lotta “tra progresso e reazione” nella cultura moderna e riecheggiava gli anni delle battaglie per la laicità dell’istruzione e della cultura contro l’invadenza clericale e l’offensiva oscurantista scatenata dalla DC e dalla Chiesa di Pio XII dopo il 1948, nel periodo della restaurazione capitalistica. La parola d’ordine era infatti: “Per l’ulteriore sviluppo di una cultura libera, moderna e nazionale alla luce dell’umanesimo e dello storicismo marxista”.
Nel primo dei quattro paragrafi in cui si articolava il documento veniva tracciato in termini di severa autocritica un bilancio dell’azione del partito e degli intellettuali comunisti sul classico “terzo fronte”. Questa azione si era venuta svolgendo, nel quadro di una ricerca strategica in quel settore specifico delle alleanze politiche rappresentato dalle alleanze culturali, attraverso lo sforzo di promuovere una “cultura libera, moderna e nazionale”, sforzo parallelo alla lotta per l’affermazione del marxismo.
Leggi tutto
Michele Castaldo: Elezioni europee maggio 2019: di caos in caos
Elezioni europee maggio 2019: di caos in caos
di Michele Castaldo
 Esattamente un anno fa
pubblicavo un articolo dal titolo: Caos Italia, ovvero la
rivolta del
ceto medio. A distanza di un anno con i risultati delle
elezioni europee viene confermata la tesi di fondo. Ovvero il
ceto medio, cioè un
insieme di categorie sociali cresciute a dismisura durante gli
anni di crescita dell’accumulazione capitalistica, con la
crisi non trovano
più spazio nel modo di produzione e si ribellano.
Esattamente un anno fa
pubblicavo un articolo dal titolo: Caos Italia, ovvero la
rivolta del
ceto medio. A distanza di un anno con i risultati delle
elezioni europee viene confermata la tesi di fondo. Ovvero il
ceto medio, cioè un
insieme di categorie sociali cresciute a dismisura durante gli
anni di crescita dell’accumulazione capitalistica, con la
crisi non trovano
più spazio nel modo di produzione e si ribellano.
Quando ho pensato di scrivere queste note mi sono posto una domanda: chi è l’interlocutore al quale mi devo rivolgere? In che modo si può parlare da vecchio militante di estrema sinistra a chi – privo di schema ideologico – come centinaia di migliaia di giovani, proletari e non, occupati, precari o disoccupati che hanno visto nel M5S un faro nella notte e lo hanno supportato fino a farlo diventare il primo partito italiano in soli 10 anni? Non mi nascondo dietro il dito: la risposta è molto complicata.
Intanto ci provo, ma con un’avvertenza: cari giovani, mentre da parte mia c’è da fare lo sforzo di rendere alcune questioni, molto complicate, accessibili a chi vuole sforzarsi di capire, da parte vostra – interessati in prima persona - c’è da fare lo sforzo di non chiedere, in primis “hic et nunc”, qui e ora, «c’amma fa?» per una ragione molto semplice: perché chi dovesse rispondere a questa domanda proporrebbe la propria idea dall’esterno, sul da farsi, a chi vive il sentimento della precarietà e del disagio, applicando così uno schema metafisico, un tempo si sarebbe detto da «coscienza esterna» cioè di sovrapposizione di un’idea esterna all’umore di chi pone quella domanda. Se proprio si vuole una risposta ci si può rivolgere a un Marco Travaglio, Gomez, Padellaro e altri sponsor del M5S.
Detto in modo brutale: chi è esasperato ed intende agire non chiede “che fare?”, ma è spinto a fare e strada facendo aggiusta il tiro.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: La sinistra lemming
La sinistra lemming
di ilsimplicissimus
Oggi tenterò un’operazione difficile, ossia assemblare due temi diversissimi tra loro, ma in fondo sotterraneamente collegati, ovvero quello politico del graduale suicidio delle sinistre in Europa perché continuano a scambiare il globalismo ultracapitalista con l’internazionalismo e quello dell’egemonia culturale americana che costituisce il nerbo della comunicazione neoliberista. Sul primo tema non c’è che da scegliere perché dovunque si guardi ve ne sono degli esempi di vivida opacità accompagnati da disastrosi risultati elettorali che tuttavia non riescono a scuotere queste elites residuali dal loro sogno dogmatico: Podemos va a fondo, Melenchon paga con una sanguinosa emorragia il sacrificio della sua originale posizione sugli altari dell’unità della sinistra, la Linke eurista nonostante Lafontaine, si posa sul fondo del barile e non parliamo nemmeno dello Stivale dove La Sinistra, unitasi al carrozzone europeista, ha raccolto un sontuoso bottino dell’ 1,75% inducendo per tutta risposta il coordinatore Nicola Fratoianni. naturalmente non dimissionario, a dire che il futuro sta nell’alleanza col Pd contro l’ “onda nera”. Bisognerebbe segnalare la cosa a qualche disegnatore di manga, che almeno potrebbe trarne qualcosa che abbia un senso.
Si tratta di cose ampiamente prevedibili, previste e non attribuibili soltanto alla scarsa organizzazione, al divisionismo a tutti i costi e all’unionismo dell’ultimo minuto, ma sono soprattutto il segnale di una tale confusione e ambiguità ideologica che prima delle elezioni Il Manifesto ha ritenuto di dover pubblicare un’articolessa di Roberta De Monticelli, nella quale si accusa la sinistra di cecità “all’orizzonte cosmopolitico della società giusta” e si rivendica la tradizione cristiana nella costruzione europea.
Leggi tutto
VoxPopuli: Europee. Un commento a caldo
Europee. Un commento a caldo
di VoxPopuli
Il commento a caldo dopo le Europee serve a tirare delle prime conclusioni su cui a parer mio bisogna riflettere.
Per prima cosa va registrato l’ennesimo totale fallimento annunciato della nostra area politica. Da Rizzo, che gioisce per un risultato insignificante, al listone “La Sinistra”, con la sua mediocrità nel proporre programmi cotti e stracotti, gonfi di europeismo idealista, di cui parlammo il giorno prima delle elezioni, abbiamo clamorosamente perso.
C’è da mettere sul banco degli imputati non un semplice dirigente o un gruppo dirigente ma l’intero modo di pensare e fare politica di questi partiti, tutti più o meno figli di Rifondazione Comunista, negli ultimi vent’anni. Non basta dire abbiamo comunicato male i nostri buoni propositi, oppure accusare di fascismo chi ha fatto una scelta ben diversa, votando Salvini.
Va fatta tabula rasa dell’approccio che una parte consistente di noi ha avuto nei confronti della gabbia europea e della lotta per i diritti dei ceti subalterni.
Per usare un’espressione di Formenti, la sinistra lemming che con questi listoni punta al suicidio e all’irrilevanza politica e culturale a parer mio va messa alla berlina e i primi che dovrebbero farlo sono i militanti che ad ogni tornata elettorale si fanno prendere in giro da dei dirigenti impresentabili e fuori dal mondo. Contrastare Salvini con l’antifascismo di maniera o con le pastasciutte antirazziste non basta, anzi, non serve a niente.
Leggi tutto
Fabrizio Poggi: 75° della vittoria sul nazismo: la storia rubata
75° della vittoria sul nazismo: la storia rubata
di Fabrizio Poggi
In vista del 75° anniversario della vittoria sul nazismo, che si celebrerà l'anno prossimo, negli Stati Uniti sarebbe stata già emessa una speciale moneta commemorativa. Nulla di strano; a parte il piccolo dettaglio che su una faccia della moneta siano raffigurati due personaggi, somiglianti a Harry Truman e Dwight D. Eisenhower, mentre sull'altra faccia siano incise le bandiere di USA, Gran Bretagna e Francia. L'Unione Sovietica non esiste più: dunque, perché ricordarla? La bandiera sovietica manca su quella moneta. Il nazismo è stato sconfitto dagli “Alleati”; senza discussioni. Sicuramente, l'anno prossimo tutti verremo chiamati a onorare le tre potenze “vittoriose”, mentre gli autentici vincitori del Drittes Reich saranno, nel migliore dei casi, passati sotto silenzio; nel peggiore, verranno assimilati al “male assoluto”, peggiori dei nazisti sconfitti.
Cosa significano i 26 milioni di cittadini sovietici caduti, civili e militari, a fronte del milione e mezzo di morti di Francia, Stati Uniti e Gran Bretagna prese insieme? Cosa importa che dal 1941 al 1944, quando l'Armata Rossa riuscì infine a portare il fronte al di là del territorio sovietico, le oltre 230 divisioni – da Germania e paesi satelliti, Italia compresa – schierate sul fronte orientale avessero condotto una guerra di sterminio, volta ad annientare la popolazione civile, mentre a ovest 60 divisioni tedesche tenevano impegnati gli Alleati quel tanto che bastava per rimandare fino al 1944 l'apertura del secondo fronte?
Leggi tutto
Jack Orlando: Vivere alla fine del giorno
Vivere alla fine del giorno
di Jack Orlando
È possibile definire grande democrazia un paese dove la polizia uccide quasi mille persone l’anno? Dove i tassi di malnutrizione infantile, povertà cronica e violenza endemica sono gli stessi di un teatro bellico?
Si direbbe di no, eppure è questa la condizione degli Stati Uniti d’America; il gigante più giovane dell’età degli imperi, che ha saputo plasmare, a sua immagine e somiglianza, l’Occidente stesso da cui è nato, un gigante dai piedi d’argilla che si voleva invincibile e che ora scorge il proprio tramonto.
Le contraddizioni stridenti del sistema yankee sembrerebbero ad una prima indagine storpiature inspiegabili. com’è possibile che la terra del benessere e dei sogni a portata di mano possa far convivere, nelle sue città, accumulazione sfrenata di ricchezza e lande sterminate di miseria?
È possibile perché l’essenza stessa di un certo modo di produrre ricchezza e concepire la democrazia si fonda proprio sul diritto del censo più forte, sulla violenza sistematica e sulla negazione di dignità degli esseri su cui questa ricchezza è prodotta.
D’altronde è il paese costruito col sudore degli schiavi, espanso con lo sterminio dei nativi, reso grande dal saccheggio di ogni terra di prossimità. Rapimento, omicidio, rapina, governo, profitto.
Leggi tutto
comidad: Soprattutto i ricchi piangono
Soprattutto i ricchi piangono
di comidad
La vera notizia di queste ultime elezioni non è il previsto trionfo di Salvini, quanto la sopravvivenza politica del PD, il quale vede finalmente esaurirsi l’effetto Renzi. Nelle elezioni europee di cinque anni fa, Renzi aveva condotto il PD al suo massimo storico, poi, nel giro di qualche anno lo ha condotto al minimo storico. Da quella vicenda Salvini dovrebbe trarre una lezione sia sul carattere volatile dei successi elettorali, sia sull’illusorietà del voler trasferire il risultato delle elezioni europee alle politiche, dove vota un 20% in più di elettori.
L’arena elettorale celebra i suoi trionfi e le sue condanne, ma il vincitore di turno si rivela regolarmente incapace di governare e la colpa, alla fine, è sempre dell’elettore, che non ha capito niente. Insomma, bisogna far votare il popolo e farlo sbagliare, così dopo si rassegna al fatto che deve affidarsi a chi ne sa più di lui.
Al di là dei sussulti elettorali, permane intanto il dominio del cosiddetto “senato virtuale”, cioè i mitici, quanto sedicenti, “Mercati”. È noto che dal 1975 le super-lobby della finanza, come la famigerata Commissione trilaterale, hanno avviato una polemica contro il cosiddetto “eccesso di democrazia”, un democrazia in crisi, bisognosa di “governabilità”.
Sulla base di queste esternazioni dei super-ricchi, è cominciata anche un’opposizione tesa alla rivendicazione della “sovranità popolare” contro il potere delle élite globaliste.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Le prigioni del Sahel
![]()
Le prigioni del Sahel
di Mauro Armanino
Niamey, maggio 2019. Per visitare i detenuti di Marassi a Genova i cancelli telecomandati da varcare erano sette. A Kollo, prigione a una trentina di kilometri da Niamey, le porte da passare sono appena tre. Una recinzione metallica, abbellita da un’artistica porta di ferro appena pitturata, annuncia il primo controllo dell’identità del visitatore. Segue poi un cortile di sabbia che conduce all’ingresso della prigione. Il secondo controllo è più accurato da quando, tra i detenuti, ci sono centinaia di sospetti militanti o simpatizzanti di Boko Haram da anni in attesa di giudizio. E più ancora da quando la prigione di massima sicurezza di Koutoukalé è stata attaccata da presunti salafisti che volevano liberare alcuni compagni ivi detenuti. Si raggiungono e passano, infine, le due ultime porte che permettono l’accesso al piccolo cortile interno di forma rettangolare. In alto, per la ronda delle guardie, appare un muretto e uno scampolo di filo spinato arrotolato, sul quale si posa il cielo.
Ma qui e nello spazio del Sahel le peggiori prigioni sono altre. Per esempio quella della violenza disarmata di cui l’ingiustizia costituisce la fonte di approvvigionamento principale. Proprio l’ingiustizia, trasformata in fenomeno naturale o culturale, è alla radice dell’esclusione sociale della maggior parte dei cittadini del Paese. Chi non ha (denaro, beni e dunque potere) non è nessuno e la sparizione forzata di persone nel Sahel rende visibile quanto la società stava già producendo.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Caro Sergio, non perdiamo la bussola
Caro Sergio, non perdiamo la bussola
di Leonardo Mazzei
 Sono molte le volte che in
questi ultimi dieci anni ci siamo trovati a fianco
dell'amico e compagno Sergio
Cesaratto, e lui a fianco nostro. Sergio non si è mai
tirato indietro, partecipando generosamente alle nostre
iniziative seminariali e
politiche di critica all'Unione europea e al regime
ordoliberista della moneta unica — fino al recente Forum Eurexit dell'aprile
scorso. Anche per
questo siamo sorpresi leggendo una sua recente intervista...
Sono molte le volte che in
questi ultimi dieci anni ci siamo trovati a fianco
dell'amico e compagno Sergio
Cesaratto, e lui a fianco nostro. Sergio non si è mai
tirato indietro, partecipando generosamente alle nostre
iniziative seminariali e
politiche di critica all'Unione europea e al regime
ordoliberista della moneta unica — fino al recente Forum Eurexit dell'aprile
scorso. Anche per
questo siamo sorpresi leggendo una sua recente intervista...
* * * *
Una recente intervista di Sergio Cesaratto ha stupito molti suoi amici. Tra questi, pure chi scrive queste righe. Successivamente, allo scopo di precisare meglio il suo pensiero, Cesaratto ha pubblicato un nuovo intervento. Il quale, se da un lato puntualizza alcune questioni, dall'altro entra in contraddizione con quanto affermato nella conversazione con Marco Biscella.
Entriamo dunque nel merito. «Lettera UE all'Italia - Le mosse da non sbagliare con l'Europa», è questo il titolo dato all'intervista, e ne restituisce perfettamente il senso. Nelle sue risposte Cesaratto dice essenzialmente quattro cose. La prima è che «i parametri di Maastricht hanno perfettamente senso». La seconda è che alla lettera UE bisogna dare «una risposta ragionevole con proposte ragionevoli e non sgangherate, come sbattere i pugni sul tavolo o minacciare di ribaltare i trattati». La terza è l'invito al governo italiano affinché lavori al seguente compromesso: «L’Europa dovrebbe aiutarci ad abbassare drasticamente i tassi d’interesse sui nostri titoli pubblici e l’Italia impegnarsi, firmando un memorandum, a una stabilizzazione, non riduzione, del rapporto debito/Pil». La quarta riguarda lo strumento "per cambiare l'Europa", che per Cesaratto è l'aumento progressivo del "bilancio federale", obiettivo da raggiungere anche alleandosi con Macron.
Leggi tutto
Carlo Galli: Pensiero forte in tempi minacciosi
Pensiero forte in tempi minacciosi
di Carlo Galli
 Per chi appartiene alla mia
generazione ha l’effetto di una madeleine reincontrare
Marcuse filosofo
politico. Questi testi inediti o poco conosciuti risvegliano
nella memoria le antiche emozioni intellettuali, le antiche
ingenuità e gli
antichi ambivalenti ideali. Per parafrasare quanto fu detto di
Heidegger da Löwith, nel leggere Marcuse era incerto se ci si
dovesse dedicare a
tempo pieno allo studio della Fenomenologia dello Spirito
o insorgere contro il dominio filisteo e repressivo del
‘sistema’. O
forse entrambe le cose, poiché in fondo si trattava, nella
testa dei giovani che siamo stati – e dello stesso Marcuse –,
della
medesima cosa.
Per chi appartiene alla mia
generazione ha l’effetto di una madeleine reincontrare
Marcuse filosofo
politico. Questi testi inediti o poco conosciuti risvegliano
nella memoria le antiche emozioni intellettuali, le antiche
ingenuità e gli
antichi ambivalenti ideali. Per parafrasare quanto fu detto di
Heidegger da Löwith, nel leggere Marcuse era incerto se ci si
dovesse dedicare a
tempo pieno allo studio della Fenomenologia dello Spirito
o insorgere contro il dominio filisteo e repressivo del
‘sistema’. O
forse entrambe le cose, poiché in fondo si trattava, nella
testa dei giovani che siamo stati – e dello stesso Marcuse –,
della
medesima cosa.
La potenza della filosofia classica tedesca, che qui risuona, sta proprio in questa confusione (o fusione) fra vita e sapere, fra politica e gesto conoscitivo, fra analisi e passione intellettuale, fra rigore scientifico ed emozione. È difficile che chi non ne ha fatto esperienza – o chi a ciò sia sordo – possa comprendere e consentire alla potenza del pensiero; come è difficile che ancora oggi parte della gioventù vi si possa sottrarre, anche se oggi il veicolo dell’innamoramento filosofico-politico può non essere Marcuse ma qualche altro pensatore più di moda.
Ma la lettura di Marcuse non attinge l’unico risultato di farci ripensare con rimpianto a un’età di giovanili entusiasmi – che hanno dovuto essere disciplinati per altre vie, e messi alla prova di altre strutture di pensiero –; c’è, in queste pagine, persistente, una sfida, connaturata alla forma della sua espressione filosofica. Una sfida che è ancora e sempre la nostra sfida: decifrare la politica attraverso la filosofia, e così intervenire in quella, per criticare le sue strutture reali e i suoi saperi specialistici – le scienze economiche e sociali in primo luogo – con quello «spirito di contraddizione reso sistema» che è il sapere filosofico. Una contraddizione che non vuol essere ignoranza ma superiore sapienza; e che consiste nello storicizzare i saperi della politica (in entrambi i sensi del genitivo), nell’attraversarli per mobilitarli, nel mostrarne la riconducibilità a un orizzonte epocale determinato e quindi all’esigenza del suo superamento.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Il consumatore votante
Il consumatore votante
di Salvatore Bravo
Il monstrum del sistema del capitale invita al voto, ma senza contenuto umanistico. Il voto è invece un gesto che umanizza. Occorre un voto che sia non utile, ma etico e partecipato
 “Per tutti i gusti”:
ecco la definizione che si può attribuire alle elezioni
europee. In assenza di cittadini capaci di esprimere un voto
consapevole, di cittadini che abbiano maturato una
progettualità politica di lungo
termine, ci troviamo dinanzi al monstrum del
sistema capitale che invita al voto, lo declama, ne fa segno
del riconoscimento immediato della
democrazia europea in una pluralità di “prospettive
politiche”. In realtà il voto è già inficiato in partenza
dall’essere in generale espresso non dal cittadino consapevole
ma dal suddito consumatore: si vota nella stessa
maniera con cui si
scelgono le merci. Le merci rispondono ad un bisogno
immediato, possono essere scelte e consumate per essere
sostituite senza scrupoli morali, senza
progettualità, senza consapevolezza. Si vive nell’empirico, si
sceglie, si desidera, si oblia per poi ricominciare l’eterno
ritorno
del medesimo. Si vota in modo simile, si sceglie il candidato
su un unico asse: l’asse dei propri particolari interessi
personali. Non ci si
scandalizza delle contraddizioni, dell’incoerenza: Salvini che
osanna i cieli e gli altari; Di Maio che insegue, solo al
comando,
un’improbabile partecipazione dal basso, falsificata da una
piattaforma (povero Rousseau!, casaleggiato) che non
ammette dialettica, ma
che pure si chiama Rousseau, nome che ammicca palesemente alla
democrazia diretta.
“Per tutti i gusti”:
ecco la definizione che si può attribuire alle elezioni
europee. In assenza di cittadini capaci di esprimere un voto
consapevole, di cittadini che abbiano maturato una
progettualità politica di lungo
termine, ci troviamo dinanzi al monstrum del
sistema capitale che invita al voto, lo declama, ne fa segno
del riconoscimento immediato della
democrazia europea in una pluralità di “prospettive
politiche”. In realtà il voto è già inficiato in partenza
dall’essere in generale espresso non dal cittadino consapevole
ma dal suddito consumatore: si vota nella stessa
maniera con cui si
scelgono le merci. Le merci rispondono ad un bisogno
immediato, possono essere scelte e consumate per essere
sostituite senza scrupoli morali, senza
progettualità, senza consapevolezza. Si vive nell’empirico, si
sceglie, si desidera, si oblia per poi ricominciare l’eterno
ritorno
del medesimo. Si vota in modo simile, si sceglie il candidato
su un unico asse: l’asse dei propri particolari interessi
personali. Non ci si
scandalizza delle contraddizioni, dell’incoerenza: Salvini che
osanna i cieli e gli altari; Di Maio che insegue, solo al
comando,
un’improbabile partecipazione dal basso, falsificata da una
piattaforma (povero Rousseau!, casaleggiato) che non
ammette dialettica, ma
che pure si chiama Rousseau, nome che ammicca palesemente alla
democrazia diretta.
Nessuno scandalo, in realtà, perché da decenni ormai si ripete che l’unico fondamento dell’esistenza di ciascun europeo sono i propri interessi privati, per cui le parole non sono ascoltate, valutate, misurate. Ci si sofferma solo sugli interessi economici che rispecchiano i propri gusti-interessi, il resto è una parodia neanche percepita. La sacralità atea ed informe del nichilismo dell’ultimo uomo è tra di noi, ha la forma brutale del capitalismo acquisitivo che martella nella mente, che ordina novello e terribile imperativo categorico a perseguire solo i propri privati interessi economici.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Oggi nell’aria c’è qualcosa di nuovo, anzi di sudamericano
Oggi nell’aria c’è qualcosa di nuovo, anzi di sudamericano
2 Giugno, stellette contro stelle
di Fulvio Grimaldi
Succede che certe volte i governi, specie quando capita per sbaglio che siano, almeno parzialmente, espressione genuina del popolo, dirazzino e si dimentichino il motivo per il quale stanno lì. Che è, tra le altre cose e in prima linea, quella di sostenere, onorare, rafforzare e retribuire chi ha il gravoso compito di difendere i sacri confini della patria, che siano al Brennero, in Crimea, Etiopia, Somalia, Serbia, Libia, Iraq, o Afghanistan. E anche l’onere e l’onore di stare a fianco, costi quel che possono costare 90 F35, di coloro che stanno sopra di noi. Queste dimenticanze da parte di governanti che insistono a voler essere civili e non uniformati, il popolo le paga. Pensiamo al Cile, all’Argentina, a tutto il Sudamerica (escluso il Venezuela, dove un fenomeno del tutto anomalo e contrario ha infranto la regola).
Succede che tre dei più illustri nostri generali, pluridecorati per meriti acquisiti nelle campagne per la democrazia e i diritti umani, che hanno fatto il lustro del nostro paese e offerto alle giovani generazioni esempi di amor di patria e di vittoria, rispettivamente già capi di Stato Maggiore della Difesa e capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, alla parata militare del 2 giugno non ci sono voluti andare.
Leggi tutto
Carlo Galli: Elezioni europee 2019
Elezioni europee 2019
di Carlo Galli
La soddisfazione del Pd per la “crescita” elettorale dimostra solo quanto grande era il suo timore. In realtà, il Pd perde circa centomila voti rispetto alle politiche del 2018 (più di sei milioni rispetto al 2014) e guadagna in percentuale solo pescando dall’astensione e da LeU, mentre i voti usciti dall’effimero e incapace M5S (meno 1.200.000 rispetto al 2014, meno 6.200.000 rispetto al 2018) vanno all’astensione e alla Lega. Che, a sua volta, guadagnando tre milioni e mezzo di voti rispetto al 2018 e 7.500.000 rispetto al 2014, cannibalizza anche Fi (che perde 2.200.000 voti rispetto al 2014 e al 2018).
Caduto il Piemonte, tutto il Nord e quasi tutto il Centro sono in mano alla Lega, che raddoppia come i grillini dimezzano. Solo le grandi città votano Pd, insieme ad alcune province rosse dell’Emilia-Romagna e della Toscana (qui l’amministrazione, meno cattiva che altrove, è premiata dai cittadini).
La Lega raddoppia, FdI avanza, Fi tende a scomparire, il M5S si dimezza; le élites di +Europa si dimostrano inconsistenti, il Pd tiene a fatica. Nel complesso, insultare i cittadini, demonizzare Salvini, puntare sulla paura delle conseguenze di un voto anti-europeo senza proporre nulla in positivo, continua a non esser un buon affare elettorale.
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: “La sveglia al collo”
“La sveglia al collo”
di Elisabetta Teghil
Con l’espressione popolare “anello al naso e sveglia al collo”, di matrice chiaramente razzista, il comune sentire intende definire una persona che viene presa bellamente in giro e neanche se ne accorge, attribuendo questa ingenuità di comportamento ai popoli colonizzati e incapaci di gestirsi da soli e che, quindi, si possono abbindolare molto facilmente. Ma, mai come oggi, questa espressione è adatta a definire le popolazioni occidentali. D’altra parte il neoliberismo tratta i territori occidentali come colonie interne sia dal punto di vista economico che del controllo sociale e della militarizzazione. In tutti questi anni sono stati messi a punto una serie di meccanismi e di dispositivi che hanno profondamente modificato il comune sentire, annullato la capacità critica, azzerato la percezione del sopruso e dell’ingiustizia, anestetizzato la gente rispetto alla violenza che subisce quotidianamente, risvegliato gli istinti più bassi dell’essere umano dalla delazione al livore per i più deboli, dal servilismo alla perdita di ogni dignità personale e politica. E questo è tangibile, è definibile da alcuni misuratori alla portata di ognuno di noi. I militari con il mitra nelle strade, nelle piazze, nelle stazioni metro, in mezzo a gente che fa shopping, a turisti che scattano foto, a bambini che giocano ci raccontano di quanto la gente si sia assuefatta agli scenari di guerra.
Leggi tutto
coniarerivolta: Sfruttare l’immigrato sì, ma con il sorriso
Sfruttare l’immigrato sì, ma con il sorriso
di coniarerivolta
Il tema immigrazione è, da ormai molti anni, ostaggio di un pericoloso scontro retorico tra due visioni apparentemente diverse, ma del tutto convergenti nel vedere nello straniero un oggetto, un mero strumento da valutare nel suo impatto sul benessere economico degli italiani.
All’odiosa schiera, sempre più nutrita, degli xenofobi di professione e dei fomentatori di odio, coloro che nello straniero vedono il pericolo principale per la stabilità sociale e l’integrità culturale ed una serissima minaccia per i posti di lavoro degli italiani, rispondono, con numeri e dati sciorinati meticolosamente, coloro secondo i quali senza stranieri il Paese andrebbe a scatafascio, l’economia collasserebbe e lo stato sociale non potrebbe più essere finanziato.
La prima visione semina odio e guerra tra poveri; la seconda, apparentemente conciliante nelle conclusioni, semina in verità un similissimo razzismo strisciante e una mostruosa concezione reificata e strumentale dell’immigrato e di tutti i soggetti economici subalterni.
Una recente indagine della UIL e dell’istituto di ricerca EURES, riportata con entusiasmo da diversi periodici di ispirazione liberal-progressista, ha simulato cosa accadrebbe nella regione Lazio se d’un tratto scomparissero tutti i lavoratori stranieri: “Scompaiono colf, babysitter, muratori, infermieri, cuochi, commercianti e imprenditori. Le aule si svuotano, diminuiscono i matrimoni. Tremano le casse dell’Inps. Le città sono in tilt.
Leggi tutto
Giorgio Cremaschi: I pensierini di Salvini e le letterine di Bruxelles
I pensierini di Salvini e le letterine di Bruxelles
di Giorgio Cremaschi
Il tema Unione Europea, scomparso dal confronto elettorale delle principali forze politiche, torna subito in campo con l’annuncio di una lettera della Commissione UE che chiederebbe all’Italia di rispettare le regole del Fiscal Compact, che sono anche più rigide del 3 % di deficit massimo previsto dal Trattato di Maastricht. Di questo avrebbe dovuto parlar una seria campagna elettorale per il Parlamento UE, invece tutte le principali forze politiche si sono scontrate sulle polemiche di casa, tutte poi aggiungendo che avrebbero voluto “andare in Europa per cambiarla”. Che voleva dire? Nulla.
Ora Salvini, dopo il successo elettorale, prevedendo la “letterina” di Bruxelles, esprime pensierini non conformisti sui vincoli di bilancio imposti dai trattati UE. Lui che nel solo bilancio ufficiale sinora stilato assieme a Di Maio, non solo non è riuscito a sforare il 3, ma si è impegnato con la UE non superare neppure il 2. Lui che ha firmato di nuovo ed ampliato le cambiali sottoscritte dai suoi predecessori, impegnandosi ad aumentare l’IVA di 50 miliardi in due anni. Lui che con i suoi alleati del fronte sovranista reazionario ha esaltato l’Europa bianca e cristiana, ma si è ben guardato dal mettere in discussione l’Europa di Maastricht. Perché i suoi alleati, felici quando chiude i porti, sono indisponibili ad aprire i cordoni della borsa per sostenere le spese pubbliche degli italiani.
Leggi tutto
Ascanio Bernardeschi: Alan Freeman e la pianificazione nell’era dell’informazione
Alan Freeman e la pianificazione nell’era dell’informazione
di Ascanio Bernardeschi
La pianificazione economica è più efficace e più democratica del libero mercato. Alcuni spunti per una teoria della pianificazione adeguata alla attuale società informatizzata
Il presente articolo riassume e commenta un’esposizione di Alan Freeman di cui sono disponibili le slide qui. Freeman è un economista marxista inglese che ha dato un notevole contributo alla interpretazione della teoria del valore di Marx ed è uno dei padri della TSSI (Temporal Single System Interpretation). La sua esperienza non è solo di tipo accademico. Negli anni 80 ha implementato il sistema di comunicazione per la produzione "just-in-time" di Sony. Più recentemente, nel corso del mandato di Ken Livingstone e fino al 2011, ha lavorato alla Greater London Authority, l’autorità che amministra Londra sotto la guida del Sindaco e dell’Assemblea, preposta all’elaborazione di un piano per la città. Ha quindi conoscenze dirette dei piani economici e nella sua esposizione propone alcune idee per una nuova teoria della Pianificazione. Attualmente è attivo nel Gruppo di ricerca sull’economia geopolitica all’Università di Manitoba. Iniziamo illustrando i punti salienti della sua esposizione.
Pianificazione, perché abbiamo bisogno di una teoria
In genere la pianificazione economica viene identificata con l’esperienza dell'economia sovietica. La disinformazione regnante in merito in Occidente trae origine da questo fraintendimento.
Leggi tutto
Hits 3693
Hits 3668
Hits 3278
Hits 3167
Hits 2865
Hits 2760
Hits 2644
Hits 2502
Hits 2178
Hits 2076
tonino

Giovanni Bruno: La nuova stagione del comunismo
La nuova stagione del comunismo
Ripensare Marx, riscoprire la lotta di classe, rilanciare i movimenti
di Giovanni Bruno
 Marx 201. Ripensare
l’alternativa è il titolo del bel convegno,
estremamente ricco e variegato, che si
è svolto a Pisa da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio. Si è
trattato di una tre giorni, con nove sessioni di discussione,
organizzata da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo e professore
ordinario dell’Università di Pisa, e da Marcello Musto, uno
tra i
più significativi studiosi attuali di Marx su scala
internazionale: l’idea fondamentale è stata quella di
ripercorrere e
recuperare alcune definizioni del pensiero di Marx, a partire
da categorie e tematiche fondamentali, “depurandolo” dalle
incrostazioni
derivanti dalle interpretazioni e dalle piegature
storico-politiche novecentesche dei molteplici marxisti e
marxismi, per tornare alle radici del suo
pensiero. L’altro aspetto che ha caratterizzato il convegno è
la volontà di coniugare la dimensione politica con quella
teorico-scientifica, mettendo in relazione le analisi e la
visione della storia di Marx con alcuni della variegata
galassia dei movimenti e delle
forme di resistenza al dominio del capitale che si sono
manifestate in questo scorcio di inizio XXI secolo.
Marx 201. Ripensare
l’alternativa è il titolo del bel convegno,
estremamente ricco e variegato, che si
è svolto a Pisa da mercoledì 8 a venerdì 10 maggio. Si è
trattato di una tre giorni, con nove sessioni di discussione,
organizzata da Alfonso Maurizio Iacono, filosofo e professore
ordinario dell’Università di Pisa, e da Marcello Musto, uno
tra i
più significativi studiosi attuali di Marx su scala
internazionale: l’idea fondamentale è stata quella di
ripercorrere e
recuperare alcune definizioni del pensiero di Marx, a partire
da categorie e tematiche fondamentali, “depurandolo” dalle
incrostazioni
derivanti dalle interpretazioni e dalle piegature
storico-politiche novecentesche dei molteplici marxisti e
marxismi, per tornare alle radici del suo
pensiero. L’altro aspetto che ha caratterizzato il convegno è
la volontà di coniugare la dimensione politica con quella
teorico-scientifica, mettendo in relazione le analisi e la
visione della storia di Marx con alcuni della variegata
galassia dei movimenti e delle
forme di resistenza al dominio del capitale che si sono
manifestate in questo scorcio di inizio XXI secolo.
È in questo contesto che vi è stato l’intervento di Álvaro Garcia Linera, intellettuale e sociologo impegnato nei movimenti guerriglieri boliviani, e oggi Vicepresidente della Bolivia di Evo Morales, nonché vera e propria eminenza grigia del governo boliviano e del MAS (Movimiento Al Socialismo), organizzazione con cui insieme a Morales ha vinto le elezioni nel 2005. Al suo attivo numerosi libri teorici e politici, tradotti in inglese ad attestare lo spessore internazionale del suo profilo di intellettuale di sinistra e marxista, tra cui Las Tensiones Creativas De La Revolución, La Potencia Plebeya, A Potência Plebeia. Ação Coletiva e Identidades Indígenas, Operárias e Populares na Bolívia.
L’ampia relazione di Linera, dal titolo: Marx en América Latina. Nuevos caminos al comunismo, ha sviluppato una riflessione sul pensiero rivoluzionario di Marx, a partire dalla sottolineatura della differenziazione tra la società dell’America Latina, a base prevalentemente contadina e rurale, rispetto alle società industriali come quella europea o nordamericana: si percepiscono sullo sfondo, filtrate e rielaborate, categorie del pensiero gramsciano, che in America Latina è peraltro conosciuto e studiato a fondo.
Leggi tutto
Giorgio Galli - Roberto Sidoli: Una discussione sulla teoria dell’effetto di sdoppiamento
Una discussione sulla teoria dell’effetto di sdoppiamento
di Giorgio Galli - Roberto Sidoli
 Nel corso degli
ultimi mesi si è avviata una discussione multilaterale fra
l’autore del
libro I rapporti di forza e il professor Giorgio
Galli, dibattito che fra le altre cose ha avuto come oggetto
anche lo schema teorico
dell’effetto di sdoppiamento e la centralità della sfera
politica, intesa in senso leninistico come “espressione
concentrata
dell’economia”, all’interno del processo di riproduzione
delle variegate e diverse società via via apparse sull’arena
storica nel corso degli ultimi undicimila anni, a partire
dalla protocittà collettivistica di Gerico. Il risultato e
il sottoprodotto del
confronto avviato in questo ultimo periodo è costituito
dallo scambio epistolare sotto riprodotto, che spera e
intende avviare un percorso di
confronto teorico su tali temi nella sinistra antagonista
[Daniele Burgio]
Nel corso degli
ultimi mesi si è avviata una discussione multilaterale fra
l’autore del
libro I rapporti di forza e il professor Giorgio
Galli, dibattito che fra le altre cose ha avuto come oggetto
anche lo schema teorico
dell’effetto di sdoppiamento e la centralità della sfera
politica, intesa in senso leninistico come “espressione
concentrata
dell’economia”, all’interno del processo di riproduzione
delle variegate e diverse società via via apparse sull’arena
storica nel corso degli ultimi undicimila anni, a partire
dalla protocittà collettivistica di Gerico. Il risultato e
il sottoprodotto del
confronto avviato in questo ultimo periodo è costituito
dallo scambio epistolare sotto riprodotto, che spera e
intende avviare un percorso di
confronto teorico su tali temi nella sinistra antagonista
[Daniele Burgio]
* * * *
Commento
di Giorgio Galli
“Il cruciale biennio novembre 1989 (abbattimento del muro di Berlino) – agosto 1991 (implosione dell’Urss, col colpo di stato di Eltsin), poté essere presentato come riprova del fallimento del marxismo e come sua scomparsa dall’orizzonte politico-teorico europeo, che aveva dominato per un secolo, dall’ultimo ventennio del XIX secolo al citato biennio del XX. In realtà, la struttura di pensiero che ha preso nome da Marx non scomparve da quell’orizzonte culturale: per limitarci all’Italia, hanno continuato ad essere pubblicati prodotti ad alto livello a quel pensiero ispirati: ne cito soltanto due, che hanno diretta attinenza col terzo (dattiloscritto di Roberto Sidoli, “I rapporti di forza – Analisi della dinamica politico-sociale dal 9000 a.C. fino ai nostri giorni”), al quale questo commento è dedicato.
Dei due testi che qui segnalo, il primo è “Guida alla lettura de ‘Il Capitale’” (di Luigi Ferrari, ed. Del Pavone, 2019). Vi si dimostra l’assoluta scientificità del pensiero di Marx, che viene collocato, ne “L’ascesa dell’individualismo economico”, sempre di Ferrari, stesso editore, 2017), con base sul rapporto tra individualismo e collettivismo (la “linea nera” e la “linea rossa” di Sidoli).
Leggi tutto
Emiliano Laurenzi: Islamismo capitalista
Islamismo capitalista
Intervista ad Emiliano Laurenzi
 Dott.
Emiliano Laurenzi, Lei è
autore del libro Islamismo capitalista. Il wahhabismo
in Arabia Saudita edito dalla Manifestolibri: quali
contraddizioni vive l’Arabia
Saudita?
Dott.
Emiliano Laurenzi, Lei è
autore del libro Islamismo capitalista. Il wahhabismo
in Arabia Saudita edito dalla Manifestolibri: quali
contraddizioni vive l’Arabia
Saudita?
La domanda tocca una grande molteplicità di aspetti religiosi, sociali ed economici, che in qualche modo attraversano tutto il mondo musulmano. Per rispondere in modo chiaro, va quindi immediatamente sgomberato dal discorso il pregiudizio di un Islam uniforme, compatto ed unito. Niente infatti è più lontano dalla realtà dei fatti e non a caso si parla di contraddizione, non a caso il libro si apre proprio utilizzando come metafora della stridente situazione dell’Arabia Saudita la pratica del tafheet. Tafheet è il termine arabo per indicare il drifting, una pratica illegale che spopola in Arabia Saudita e consiste nel lanciare ad elevate velocità grosse automobili, costose e potenti, per farle sterzare in controsterzo, con giravolte ed intraversamenti. Una pratica spesso fatale, in parte recuperata attraverso la creazione di campionati legali, con gare vere e proprie – in cui la RedBull fa la parte del leone – e la sua spettacolarizzazione cinematografica.
Questa pratica, che unisce uno degli oggetti consumistici più riconoscibili sul pianeta, l’automobile, allo sfoggio di abilità personale, sullo sfondo di un’urbanizzazione molto forte, di cui noi però conosciamo solo gli aspetti sfarzosi ed alla moda che ci vengono proposti dai media, è icastica delle contraddizioni che scuotono l’Arabia Saudita. Queste contraddizioni, prima ancora che sociali ed economiche, sono fondamentalmente quelle tipiche dei paesi che vengono investiti dalle dinamiche del regime capitalistico e dalle sue ricadute consumistiche in termini di comportamenti individuali.
La principale contraddizione che vive l’Arabia Saudita oggi è infatti quella di un paese che afferma di avere come costituzione il Corano, che è custode dei luoghi Santi dell’Islam e che diffonde la religiosità wahhabita in tutto il mondo, ma che allo stesso tempo è uno dei laboratori più avanzati del capitalismo contemporaneo, con tutto il suo carico di sregolato desiderio consumistico.
Leggi tutto
Giacomo Marchetti: Sudan: colpo di stato ed “escalation della rivoluzione”
Sudan: colpo di stato ed “escalation della rivoluzione”
di Giacomo Marchetti
Lunedì mattina è stato sgomberato con estrema violenza il sit-in di fronte al quartier generale dell’esercito nella capitale sudanese, e azioni di “rappresaglia” analoghe si sono svolte in altre città, come Nuhood, Atbara, Port Sudan, ecc.
È stato l’ultimo atto di una serie di provocazioni e minacce che “lo stato profondo” del defunto regime ha messo in atto per cercare di stroncare le aspirazioni ad un cambiamento radicale, che non si limitasse alla sola “uscita di scena” di Omar Al-Bashir, nonostante la TMC neghi avere avuto alcuna responsabilità nell’accaduto, sfiorando lo sprezzo del ridicolo.
Il dittatore sudanese – salito al potere con un colpo di stato appoggiato dalle forze dell’islam radicale più retrivo nel 1989 – era stato deposto l’11 aprile al culmine della mobilitazione iniziata il 6 aprile, facendo convergere proprio di fronte al quartier generale una marea umana da ogni angolo del paese.
Da allora il governo del Sudan è in mano ad alcuni generali “golpisti” (ex fedelissimi del regime) mentre le mobilitazioni non sono cessate; il sit in era stato mantenuto per più di 50 giorni – nonostante provocazioni e minacce reiterate – divenendo di fatto il centro della vita politica non solo della capitale; un approdo per le delegazioni da ogni parte del paese, specie in periodo di Ramadam dove, con la fine del digiuno, le persone si recavano in questo presidio permanente.
Leggi tutto
Redazione: Sostituire il ministro dell'economia
Sostituire il ministro dell'economia
di Redazione
Al di là di come siano andate effettivamente le cose nessuno, nel governo, ci fa una bella figura. Ed infatti i giornali ed i media di regime fanno a gare nel parlare di "governo allo sbando", "siamo senza governo", "nuova crisi tra gli alleati di governo", ecc.
La "manina 2"...
Già nell'ottobre scorso accadde che Di Maio denunciò "la manina" che manomise, a suo dire, il decreto sul condono fiscale. Accusa che Di Maio fece a Porta a Porta incolpando esplicitamente i colleghi della Lega. Annunciò addirittura una denuncia alla Procura, ma poi dovette fare marcia indietro.
Ora ci risiamo, ma questa volta la cosa è decisamente più grave, dato che si tratta della risposta alla missiva della Commissione della Ue. Nella lettera circolata ieri pomeriggio si rassicurava la Commissione che il governo avrebbe rispettato le stringenti condizioni per il rispetto dei parametri sul deficit e il percorso di abbassamento del debito. Detto in parole povere: sarebbero stati fatti tagli allo stato sociale, con eventuale retromarcia sulle due misure simbolo del governo: RdC e Quota 100. Si leggeva intatti testualmente:
«riduzioni delle proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022»
Leggi tutto
Girolamo De Michele: Valeria Pinto, "Valutare e punire
Valeria Pinto, "Valutare e punire
di Girolamo De Michele
La nuova edizione (arricchita da tre nuovi saggi) di Valutare e punire (Cronopio 2019, pp. 306, € 15), libro col quale Valeria Pinto ha segnato, nel 2012, un punto fermo nel dibattito critico sulla valutazione nei sistemi di apprendimento, si apre con uno spiazzamento significativo. La prima edizione cominciava da Popper, al quale veniva imputato l’aver fornito le basi teoriche per la ratio dell’homo œconomicus che è alla base di tutti i processi della valutazione, disegnando il percorso battuto dai teorici del “capitale umano”: un olismo per il quale può essere compresa con categorie di tipo economico ogni condotta che, semplicemente, “accetti la realtà”. Non si comprende la pervasività dei processi di valutazione se non li si colloca nell’orizzonte del neo-liberalismo, di quel “realismo capitalista”, per dirla con Mark Fisher, pervaso dall’ideologia del There Is No Alternative. Questa nuova edizione è invece introdotta da un nuovo, denso capitolo, “Caduta libera”, il cui titolo fa riferimento a un episodio della serie Black Mirror (3.01), nel quale l’intera vita quotidiana è sottoposta a valutazione quantitativa istantanea. Fantascienza, verrebbe da dire: se il sistema dei crediti sociali in Cina non evidenziasse la produzione di “vite a punti all’ombra del partito” e di prime forme di esclusione dei “poco virtuosi” che già ora subiscono limitazioni alla libertà di movimento (vedi gli articoli di Simone Pieranni ⇒ qui e ⇒ qui) : i presenti possibili tratteggiati da Black Mirror, come nota Pieranni [⇒ qui], sembrano superati dalla realtà.
Leggi tutto
Stop TTIP: Italia condannata dal tribunale delle multinazionali
Italia condannata dal tribunale delle multinazionali
di Stop TTIP
L’Italia perde ancora in un arbitrato internazionale. La recente sentenza emessa da tre avvocati commerciali è l’amaro epilogo di una causa intentata dalla società olandese CEF Energia BV al nostro paese presso la Camera di commercio di Stoccolma.
I dettagli della vicenda li spieghiamo più avanti, ma il succo è che dobbiamo pagare di 10,6 milioni di euro di multa per aver ridotto gli incentivi alle rinnovabili cinque anni fa: non importa se abbiamo dovuto fare questi tagli per rispettare vincoli di bilancio imposti dall’austerity della Commissione Europea. Non fa testo alcuna discussione sull’opportunità o meno di continuare a sussidiare il fotovoltaico. Agli arbitri non interessa: i contribuenti italiani dovranno sborsare quei 10,6 milioni di sudati euro all’impresa che si è appellata alla clausola ISDS contenuta nel Trattato sulla Carta dell’Energia. L’ISDS (Investor-State Dispute Settlement) è il meccanismo di composizione delle controversie fra investitori e stati presente in molti accordi sul commercio e gli investimenti, tra cui i ben noti TTIP e CETA. Permette alle imprese di un paese contraente di chiedere danni virtualmente illimitati a un altro stato firmatario se questo – con le sue politiche – ha violato le loro “legittime aspettative” di profitto.
Le cause vengono affidate a opachi tribunali commerciali, retti da pochi professionisti su cui grava l’ombra del conflitto di interessi, che operano fuori dal controllo pubblico (leggi il rapporto di Stop TTIP Italia sull’ISDS).
Leggi tutto
Gerardo Torres: Uno sciopero per la democrazia
Uno sciopero per la democrazia
Geraldina Colotti intervista Gerardo Torres*
Honduras di nuovo in fiamme per lo sciopero generale indetto dai lavoratori della sanità e dell’educazione contro i piani di privatizzazione approvati per decreto dal governo di Juan Orlando Hernández (Partido Nacional Honduregno). Ne abbiamo parlato con Gerardo Torres, segretario internazionale del Partido Libre de Honduras, che avevamo intervistato a Caracas in occasione del II Forum sulla Gran Mision Vivienda Venezuela, e che abbiamo sentito al telefono per gli ultimi aggiornamenti.
* * * *
Cosa sta succedendo in Honduras? E’ vero che è stata data alle fiamme l’ambasciata USA? Sulle reti sociali c’è chi ha parlato di una provocazione architettata
E’ vero, ieri un incendio ha distrutto quasi completamente l’entrata principale dell’ambasciata nordamericana nel secondo giorno di sciopero generale. Il paese è completamente militarizzato, ma durante una mobilitazione che ci ha portato nei pressi dell’ambasciata USA, alcuni giovani sono riusciti ad avvicinarsi approfittando del poco controllo che c’era in un perimetro solitamente militarizzato. L’Iran e l’Honduras sono gli unici due paesi che hanno dato fuoco a un’ambasciata gringa. Da noi è la seconda volta che succede, la prima è stata nel 1986, durante una protesta con un’alta partecipazione di studenti. Siamo nel pieno di un processo di privatizzazione della salute e dell’educazione voluto da un governo al soldo degli Stati uniti e delle grandi multinazionali.
Leggi tutto
r.s.: Italy-Europa e ritorno
Italy-Europa e ritorno
di r.s.
 Su cosa si è votato domenica scorsa? Non sull’Europa
che
vogliamo. L’elettore medio europeo non da ora si è
dovuto convincere, con buona dose di realismo, che l’obiettivo
è
più modestamente quello di ridefinire, per quanto ciò è
possibile con il voto, i rapporti tra il
proprio stato e
questa strana entità sovranazionale che non è né una
federazione né una confederazione, ma piuttosto un comitato di
contrattazione permanente tra componenti statuali e potentati
economici. Dagli interessi visibilmente divergenti e però tali
da pesare, eccome,
sulla vita del cittadino/clienteeuropeo.
Piano dunque oramai inaggirabile anche se - secondo una
percezione oramai diffusa - a
rischio di implosione a misura che il gioco geopolitico e
geoeconomico globale va facendosi sempre più duro. Su questo
criterio di fondo si
è andati a testare l’offerta
politica nazionale cogliendo altresì l’occasione, soprattutto
in alcuni scenari nazionali, di fare una verifica dei
poteri. Il che, al di là del velo
mistificante di una
comunicazione politica continuamente on, è
nei fatti operazione sempre più rara e difficoltosa.
Su cosa si è votato domenica scorsa? Non sull’Europa
che
vogliamo. L’elettore medio europeo non da ora si è
dovuto convincere, con buona dose di realismo, che l’obiettivo
è
più modestamente quello di ridefinire, per quanto ciò è
possibile con il voto, i rapporti tra il
proprio stato e
questa strana entità sovranazionale che non è né una
federazione né una confederazione, ma piuttosto un comitato di
contrattazione permanente tra componenti statuali e potentati
economici. Dagli interessi visibilmente divergenti e però tali
da pesare, eccome,
sulla vita del cittadino/clienteeuropeo.
Piano dunque oramai inaggirabile anche se - secondo una
percezione oramai diffusa - a
rischio di implosione a misura che il gioco geopolitico e
geoeconomico globale va facendosi sempre più duro. Su questo
criterio di fondo si
è andati a testare l’offerta
politica nazionale cogliendo altresì l’occasione, soprattutto
in alcuni scenari nazionali, di fare una verifica dei
poteri. Il che, al di là del velo
mistificante di una
comunicazione politica continuamente on, è
nei fatti operazione sempre più rara e difficoltosa.
Sotto questo aspetto, in Italia il voto ha sostanzialmente registrato la tenuta del governo nel suo atteggiamento di fronte alla UE. Premiando, ovviamente, chi si è mostrato più battagliero e coerente, quindi indubbiamente Salvini, nel recupero di sovranità senza rimessa in discussione dell’euro, sul doppio terreno dell’allentamento dei vincoli economici posti da Bruxelles e della richiesta di regolamentazione condivisa dell’immigrazione extra-europea. I due temi, attenzione, strettamente intrecciati nella percezione - che per quell’animale simbolico che è l’essere umano è parte essenziale della realtà - dei ceti popolari medio-bassi. Questi vivono sulla propria pelle il quadro di crisi profonda del paese e sanno che la questione immigrazione è già oggi questione di distribuzione del welfare e, domani, anche del (cattivo) lavoro che resterà. Buon senso materialistico, che può non piacere, ma sarebbe disonesto liquidare come razzismo.
Leggi tutto
Vincenzo Comito: Vincerà la Cina?
Vincerà la Cina?
di Vincenzo Comito
Quali potrebbero essere le contromisure ai dazi di Trump, dalla cacciata di Apple al renmimbi come valuta alternativa al dollaro fino alla vendita dei titoli pubblici statunitensi detenuti dalla Banca centrale cinese (1.130 miliardi). Tutti incubi per gli Usa
 Di cosa
siamo abbastanza sicuri
Di cosa
siamo abbastanza sicuri
Sulla guerra scatenata su più fronti da Trump nei confronti della Cina alcune cose sembrano già oggi chiare. La prima è che tale guerra, partita apparentemente come un problema commerciale, si è via via mostrata nel suo vero volto, che è quello della lotta per il dominio tecnologico e, più in generale, per l’egemonia globale sul mondo. La potenza sino a ieri dominante cerca di impedire in ogni modo a quella emergente di raggiungerla e, peggio, di effettuare il sorpasso. Non è evidentemente la prima volta che ciò accade nella storia, con esiti nel tempo piuttosto vari.
Un’altra cosa che sembra certa è che tale guerra non si chiuderàcon qualche accordo decisivo. Nel breve termine sembrerebbe in qualche modo possibile che si trovi un punto di incontro, perché i costi della rottura sarebbero troppo alti per entrambi i contendenti, anche se bisogna tener conto dell’irrazionalità frequentemente presentenei comportamenti umani. Tra l’altro, le catene di fornitura a livello mondiale sono strettamente interconnesse e introdurvi dei cambiamenti significativi costa molto e richiede comunque tempi adeguati.
Ma la lotta è destinata a protrarsi a lungo e a non venir meno anche se le prossime elezioni presidenziali venissero vinte dai democratici; infatti, “moderati” o liberal che siano, i membri di quest’ultimo partito appaiono dei sostenitori ancora più accaniti dell’egemonia statunitense. Qualcuno pensa persino che il conflitto tra i due Paesi strutturerà tutto il XXI° secolo (Frachon, 2019).
L’altra cosa che almeno a chi scrive sembra evidente è che, in qualche modo, come anche qualcuno ha detto, il presidente Usa era obbligato a fare qualcosa per contrastare l’avvento di un nuovo potenziale Paese egemone. Alla fine, plausibilmente, la Cina vincerà la nuova guerra fredda o almeno questa prima battaglia, peraltrocon qualche danno temporaneo; maa soffrire, per un po’ almeno, saranno, oltre alla Cina, anche gli Stati Uniti, ma non solo, tutta l’economia mondiale.
Leggi tutto
Noi Restiamo: Dobbiamo cominciare a pensare a come sarà la guerra futura
Dobbiamo cominciare a pensare a come sarà la guerra futura
di Noi Restiamo
 Pubblichiamo di
seguito la traduzione di un articolo comparso su Nature dal
titolo Europe’s
controversial plans to expand defence research di Elizabeth
Gibney, con l’intento di rovesciare il punto di vista della
questione che pone
Kleyheeg – specialista nel settore difesa del TNO, un ente
di ricerca indipendente che si propone di mettere la propria
conoscenza e la
tecnologia che sviluppa al servizio della difesa e della
sicurezza – “Dobbiamo cominciare a pensare a come sarà la
guerra
futura”.
Pubblichiamo di
seguito la traduzione di un articolo comparso su Nature dal
titolo Europe’s
controversial plans to expand defence research di Elizabeth
Gibney, con l’intento di rovesciare il punto di vista della
questione che pone
Kleyheeg – specialista nel settore difesa del TNO, un ente
di ricerca indipendente che si propone di mettere la propria
conoscenza e la
tecnologia che sviluppa al servizio della difesa e della
sicurezza – “Dobbiamo cominciare a pensare a come sarà la
guerra
futura”.
La tendenza alla costruzione dell’Esercito Europeo e alla conseguente indipendenza militare dell’UE sta nei fatti ed ha percorso strade del tutto originali. Spesso infatti le tecnologie sviluppate in ambito militare trovano applicazione nel civile ma l’Unione Europea – forse perché ancora ancorata alla NATO – con le tecnologie dual use e nell’ambito del programma quadro Horizon 2020 utilizza le ricerche a scopo civile in ambito militare: ed è così che i droni possono essere usati per le previsioni atmosferiche, per le rilevazioni geografiche come pure per il controllo dei territori e la guerra guerreggiata. Alta tecnologia che spesso non ha bisogno di “carne da cannone” ma di militari esperti, si veda in cui avevamo fatto notare la preoccupazione del governo nel creare una élite militare altamente formata. E’ interessante inoltre notare come questo processo si rafforzi in virtù delle contraddizioni che esso stesso genera, la Brexit che sembra indicare la possibilità reale di uscita dall’Unione Europea imprime una spinta notevole sugli investimenti in campo militare che allo stesso tempo rafforza il polo imperialista europeo. Ma se alcune contradizioni si risolvono se ne aprono altre: quali interessi deve proteggere un eventuale Esercito Europeo? La questione è tutta politica e le divergenze tra gli stati membri sono attualmente l’unico limite allo sviluppo coerente di questo processo, insomma è necessario delineare una politica estera comune e il Trattato di Aquisgrana tra Francia e Germania sembra andare proprio in questa direzione.
Leggi tutto
Francesco Piccioni: L’urlo di dolore dagli Usa: “La Cina ci sta battendo!”
L’urlo di dolore dagli Usa: “La Cina ci sta battendo!”
di Francesco Piccioni
Sapere come va il mondo è cosa complicata; capirlo, molto di più. Oltre ai nostri limiti di conoscenza, infatti, c’è anche il peso – enorme – dell’informazione-spazzatura diffusa a piene mani dai media mainstream. Una macchina produttiva che, nel caso di “nemici dell’Occidente”, è ben oltre il limite della pura propaganda di guerra. Un esempio ormai classico sono le notizie sulla “crudeltà” di Kim Jong Un, leader nordcoreano accusato di cannoneggiare o far sbranare dai cani i propri collaboratori meno efficienti (in queste ore viaggia un aggiornamento che riguarderebbe i “negoziatori con Trump”), salvo poi rimangiarsi tutto a mesi di distanza e senza altrettanto spazio mediatico.
Il risultato è – per tutti – una conoscenza scarsa, monca, intossicata. Inutile.
Se questo risultato deprimente riguardasse solo il “popolino”, si potrebbe dire che il potere ha ottenuto ciò che voleva. Se però questa intossicazione informativa infetta anche i vertici aziendali e politici dell’Occidente allora il problema è serio. Anzi, sistemico.
Di fato, è quanto rileviamo da questo articolo di David Goldman, pubblicato addirittura su una testata leader dell’anticomunismo come Il Foglio. L’argomento è il progresso tecnologico cinese, in specifico di Huawei, talmente rapido, economico, efficace da spiazzare completamente la concorrenza Usa ed europea.
Leggi tutto
Alberto Bagnai: Ancora sulle regole
Ancora sulle regole
di Alberto Bagnai
Il Financial Times torna su un tema del quale qui ci siamo occupati per anni, e che ora dovremo approfondire, quello delle regole fiscali. Le posizioni del mainstream, come previsto, sono in rapida evoluzione. La logica della deflazione è quella della concentrazione del reddito e della ricchezza: una logica politicamente insostenibile nel lungo andare, almeno in un regime democratico. Nonostante i media ci raccontino il gran successo elettorale degli unionisti, in giro si nota una certa preoccupazione. Darci dei fascisti può funzionare nel brevissimo periodo, ma nel lungo andare bisognerà pur trovare una strategia meno perdente dell'insultare chi ti ha votato contro! Per giustificare il fatto che adesso (cioè dopo aver impoverito i poveri, ma prima di impoverire tutti i ricchi!) bisogna fare investimenti c'è chi drammatizza la "crisi climatica" (il verde, per gli investimenti, si porta sempre bene...), e c'è chi invece se la prende con le regole, scoprendo l'acqua calda, ovvero che il concetto di Pil potenziale è una colossale scemenza.
Il migliore articolo che ho trovato su questo argomento è quello di Heimberger e Kapeller (2017). Se avremo tempo, lo leggeremo insieme, ma il messaggio è molto semplice, ed è quello che vi avevo illustrato nell'articolo sulle regole (scritto prima di leggere questo contributo "tecnico"): il Pil potenziale, per come viene calcolato, è semplicemente una sorta di media dei passati risultati economici.
Leggi tutto
Ambrose Evans Pritchard: L’Italia manda in campo la sua “moneta parallela” e sfida l’ultimatum della UE
L’Italia manda in campo la sua “moneta parallela” e sfida l’ultimatum della UE
di Ambrose Evans Pritchard - telegraph.co.uk
“Io non governo un paese in ginocchio”, ha detto Matteo Salvini dopo aver stravinto le elezioni europee in modo ancora più chiaro di quelli del partito della Brexit. Da notare bene l’uso di un “maestoso IO”: Salvini si sente già padrone di Roma.
Le élite della zona euro cominciano a vedere in fondo al barile, una rivolta degli economisti italiani e una valuta parallela: I sovversivi “minibot” stanno per tornare in campo.
Nessuno riesce più a contenere l’uomo forte della Lega, nemmeno quella sempre geniale classe dei mandarini italiani. Il suo partito conta sul 40% del paese insieme ai suoi euro-scettici confederati dei Fratelli d’Italia. La Lega è scoppiata nei territori borbonici del Mezzogiorno come un vulcano e ora è in prima linea sui flussi migratori e ha smesso di dar retta all’Europa. In qualsiasi momento Salvini ora può dare una spallata e chiedere le elezioni .
Per qualche maniacale riflesso, una morente Commissione europea in mano a Jean-Claude Juncker ha scelto proprio questo momento per inviare la sua prima lettera di accusa per contestare la nuova fiammata del debito e del deficit a regime. L’Italia si trova di fronte multe per 3,5 miliardi di euro per non essersi allacciate le cinture di sicurezza ed ha 48 ore per rispondere.
“Non siamo la Grecia“, ha detto Claudio Borghi della Lega e Presidente del Comitato per il Bilancio di casa Italia. “Noi siamo contribuenti attivi sul bilancio della UE. Noi abbiamo un surplus commerciale e un avanzo di bilancio primario. Non abbiamo bisogno di chiedere niente a nessuno. E stiamo meglio della Francia “.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Rousseau non abita qui
Rousseau non abita qui
di ilsimplicissimus
E’ interessante leggere i commenti dopo le elezioni e in particolar modo quelli dei militanti 5 stelle o comunque simpatizzanti perché esprimono due contrastanti modi di vedere le cose. Non parlo ovviamente dei fan o dei circoli che si stanno scannando su di Maio si o di Maio no, né del verdetto della piattaforma Rousseau – in realtà un semplice sito sul modello intranet aziendale – che probabilmente confermerà l’attuale capo politico, nonostante una batosta epocale. Parlo degli interventi di persone dentro o fuori del movimento che si domandano cosa sia successo e tentano qualche spiegazione. Una parte di queste persone tra le quali è possibile includere Massimo Fini e lo stesso Grillo accusano intanto gli elettori di non aver compreso tutto quello che i Cinque stelle hanno fatto in questo anno di governo nonché la campagna a tappeto contro i pentastellati condotta sia dall’informazione maistream del capitale, sia dal Pd, con il risultato di aver fatto vincere Salvini. Un’ altra parte invece ha il coraggio di mettere il dito nella piaga, mostrando che le riforme attuate dal governo sono appena un fantasma rispetto a quanto promesso e spesso ciò che viene dato ad alcuni è preso ad altri perché la coperta è troppo corta e lo sarà sempre in mancanza di una forte politica europea basata innanzitutto sulla difesa degli interessi italiani, anche a costo di mettere in crisi l’Ue che , tra l’altro nelle sue forme attuali, è destinata a disgregarsi.
Leggi tutto
Eros Barone: Storia e dramma dell’Oxford English Dictionary
![]()
Storia e dramma dell’Oxford English Dictionary
di Eros Barone
È possibile scrivere una storia avvincente collocando al centro di essa un dizionario? E, ancora, è possibile collegare questo inèdito protagonista alla figura di un ufficiale medico nordamericano che, dopo aver perso il senno nel corso di quella guerra di secessione che, assieme alla guerra di Crimea, fu uno dei conflitti più sanguinosi ed atroci dell’età moderna prima delle due guerre mondiali del Novecento, consuma, senza motivo apparente, un omicidio nella brumosa Londra dickensiana e trascorre infine lunghi decenni di reclusione in un manicomio criminale?
A quanto pare, tutto ciò e altro ancora è possibile, ad ennesima riprova della talentuosa originalità di certa cultura anglosassone, soprattutto se a raccontare questa storia incredibile ma vera è un giornalista di grande prestigio come Simon Winchester, il quale, scrivendo il romanzo intitolato “L’assassino più colto del mondo” (1999), ha compiuto uno straordinario reportage storico e glottologico, in cui è riuscito a ricostruire, giovandosi di una solidissima base documentaria, il clima, gli usi e i costumi, la cultura, il linguaggio e il paesaggio, che caratterizzano quell’America protocapitalistica e tardoschiavistica lacerata dallo scontro fra unionisti e confederati, così come quella imperiale società cristiano-borghese in versione britannica, che concorsero a produrre la singolare vicenda di William Chester Minor, cioè un misto di pazzia e di filologia.
Leggi tutto
Hits 3717
Hits 3694
Hits 3304
Hits 3200
Hits 2883
Hits 2786
Hits 2654
Hits 2513
Hits 2103
Joseph Stiglitz: "E' l'Europa che sta spingendo l'Italia ad accettare i soldi cinesi"
Hits 2075
tonino

coniare rivolta: La Lega e la farsa dei Minibot
La Lega e la farsa dei Minibot
di coniare rivolta
Prima parte
 Capita a volte che un
fatto insignificante si trovi nel posto giusto al momento
giusto, e per questa semplice ragione
assurga agli onori delle cronache, diventando questione
importantissima. Diventando, quindi, altro. Quando questo
capita, può essere
interessante concentrare l’attenzione non tanto sul fatto in
sé – che resta insignificante – quanto piuttosto sul
particolare
contesto che in quel fatto ha trovato un riflesso. Guardando
attraverso il prisma dei Minibot – come vedremo, un fatto di
per sé
irrilevante – possiamo inquadrare la situazione politica
italiana con molta più chiarezza di quella che ci
restituiscono schiere di
politologi armati di rumors e flussi elettorali.
Capita a volte che un
fatto insignificante si trovi nel posto giusto al momento
giusto, e per questa semplice ragione
assurga agli onori delle cronache, diventando questione
importantissima. Diventando, quindi, altro. Quando questo
capita, può essere
interessante concentrare l’attenzione non tanto sul fatto in
sé – che resta insignificante – quanto piuttosto sul
particolare
contesto che in quel fatto ha trovato un riflesso. Guardando
attraverso il prisma dei Minibot – come vedremo, un fatto di
per sé
irrilevante – possiamo inquadrare la situazione politica
italiana con molta più chiarezza di quella che ci
restituiscono schiere di
politologi armati di rumors e flussi elettorali.
Nulla è come appare in questa storia dei Minibot. Inizieremo quindi col chiarire i termini del discorso e gli aspetti tecnici del problema, innanzi tutto per rendere evidente l’insignificanza di questa ultima alzata d’ingegno della Lega di Salvini. Questo ci permetterà anche di concentrare l’attenzione su tutto ciò che ha iniziato a volteggiare intorno a questi curiosi ‘oggetti finanziari’, una fitta trama di interessi politici che ha generato un’impenetrabile maglia di equivoci, utili a tenere in vita un mito: l’idea che la Lega sia un partito di lotta lanciato in uno scontro all’ultimo sangue contro l’Unione Europea. Su questo mito si basa la gestione del potere in Italia oggi. Grazie ad esso, la Lega continua a macinare consensi tra gli sconfitti della globalizzazione, tra le masse di italiani precari, impoveriti, disoccupati, e in cerca di un riscatto da oltre venti anni di politiche neoliberiste, proprio mentre quelle politiche le pratica al Governo.
Cosa sono i Minibot? Questa storia nasce dalla constatazione di un dato di fatto: spesso e volentieri, le pubbliche amministrazioni pagano in ritardo i loro fornitori. Immaginiamo, ad esempio, un Ministero che acquista computer per i suoi uffici e li paga dopo sei mesi dall’acquisto. I motivi del ritardo possono essere i più disparati, dalla goffaggine burocratica ai vincoli di cassa legati alla gestione della liquidità.
Leggi tutto
Piero Bevilacqua: Ecologia del tempo. Un nuovo sentiero di ricerca
Ecologia del tempo. Un nuovo sentiero di ricerca
di Piero Bevilacqua
Riproduciamo, con le note redazionali di Adriana Perrotta Rabissi e Franco Romanò, gli ultimi due capitoli del saggio di Piero Bevilacqua 'Ecologia del tempo. Un nuovo sentiero i ricerca'. L'intero saggio compare su 'Altronovecento, ambiente, tecnica, società. Rivista on line promossa dalla Fondazione Luigi Micheletti'. Dei due capitoli iniziali – Il tempo della fabbrica e Un secolare apprendistato sociale – riportiamo l’ultimo capoverso del secondo che ci sembra riassumere efficacemente la lunga digressione storica
 Il saggio di Bevilacqua ricostruisce il lungo
processo storico che ha piegato gli
individui e la natura stessa alla logica della produzione
capitalistica. Lo sfruttamento intensivo delle risorse
naturali ha introdotto una drammatica
asimmetria fra il tempo della natura e quello del consumo di
cui solo recentemente si stanno tutte le implicazioni, così
come la percezione del
lavoro occulto necessario alla riproduzione sociale, in
larga parte delegato alle donne.
Il saggio di Bevilacqua ricostruisce il lungo
processo storico che ha piegato gli
individui e la natura stessa alla logica della produzione
capitalistica. Lo sfruttamento intensivo delle risorse
naturali ha introdotto una drammatica
asimmetria fra il tempo della natura e quello del consumo di
cui solo recentemente si stanno tutte le implicazioni, così
come la percezione del
lavoro occulto necessario alla riproduzione sociale, in
larga parte delegato alle donne.
* * * *
"Dunque, il sistema industriale di fabbrica organizzato dal capitalismo per produrre merci su una scala incomparabilmente più vasta rispetto al passato ha inaugurato un mutamento epocale: un’appropriazione totalitaria del tempo di vita degli uomini ( e, come vedremo, una dimensione e velocità di sfruttamento della natura destinata a crescere indefinitamente.) Finora gli storici hanno sottolineato, di questo grande mutamento, soprattutto le conquiste della tecnologia, la crescita senza precedenti della produzione della ricchezza, lo sfruttamento dei lavoratori. Assai meno l’inizio una nuova storia della vita biologica e psichica degli esseri umani: quello della perdita del controllo personale del tempo della propria vita e il loro assoggettamento a una potenza astratta e totalitaria che li avrebbe rinchiusi entro ferree delimitazioni e ritmi imposti. Gli uomini sottomessi al tempo della società industriale diventavano gli utensili di una nuova epoca di asservimento. E oggi suona paradossale rammentare che, nell’epoca in cui Immanuel Kant indicava come supremo principio etico del nascente illuminismo quello di considerare « l’uomo sempre come fine e mai come mezzo», gli uomini in carne ed ossa stavano per essere trasformati, nella loro grande maggioranza, in mezzi della società industriale capitalistica.
I tempi di lavoro della natura.
L’epoca che vede nascere la teoria del valore-lavoro, e quindi l’oscuramento del ruolo delle risorse fisiche nel processo di produzione della ricchezza, è la stesso che assiste al più gigantesco sfruttamento di quello che potremmo chiamare a buon diritto il tempo di lavoro della natura.
Leggi tutto
Greg Godels: Due marxismi?
Due marxismi?
di Greg Godels
 Google sa che nutro un
costante interesse per il marxismo. Di conseguenza, ricevo
spesso link ad articoli
che gli algoritmi di Google selezionano come popolari o
influenti. Sistematicamente, in cima all'elenco figurano
articoli di o sull'incontenibile
Slavoj Žižek. Žižek padroneggia alla perfezione le arti
dell'intellettuale pubblico - è divertente, pomposo,
offensivo,
deliberatamente oscuro e ricercato. L'aspetto trasandato e la
barba lo fanno assomigliare a una caricatura del professore
europeo che dona al mondo
grandi idee avviluppate in strati multipli di astrusità - un
metodo di sicuro effetto per apparire profondi. E di sicuro
effetto anche per
promuovere il proprio potenziale commerciale di
intrattenimento.
Google sa che nutro un
costante interesse per il marxismo. Di conseguenza, ricevo
spesso link ad articoli
che gli algoritmi di Google selezionano come popolari o
influenti. Sistematicamente, in cima all'elenco figurano
articoli di o sull'incontenibile
Slavoj Žižek. Žižek padroneggia alla perfezione le arti
dell'intellettuale pubblico - è divertente, pomposo,
offensivo,
deliberatamente oscuro e ricercato. L'aspetto trasandato e la
barba lo fanno assomigliare a una caricatura del professore
europeo che dona al mondo
grandi idee avviluppate in strati multipli di astrusità - un
metodo di sicuro effetto per apparire profondi. E di sicuro
effetto anche per
promuovere il proprio potenziale commerciale di
intrattenimento.
I più fedeli seguaci del «maestro» pubblicano perfino video di Žižek che divora hot-dog - tenendone uno in ciascuna mano! Attualmente sta incassando alla grande con un dibattito pubblico con un pallone gonfiato di destra - a quanto si dice, i biglietti di ingresso costano una fortuna. Il marxismo come attività imprenditoriale.
Žižek è tra le più recenti incarnazioni di una lunga successione di accademici, perlopiù europei, che si sono costruiti una modesta fama pubblica attraverso l'identificazione con il marxismo o con la tradizione marxista. Da Sartre e l'esistenzialismo, attraverso lo strutturalismo, il postmodernismo e il post-essenzialismo, fino a giungere al post-fordismo e alla politica identitaria, vari accademici si sono impossessati di frammenti della tradizione marxista e hanno preteso di rielaborare tale tradizione, mantenendosi nel contempo a distanza di sicurezza da qualsiasi movimento marxista. Sono marxisti quando questo serve loro ad attirare un pubblico, ma di rado reagiscono agli appelli all'azione.
L'aspetto curioso di questo marxismo intellettuale, di questo marxismo dilettante da salotto, è che non è mai marxismo e basta; è sempre un marxismo «con riserva». Il marxismo va bene se è quello del «primo» Marx, il Marx «hegeliano», il Marx dei Grundrisse, il Marx senza Engels, il Marx senza classe operaia, il Marx prima del bolscevismo o prima del comunismo.
È comprensibile: chi aspira a essere il prossimo grande «interprete» di Marx deve distinguersi dalla massa, deve ripensare il marxismo, riscoprire il «vero» Marx, individuare dove Marx ha sbagliato.
Nel passato, intere generazioni di studenti universitari benintenzionati ma confusi sul concetto di classe si sono fatte sedurre da pensatori «radicali» che offrivano loro un assaggio di ribellione confezionato in un'accattivante veste accademica.
Leggi tutto
Dante Barontini: Governo a pezzi, come e più del Paese
Governo a pezzi, come e più del Paese
di Dante Barontini
Prima avvertenza ai nostri lettori: questa non è una crisi di governo, ma una crisi di sistema. Che naturalmente investe anche il governo, ma non nasce da lì e anzi ne determina l’evoluzione. E anche la soluzione.
Partiamo con la cronaca, che già conoscete per sommi capi sotto il bombardamento delle tv.
Il presidente del consiglio Giuseppe Conte, dopo settimane alle corde sotto i colpi congiunti e opposti di Lega e Cinque Stelle, ha dato il suo penultimatum:
“Non mi presto a vivacchiare, a galleggiare. E sono pronto a rimettere il mio mandato nelle mani del presidente della Repubblica. Alle forze politiche chiedo una risposta chiara e rapida“.
A prima vista sembra soltanto un richiamo ai suoi due presunti vice – in realtà gli azionisti vero dell’esecutivo che lui formalmente dirige – anche grazie ai riferimenti quasi espliciti alle modalità con cui avviene quotidianamente la rissa: “Il mio motto è sobri nelle parole e operosi nelle azioni. Ma se continuiamo nelle provocazioni per mezzo di veline quotidiane, nelle freddure a mezzo social, non possiamo lavorare. I perenni costanti conflitti comunicativi pregiudicano la concentrazione sul lavoro“. E certo si riferiva a Salvini ammonendo “Nessun ministro prevalichi le sfere che gli competono“.
Il voto per le europee ha decisamente rovesciato i rapporti di forza interni, rispetto al 4 marzo 2018. E consente al leghista di pretendere di dettare l’agenda, in modo provocatorio nei toni e nei temi.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: La casta togata
La casta togata
di Leonardo Mazzei
Siamo dunque alla scoperta dell'acqua calda: la Magistratura (quella con la emme rigorosamente maiuscola) è corrotta. Ma guarda un po'! Come sempre in questi casi, i giornaloni fingono grande stupore. Riferendosi alle note vicende del Consiglio Superiore della Magistratura (Csm), Ernesto Galli della Loggia scriveva ieri sul Corriere della Sera che «l'immagine che esce dalle inchieste è devastante».
Ovviamente ha ragione. Ma ridurre tutto a un problema di «borghesucci ineducati a caccia di privilegi», come fa il noto editorialista, è decisamente troppo poco. Certo, il solito elenco di omaggi - dalle vacanze ai biglietti della Lazio elargiti dall'impagabile Lotito - è cosa piuttosto pittoresca. Ma anche qui niente di nuovo sotto il sole. La "borghesia reale", la "classe dirigente reale" (di cui il Csm è parte integrante a pieno titolo) è quella roba lì. Roba miserevole e schifosetta, ma non sorprendente.
La casta di Palazzo dei Marescialli
Da quando è entrato nel linguaggio corrente, il termine "casta" è stato solitamente applicato in esclusiva ai politici. E la cosa mi ha sempre fatto ridere assai. La casta, parola che se usata correttamente è in effetti utile a comprendere la vera natura dei soggetti di cui stiamo parlando, va ben oltre il mondo delle istituzioni politiche in senso stretto. La casta la troviamo nell'alta burocrazia, nei vari corpi dello Stato, nelle Università, nei media, nei consigli d'amministrazione delle grandi aziende, ed appunto nella Magistratura.
Leggi tutto
Riccardo Realfonzo: I torti della Commissione e quelli del Governo. Ovvero come uscire dalla crisi
I torti della Commissione e quelli del Governo. Ovvero come uscire dalla crisi
di Riccardo Realfonzo
Perchè la Commissione europea sbaglia sul debito pubblico e perchè anche il Governo italiano ha le sue responsabilità nella crisi
La Commissione Europa minaccia una procedura di infrazione contro l’Italia per il mancato rispetto della regola del debito. Una regola assurda e irrealizzabile, non solo per l’Italia, secondo la quale sostanzialmente il debito pubblico andrebbe abbattuto ogni anno mediamente in ragione di un ventesimo della differenza tra il valore attuale del debito e l’obiettivo del 60% del pil. Un obiettivo, come sanno gli addetti ai lavori, che non alcun fondamento scientifico perché nessuno mai ha dimostrato, o potrà mai dimostrare, che il 60% rappresenta un numero preferibile al 50% o al 70%. Abbattere a quel ritmo il debito al 60% del pil significherebbe per l’Italia sperimentare almeno due decenni di politiche di lacrime e sangue, che produrrebbero la desertificazione economica e sociale del Paese. D’altronde, sui danni dei consolidamenti fiscali, tanto amati dalla Commissione Europea, abbiamo ormai una grande evidenza empirica.
La Grecia è il migliore esempio di quanto possano essere disastrose le politiche di taglio indiscriminato della spesa pubblica e di aumento della pressione fiscale. Ma anche l’Italia è un esempio eccellente. Pochi ricordano, infatti, che il nostro Paese detiene il record europeo in fatto di politiche di austerità, avendo realizzato sempre manovre di bilancio in avanzo primario, dal 1990 ad oggi (con la sola eccezione del 2009).
Leggi tutto
Antonello Boassa: Assange. Perchè la “cultura” e la stampa tacciono
Assange. Perchè la “cultura” e la stampa tacciono
di Antonello Boassa
E come potrebbero non farlo? Nessun punto interrogativo nel titolo. Sarebbe un eccesso di retorica.
Tacciono perché trattare in modo non superficiale il “caso Assange”, esaminarne le varie procedure giudiziarie in concomitanza con i “fatti” politici che anche nell’immediato hanno motivato un bliz poliziesco senza precedenti in una ambasciata, nel totale disprezzo del diritto internazionale più elementare e “di fatto” datato da secoli, significherebbe un atto di accusa troppo severo contro sè stessi, contro la cultura di regime, contro la stampa di regime (ma anche contro la cultura e la stampa più illuminata).
Dispensatrici di futilità, manipolatrici di informazioni, produttrici attivi di fake news ( dalle armi di distruzione di massa di Hussein alla distruzione delle torri gemelle da parte di Bin Laden, dai massacri di Gheddafi alle armi chimiche usate dal governo siriano, dalla dittatura di Maduro alla distruzione dello stato libero di Grenada , dal finanziamento di Usa/Israele/UE dei nazisti in Ucraina alla complicità degli eccidi e del colpo di stato nello stesso Paese ex sovietico…).
Julian Assange, “il giornalista più importante dei nostri tempi” 1) ha saputo “reiventare il giornalismo”, trasformandolo in una professione scomoda, a rischio, in quanto la sua pratica dovrebbe essere la ricerca incessante delle pratiche occulte ed illegali degli stati e dei governi, pratiche indirizzate verso colpi di stato, il finanziamento e la copertura del terrorismo, la partecipazione in eccidi, l’impunibilità di un sistema finanziario corrotto.
Leggi tutto
Alessandro Somma: Sovranità nazionale, pace e giustizia sociale
Sovranità nazionale, pace e giustizia sociale
di Alessandro Somma
La tesi dell'ultimo libro di Carlo Galli, Sovranità (il Mulino, 2019), è che alla sovranità si possono indubbiamente addebitare momenti bui della storia recente, ma essa resta pur sempre il motore delle istanze emancipative fondative del nostro stare assieme come società
 Alcune recenti pubblicazioni indicano
l’affiorare di un filone
letterario in controtendenza rispetto alla vulgata per cui la
sovranità costituisce un concetto “odioso perché presuppone
uno
stare sopra” e dunque implica “subordinazione”[1]. Non è ancora un filone dai
tratti particolarmente definiti, e tuttavia l’indicazione che
se ne ricava è sufficientemente univoca: nella storia recente
della
sovranità si possono indubbiamente registrare momenti bui, ma
essa resta pur sempre il motore dei moti emancipatori
fondativi del nostro stare
assieme come società. Si colloca su questo terreno l’analisi
di coloro i quali, dai punti di vista più disparati, salutano
con
favore il ritorno dello Stato e “un recupero non nazionalista
della dimensione nazionale”[2], e a monte della sovranità
popolare[3]. E che nel contempo
sottolineano le radicali differenze tra la loro prospettiva e
quella di chi invoca confini al solo fine di promuovere
identità violente e
premoderne[4].
Alcune recenti pubblicazioni indicano
l’affiorare di un filone
letterario in controtendenza rispetto alla vulgata per cui la
sovranità costituisce un concetto “odioso perché presuppone
uno
stare sopra” e dunque implica “subordinazione”[1]. Non è ancora un filone dai
tratti particolarmente definiti, e tuttavia l’indicazione che
se ne ricava è sufficientemente univoca: nella storia recente
della
sovranità si possono indubbiamente registrare momenti bui, ma
essa resta pur sempre il motore dei moti emancipatori
fondativi del nostro stare
assieme come società. Si colloca su questo terreno l’analisi
di coloro i quali, dai punti di vista più disparati, salutano
con
favore il ritorno dello Stato e “un recupero non nazionalista
della dimensione nazionale”[2], e a monte della sovranità
popolare[3]. E che nel contempo
sottolineano le radicali differenze tra la loro prospettiva e
quella di chi invoca confini al solo fine di promuovere
identità violente e
premoderne[4].
Ad accrescere questa produzione si è aggiunta l’ultimo libro di Carlo Galli[5]. Questi non si sofferma tanto sulle ragioni per cui la sovranità debba essere recuperata, il che presupporrebbe la possibilità di farne a meno, bensì sui motivi per cui essa costituisce l’imprescindibile “forma politica di una società, che grazie a essa si costituisce e agisce” (29). Il tutto documentato a partire da una panoramica succinta ma ricca e ampia sullo sviluppo storico e i fondamenti di ordine filosofico della sovranità, impiegata come sfondo per riflettere sui pericoli e le potenzialità riconducibili a quanto viene volgarmente descritto in termini di momento sovranista. E per farlo rifuggendo dai facili entusiasmi tipici di certa letteratura critica con il cosmopolitismo, ma non per questo aliena dalle semplificazioni che caratterizzano l’argomentare dei suoi fautori.
Storicizzare la sovranità
Prima di entrare nel vivo delle riflessioni di Galli, occorre soffermarsi su un invito ricorrente nella sua opera, ma che in questo caso è particolarmente amplificato: l’invito a storicizzare l’oggetto di studio.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Come ti sistemo quelli del sovranismo altrui
Come ti sistemo quelli del sovranismo altrui
Il Bilderberg dei nostri
di Fulvio Grimaldi
Ecco qui coloro che ci hanno guidato alle nostre magnifiche sorti e progressive. E insistono
 “Mai otterrai che il granchio cammini diritto”
(Aristofane, Le Commedie)
“Mai otterrai che il granchio cammini diritto”
(Aristofane, Le Commedie)
Trentesimo anniversario dei fatti di Tien An Men, 65esima riunione segreta del Gruppo Bilderberg. C’è qualcosa che collega i due anniversari? Inevitabilmente, l’uno, nella congiuntura, è propedeutico all’altra e ne fonda l’attualità. Insieme a temi vari, segretissimi nella definizione del metodo, tra i quali abbastanza scoperto è quello delle Quinte Colonne politico-economico-mediatiche da infiltrare in campo amico, neutro o nemico. Però manifesti negli obiettivi, giacchè praticati dalla fondazione in piena prima guerra fredda, 1954. Fondazione in Olanda agevolata e protetta dai servizi segreti angloamericani e a cui hanno dato corpo, denaro, tattica e strategia le residue case monarchiche e le massime divinità del capitalismo imperial-tribale, Rockefeller e Rothschild. Obiettivo finale: globalizzazione, affermazione di una sovranità di portata planetaria e guerra totale a quella altrui, a partire – o finire – con la conquista del “cuore terrestre del mondo” (“Heartland”, nella famosa espressione di Brzezinski), Russia e Cina.
L’evento, dagli aspetti securitari di una trasparenza democratica da far scoppiare d’invidia un vertice mondiale della ‘ndrangheta e di Cosa Nostra messi insieme, ha avuto luogo dal 30 maggio al 2 giugno tra i fasti ultralusso dell’Hotel Montreux, congeniali a questo parterre de Rois , ascendente nobile dei Casamonica, nell’omonima cittadina svizzera. 130 partecipanti da 23 paesi, euro-atlantici con poche eccezioni. Tra cui lacréme de la créme di quell’0,1%, poche decine di individui, che veleggia sulla ricchezza di metà dell’umanità grazie a una pervicace creazione di diseguaglianza tramite guerra di classe capitalista , colonialismo, guerra e, appunto, globalizzazione.
Leggi tutto
Mattia Gambilonghi: Il PCI e la democrazia industriale
Il PCI e la democrazia industriale
Consigli di fabbrica e partecipazione conflittuale
di Mattia Gambilonghi*
 Introduzione:
autogoverno dei produttori e governo dell’economia nella
strategia del
comunismo italiano
Introduzione:
autogoverno dei produttori e governo dell’economia nella
strategia del
comunismo italiano
L'ipotesi di riforma dello Stato che muove il PCI e il suo progetto riformatore, così come la sua concezione di democrazia mista – che vede la dimensione generale e rappresentativa rapportarsi alla base con una ricca articolazione di momenti ed istituti democratici (dai consigli di quartiere ai consigli di fabbrica, passando per le nuove forme di rappresentanza all'interno del mondo della scuola ottenute agli inizi dei Settanta) – delineano un preciso modo di essere della programmazione economica e del governo dell'economia che ha il suo fulcro nel concetto di autogoverno dei produttori.
I lavoratori e la classe operaia sono cioè chiamati ad incidere e (co)determinare la politica economica e i processi produttivi tanto sul livello nazionale, attraverso l'azione svolta dai partiti di riferimento nell'ambito della rappresentanza politica generale, quanto su quello aziendale, attraverso l'azione di pressione e contrattazione e successivo controllo esercitata dai consigli di fabbrica e dalle organizzazioni sindacali nei confronti delle dirigenze d'azienda, riguardo quelle tematiche relative all'organizzazione del lavoro e alla localizzazione e composizione degli investimenti. Nonostante le caratteristiche e le specificità della strategia di riforma e trasformazione sociale delineatasi a livello teorico nel comunismo italiano, quest'ultima risulta accomunata alle altre e differenti realtà della sinistra europea (includendo perlopiù all'interno di questa categoria le esperienze di governo socialdemocratiche) dall'ispirazione e dall'idea di fondo. Ossia, la convinzione che attraverso questo doppio movimento (“dall'alto” e “dal basso”, “statale” e “sociale”) di intervento e di governo delle dinamiche economiche, attraverso l'immissione nel circuito sotteso al processo di circolazione e valorizzazione capitalistica di «soggetti e finalità antagonistiche alla pura logica di mercato», fosse possibile non solo «sottrarre spazio al calcolo puramente economico», ma soprattutto «reagire alla condizione di merce della forza lavoro e agli effetti negativi […] della gestione privata dell'accumulazione»[1].
Leggi tutto
Alessandro Avvisato: Trump abbaia, Cina e Russia fanno sul serio
Trump abbaia, Cina e Russia fanno sul serio
di Alessandro Avvisato
Mentre i leader occidentali si trastullavano con Trump tra Gran Bretagna e Francia per l’ anniversario dello sbarco in Normandia, i capi di Stato di Cina e Russia hanno utilizzato il contemporaneo Forum economico di San Pietroburgo per cementare alleanze e concretizzare accordi economici strategici.
Il Presidente cinese Xi Jinping ieri a Mosca ha incontrato Vladimir Putin ed oggi sarà ospite principale al Forum economico internazionale di San Pietroburgo, un forum boicottato dagli Usa per via delle detenzione in Russia del businessman americano Bayley arrestato per frode. Trump è tornato a minacciare altri dazi contro la Cina su 300 miliardi di dollari di prodotti. “Deciderò nelle prossime due settimane”, ha detto il presidente Usa, “probabilmente dopo il summit del G20 ad Osaka”. Al summit Trump dovrebbe incontrare il leader cinese Xi Jinping: “Vedremo quel che accadrà”, ha aggiunto il presidente Usa.
Ma sul piano delle relazioni internazionali, Cina e Russia appaiono ormai allineati sulla maggior parte dei dossier più contrastanti con gli Usa – Iran, Corea del Nord, Venezuela, Siria – e condividono l’ostilità degli Stati Uniti. Tra Mosca e Washington le relazioni sono al punto più basso dalla fine della Guerra Fredda, mentre Pechino è alle prese con la guerra commerciale scatenata da Trump.
Leggi tutto
Fosco Giannini: Golpismo dell'Ue e cedimenti del governo Conte: costruire l'unità del Fronte Popolare
Golpismo dell'Ue e cedimenti del governo Conte: costruire l'unità del Fronte Popolare
di Fosco Giannini*
I grandi avvenimenti e i grandi processi storici guidati dalle classi dominanti e che queste classi conducono, senza mediazioni, per i propri interessi e contro gli interessi dei lavoratori e dei popoli, vengono scientemente, dalle stesse classi dominanti, sempre accuratamente celati. Tutta la storia del colonialismo si è, ad esempio, dispiegata con questa modalità ed ogni azione coloniale si è sempre mascherata da “aiuto ai Paesi sottosviluppati”, nello stesso modo in cui tante guerre imperialiste si sono presentate come “interventi umanitari”. Così è per la costruzione dell’Unione europea, che procede come un treno di gangster dentro un lunghissimo tunnel buio: i viaggiatori non conoscono la strada reale né il reale punto d’arrivo e durante il viaggio vengono continuamente ingannati da informazioni che parlano di stazioni finte e di mete diverse da quelle reali. Essendo, l’obiettivo del grande capitale europeo, quello di costruire un’Unione europea come nuovo polo imperialista mondiale dotato di leggi sovranazionali in grado di assicurare alle forze capitaliste dei vari Paesi piena libertà di manovra politica, economica e finanziaria, volta alla più alta estrazione di plus valore possibile dal mondo complessivo del lavoro, tutta questa complessa dinamica va tenuta accuratamente nascosta: che i popoli non vedano, che i lavoratori non capiscano.
Leggi tutto
Ma chi farà l’opposizione a Salvini?Aldo Giannuli:
Ma chi farà l’opposizione a Salvini?
di Aldo Giannuli
Salvini ragiona come se una serie di limiti alla sua vittoria non esistessero: Fi è in via di liquefazione, i 5 stelle sono al tappeto, il Pd, nella migliore delle ipotesi, è convalescente, FdI pronti a schierarsi con lui, e se non ci sono i numeri per fare ora un governo –magari per la rottura dei 5 stelle- si va ad elezioni anticipate e si prende la maggioranza assoluta. Perfetto, solo che qui facciamo i conti senza l’oste e l’oste non sta in Italia.
Lui dice che bisogna vedere chi ha la testa più dura fra lui e l’Europa, ma non ha capito che l’Europa, la testa gliela rompe. In primo luogo è ragionevole che l’Italia non manterrà una sola delle quattro super poltrone europee che attualmente detiene e sarà messa all’angolo.
Poi pare che stiamo sulla strada giusta per una procedura di infrazione, anche se ci vorrà qualche tempo. Ma i mercati finanziari non aspettano che i processi siano completi, scontano gli effetti già da prima ed è ragionevole che lo spread ne risentirà già all’annuncio. Poi è realistico pensare che ci si metterà anche il plotone d’esecuzione del rating che declasserà i titoli italiani a poco più che spazzatura.
E non pare così probabile un soccorso della Bce da un Draghi già sulla via dell’uscita. E sin qui i guai a livello internazionale: lo so che siamo uno Stato sovrano, ma quando rappresenti il terzo debito mondiale, la tua è una sovranità oggettivamente limitata.
Leggi tutto
Francesco Paolella: Il popolo in massa
Il popolo in massa
di Francesco Paolella
Eric Weil, Masse e individui storici [1957], a cura di Livio Sichirollo, Feltrinelli, Milano, 1980
Nell’ubriacatura attuale di popolo – per la quale il popolo (come il cliente) ha sempre ragione o, al contrario, il popolo non dovrebbe neanche votare – può essere utile tornare a libri che ragionano con più criterio di che peso possano avere le masse nella vita politica delle società moderne. È appunto il caso di un piccolo volume del filosofo Eric Weil – Masse e individui storici – uscito nel 1957, cioè nel cuore del Novecento totalitario, e che Feltrinelli ha poi tradotto nel 1980.
Il discorso di Weil riprende alcuni temi classici della sociologia, quale la massificazione intesa come conseguenza diretta della modernità (industrializzazione e urbanizzazione) o l’idea che la società moderna possa reggersi soltanto continuando a investire nella “crescita”, nel proprio progresso economico e sociale. Le masse moderne tendono a comprendere tutti gli individui, non ponendo limiti che escludano alcun strato sociale inferiore, ma soltanto cercando di individuare dei “nemici” verso l’esterno e, soprattutto, verso l’alto (come le classi dirigenti attualmente al potere). La massa vive nell’uniformità e richiede che una parte importante della vita personale (i “valori”, le credenze tradizionali ecc.) si riducano sempre più a un fatto privato. Ciò che conta è il progresso, inteso essenzialmente come aumento del benessere materiale (allungamento della vita media, aumento del reddito disponibile e dei consumi, miglioramento delle condizioni di vita) e, di conseguenza, è la calcolabilità il criterio fondamentale da seguire per riconoscerlo.
Leggi tutto
Hits 3750
Hits 3732
Hits 3332
Hits 2911
Hits 2806
Hits 2671
Hits 2534
Hits 2142
tonino

Sergio Cesaratto: Europeisti no, realisti sì
Europeisti no, realisti sì
Risposta ai critici
di Sergio Cesaratto
Indossato l'elmetto per le bombe che pioveranno, ecco una risposta più articolata alle critiche all'intervista al sussidiario.net
 Un mia recente intervista ha fatto sollevare più
di un
sopracciglio ai miei amici, per metterla all’inglese. Uno di
questi, che ringrazio, mi ha dedicato addirittura un
editoriale su Sollevazione (luogo appropriato
per la detta
espressione facciale). Leonardo Mazzei riassume quanto dico in
quattro punti:
Un mia recente intervista ha fatto sollevare più
di un
sopracciglio ai miei amici, per metterla all’inglese. Uno di
questi, che ringrazio, mi ha dedicato addirittura un
editoriale su Sollevazione (luogo appropriato
per la detta
espressione facciale). Leonardo Mazzei riassume quanto dico in
quattro punti:
1) «i parametri di Maastricht hanno perfettamente senso».
2) “alla lettera UE bisogna dare «una risposta ragionevole con proposte ragionevoli e non sgangherate, come sbattere i pugni sul tavolo o minacciare di ribaltare i trattati»”.
3) un “invito al governo italiano affinché lavori al seguente compromesso: «L’Europa dovrebbe aiutarci ad abbassare drasticamente i tassi d’interesse sui nostri titoli pubblici e l’Italia impegnarsi, firmando un memorandum, a una stabilizzazione, non riduzione, del rapporto debito/Pil».
4) “lo strumento "per cambiare l'Europa", ... per Cesaratto è l'aumento progressivo del "bilancio federale", obiettivo da raggiungere anche alleandosi con Macron”.
Forse è bene ricontestualizzare certe affermazioni che, come le mette Mazzei, mi farebbero preoccupare di me stesso.
1. L’analisi economica delle unioni monetarie
Sono sempre stato sospettoso dell’attacco semplicistico ai “parametri di Maastricht”. Facciamo un passo indietro. Le unioni monetarie si dividono in sostenibili (o complete) ovvero insostenibili (o incomplete).
Sono sostenibili le unioni monetarie che: a) sono fra paesi abbastanza omogenei da avere bilance commerciali fra loro in equilibrio (non importa che siano in equilibrio quelle verso l’esterno dell’unione, questa può sempre svalutare la propria divisa per aggiustare il disavanzo esterno); o che b) sebbene non completamente omogenei economicamente, sono sufficientemente omogenei politicamente per cui si dotano di meccanismi compensativi degli squilibri che l’unione monetaria può portare. Gli Stati Uniti sono una via di mezzo fra i casi a) e b).
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Algeria e Sudan a colori?
Algeria e Sudan a colori?
di Fulvio Grimaldi
Le cantonate degli utili idioti, le manovre degli amici del giaguaro
 Sinistre burlesque e
media a disposizione
Sinistre burlesque e
media a disposizione
Con tutti i tumulti, le sollevazioni, i casini che succedono in giro per il mondo, dal Sudan all’Algeria, da Haiti al Kazakistan, da Hong Kong all’Albania e in decine di altri posti, diventa sempre più difficile non prendere cantonate nelle analisi e distinguere il piombo dall’oro. Qualche criterio è relativamente affidabile. Quando il cattolico unanimismo destre in ghingheri e pseudo-sinistre in putrefazione sostiene un movimento di contestazione al governo ci sono buone ragioni per ritenerlo “rivoluzione colorata” mirante alregime change in un paese che non si allinea a ordini e strategie imperiali e globali. Quando il paese in questione si colloca storicamente fuori dal contesto Nato, nelle sue espressioni euro-atlantica, latinoamericana, araba, africana, c’è di nuovo motivo per giungere alla medesima conclusione, viste le pratiche sovversive impiegate dal consorzio anglosassone nel corso dei secoli in casi di non ottemperanza ai suoi interessi e diktat. Infine, e stavolta probanti, sono le caratteristiche formali, iconografiche, sociali, sloganistiche, tecniche, organizzative, di protagonisti e di contenuti, di sostegno esterno, come pedissequamente si ripetono di movimento in movimento, a partire dagli esordi in Serbia con Otpor, la Ong di tutte le Ong.
Le mie rivoluzioni colorate
Personalmente mi pregio di aver avuto qualche esperienza diretta di classica “rivoluzione colorata” gestita da un mix di ingenui, disperati, rivoluzionari della pippa e grandissimi figli di buona donna, formati, istruiti, equipaggiati e finanziati come si deve e elevati nell’olimpo dei contestatori democratici dalle presstitute dei media, con più accanimento addirittura da quelli della pseudo sinistra. Senza quelle ai colorati verrebbe a mancare la maschera d’ossigeno. Da Belgrado a Caracas, da Tripoli a Damasco ho visto attuare, in assoluta analogia, gli insegnamenti del padre di queste sollevazioni dette pacifiche, Gene Sharp, esordiente a Tien An Men, e del suo strumento prediletto: Otpor.
Leggi tutto
Claudio Conti: Quei pregiudizi sul debito
Quei pregiudizi sul debito
di Claudio Conti
 Per una
volta ci perdonerete. Vi proponiamo l’editoriale di Guido
Salerno
Aletta su Milano Finanza praticamente
senza ulteriori commenti e riflessioni.
Per una
volta ci perdonerete. Vi proponiamo l’editoriale di Guido
Salerno
Aletta su Milano Finanza praticamente
senza ulteriori commenti e riflessioni.
Viene qui smontata, tecnicamente, la narrazione sulle cause strutturali del debito pubblico eccessivo dell’Italia, alla vigilia dell’apertura della procedura di infrazione. Si tratta di una prima assoluta, e come tale destinata a fare scuola e giurisprudenza europea. Così com’è stato per la “tutela della Troika” sulla Grecia, con Tsipras alla guida.
Qui c’è un governo di destra, ma lo schema contro le ambizioni di “cambiamento” si applica lo stesso. Per recuperare – come con Tsipras – c’è sempre tempo…
Come per la Grecia, probabilmente “dopo” ci chiederanno scusa per avere esagerato. Ma è il principio “puniscine uno per educarne 26” (gli altri membri dell’Unione Europea): a chi tocca non s’ingrugna…
L’analisi tecnica aiuta a individuare la ragione politica dietro decisioni e giustificazioni che vengono presentate come “scientifiche”, come dati oggettivi e ricette (“buone pratiche”) per cui non esisterebbe alternativa. E invece proprio l’analisi tecnica mostra e dimostra che di “oggettivo”, nei trattati europei e nella governance attuale, non c’è neanche l’odore.
La ragione politica, però, non sta in un presunto “odio per l’Italia”. Anzi, è dettata da fin troppo amore. Non per il paese o la sua popolazione, ma per le sue ricchezze, il suo know how, il patrimonio immobiliare ed il risparmio.
Risorse calcolate in oltre 9.000 miliardi di euro, quote di mercato globale più complicate da calcolare ma comunque ancora rilevanti, marchi e merci che si vendono ad occhi chiusi, ecc; ma che fanno gola a un sistema finanziario con l’acqua alla gola (basti guardare la tecnicamente fallita Deutsche Bank che si è appropriata di 20 tonnellate di oro venezuelano) e a multinazionali manifatturiere arretrate sul piano tecnologico e in difficoltà estrema nella “competizione” che si è aperta tra Stati Uniti, Cina e altri grandi attori.
Leggi tutto
CC P101: Minibot: disobbedire alla UE
Minibot: disobbedire alla UE
di CC P101
Un vantaggio per lo stato
Al pari della partita sulla "procedura d'infrazione" avviata dalla Commissione europea, la vicenda dei Minibot sarà la cartina al tornasole della determinazione a resistere del governo giallo-verde nei confronti dei diktat di Bruxelles e Francoforte.
La questione è nota. La Camera ha approvato all'unanimità (dunque anche con il voto del Pd e di +Europa, che ora dicono di essersi "sbagliati"), una mozione che impegna il governo a risolvere l'annosa questione dei lunghi tempi di pagamento dei debiti delle pubbliche amministrazioni verso le imprese, utilizzando allo scopo anche "strumenti quali titoli di Stato di piccolo taglio", gli ormai famosi Minibot. Tutto ciò, dice sempre la mozione, al fine di ampliare i meccanismi di "compensazione tra crediti e debiti della pubblica amministrazione".
Di fronte a questa misura di assoluto buon senso, tra l'altro assai vantaggiosa per lo Stato, visto che per i Minibot non sono previsti né interessi né date di scadenza, c'è stata l'alzata di scudi di tutto il partito eurista al gran completo. Non solo quella di un'opposizione evidentemente un po' distratta, non solo quella assai scontata del governatore Visco, non solo quella piuttosto significativa della Confindustria, ma pure quella - politicamente gravissima - del ministro Tria, nella sostanza coperto dallo stesso presidente del consiglio.
Leggi tutto
Alberto Benzoni: Il fattore Q: la Sinistra e gli LGBT (e ora anche Q)
Il fattore Q: la Sinistra e gli LGBT (e ora anche Q)
di Alberto Benzoni
Personalmente ho sempre pensato che i “sessualmente diversi” abbiano diritto all’indifferenza. Leggi al fatto che la loro differenza sessuale non debba in alcun modo essere motivo di discriminazione. E, ancora, al fatto che la loro richiesta di essere considerati in tutto e per tutto anche uguali (matrimonio, adozioni e così via) agli etero sia pienamente legittima e sostenibile. Ma da qui a ritenere che la loro causa, le loro richieste o le loro aspirazioni e, in generale, l’ideologia “gender” vadano non solo sostenute senza riserve ma diventino il criterio discriminante nel definire chi è moderno e chi è antidiluviano o chi è di sinistra e chi è di destra, ce ne corre.
Non sto evocando fantasmi, magari perché inconsciamente sedotto dal Salvinipensiero. Sto descrivendo quello che sta avvenendo in tutto il mondo occidentale. In Italia, dove la disdicevole gazzarra alimentata dal congresso di Verona si è, in definitiva, tradotta in un tacito referendum tra i sostenitori della famiglia naturale e gli altri. In Francia, dove lo sciagurato Hollande non ha mantenuto nessuno dei suoi impegni elettorali, salvo quello del matrimonio per i gay; suscitando l’inevitabile sensazione di voler privilegiare un problema a danno di tutti gli altri. E, ora, negli Stati Uniti: paese che ha il singolare, ma non casuale, privilegio di essere il regno del “politicamente corretto” (in nome del quale si bandiscono dalle università Shakespeare e Dante) e, nel contempo, di avere un presidente e un’amministrazione tra le più politicamente scorrette e reazionarie della storia.
Leggi tutto
Beppe Grillo: E adesso…
E adesso…
di Beppe Grillo
Nonostante la storia di questi ultimi mesi sia stata raccontata come una brutta favola, non una cronaca, possiamo comunque affermare che sia sotto gli occhi di tutti. Si è trattato quasi unicamente di propaganda mainstream contro il movimento, una narrazione che ha determinato la sistematica distorsione della volontà popolare, talk show dopo talk show, falsità dopo falsità.
Siamo abituati a trovarci costantemente dalla parte “sbagliata” di questa nazione, resistendo ad ogni genere di attacco con fierezza. Quella parte che vorrebbe il paese fuori dalle sabbie mobili culturali ed economiche che lo imprigionano da troppo tempo.
Siamo cresciuti con una velocità incredibile, lanciati contro nidi di mitragliatrici mediatiche e continui capovolgimenti di scena, da parte di vecchi parrucconi e starlette.
Il mondo occidentale sta subendo un processo di degenerazione nel quale non è prevista alcuna forma di Europa diversa da una banca.
E’ il “pensiero unico”, che presenta alla gente sempre e soltanto un parametro vitale alla volta di questo paese ammalato. E’ incredibile che le regole del gioco siano stabilite solo e sempre da chi da le carte, ma è così. E chi da le carte non cambia mai: sempre il più forte se sono utilizzati i parametri giusti per rappresentarlo come tale.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: I post gretini
I post gretini
di ilsimplicissimus
Non sono state elezioni facili per il potere oligarchico, né è stato semplice riuscire a contenere sovranisti ed eurocritici e non concedere loro la platea del parlamentino di Strasburgo che sul piano concreto conta meno del due di coppe quando briscola è a bastoni, ma che può avere comunque un potere di tribuna. Tuttavia la governance è riuscita a sfruttare i suoi stessi peccati per recuperare consensi usciti dalla porta principale facendoli transitare dalla porta di servizio grazie all’operazione Greta Thunberg: deviando il discorso sui temi dell’ambiente che essi stessi tradiscono quotidianamente, sono riuscite a riempire i serbatoi dei Verdi continentali. Occorreva però qualcosa di forte per poter spostare consensi su formazioni da sempre alleate con le socialdemocrazie più corrive con il capitalismo di mercato: ed ecco la ragazzina davanti al Parlamento di Stoccolma che già fa simpatia, soprattutto se si dimentica che è circondata da guardie del corpo, per giunta autistica o dichiaratasi tale che moltiplica per due l’interesse, portatrice di discorsi apocalittici, abbastanza ingenui e rozziin pratica solo slogan, da far presa a largo raggio dentro un’opinione pubblica devastata e facile all’emozione più che al pensiero e tanto meno all’azione. In ogni caso del tutto aliena dall’avere un’idea coerente dell’insieme dei problemi che in realtà sono spesso molti diversi da come vengono affrontati (vedi nota).
Leggi tutto
Csepel: L’euro e il capitalismo europeo
L’euro e il capitalismo europeo
di Csepel
Osservazioni su Bellofiore, Garibaldo e Mortagua, Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea
 Negli ultimi anni si sono
succeduti testi che analizzano, da una prospettiva più o meno
eterodossa, la parabola dell’euro
1. Anche questo testo interviene nel dibattito che
si sviluppa a sinistra sul futuro della moneta unica. Il tema
di fondo è che per
capire l’euro bisogna analizzare la ricomposizione del tessuto
produttivo europeo, innanzitutto tedesco, a partire dalla
caduta del muro di
Berlino. Nato nel mondo della guerra fredda, il progetto di
unificazione europea risorge, soprattutto per impulso
francese, con lo scopo di
controllare l’ormai straripante potenza tedesca. In cambio di
una banca centrale unica (comunque plasmata sulla Bundesbank)
la Germania pretende
vincoli sulla situazione dei conti pubblici dei futuri paesi
dell’Unione. Da qui il Trattato di Maastricht e tutto il
resto, sino al Fiscal
Compact. La politica economica condotta dal grande capitale
tedesco dagli anni ‘80 in poi è stata coerentemente orientata
a riorganizzare
la produzione su scala europea, riprendendosi il cortile di
casa (Ungheria, Polonia, ecc.) in cui esternalizzare le
produzioni a minor valore
aggiunto, affiancandolo alle aree già prima fortemente integr
ate nella filiera produttiva tedesca, come il Veneto o
l’Austria. La moneta
unica va studiata all’interno di questo quadro di cui
costituisce una tessera importante ma non esclusiva. Lo
dimostra il fatto che buona parte
dell’est europeo, colonia tedesca, non ha nemmeno l’euro anche
se fa parte dell’UE. Ridurre dunque il tema dell’uscita
dall’Eurozona alla possibilità di svalutare è sicur amente
futile.
Negli ultimi anni si sono
succeduti testi che analizzano, da una prospettiva più o meno
eterodossa, la parabola dell’euro
1. Anche questo testo interviene nel dibattito che
si sviluppa a sinistra sul futuro della moneta unica. Il tema
di fondo è che per
capire l’euro bisogna analizzare la ricomposizione del tessuto
produttivo europeo, innanzitutto tedesco, a partire dalla
caduta del muro di
Berlino. Nato nel mondo della guerra fredda, il progetto di
unificazione europea risorge, soprattutto per impulso
francese, con lo scopo di
controllare l’ormai straripante potenza tedesca. In cambio di
una banca centrale unica (comunque plasmata sulla Bundesbank)
la Germania pretende
vincoli sulla situazione dei conti pubblici dei futuri paesi
dell’Unione. Da qui il Trattato di Maastricht e tutto il
resto, sino al Fiscal
Compact. La politica economica condotta dal grande capitale
tedesco dagli anni ‘80 in poi è stata coerentemente orientata
a riorganizzare
la produzione su scala europea, riprendendosi il cortile di
casa (Ungheria, Polonia, ecc.) in cui esternalizzare le
produzioni a minor valore
aggiunto, affiancandolo alle aree già prima fortemente integr
ate nella filiera produttiva tedesca, come il Veneto o
l’Austria. La moneta
unica va studiata all’interno di questo quadro di cui
costituisce una tessera importante ma non esclusiva. Lo
dimostra il fatto che buona parte
dell’est europeo, colonia tedesca, non ha nemmeno l’euro anche
se fa parte dell’UE. Ridurre dunque il tema dell’uscita
dall’Eurozona alla possibilità di svalutare è sicur amente
futile.
In questo quadro, l’Italia gioca un ruolo particolare. Già verso la fine del miracolo economico era chiaro che il capitale italiano non fosse in grado di reggere lo scontro con i concorrenti internazionali sul piano dell’innovazione. Alle difficoltà fece fronte, in un primo momento, con le svalutazioni, in seguito con le delocalizzazioni, il far west sul mercato del lavoro, l’appropriazione delle ex aziende pubbliche. Definire come fanno gli autori questo calo degli investimenti come “kaleckiano” nel senso di legato a una decisione co sciente di “punire” le lotte operaie ci sembra parziale. Può essere vero per alcuni momenti di acu to scontro sociale, ma qui si parla di un processo ultradecennale legato a fattori strutturali, peraltro indicati nel libro stesso, come la polverizzazione produttiva delle aziende, la loro concentrazione in settori maturi, ecc.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Quale socialismo?
Quale socialismo?
di Andrea Zhok

1. Introduzione
In tempi recenti, con il chiarirsi dell’inadeguatezza politica e teorica di ciò che va sotto il nome di ‘sinistra’, si è riproposta l’esigenza di usare termini meno ambigui e più sostanziali per definire visioni alternative al dominio dell’ordinamento capitalistico e della teorizzazione liberale. La direzione più semplice in cui si può operare tale chiarimento è recuperando il concetto di ‘socialismo’.
E tuttavia si fa presto a parlare di ‘socialismo’.
Nel tempo il termine è venuto a significare cose assai diverse, e le discussioni sull’essenza del socialismo (o comunismo) e sulla loro versione autentica occupano intere biblioteche. È totalmente impensabile ripercorrere qui un’esegesi storica di quel dibattito. Di socialismo parla per primo Saint-Simon, opponendolo all’individualismo liberale, ma il concetto si consolida sul piano teorico solo con la riflessione marxiana, dove esso emerge come teoria che sostiene la proprietà sociale (comune, collettiva, pubblica, o cooperativa) dei mezzi di produzione.
Nelle pagine di Marx il termine socialismo venne tuttavia subordinato al termine ‘comunismo’, che però a sua volta cadde in parziale disuso negli anni immediatamente successivi alla sua morte. Negli ultimi decenni prima della Prima Guerra Mondiale sarà il termine socialismo ad occupare quello spazio concettuale, fino alla Rivoluzione d’Ottobre, quando Lenin userà socialismo e comunismo con accezioni divergenti: egli contrapporrà lo Stato socialista come necessario momento intermedio, alla Società Comunista, come ideale futuro.
Dopo il 1918 il termine ‘comunismo’ riprese perciò quota, anche nel tentativo di distanziarsi dal fallimento dei partiti socialisti europei di fronte all’ingresso in guerra, e rimarrà termine diffuso e prevalente, seguendo le sorti dell’avventura storica sovietica, fino al suo collasso. Nel frattempo il termine ‘socialismo’, spesso nella sua variante ‘socialdemocratica’, si sposterà sempre di più in posizione antitetica al comunismo sovietico.
Leggi tutto
Renato Marvaso: La tribalizzazione delle dinamiche capitalistiche
La tribalizzazione delle dinamiche capitalistiche*
di Renato Marvaso
Il fenomeno del lavoro che viene ceduto gratuitamente si affaccia sulla nostra contemporaneità in forme, ambienti e contrattualizzazioni differenti: ma lo studio di tale meccanismo ci dà anche la stura delle sofferenze e delle privazioni dettate in tutto il mondo dai recenti cambiamenti del capitalismo moderno, sia nella sfera della produzione materiale, sia in quella rivolta a una fittizia generazione di plusvalore
 Come già era accaduto
dopo il rivoluzionamento sociale ed economico scaturito dalla
seconda rivoluzione industriale,
l’irrazionalità della finanza e la voracità dei processi di
accumulazione, un tempo prospettanti l’imperialismo, tendono
ancora oggi, e quasi ciclicamente, a nascondersi sotto l’ombra
del motto libero-scambista «laissez-faire, laissez passer».
Nell’attuale momento storico il capitalismo sembra senza una
direzione precisa, se da un lato la cronicità delle
conseguenze della crisi
sulle vite umane aggrava soprattutto le condizioni di vita dei
lavoratori e dei disoccupati dall’altro la politica delle
varie riforme
governamentali non è stata in grado di far ripartire un altro
ciclo di accumulazione, dopo quello apertosi nel secondo
dopoguerra.
Come già era accaduto
dopo il rivoluzionamento sociale ed economico scaturito dalla
seconda rivoluzione industriale,
l’irrazionalità della finanza e la voracità dei processi di
accumulazione, un tempo prospettanti l’imperialismo, tendono
ancora oggi, e quasi ciclicamente, a nascondersi sotto l’ombra
del motto libero-scambista «laissez-faire, laissez passer».
Nell’attuale momento storico il capitalismo sembra senza una
direzione precisa, se da un lato la cronicità delle
conseguenze della crisi
sulle vite umane aggrava soprattutto le condizioni di vita dei
lavoratori e dei disoccupati dall’altro la politica delle
varie riforme
governamentali non è stata in grado di far ripartire un altro
ciclo di accumulazione, dopo quello apertosi nel secondo
dopoguerra.
Nell’attuale fase di arresto della deflazione e di quasi stagnazione economica un dato certo, e che caratterizza gli ultimi decenni del corso capitalistico, è il decremento in tutto il pianeta del costo della forza lavoro1; l’effetto di tale ribasso ha creato su scala globale una serie crescente e multi-localizzata di squilibri sociali generando, in maniera sclerotizzata e, come ovvio, a seconda delle condizioni di vita locali, le rivolte del pane in Egitto, la protesta contro la Loi Travail in Francia e i finora pochi sparsi scioperi generalizzati in Europa2. Secondo quanto dedotto, filosoficamente e materialisticamente, da Karl Marx già al principio del capitalismo il costo della forza-lavoro è stabilito in base al valore complessivo dei beni di consumo, i quali assicurano la conservazione in buono stato della forza-lavoro stessa: ed esso rimane, dunque, invariato, non nel prezzo che può variare ma bensì nel contenuto, ovvero nella costante, corrispondente a un accesso monetario ai beni materiali che, al di là delle epoche e dei luoghi o dei modi di lavoro, garantiscono la sopravvivenza e il recupero (la rigenerazione) della forza fisica e mentale, elargite durante il faticoso atto della produzione3.
In alcuni casi storici le circostanze che hanno garantito una maggiorazione del salario hanno quasi sempre ovviato a dei periodi, più brevi che lunghi, in cui il capitale si accrebbe enormemente. Una parte degli extra-profitti poteva quindi essere concessa ai lavoratori in forma di tutele, incentivi, incrementi diretti o indiretti del costo della forza-lavoro, con relativo aumento dei salari, questi ultimi rigorosamente stabiliti, dal dopo-guerra in poi, su base contrattuale e organizzata collettivamente.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Piccola nota sui "minibot"
Piccola nota sui "minibot"
di Andrea Zhok
Ok, abbiamo sentito tutte le possibili raffiche di spiegazioni dotte sul perché i minibot sarebbero, a scelta e in crescendo: "moneta falsa", "debito pubblico", una "buffonata", "il preludio all'Armageddon finanziario", ecc.
Ora, visto quanto poco e male sono stati difesi da chi li ha proposti, credo anch'io che si tratti solo di una mossa propagandistica ad uso interno, e che non abbiano alcun significato politico.
Detto questo i minibot, se perseguiti con coerenza, facendone un luogo di trattativa a livello europeo sono una iniziativa ragionevole, buona quanto altre per porre le questioni giuste a Bruxelles.
Tecnicamente le obiezioni che sono state mosse sono tanto corrette quanto irrilevanti: dal punto di vista contabile il debito non saldato delle amministrazioni pubbliche non è ancora conteggiato come debito pubblico fino a quando il creditore non ne chiede il riscatto presso un istituto privato. Questo significa che dei 53 miliardi di debito non saldato della pubblica amministrazione solo 10 miliardi pesano già come debito pubblico italiano nella contabilità europea.
Ora, però, quello che deve essere chiaro è che la 'contabilità europea' è semplicemente una convenzione frutto di accordi politici.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Apologia della sovranità democratica
Apologia della sovranità democratica
di Carlo Formenti
In uno strepitoso saggio breve (“Sovranità”, il Mulino) che ho divorato in poche ore (era da tempo che una lettura non mi appassionava tanto), Carlo Galli fa piazza pulita delle idiozie, dei luoghi comuni e degli ideologismi che funestano le campagne anti sovraniste condotte da media, partiti e accademici (come populismo, sovranismo è un concetto passepartout che, a furia si essere riempito dei contenuti più disparati, ha finito per perdere senso). Approfittando del fatto che Alessandro Somma dedica, su queste stesse pagine, un’ampia recensione al lavoro di Galli, mi permetto di estrarne in poche righe il “succo” politico e, per sintetizzarlo nel modo più chiaro possibile (ammettendo apriori le inevitabili semplificazioni e le altrettanto inevitabili – ma spero non troppo arbitrarie – interpretazioni soggettive) dividerò l’argomentazione in quattro parti.
Uno. Galli, evitando la trappola in cui cadono i filosofi della politica che assumono una prospettiva metastorica (inscrivendo ad esempio la democrazia ateniese e la democrazia moderna in un medesimo ordine fenomenico), mette in luce la specificità della sovranità dei moderni che consiste nel fatto, già evidenziato dal Machiavelli, che essa non è legittimata da alcun fattore trascendente ma appare esposta alle sfide che la contingenza lancia all’ordine politico – ordine che si presenta quindi come frutto di costruzione, più che come portato di fattori naturali e/o tradizionali. “La modernità, scrive, è l’epoca in cui la legittimità diventa problema, non è più data ma assente e quindi ricercata, inseguita, costruita”.
Leggi tutto
Stefano Fassina: “Il Pd si è inchinato al neoliberismo
“Il Pd si è inchinato al neoliberismo"
"Con l’Europa bisogna resistere e andare all’attacco”
Intervista a Stefano Fassina
Intervista di Carmine Gazzanni per la notiziagiornale.it
“Una procedura d’infrazione all’Italia sarebbe assolutamente controproducente perché in una fase di stagnazione una stretta di bilancio determinerebbe un aggravamento delle condizioni dell’economia reale”. Per questa ragione l’onorevole Stefano Fassina, fondatore del movimento politico “Patria e Costituzione”, non ha dubbi sul da farsi: “è arrivato il momento che l’Italia giochi in attacco e resista alle pressioni della Commissione”.
* * * *
Ha ragione Di Maio, dunque, quando dice che la Commissione non ha imparato dai suoi errori?
Assolutamente sì. Il Fondo Monetario già ai tempi di Olivier Blanchard ha ammesso di aver drammaticamente sottostimato il moltiplicatore. Ci sono importanti istituzioni ed economisti internazionali che raccomandano ora una politica di bilancio espansiva. Il problema però è innanzitutto politico.
In che senso?
Nell’eurozona domina un paradigma che è funzionale agli interessi della finanza e delle imprese esportatrici. La Commissione non fa altro che attuare un impianto funzionale a questi interessi. Il problema, insomma, è di conflitto tra interessi che poi si riverbera in posizioni di politica economica.
Leggi tutto
Turi Palidda: L’aumento dell’imprenditoria straniera non è una buona notizia
L’aumento dell’imprenditoria straniera non è una buona notizia
di Turi Palidda
Ancora una volta tante voci dell’area pro-immigrati si entusiasmano leggendo l’ultima ricerca Censis – peraltro mediocre – in cui soltanto si registra quanto già si sapeva, da anni. Ne avevo scritto nel 1992 in francese e nel 2002 in italiano, qui.
L’aumento continuo della cosiddetta imprenditoria straniera non conosce crisi, è composta da giovani, e aumenta, a differenza di quella italiana, che diminuisce. Molti ricercatori, considerati rinomati, continuano a esaltare l’epopea di questa imprenditorialità; l’abuso del termine comunità impera come quello di identità, quando non si sconfina a etnie o razze (sic!). Alcuni di questi ricercatori hanno contribuito al convegno Neodemos del 2015, “L’integrazione delle comunità immigrate e l’imprenditoria straniera”, per la Fondazione Cesifin, o anche per la Fondazione Moressa, e ancora altri per altre committenti. Questa epopea da tempo sembra essere particolarmente apprezzata presso il padronato (Confindustria e Camere di Commercio), presso le banche e le società immobiliari.
L’acriticità di queste descrizioni, spesso solo statistiche, anche dettagliate ma generiche, senza mai vere ricerche sul campo, di tipo economico-antropologico-etnografico, è tale che – vedi caso – non si dice mai nulla di ciò che è palesemente un processo di etnicizzazione liberista.
Leggi tutto
Hits 3783
Hits 3751
Hits 3361
Hits 2939
Hits 2825
Hits 2693
Hits 2548
Hits 2186
Hits 2128
tonino

Piemme: La verità (che li spaventa) sui minibot
La verità (che li spaventa) sui minibot
di Piemme
 Martedì 28 maggio il Parlamento ha approvato all'unanimità una
mozione
che impegna il governo a rendere possibile il pagamento dei
debiti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici
con titoli di Stato di
piccolo taglio, altrimenti denominati MiniBoT.
Martedì 28 maggio il Parlamento ha approvato all'unanimità una
mozione
che impegna il governo a rendere possibile il pagamento dei
debiti della pubblica amministrazione alle imprese creditrici
con titoli di Stato di
piccolo taglio, altrimenti denominati MiniBoT.
Contro i MiniBoT è giunta fulminea la scomunica di Draghi — «O sono moneta, e allora sono illegali, oppure sono debito e quindi lo stock sale. Non vedo altra possibilità» — si sono scatenati contro, oltre a Moody's, non solo i suoi mastini di guerra — a cominciare dal ministro Tria con piddini, berluscones e giornalisti al seguito — ma pure comunisti presunti, gli improbabili economisti di Coniare Rivolta, e neofascisti in pectore come l'avvocato (del diavolo) Marco Mori.
Ma andiamo con ordine
Cosa sono infatti i Buoni ordinari del Tesoro (BoT)? Spiega il Mef:
«Sono titoli a breve termine, ovvero con durata non superiore a un anno, privi di cedole; il rendimento infatti è dato tutto dallo scarto d'emissione».
Detto in parole semplici: chi compra un BoT presta i suoi euro allo Stato in cambio di un titolo, ma non incasserà alla scadenza alcun interesse, otterrà un guadagno solo ove il valore d'emissione sia inferiore a quello nominale — può evidentemente accadere il contrario. Ogni anno lo Stato lancia dei BoT e li mette all'asta. Per la cronaca: l'ultima asta, che c'è stata proprio ieri (BoT con scadenza al 12 giugno 2020) ha avuto una domanda per quasi 10 miliardi di euro.
Un "MiniBoT" (salvo "sorprese", che più avanti vedremo) è un BoT come gli altri, niente di più niente di meno. Il suffisso "mini" sta ad indicare, così recita la mozione parlamentare, che con la liquidità ottenuta lo Stato non va a finanziare il debito pubblico (in essere o futuro) ma ci rimborsa le aziende che per lo Stato hanno prestato dei servizi. Come mai una misura tanto modesta, del tutto lecita e tutt'altro che eversiva (non a caso votata, salvo patetici mea culpa successivi in modo bypartisan) sta suscitando tutto questo grande casino?
Leggi tutto
Fabio Ciabatti: Rosa Luxemburg e la rivoluzione impossibile
Rosa Luxemburg e la rivoluzione impossibile
di Fabio Ciabatti
 In un
periodo come quello attuale in cui è più facile immaginare la
fine del
mondo che la fine del capitalismo può essere utile riprendere
le parole di Rosa Luxemburg a proposito della rivoluzione:
In un
periodo come quello attuale in cui è più facile immaginare la
fine del
mondo che la fine del capitalismo può essere utile riprendere
le parole di Rosa Luxemburg a proposito della rivoluzione:
“non esiste nulla di più inverosimile, di più impossibile, di più fantasioso di una rivoluzione un’ora prima che scoppi. Non esiste nulla di più semplice, di più naturale e di più evidente di una rivoluzione nel momento in cui ha sferrato la sua prima offensiva e ha riportato la sua prima vittoria”.
A partire da queste righe dedicate agli avvenimenti russi del 19171 si potrebbe dire, utilizzando un linguaggio che non appartiene alla Luxemburg, che la rivoluzione si configura come evento. Cos’è un evento? Seguiamo Badiou. Si tratta di un immanente rovesciamento delle leggi dell’apparire che ha come conseguenza di far esistere in una data situazione un termine prima inesistente. Si tratta, in altri termini dell’imprevedibile inizio di una rottura che si impone su tutti gli elementi che contribuiscono a creare la sua esistenza.2 Detto in modo ancora diverso, un evento è ciò che porta alla luce nuove possibilità che prima erano invisibili e addirittura impensabili. Non è in sé stesso la creazione di una nuova realtà, ma soltanto la creazione di una imprevista possibilità, ponendo in essere nuove soggettività e dando il via ad una serie di avvenimenti che aprono una nuova sequenza storica.3
Come noto il pensiero della Luxemburg è stato spesso accusato di spontaneismo. Però, se si può applicare, almeno in parte, la categoria di evento alla sua opera, allora parlare di spontaneismo non è la cosa più appropriata. Certo l’autrice contrappone spesso l’attività spontanea delle masse e la loro capacità di innovare la prassi politica all’inerzia e alla funzione frenante del partito e del sindacato. Ma se volessimo parlare in senso proprio di spontaneità dovremmo presupporre un tipo di comportamento che appartiene ad un soggetto come suo necessario attributo. Nel mettere in atto questo modo di agire il soggetto dovrebbe rimane identico sé stesso. Quello che compare nello sciopero di massa e nella rivoluzione si configura, invece, nello spirito della Luxemburg, come un vero e proprio “termine nuovo”.
Leggi tutto
Thomas Fazi: Il nostro “no” socialista all’Unione europea
Il nostro “no” socialista all’Unione europea
di Thomas Fazi
 Sarebbe un
errore considerare il processo di processo di integrazione
economica europea un
fallimento. Dal punto di vista degli obiettivi delle classi
dominanti – indebolimento delle classi lavoratrici ed
esautoramento della democrazia
– si è rivelato uno straordinario successo. L’Unione europea e
in particolare l’architettura di Maastricht, infatti, possono
essere considerate la risposta delle oligarchie europee alla
crisi della democrazia – intesa come “eccesso di democrazia” –
denunciata dal celebre rapporto del 1973 della Trilateral
Commission. I vari “vincoli esterni” europei – dal cambio
semifisso del
Sistema monetario europeo (SME) alla liberalizzazione dei
movimenti di capitali per mezzo della creazione del mercato
unico fino
all’introduzione della moneta unica – hanno permesso alle
varie élitenazionali (in particolare quella italiana) di
perseguire
obiettivi di politica economica – finalizzati
all’esautoramento delle conquiste democratiche ed
economico-sociali che erano state
precedentemente raggiunte dalle classi subordinate – che
altrimenti sarebbero stati molto più difficili, se non
impossibili, da
realizzare. Come ammise lo stesso Guido Carli, l’Unione
europea è stata lo strumento per «sconvolgere la Costituzione
materiale del
paese», obiettivo che sarebbe stato impossibile da ottenere
«per le vie ordinarie del governo e del Parlamento»[1].
Sarebbe un
errore considerare il processo di processo di integrazione
economica europea un
fallimento. Dal punto di vista degli obiettivi delle classi
dominanti – indebolimento delle classi lavoratrici ed
esautoramento della democrazia
– si è rivelato uno straordinario successo. L’Unione europea e
in particolare l’architettura di Maastricht, infatti, possono
essere considerate la risposta delle oligarchie europee alla
crisi della democrazia – intesa come “eccesso di democrazia” –
denunciata dal celebre rapporto del 1973 della Trilateral
Commission. I vari “vincoli esterni” europei – dal cambio
semifisso del
Sistema monetario europeo (SME) alla liberalizzazione dei
movimenti di capitali per mezzo della creazione del mercato
unico fino
all’introduzione della moneta unica – hanno permesso alle
varie élitenazionali (in particolare quella italiana) di
perseguire
obiettivi di politica economica – finalizzati
all’esautoramento delle conquiste democratiche ed
economico-sociali che erano state
precedentemente raggiunte dalle classi subordinate – che
altrimenti sarebbero stati molto più difficili, se non
impossibili, da
realizzare. Come ammise lo stesso Guido Carli, l’Unione
europea è stata lo strumento per «sconvolgere la Costituzione
materiale del
paese», obiettivo che sarebbe stato impossibile da ottenere
«per le vie ordinarie del governo e del Parlamento»[1].
In questo senso, risulta estremamente superficiale la lettura che vede l’Europa come un Moloch che impone il proprio volere agli Stati nazionali: al contrario, il più delle volte (sebbene non sempre) “l’Europa” è precisamente il dispositivo attraverso il quale una parte della comunità nazionale – l’élite – impone le proprie politiche al resto della comunità nazionale. È il celebre “ce lo chiede l’Europa”. In questo senso, la moneta unica incarna quello che Edgar Grande chiama il «paradosso della debolezza», per cui le élite nazionali trasferiscono una parte del potere a un decisore sovranazionale (apparendo in tal modo più deboli) per essere in grado di sopportare meglio la pressione da parte degli attori sociali, asserendo che «lo vuole l’Europa» (e divenendo così più forti)[2]. Come dice Andrew Moravcsik: «Gli impegni vincolanti della UE permettono ai governi di varare riforme impopolari nei loro paesi, e nel contempo darne la colpa alla UE, anche se essi stessi desideravano attuarle[3].
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Bot a destra e sinistra
Bot a destra e sinistra
di ilsimplicissimus
Quando si parla di sinistra salottiera non s’intende solo quella che va a mostrare le chiappe chiare a Capalbio, per la quale il discorso sociale ha ormai lo stesso valore del sudoku e la cui interazione con i ceti popolari è limitato alle colf e ai filippini di servizio, ma soprattutto uno stato d’animo, un modo di essere che non prevede l’azione, se non episodica e occasionale, ma l’affabulazione sociale dentro il giardino della memoria con le sue oasi e i suoi paletti. Ogni qualvolta però occorre uscire dal discorso e scegliere si fa un passo indietro come spaventati dalla possibilità che le ipotesi possano tradursi in realtà. Lo vediamo bene in questi giorni sulla questione dei minibot che in qualche modo portano nel concreto quella possibilità di moneta fiscale che in questi anni è stata costantemente proposta proprio a sinistra come scappatoia per attutire l’impatto disastroso dell’euro senza dover mettere in questione l’intera costruzione dell’unione a guida ordoliberista che dopo la dissoluzione dell’Urss è diventata un totem e un tabù.
Potrei portare a conferma di questa evidenza molte decine di articoli usciti in questi ultimi anni e che hanno visto come pioniere lo scomparso Luciano Gallino, ma mi limiterò a suggerirvene alcuni più riassuntivi che sono usciti di recente ovvero tra la fine dell’anno scordo scorso e questi ultimi mesi. Li potete trovare, qui, qui, qui, qui e tutti suggeriscono sistemi, abbastanza simili tra loro, per la creazione di moneta fiscale, la quale, tanto per essere chiari e per uscire dalle fumisterie, è discussa anche da numerosi economisti tedeschi per i quali sarebbe utile una moneta a fianco dell’euro, che non lo sostituisce e che lo Stato emette per poi accettarlo in pagamento delle tasse.
Leggi tutto
La moneta del Monopoli e i monopolisti della moneta
La moneta del Monopoli e i monopolisti della moneta
A commento dell'articolo sull'infame posizione uscita sul Manifesto a firma Anna Maria Merlo contro i Minibot, una lettrice/lettore che si firma "Rosso Nera" causticamente scrive:
«Ahah ormai sto blog difende pure le monete del monopoli. Vi avverto, se si crea una situazione latinoamericana, coi ricchi coi dollari in saccoccia, e i poveri coi mini bot, e se a me mi pagano lo stipendio coi mini bot, la cena la vengo a fare a casa vostra».
Affermazioni, quelle di Rosso Nera, che riprendono pari pari gli "argomenti" dei giornaloni sistemici, di Confindustria ed appunto del Manifesto. E' come se di fronte alla questione della moneta ogni critica politica e di classe dovesse essere rimossa in nome della "sacralità" di quest'ultima. Visto da sinistra è come dire che del sistema tutto si può cambiare, ma la moneta proprio no. Un atteggiamento cieco, irrazionale ed irresponsabile. Potremmo dire quasi religioso.
Al confronto Mario Draghi ci fa la parte del signore. Egli attacca infatti i minibot in quanto "illegali" perché sfuggono al controllo della Bce. Li attacca come "nuovo debito", perché ne vede l'utilizzo in funzione di politiche espansive vietate dalle regole ordoliberali. Ma non essendo uno stupido si guarda bene dal definire i Minibot come "cartastraccia", che è invece l'"argomento" di certuni.
Leggi tutto
Nasce il Comitato per la liberazione di Assange - Italia
Nasce il Comitato per la liberazione di Assange - Italia
L'appello per la mobilitazione
Riceviamo e volentieri pubblichiamo il volantino del Comitato per la liberazione di Assange - Italia da poco costituitosi.
Come redazione dell'AntiDiplomatico invitiamo tutti i democratici veri e progressisti a mobilitarsi al fine di diffondere e promuovere questa giusta causa. Far morire Assange come terrorista in un carcere di massima sicurezza del Regno Unito è il messaggio ultimo di prepotenza dell'imperialismo Usa e Ue.
DAL COMITATO PER LA LIBERAZIONE DI JULIAN ASSANGE - ITALIA
"Pubblichiamo il modulo comprendente l'appello per la raccola firme del comitato, al fine di poterlo utilizzare a livello nazionale.
Invitiamo i sostenitori in tutte le città del paese a diffondere e promuovere questa causa.
Diamo indicazione di farlo fisicamente.
Troppe volte si è visto che una raccolta firme sostenuta prevalentemente in rete non ha avuto poi le gambe per diffondersi materialmente: i banchetti consentono di incontrare fisicamente e approfondire le questioni inerenti la causa per cui ci stiamo battendo e favoriscano la conoscenza, lo scambio di informazione e la possibilità di mobilitare successivamente.
Leggi tutto
Italo Nobile: Gli Stati Uniti d’Europa secondo Lenin
Gli Stati Uniti d’Europa secondo Lenin
di Italo Nobile
“La prossima parola d’ordine politica dei socialdemocratici europei deve essere la formazione degli Stati Uniti repubblicani d’Europa; ma a differenza della borghesia, la quale è sempre pronta a promettere tutto ciò che si vuole pur di trascinare il proletariato nella corrente generale dello sciovinismo, i socialdemocratici spiegheranno quanto sia assurda e bugiarda questa parola d’ordine senza l’abbattimento rivoluzionario delle monarchie tedesca, austriaca e russa”.
Così recita un passo di “La guerra e la socialdemocrazia russa” scritto a fine Settembre 1914 e pubblicato ad inizio Novembre dello stesso anno. Viene attribuito a Lenin, ma è firmato Il Comitato centrale del Partito Operaio socialdemocratico della Russia. Non a caso Lenin ad Agosto del 1915 rammenta in “Sulla parola d’ordine degli Stati Uniti d’Europa” che la Conferenza delle sezioni del partito all’estero (svoltasi a Berna tra Febbraio e Marzo del 1915) aveva deliberato di soprassedere alla questione della parola d’ordine “Stati Uniti d’Europa” finchè non se ne fosse discusso l’aspetto economico. E Lenin ricorda che il manifesto del Comitato Centrale aveva formulato questa parola d’ordine come parola d’ordine politica e aveva sottolineato che essa sarebbe stata bugiarda senza l’abbattimento rivoluzionario delle monarchie tedesca, austriaca e russa. Lenin precisa che opporsi, entro i limiti degli apprezzamenti politici di questa parola d’ordine, mettendosi dal punto di vista che essa offusca o indebolisce, sarebbe del tutto errato. E continua, parlando delle rivoluzioni politiche di tipo democratico intendendole come propedeutiche alla rivoluzione socialista.
Leggi tutto
Enrico Grazzini: La guerra dei Minibot: gli scenari della crisi italiana
La guerra dei Minibot: gli scenari della crisi italiana
di Enrico Grazzini
 La battaglia politica sui minibot
è sempre più accesa: il Parlamento Italiano ha votato
all'unanimità a favore dell'emissione dei titoli fiscali
proposti da Claudio Borghi della Lega con il supporto dei 5
Stelle, ma poi PD e Forza
Italia si sono schierati contro i minibot. Anche Mario Draghi,
presidente della Banca Centrale Europea, Vincenzo Boccia, a
capo di Confindustria, e il
ministro del Tesoro Giuseppe Tria hanno espresso chiaramente
la loro contrarietà verso la proposta votata dal Parlamento
italiano. Per contro i
due vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini
e Luigi Di Maio, hanno attaccato il “loro” ministro contrario
ai minibot.
E' scoppiata quindi una vera e propria guerra politica sui
titoli di stato con valore fiscale che dovrebbero essere
emessi per pagare gli arretrati
della pubblica amministrazione alle imprese e ai privati
cittadini. La posta in gioco è alta: in futuro l'emissione dei
minibot potrebbe
perfino mettere in discussione la partecipazione dell'Italia
nell'eurozona e quindi provocare anche la rottura dell'euro[1].
La battaglia politica sui minibot
è sempre più accesa: il Parlamento Italiano ha votato
all'unanimità a favore dell'emissione dei titoli fiscali
proposti da Claudio Borghi della Lega con il supporto dei 5
Stelle, ma poi PD e Forza
Italia si sono schierati contro i minibot. Anche Mario Draghi,
presidente della Banca Centrale Europea, Vincenzo Boccia, a
capo di Confindustria, e il
ministro del Tesoro Giuseppe Tria hanno espresso chiaramente
la loro contrarietà verso la proposta votata dal Parlamento
italiano. Per contro i
due vice-presidenti del Consiglio dei Ministri, Matteo Salvini
e Luigi Di Maio, hanno attaccato il “loro” ministro contrario
ai minibot.
E' scoppiata quindi una vera e propria guerra politica sui
titoli di stato con valore fiscale che dovrebbero essere
emessi per pagare gli arretrati
della pubblica amministrazione alle imprese e ai privati
cittadini. La posta in gioco è alta: in futuro l'emissione dei
minibot potrebbe
perfino mettere in discussione la partecipazione dell'Italia
nell'eurozona e quindi provocare anche la rottura dell'euro[1].
Le polemiche riguardano le caratteristiche e gli obiettivi dei minibot: questi titoli fiscali che circolerebbero in Italia anche come contante, sono legali o illegali? Rappresentano o no una moneta parallela? Violano il monopolio della Banca Centrale Europea sull'euro, l'unica moneta legale dell'eurozona? I minibot sono realmente efficaci per ridare liquidità alle imprese? Sono utili per rilanciare l'economia reale? O servono invece solo come espediente per uscire dall'Euro? Aumentano o no il debito pubblico? Esistono sistemi alternativi di titoli fiscali più efficaci nel rilanciare l'economia nazionale, che non aumentino il debito pubblico e garantiscano di essere pienamente rispettose delle regole dell'eurozona?
Queste le domande che attraversano il mondo politico, quello dell'economia e l'opinione pubblica, a cui questo articolo intende dare delle risposte.
Un'avvertenza preliminare: la polemica sui minibot non è di poco conto, è seria ed è, magari anche con diverse forme e contenuti, destinata a durare e a crescere. La questione monetaria non può mai essere trattata in maniera derisoria e superficiale, come hanno fatto molti commentatori paragonando i minibot alle monete false del gioco del Monopoli.
Leggi tutto
Alessio Giacometti: Analisi di una sconfitta
Analisi di una sconfitta
di Alessio Giacometti*
Il fallimento del comunismo in Italia in un dialogo inedito tra Pietro Ingrao e lo scrittore Ferdinando Camon
 Quando nel
1991 il PCI rinuncia a ogni legame con le sue origini
sovietico-marxiste e cambia
nome, i telegiornali di tutto il mondo trasmettono l’immagine
di Pietro Ingrao in lacrime, il volto coperto con una mano. In
quel pianto si
consumava il residuo ideologico del più forte partito
comunista d’Occidente. È allora che Ferdinando Camon,
scrittore cattolico e
contadino, decide di incontrarlo. Ingrao accetta il confronto,
come peraltro aveva già fatto nel 1990, quando nel resoconto
autobiografico
Le cose impossibili prova a dirimere quell’ “intreccio
di vicenda personale, di confronto di idee, di riflessione
storica”
che era stato per lui il comunismo.
Quando nel
1991 il PCI rinuncia a ogni legame con le sue origini
sovietico-marxiste e cambia
nome, i telegiornali di tutto il mondo trasmettono l’immagine
di Pietro Ingrao in lacrime, il volto coperto con una mano. In
quel pianto si
consumava il residuo ideologico del più forte partito
comunista d’Occidente. È allora che Ferdinando Camon,
scrittore cattolico e
contadino, decide di incontrarlo. Ingrao accetta il confronto,
come peraltro aveva già fatto nel 1990, quando nel resoconto
autobiografico
Le cose impossibili prova a dirimere quell’ “intreccio
di vicenda personale, di confronto di idee, di riflessione
storica”
che era stato per lui il comunismo.
Tra il dicembre del 1993 e il maggio del 1994 i due si scambiano otto lettere e si incontrano per tre volte nella villa romana di Ingrao, in via Ugo Balzani, a ridosso della borgata di Pietralta. Questo scontro ha un peso: le domande di Camon sono impetuose, serrate, assillanti. Da un incontro all’altro Ingrao ha dei ripensamenti, il numero di note alle trascrizioni che gli arrivano da Padova scema rapidamente. Al termine degli incontri, l’insoddisfazione lo spinge addirittura a chiedere che quei dattiloscritti non vengano pubblicati. Camon resta sgomento, ma decide di accontentarlo.
Passa un quarto di secolo, Ingrao muore centenario nel 2015 e Alberto Olivetti, amministratore dell’archivio eponimo alla Fondazione Centro di studi e iniziative per la Riforma dello Stato, ritrova quei carteggi ancora inediti nel faldone B 42. Scrive subito a Camon e ottiene l’assenso a pubblicarli in un libriccino essenziale, Tentativo di dialogo sul comunismo (Ediesse, 2019), offerto oggi “alla comprensione e alla sofferenza di chi vuol condividerlo”.
Liberare l’animale
“Lei parla di ‘morte’ definitiva”, accusa Ingrao già nel primo incontro, “e vuol ragionare su questa morte: il nostro discorso sarebbe [così] un’epigrafe”. Meglio parlare di “crisi”, che è una morte passeggera, uno sfogo cutaneo sulla pelle della storia.
Leggi tutto
Michele Nobile: Euro al capolinea?
Euro al capolinea?
Sul libro di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua
di Michele Nobile
 È necessario uscire
dall’euro? Potrebbe essere questa, se non la panacea per i
problemi
sociali italiani, almeno la condizione necessaria per iniziare
a invertire l’orientamento antipopolare della politica
economica e sociale?
È questo un obiettivo per cui devono battersi lavoratrici e
lavoratori, giovani e pensionati in Europa?
È necessario uscire
dall’euro? Potrebbe essere questa, se non la panacea per i
problemi
sociali italiani, almeno la condizione necessaria per iniziare
a invertire l’orientamento antipopolare della politica
economica e sociale?
È questo un obiettivo per cui devono battersi lavoratrici e
lavoratori, giovani e pensionati in Europa?
Se si vuole approfondire la questione è utilissimo il libro Euro al capolinea? La vera natura della crisi europea, Di Riccardo Bellofiore, Francesco Garibaldo e Mariana Mortágua (Rosenberg & Sellier, Torino 2019), strutturato in due lunghi saggi e due appendici. È convinzione degli autori che
«l’euro faccia parte di una strategia più ampia - condivisa dalle élite economiche e finanziarie nazionali - di riorganizzare i capitali singoli e di comprimere i diritti della classe lavoratrice, attraverso l’accelerazione della liberalizzazione fianziaria e la maggiore esposizione delle economie nazionali alla concorrenza internazionale» (p. 81).
E tuttavia, pensare di por fine al cosiddetto neoliberismo uscendo dall’euro è un’illusione. Il libro spiega bene perché sia sbagliato il presupposto economico alla base di questa idea e perché, per cambiare la direzione prevalente delle politiche economiche e sociali, una strategia politica realistica debba avere una dimensione internazionale. Di seguito ne espongo le tesi principali, con qualche mia considerazione; le conclusioni politiche dell’ultima sezione sono mia unica responsabilità personale.
Uscire o no dall’euro è in realtà un dilemma falso e fuorviante, quando si considerino il livello d’integrazione dei capitalismi europei, le ragioni di fondo della cosiddetta crisi del «debito sovrano» e la dimensione dei problemi strutturali su scala continentale. La risposta di Bellofiore, Garibaldo e Mortágua a questi ultimi è che
«Essi resuscitano il conflitto sul “come”, “quanto” e “per chi” produrre, che furono al centro delle lotte del mondo del lavoro negli anni Sessanta e Settanta del Novecento. A esse deve rispondere una politica di socializzazione dell’economia (socializzazione dell’investimento, socializzazione dell’occupazione, socializzazione della banca) e di “buoni” disavanzi statali, “programmati” e mirati alla produzione di valori d’uso sociale per il tramite di un intervento sulla composizione della produzione e di occupazione diretta dello Stato, un vero e proprio “piano del lavoro”» (p. 86).
Leggi tutto
Domenico Moro: Le vere paure dietro i minibot
Le vere paure dietro i minibot
di Domenico Moro
La vicenda dei minibot, che da giorni riempie pagine dei giornali e talk show, è rivelatrice della difficoltà a coniugare il rispetto delle regole Ue con investimenti e crescita della produzione. Malgrado l’Italia sia sempre additata come poco virtuosa nella gestione della finanza pubblica, negli ultimi 20 anni ha speso meno delle entrate (al netto degli interessi), realizzando surplus primari del bilancio statale, con la sola eccezione del 2009, anno di picco della crisi. Molto meglio non solo della Spagna e della Francia, ma persino della Germania. Non parliamo poi di Paesi al di fuori dell’area euro, come Usa, Regno Unito e Giappone, sempre con deficit primari molto alti. Il problema è che il raggiungimento del surplus primario ha contribuito a ridurre gli investimenti pubblici, la cui contrazione non ha permesso di compensare il calo degli investimenti privati, che risulta il più accentuato in Europa dall’inizio della crisi. A dispetto di questa situazione, la recente lettera della Commissione europea richiama l’Italia a una maggiore disciplina di bilancio, che, come si vede da un decennio, è foriera di recessione, specie quando, come accade oggi, il mercato estero e quindi le esportazioni, su cui ormai è orientata l’economia italiana, calano.
In questo contesto dominato dal Fiscal compact si inseriscono i minibot, che hanno già sollevato le proteste della Bce, attraverso Draghi, e dello stesso ministro dell’economia, Tria. Ma che cosa sono i minibot? Sono titoli di debito cioè buoni emessi dal Tesoro per finanziare il debito dello Stato.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Frammenti di un'apocalisse civile
Frammenti di un'apocalisse civile
di Andrea Zhok
Ieri sera il nuovo segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti ha preso finalmente posizione sul caso ANM, che coinvolge esponenti del PD ed in special modo l'ex ministro renziano Luca Lotti.
Con un intervento in televisione, Zingaretti, quello che ha vinto le primarie PD nel nome del rinnovamento, del riavvicinamento alle periferie, e della presa di distanza dal renzismo, ha difeso senza remore Lotti, adottandone la linea difensiva ("non ci sono reati; erano solo chiacchiere private.")
Secondo le ricostruzioni della Guardia di Finanza, tra il 9 e il 16 maggio, in diversi alberghi di Roma si sono incontrati: Luca Palamara (ex presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati), i consiglieri del CSM (massimo organo di autogoverno della magistratura) Criscuoli, Morlini, Lepre, Cartoni e Spina, e infine i deputati del PD Lotti e Ferri.
Dalle intercettazioni di Palamara emerge un esercizio sistematico di pressioni per condizionare nomine e promozioni alle più alte cariche della magistratura nazionale.
Nello specifico, Palamara e Lotti discutono di come orientare la nomina del successore di Giuseppe Pignatone a capo della procura di Roma, e del trasferimento del PM Creazzo a Reggio Calabria, liberando così Firenze, in seguito all’inchiesta promossa dallo stesso Creazzo a carico dei genitori di Matteo Renzi.
Emergono richieste di "dare un messaggio forte" al membro del CSM Ermini, che si presentava in qualche misura come 'intrattabile'.
Leggi tutto
coniarerivolta: Bruxelles chiede, il Governo esegue: ora abbiamo le prove
Bruxelles chiede, il Governo esegue: ora abbiamo le prove
di coniarerivolta
Edgar Allan Poe ci insegna, e la saggezza popolare lo conferma, che il posto migliore per nascondere qualcosa è in piena vista. Se, dunque, il Governo attualmente in carica volesse nascondere la vera portata delle proprie scelte di politica economica, quale sarebbe il posto migliore per trovare documenti compromettenti? Probabilmente, sarebbe il sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze, un luogo dove è possibile trovare facile e immediata conferma della natura di questo Governo, l’ennesimo solerte esecutore dei diktat che soffocano la nostra economia da più di vent’anni.
Com’è noto ai più, il 29 maggio scorso la Commissione Europea ha avvertito il Governo italiano che gli sforzi che Tria, Conte e soci stanno facendo per ridurre il debito pubblico sono insufficienti. La risposta dell’esecutivo gialloverde non si è fatta attendere. Due giorni dopo la richiesta di chiarimenti della Commissione, infatti, da via Venti Settembre è partita la lettera di Tria, accompagnata da un rapporto contenente i cosiddetti ‘fattori rilevanti’ ai fini della valutazione della situazione debitoria dell’Italia. Come la Commissione abbia accolto le giustificazioni del Governo italiano, è cosa nota. I commissari, sempre assetati di tagli, non si sono fatti convincere dalle argomentazioni dei tecnici del MEF e hanno suggerito l’apertura di una procedura d’infrazione. D’altro canto, l’austerità non è mai abbastanza e la lotta feroce tra europeisti liberisti e sovranisti liberisti su chi deve esserne l’amministratore ultimo è stato il tema politico principale degli ultimi mesi.
Leggi tutto
Stefano Re: La sporca partita per la moneta globale che si sta giocando sotto i nostri occhi
La sporca partita per la moneta globale che si sta giocando sotto i nostri occhi
di Stefano Re*
Trump ha detto: l’azienda Huawei sta depredando informazioni sul pubblico americano, quindi gli faccio una guerra commerciale. Google si scatena contro il governo degli Stati Uniti perché gli consenta di continuare a fare affari (d’oro) con Huawei. La domanda sembrerebbe: chi comanda davvero? Il governo votato dai cittadini americani, o le aziende che permettono a quegli stessi cittadini di trovare, ogni giorno, ogni risposta su praticamente tutto?
Indubbiamente capire se comandino le aziende o gli organi elettivi è importante, ma qui il tema decisivo è la nuova moneta, di cui si parla abbastanza ma di cui ancora non si è messo a fuoco il trionfo globale: le informazioni.
Ve lo spiego nel modo più semplice possibile: è stato internet, sono stati i social network. Prima le informazioni toccava cercarle in giro nel mondo, sguinzagliare investigatori privati, esperti nella ricerca di informazioni, fossero esse personali, commerciali, politiche, economiche. E raccogliere tutte queste informazioni costava. Costava tantissimo: soldi, tempo, energie, risorse umane, competenze. Da quando c’è la rete, ma soprattutto da quando è diventata lo standard comunicativo di massa, le informazioni vengono raccolte ogni secondo a tonnellate dai gestori dei servizi su internet. Compagnie telefoniche, motori di ricerca, social network, raccolgono miliardi di informazioni su chiunque, privati e società, enti e gruppi, ovunque nel mondo.
Leggi tutto
Hits 3802
Hits 3763
Hits 3374
Hits 2950
Hits 2828
Hits 2700
Hits 2553
Hits 2217
Hits 2131
Hits 1989
tonino

Antonio Pagliarone: La Teoria Monetaria Moderna: un’illusione che abbaglia

La Teoria Monetaria Moderna: un’illusione che abbaglia
di Antonio Pagliarone1
Una nota critica alla raccolta di testi di Michael Roberts sulla teoria moderna della moneta in uscita presso la casa editrice Asterios di Trieste - a.delit...@asterios.it
 La pubblicazione di una serie di
testi critici sulla MMT
(Modern Monetary Theory), prodotti da Michael Roberts e
apparsi nel suo blog, è risultata necessaria in quanto
possiamo osservare che negli
ultimi anni, come reazione ad una “austerity” prolungata, sono
sempre di più coloro che fanno affidamento su politiche
economiche
definite rozzamente come “sovraniste”. Ma tale “teoria”
mescolata ad un keynesismo rinnovato, ha preso piede anche
negli
ambienti della sinistra progressista, mentre molti
intellettuali ultrasinistri sono stati abbagliati dalle
contorsioni monetariste, dopo aver
sostenuto lo “stimolo della domanda”, e confondono con estrema
leggerezza Marx con Keynes. Gratta gratta sotto un marxista
troverai sempre
un keynesiano.
La pubblicazione di una serie di
testi critici sulla MMT
(Modern Monetary Theory), prodotti da Michael Roberts e
apparsi nel suo blog, è risultata necessaria in quanto
possiamo osservare che negli
ultimi anni, come reazione ad una “austerity” prolungata, sono
sempre di più coloro che fanno affidamento su politiche
economiche
definite rozzamente come “sovraniste”. Ma tale “teoria”
mescolata ad un keynesismo rinnovato, ha preso piede anche
negli
ambienti della sinistra progressista, mentre molti
intellettuali ultrasinistri sono stati abbagliati dalle
contorsioni monetariste, dopo aver
sostenuto lo “stimolo della domanda”, e confondono con estrema
leggerezza Marx con Keynes. Gratta gratta sotto un marxista
troverai sempre
un keynesiano.
La Teoria Monetaria Moderna è stata ideata da Warren Mosler2, Bill Mitchell e Randy Wray, mentre James K.Galbraith è uno dei suoi maggiori sostenitori3. La MMT si basa sostanzialmente sull’idea, in passato sostenuta dai cartalisti, che sia lo stato a creare moneta, di conseguenza il denaro circolante è denaro emesso dal governo per cui non occorre la tassazione dei cittadini perché lo stato possa disporre della valuta corrente. Caso mai la tassazione potrebbe contribuire al regolare funzionamento del sistema in quanto permetterebbe di attenuare una eventuale inflazione. Michael Roberts sviluppa inizialmente la teoria dei cartalisti collegandola, giustamente, alla Teoria Monetarista Moderna che ne è l’erede, facendo un raffronto con la teoria della moneta di Marx secondo la quale il denaro è inconcepibile se viene separato dallo scambio di merci. Lo stato non crea moneta dal nulla ma sono “le banche (che) fanno prestiti e di conseguenza vengono creati depositi e debiti per finanziare tali prestiti, non viceversa”. Roberts insiste nel sottolineare le differenze sostanziali tra la teoria marxista e quella cartalista/MMT e dichiara “Per Marx, nel capitalismo, il denaro è la rappresentazione del valore e quindi del plusvalore”. Ma il problema non consiste nel confutare la MMT, e i neokeynesiani che la caldeggiano, sostenendo che: “A meno che i sostenitori della MMT non siano pronti a passare a una conclusione politica marxista: vale a dire l'appropriazione del settore finanziario e il comando del settore produttivo attraverso la proprietà pubblica e un piano di produzione, ponendo così fine alla legge del valore in economia, la politica della spesa pubblica attraverso la creazione illimitata di denaro fallirà”.
Leggi tutto
Marta Fana e Angelo Salento: Il benessere è solo collettivo
Il benessere è solo collettivo
di Marta Fana e Angelo Salento
L'"economia fondamentale" riguarda tutti i settori che costituiscono la base materiale della coesione sociale. Da anni è sotto attacco del capitale. Adesso è il momento di tutelarla, sostiene una rete internazionale di ricercatori e ricercatrici
 I
processi finanziari hanno ormai aggredito e assoggettato ai
propri interessi anche ambiti
storicamente rivolti a soddisfare i bisogni sociali, come la
sanità, la cura, la previdenza, l’istruzione e le
infrastrutture. A essere
sotto attacco è la cosiddetta «economia fondamentale»,
costituita da tutti i beni e servizi necessari al benessere
quotidiano della
società che comprende ma non si riduce al concetto di
welfare. In un recente saggio, Economia fondamentale –
L’infrastruttura della vita quotidiana
(Einaudi) un collettivo interdisciplinare di ricercatori e
ricercatrici ripercorre i passaggi
che hanno portato alla finanziarizzazione di questa parte
dell’economia, che raccoglie in Europa circa il 40% della
forza lavoro occupata, dalle
esternalizzazioni alle
privatizzazioni di
infrastrutture come ferrovie e autostrade: «Seguiamo la
pista dei soldi – dicono – Analizziamo i modi e gli
strumenti con
cui viene sviluppato il business». Gli autori evidenziano lo
scontro politico, di classe, alla base di questi processi,
provando a tracciare se
non delle soluzioni almeno dei percorsi da seguire.
«Suggeriamo di non coltivare l’idea che il reddito
individuale sia la variabile
decisiva per il benessere in quanto una gran parte delle
infrastrutture e dei servizi indispensabili per il benessere
sono necessariamente collettivi
ma non possono spesso esser prodotti a livello ‘locale’,
illudendosi che l’auto-organizzazione economica ‘dal basso’
possa in modo autosufficiente sostenere il benessere
collettivo. Una parte consistente delle attività economiche
fondamentali è di larga
scala, e non è pensabile un’economia fondamentale robusta e
sostenibile senza una regolazione di scala nazionale e
internazionale».
I
processi finanziari hanno ormai aggredito e assoggettato ai
propri interessi anche ambiti
storicamente rivolti a soddisfare i bisogni sociali, come la
sanità, la cura, la previdenza, l’istruzione e le
infrastrutture. A essere
sotto attacco è la cosiddetta «economia fondamentale»,
costituita da tutti i beni e servizi necessari al benessere
quotidiano della
società che comprende ma non si riduce al concetto di
welfare. In un recente saggio, Economia fondamentale –
L’infrastruttura della vita quotidiana
(Einaudi) un collettivo interdisciplinare di ricercatori e
ricercatrici ripercorre i passaggi
che hanno portato alla finanziarizzazione di questa parte
dell’economia, che raccoglie in Europa circa il 40% della
forza lavoro occupata, dalle
esternalizzazioni alle
privatizzazioni di
infrastrutture come ferrovie e autostrade: «Seguiamo la
pista dei soldi – dicono – Analizziamo i modi e gli
strumenti con
cui viene sviluppato il business». Gli autori evidenziano lo
scontro politico, di classe, alla base di questi processi,
provando a tracciare se
non delle soluzioni almeno dei percorsi da seguire.
«Suggeriamo di non coltivare l’idea che il reddito
individuale sia la variabile
decisiva per il benessere in quanto una gran parte delle
infrastrutture e dei servizi indispensabili per il benessere
sono necessariamente collettivi
ma non possono spesso esser prodotti a livello ‘locale’,
illudendosi che l’auto-organizzazione economica ‘dal basso’
possa in modo autosufficiente sostenere il benessere
collettivo. Una parte consistente delle attività economiche
fondamentali è di larga
scala, e non è pensabile un’economia fondamentale robusta e
sostenibile senza una regolazione di scala nazionale e
internazionale».
* * * *
L’economia fondamentale e la sua centralità sono una questione politica, in che modo può essere compatibile con il capitalismo, sistema economico predatorio in cui pure i tentativi di «renderlo umano» vengono spiazzati ogni volta che le esigenze di accumulazione e profitto vengono messe a rischio?
Leggi tutto
Giorgio Riolo: Noi e loro
Noi e loro
Nota a margine de I dannati della terra di Frantz Fanon
di Giorgio Riolo
 Pubblico la nota introduttiva a
“I dannati della terra” di Frantz Fanon. argomento
conclusivo del
ciclo di incontri di letteratura che Giorgio Riolo tiene a
Milano (qui), accogliendo in
pieno –
anche con un invito a guardare e ad ascoltare le voci di
questo tremendo video (qui ) – l’esigenza
di
capire il dramma dell’Africa, liberandoci dai paraocchi del
sovranismo nazionalista o eurocentrico. Non per
“romanticismo
rivoluzionario”, ma per obbligo a pensare tutta la realtà.
Di fronte alla “tempesta” in corso, non possiamo metterci,
come
aveva capito Sartre citato da Giorgio, dalla parte dei
“seminatori di vento” . Essi l’hanno alimentata e ora se ne
lavano le mani.
Dobbiamo impedirglielo o, se non fosse più possibile, almeno
testimoniare la tragedia. [E. A.]
Pubblico la nota introduttiva a
“I dannati della terra” di Frantz Fanon. argomento
conclusivo del
ciclo di incontri di letteratura che Giorgio Riolo tiene a
Milano (qui), accogliendo in
pieno –
anche con un invito a guardare e ad ascoltare le voci di
questo tremendo video (qui ) – l’esigenza
di
capire il dramma dell’Africa, liberandoci dai paraocchi del
sovranismo nazionalista o eurocentrico. Non per
“romanticismo
rivoluzionario”, ma per obbligo a pensare tutta la realtà.
Di fronte alla “tempesta” in corso, non possiamo metterci,
come
aveva capito Sartre citato da Giorgio, dalla parte dei
“seminatori di vento” . Essi l’hanno alimentata e ora se ne
lavano le mani.
Dobbiamo impedirglielo o, se non fosse più possibile, almeno
testimoniare la tragedia. [E. A.]
* * * *
I.
Periodicamente, dalla sua morte, si può parlare di una sorta di riscoperta di Frantz Fanon e del suo grande libro I dannati della terra. Un tempo, tra gli anni sessanta e gli anni settanta, per esempio, negli Stati Uniti a opera soprattutto del Black Panther Party. A fine anni settanta, negli Usa se ne erano vendute 750.000 copie della traduzione inglese del libro.
Oggi soprattutto a causa dei pericoli del razzismo, della chiusura identitaria, anche entro gli strati popolari occidentali, italiani nel nostro caso. A causa della bella guerra tra poveri, alimentata, manipolata, incoraggiata dalle classi dominanti, beneficiarie in primo luogo dello sfruttamento di quello che un tempo chiamavamo “proletariato esterno”. Gli esseri umani costretti a emigrare per vivere. Sempre da Sud a Nord. Un tempo dal Mezzogiorno d’Italia e oggi dalle periferie del mondo.
Frantz Fanon è figura storica, nel tempo e nello spazio, figlio del suo tempo, sicuramente. Ma la sua vita, recisa come un fiore nella sua piena fioritura, ne ha fatto un mito. Un essere umano che segna un destino, che segna un’epoca. Anche una generazione.
Figlio del mondo diviso tra metropoli e colonie, come si diceva allora, del mondo manicheicamente diviso tra colonizzatori e colonizzati, tra centri che prosperano e periferie che danno sangue e lavoro per quella prosperità, nel segno del dominio territoriale, economico, culturale, antropologico, psichico.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: 75° dello sbarco in Normandia
75° dello sbarco in Normandia
"L’un popolo e l’altro sul collo vi sta"
di Fulvio Grimaldi
Vittorie, liberazioni, processi
Nei giorni scorsi, in Normandia, rianimando un po’ di vecchietti scampati al pianificato massacro e ciononostante belli giulivi, con in testa il basco e sul petto la spilletta di reduce, hanno iniziato alla grande a scassarci quanto è particolarmente caro a noi e prezioso alla continuità della specie minacciata. E diabolicamente persevereranno quando, dallo sbarco, l’anno prossimo, passeranno al settantacinquesimo della “vittoria”. Da noi, in mancanza di quella, si blatererà di “Liberazione”, che è come dire bravo a chi ha raso al suolo Montecassino. Indi, un altro anno, ottobre 1946, fanfare, piatti e timpani per la celebrazione del primo processo chiamato “Giustizia”, inflitto dal vincitore al vinto, dal bene assoluto al, per antonomasia, “male assoluto”.
Da lì in poi, come sappiamo, non passa anno che non vi sia occasione per celebrare la ricorrenza di un qualche glorioso effetto della “vittoria”. Tipo l’UE, con concomitante fine di un’obsoleta forma di democrazia costituzionale antifascista e della pericolosamente nazionalista autodeterminazione dei popoli; tipo Nato, che ci permette di diffondere i suddetti principi a un universo mondo preda di fobie anti-occidentali; tipo mercato, addetto a una più felice distribuzione della ricchezza, come già sperimentata in forme meno radicali nella migliori tradizioni della civiltà umana: feudali, imperiali, coloniali. E non ci sarà celebrazione nella quale non si onorerà anche il magistero della Chiesa, sempre e comunque patrocinatrice di ogni forma di processo che irrobustisca i forti e nobili.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Di Maio e la giravolta liberista del M5S
Di Maio e la giravolta liberista del M5S
di Carlo Formenti
Sulle pagine di Economia del Corriere dell’8 Giugno, leggo la seguente dichiarazione di Luigi Di Maio in merito al fallimento della trattativa fra Fca e Renault, a seguito dell’intervento dello Stato francese che detiene il 15% del pacchetto azionario di Renault: “è l’interventismo di Stato che ha provocato il fallimento dell’operazione. La Francia non ha fatto bella figura, noi anche se in contatto con Fca, abbiamo rispettato un’operazione di mercato. Se si fa mercato non è che interferiscono ministri e presidenti della Repubblica”.
Caro Di Maio qui, a fare brutta figura (per non dire di peggio), non è lo Stato francese, siete tu e lo Stato italiano che tu dovresti rappresentare (che a sua volta dovrebbe rappresentare gli interessi del Paese). Da quando ti hanno consegnato le chiavi dell’M5S, questo movimento, che inizialmente aveva assunto – almeno a parole – posizioni antiliberiste ed antieuropeiste, e aveva manifestato l’intenzione di tutelare gli interessi delle classi subalterne, ha compiuto una svolta di centottanta gradi, cercando di ottenere il consenso di Confindustria e delle grandi imprese, adottando senza riserve il punto di vista liberista in economia e mostrandosi sempre più acquiescente ai diktat della Ue.
Così la Francia – che assieme alla Germania può permettersi sia di dettare le regole agli altri Paesi dell’Unione, sia di prevedere per sé le opportune eccezioni alle stesse regole – fa pesare i propri rapporti di forza per tutelare i livelli di occupazione dei lavoratori francesi.
Leggi tutto
Nicolai Caiazza: Ruanda

Ruanda
di Nicolai Caiazza
Gli avvenimenti in Ruanda, i processi di genocidio e le implicazioni di lotta economica, di scontri geopolitici e etnici sono tuttora oggetto di scontri diplomatici, di interferenze, di comportamenti opportunistici della “comunita’ internazionale”, cioe’ dei paesi al vertice della gerarchia imperialista.
“In Praise of Blood” (Il valore del sangue) e’ un libro-inchiesta della giornalista Judi Rever, edito in Canada nel 2018 e tradotto in varie lingue (non ancora in italiano). Consiste nella compilazione di una vasta documentazione del secondo genocidio, quello eseguito da parte della frazione comandata dai Tutsi e avendo come vittime gli Hutu. Si tratta del proseguimento del genocidio con parti questa volta invertite. Dalla documentazione raccolta dell’A. risulta un quadro di complicita’, a volte diretta, a volte implicita da parte delle potenze direttamente coinvolte negli interessi di saccheggio delle ricchezze minerarie del Congo oltre a quelli di dominio geopolitico della regione centro-africana.
Il processo di lotta in Ruanda e’ combinato a quello che portera’ alla destituzione di Mobutu in Zaire e all’ insediamento al governo di Kabila (che ripristinera’ il precedente nome di Congo). Nel 1997, dice l’ A. citando un diplomatico, “il problema dello Zaire e’ che tutti sanno che il regime di Mobutu cadra’, ma nessuno sapeva quando. Adesso lui e’ via e c’ e’ un regime legittimo dal punto di vista degli americani.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Agnulus Dei
Agnulus Dei
di Andrea Zhok
Ieri, servizio sulla BBC. Titolo: "Cinque adolescenti che hanno cambiato il mondo" ("Five teens who changed the world").
Vi si narra la moderna epopea di Greta Thunberg (impegnata contro il cambiamento climatico), Malala Yousafzai (eroina dell'emancipazione femminile antitalebana), Emma González (sopravvissuta di una sparatoria scolastica USA e attivista per il controllo delle armi da fuoco), Jack Andraka (inventore di un test medico in una fiera americana per piccoli inventori), Amika George (sostenitrice del diritto per le meno abbienti ad avere assorbenti gratis).
Questa carrellata di 'nuovi eroi', al netto di qualche involontario effetto comico nella giustapposizione un po' impari dei casi, risulta assai illuminante. Essa ci mostra una forma significativa con cui l'apparato mediatico dell'occidente industrializzato tutela gli interessi dei ceti che firmano i loro assegni.
Ogni questione intorno al valore umano o alla reale eccezionalità dei suddetti ragazzi va subito messa da parte. Può ben darsi che i giovani in questione siano tutti persone meravigliose, capaci e virtuose. Non sono loro qui i protagonisti.
Ciò che conta è il tipo di modello umano che viene così proposto al grande pubblico.
Quattro sono i punti da sottolineare, che possiamo elencare come segue.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3823
Hits 3779
Hits 3402
Hits 2971
Hits 2849
Hits 2709
Hits 2565
Hits 2258
Hits 2155
Hits 2016
tonino

Giordano Sivini: La centralizzazione del capitale e la caduta del saggio di profitto
La centralizzazione del capitale e la caduta del saggio di profitto
di Giordano Sivini
Il peso del capitale fittizio a partire dalle evidenze empiriche del Mckinsey Global Institute 14/6/2019
 L’economia mainstream considera il
sistema finanziario come creatore di ricchezza. Stavros
Mayroudeas, economista
greco, osserva che anche una parte degli economisti marxisti
sono contagiati da questa tesi, e che il contagio viene
espresso con molte sfumature
slegando il profitto dal rapporto con la valorizzazione. “La
tesi di base è che il capitalismo moderno ha subito una
trasformazione
radicale negli ultimi trent’anni. Il sistema finanziario,
attraverso una serie di meccanismi innovativi, ha conquistato
le posizioni di comando
del capitalismo. È diventato indipendente dal capitale
produttivo ed ha trasformato l’intero sistema secondo le
proprie logiche”[1].
L’economia mainstream considera il
sistema finanziario come creatore di ricchezza. Stavros
Mayroudeas, economista
greco, osserva che anche una parte degli economisti marxisti
sono contagiati da questa tesi, e che il contagio viene
espresso con molte sfumature
slegando il profitto dal rapporto con la valorizzazione. “La
tesi di base è che il capitalismo moderno ha subito una
trasformazione
radicale negli ultimi trent’anni. Il sistema finanziario,
attraverso una serie di meccanismi innovativi, ha conquistato
le posizioni di comando
del capitalismo. È diventato indipendente dal capitale
produttivo ed ha trasformato l’intero sistema secondo le
proprie logiche”[1].
Questa tesi porta a concentrare l’analisi sul rapporto D-D’, dimenticando che, in qualsiasi interpretazione che si richiami al marxismo, il capitalismo non può che essere identificato con la produzione di plusvalore, risultato della relazione D-M-D’. La centralità dei processi di valorizzazione è essenziale, sia quando si intende, con Harvey, che il capitale si trasforma indefinitamente, sia quando, a partire da Kurz, si sostiene che si è arrestata la sua capacità di produrre valore. Da qui muove l'interpretazione del passaggio dalla valorizzazione alla finanziarizzazione come risultato di una crisi del capitale produttivo di merce che provoca l’inversione del suo rapporto con il capitale produttivo di interesse. Questo, non potendo accrescersi nel circuito D-M-D’, si riversa su D-D’ e produce capitale fittizio[2].
L’attuale inversione non è riconducibile alla teoria delle crisi segnate da temporanee inversioni nelle quali il credito contribuisce a riattivare il movimento di un capitale che continuamente si ridefinisce. Fino a quando di questa riattivazione non emergono almeno i sintomi, non si può scartare l’ipotesi che la crisi attuale vada collocata nella fase terminale del tempo lungo della caduta del tasso di profitto, una volta esaurita la capacità del capitale di produrre controtendenze.
A stimolare una riflessione in proposito arrivano i dati di un rapporto del McKinsey Global Institute (MGI)[3], multinazionale di consulenza manageriale che monitora il movimento del capitale globale. Presenta i risultati economici comparati delle più grandi società madri del mondo nel 2014-16 e nel 1995-97.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Golunov, giornalista russo, martire. Assange, Assa… chi? .....
Golunov, giornalista russo, martire. Assange, Assa… chi? .....
di Fulvio Grimaldi
Loro devono sapere tutto di noi, noi niente di loro. La “Polizia del Pensiero” settant’anni dopo Orwell
 Per capire
chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso
criticare”(Voltaire)
Per capire
chi vi comanda basta scoprire chi non vi è permesso
criticare”(Voltaire)
Una premessa non del tutto fuori tema
Si succedono i momenti di sconforto-sconcerto davanti a un “capo politico”, bravo ragazzo di provincia, sveglio, a suo modo geniale, onesto per carità, buona parlantina (anche perché di fronte gli capitano nullità fuffarole), ma incolto sul piano generale e specifico e quindi portato a scopiazzare dal tema degli altri, magari da uno più ignorante di lui. Ieri, invece, addiritturanel boudoir di Lilli Bilderberg Gruber, ho vissuto un’impennata di orgoglio e soddisfazione. C’era la solita combine dei tre pitbull, tra femmina e maschi,riuniti a sbranare qualunque ospite 5Stelle, o non conforme a coloro che in Bilderberg, in Quirinale e in Vaticano, fissano la dicotomia Bene-Male. Una trasmissione di gossipari, modello tabloid, con quesiti filosofici alla “chi butteresti dalla torre?” “Da uno a 10 quanto valuti Salvini?”.Stavolta, a dar man destra alla Gruber, che si raggrinza oltre la benevolenza delle luci spiananti quando ha di fronte un governativo del momento, c’era il debenedettiano Marco Da Milano, della coppia comica Zoro-Da Milano di “Propaganda Live”, che, collateralmente, dirige anche “L’Espresso”.
Morra, pane per i denti di Gruber
Di solito quella combinazione democratica del 3 a 1 risolve la partita per superiorità numerica. Ma stavolta ai nanetti da giardino si contrapponeva un gigante, Nicola Morra, 5Stelle delle origini, senatore, oggi un po’ in disparte come altri della nobile schiatta, ma inflessibile combattente a capo dell’Antimafia parlamentare. Morra insegna, sa di lettere, storia e filosofia e contro tale roccia di competenza, sicurezza, sorridente ed elegante imperturbabilità le punzecchiature velenose finivano come graffi sul marmo. Rivedetevelo quell’Otto e Mezzo, è ancora meglio del video dell’altra volta, in cui la Fraulein perdeva le staffe davanti a chi aveva menzionato Soros, grande timoniere e ufficiale pagatore delle Ong di mare e di terra.
Leggi tutto
Isabella Weber: Alle origini delle riforme economiche cinesi
Alle origini delle riforme economiche cinesi
Raffaele Danna intervista Isabella Weber
 Isabella Weber è Lecturer in
Economics alla
University of London, dove è anche Principal Investigator
del progetto “What drives specialisation? A century of
global export
patterns”. Si occupa in particolare di politica economica
cinese e storia del pensiero economico.
Isabella Weber è Lecturer in
Economics alla
University of London, dove è anche Principal Investigator
del progetto “What drives specialisation? A century of
global export
patterns”. Si occupa in particolare di politica economica
cinese e storia del pensiero economico.
Questa intervista, a cura di Raffaele Danna, è nata in occasione di una presentazione di Isabella Weber al Research Network “The Politics of Economics”, organizzato, insieme ad altri, da Danna. Arianna Papalia ha contribuito alla formulazione delle domande e ha curato la traduzione italiana dell’intervista, qui la versione originale in lingua inglese. I temi affrontati in questo testo sono presentati in modo approfondito nel primo libro di Isabella Weber, in attesa di pubblicazione con Routledge.
* * * *
Qual è il ruolo della memoria della lunga storia cinese, così come dell’influenza occidentale, nella costruzione e nella narrazione della riforma cinese?
Isabella Weber: In realtà, non solo alla fine degli anni ‘70, ma ancora oggi, la lunga storia cinese è un tema ricorrente nei discorsi dei leader di Partito e degli intellettuali, soprattutto in un anno come il 2019 che celebra il settantesimo anniversario dalla fondazione della Repubblica Popolare Cinese. Ma anche al di là degli importanti anniversari politici, la storia è parte integrante del ragionamento politico cinese. Per esempio, durante il discorso che Xi Jinping ha tenuto alla sede UNESCO nel 2014, il presidente ha affermato: “Per ogni paese nel mondo, il passato porta con sé le chiavi del presente, e il presente affonda le sue radici nel passato. Soltanto sapendo da dove viene un paese è possibile capire quello che rappresenta oggi, e soltanto allora intuire verso quale direzione si dirige”. Fino ad oggi c’è stato un chiaro e costante riferimento a diversi aspetti e periodi della storia della Cina, anche per quanto riguarda le questioni di politica economica. Gli anni ‘70 furono un momento in cui gli intellettuali e i leader politici aprirono le loro menti al “mondo esterno” – come piaceva sostenere a Deng Xiaoping.
Leggi tutto
Guido Salerno Aletta: C’è confusione al gran ballo di Bruxelles
C’è confusione al gran ballo di Bruxelles
di Guido Salerno Aletta
“Ci hanno dato gli otto giorni”… Quando i rapporti di lavoro erano un po’ meno schiavistici di oggi – ti mandano un sms, al massimo – questa frase significava licenziamento. Se invece gli otto giorni sono dati dalla Commissione Europea a un paese, l’Italia per esser chiari, la questione è parecchio più complessa.
Tutti i giornali mainstream parlano della “procedura di infrazione” che potrebbe essere comminata al nostro paese, ma ben pochi si azzardano a spiegare di che tipo di procedura si tratta e soprattutto cosa comporta. Per non dire del silenzio assoluto sul contesto economico e militare globale in cui questa discussione avviene.
La Commissione chiede immediatamente – entro il prossimo fine settimana, appunto – di sapere in che modo il governo gialloverde intende coprire la differenza tra il deficit a 2,2-2,2 maturato negli ultimi mesi e il 2,04 scritto della “legge di stabilità” approvata a Capodanno. Altrimenti darà l’avvio a una procedura di infrazione per debito pubblico eccessivo.
La sproporzione tra le due cose (uno sforamento dello zero virgola, equivalente al massimo a meno di 3 miliardi, e la messa sotto controllo europeo dei conti pubblici italiani da qui all’eternità per riportare quel 132% a livelli compatibili con i parametri di Maastricht) è talmente evidente, ad occhi esperti, da risultare poco credibile. E’ come sanzionare con la pena di morte il furto di una mela (e c’è gente, in qeusto disperante paese, che non ci troverebbe nulla di strano, ormai…).
Per capirci qualcosa di più abbiamo cercato su molte e diverse fonti, trovando ancora una volta aiuto nell’editoriale di Guido Salerno Aletta su Milano Finanza.
Leggi tutto
Miguel Martinez: Totò e la Fontana Ecosostenibile
Totò e la Fontana Ecosostenibile
di Miguel Martinez
Come avrete notato, va di moda l’ambiente, e persino in Italia, la gente si è messa in testa che bisogna fare qualcosa, se non vogliamo finire tutti nella pattumiera noi stessi.
C’è quindi chi si dedica alle energie alternative…

e chi al riciclaggio:

Insomma, ci sono mille modi per fregare la Seconda Legge della Termodinamica.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Russia-Cina: il vertice che non fa notizia
Russia-Cina: il vertice che non fa notizia
di Manlio Dinucci
L'arte della guerra. Mentre celebravano l'incontro tra Trump e i leader europei della Nato nell’anniversario del D-Day, i grandi media hanno invece ignorato quello, ben più rilevante, svoltosi a Mosca tra i presidenti di Russia e Cina, Vladimir Putin e Xi Jinping
I riflettori mediatici si sono focalizzati il 5 giugno sul presidente Trump e i leader europei della Nato che, nell’anniversario del D-Day, autocelebravano a Portmouth «la pace, libertà e democrazia assicurate in Europa» impegnandosi a «difenderle in qualsiasi momento siano minacciate». Chiaro il riferimento alla Russia.
I grandi media hanno invece ignorato o relegato in secondo piano, a volte con toni sarcastici, l’incontro svoltosi lo stesso giorno a Mosca tra i presidenti di Russia e Cina. Vladimir Putin e Xi Jinping, quasi al trentesimo incontro in sei anni, che hanno presentato non concetti retorici ma una serie di fatti. L’interscambio tra i due paesi, che ha superato l’anno scorso i 100 miliardi di dollari, viene accresciuto da circa 30 nuovi progetti cinesi di investimento in Russia, in particolare nel settore energetico, per un totale di 22 miliardi.
La Russia è divenuta il maggiore esportatore di petrolio in Cina e si prepara a divenirlo anche per il gas naturale: a dicembre entrerà in funzione il grande gasdotto orientale, cui se ne aggiungerà un altro dalla Siberia, più due grossi impianti per l’esportazione di gas naturale liquefatto.
Leggi tutto

Niamey, una città di sabbia
di Mauro Armanino
Niamey, maggio 2019. Non fatevi ingannare dagli edifici a piani e dai cavalcavia dai nomi epici. Niamey è una città immaginata dalla sabbia. Ospiterà tra un paio di mesi l’Assemblea dell’Unione Africana e per questo arrivano in tanti a truccarla da capitale comune. Qualche hotel di lusso, un’università islamica a piani girevoli, snodi stradali che inseguono la direzione e l’ordinanza municipale che impone ai mendicanti di passare all’invisibilità dal primo di maggio. La festa dei lavoratori ha coinciso con la pulizia delle strade, cominciata dagli allievi della Scuola Nazionale della Gendarmeria e poi continuata dai cittadini stranieri suddivisi per nazionalità di provenienza. Alcuni cittadini locali sono assunti ad ore e col ‘gilet- verde-ecologico’, lavorano di notte per liberare le strade dalla sabbia che la mattina seguente rispunta, fresca di giornata, poco lontano. Niamey è in realtà una città di sabbia che passando dai ministeri, aggirando le rotonde e facilitando il digiuno ben prima e ben oltre il mese di Ramadan, si infiamma solo per l’esplosione di una cisterna di benzina. 60 i morti accertati e alcune decine gli ustionati gravi ancora in pericolo di vita. Terminato il lutto nazionale, c’è da giurarlo, sarà ancora la sabbia a coprire le rotaie del treno, anch’esso di sabbia, che mai raggiungerà la città di Dosso con la stazione di arrivo. Solo per attimo, in questa drammatica esplosione, la città reale era apparsa. La città che sopravvive di niente perchè tutto spera dalla clemenza della sabbia divina.
Leggi tutto
Tra impotenza e ricostruzione di una egemonia: la sinistra intellettuale oggi
di Carlo Formenti
La maggior parte degli autori esaminati nel libro di Giorgio Cesarale (A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989, Laterza, 2019), è priva di quella traducibilità politica che oggi serve per reinventare l'opposizione al neoliberismo. All'interno di questo panorama, l'unica via che prepara la ricostruzione del blocco sociale antagonista è quella di Laclau
 Che ne è di una sinistra travolta da quella
mutazione del
capitalismo che, a partire dagli anni Ottanta del secolo
scorso, 1) ha cessato di generare ricchezza per tutti, negando
alla sua controparte sociale
ogni spazio di contrattazione del reddito; 2) ha prodotto
élite dominanti che non si assumono più responsabilità civili,
diversamente dalla vecchia borghesia; 3) ha sostituito
all’universalismo illuminista e dialettico l’universalismo
della ragione liberale;
4) si è intestato i valori del progresso e del riformismo
“scippandoli” all’avversario storico; 5) ha regalato ai
partiti
populisti l’egemonia politica sulle masse; 6) ha svilito la
democrazia, non più associata al dissenso organizzato e di
massa ma al
mero riconoscimento dei diritti umani attribuiti ai singoli
individui?
Che ne è di una sinistra travolta da quella
mutazione del
capitalismo che, a partire dagli anni Ottanta del secolo
scorso, 1) ha cessato di generare ricchezza per tutti, negando
alla sua controparte sociale
ogni spazio di contrattazione del reddito; 2) ha prodotto
élite dominanti che non si assumono più responsabilità civili,
diversamente dalla vecchia borghesia; 3) ha sostituito
all’universalismo illuminista e dialettico l’universalismo
della ragione liberale;
4) si è intestato i valori del progresso e del riformismo
“scippandoli” all’avversario storico; 5) ha regalato ai
partiti
populisti l’egemonia politica sulle masse; 6) ha svilito la
democrazia, non più associata al dissenso organizzato e di
massa ma al
mero riconoscimento dei diritti umani attribuiti ai singoli
individui?
Partendo da tale interrogativo, Giorgio Cesarale costruisce un percorso (“A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989”, Laterza) che, data per scontata l’impotenza delle sinistre tradizionali, incapaci di far fronte alle sfide sopra elencate, tenta di cogliere i sintomi del riemergere di un “pensiero critico” che, liberatosi di categorie, paradigmi e concetti obsoleti, esplora percorsi di emancipazione alternativi. In particolare, nei cinque capitoli del libro, l’autore esamina nell’ordine: le teorie che hanno ridisegnato l’immagine del capitalismo, svelandone i rapporti strategici con una serie di fattori esterni alla sfera dei rapporti produttivi (Wallerstein, Arrighi, Harvey, Streeck, Boltanski); i profeti della morte del potere sovrano e del suo luogo d’elezione, lo stato-nazione (Agamben, Negri); le nuove definizioni filosofiche della soggettività (Badiou, Žižek, Jameson); le vie d’una possibile rianimazione della democrazia (Balibar, Rancière, Laclau); la problematica generata dalla proliferazione delle identità (Butler, Fraser, Spivak).
Il risultato è un’opera difficile da recensire. In primo luogo perché Cesarale, immagino per scrupolo di obiettività (intesa come distacco scientifico dall’oggetto di indagine), limita al minimo lo spazio dedicato ai propri giudizi soggettivi sul pensiero degli autori trattati, il che, se da un lato consente al lettore di appropriarsi autonomamente degli “attrezzi” che ritiene più congeniali al proprio modo di approcciare la realtà, dall’altro non agevola l’individuazione di percorsi trasversali fra autori e campi teorici.
Leggi tutto
Mimmo Cangiano: Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra
Intersezionalità, identità e comunità: a che punto siamo a sinistra
di Mimmo Cangiano
 “... anche quando tutto sembra perduto bisogna
“... anche quando tutto sembra perduto bisogna
mettersi
tranquillamente all’opera
ricominciando
dall’inizio” (Antonio Gramsci)
Identità
Poche settimane fa l’europarlamentare Eleonora Forenza (area di Rifondazione di Potere al Popolo) ha scatenato una piccola bagarre nel minuscolo stagno della sinistra italiana. Forenza ha bollato, su Twitter, la Brexit come “pasticcio di maschi”, non negando una certa solidarietà ‘femminista’ a Theresa May e alla gatta da pelare che i colleghi “maschi” le avrebbero rifilato. L’uscita infelice di Forenza non è cosa nuova (ma preoccupa che venga da una gramsciana). È parte integrante di un certo orientamento della sinistra diritto-civilista e culturalista, cioè di quella sinistra che, pur non escludendo le questioni legate al mondo del lavoro e della produzione, individua ormai nei diritti civili la principale chiave d’intervento sociale e, proprio a causa di tale scelta, si ritrova fatalmente irretita all’interno di un uso distorto del concetto di “identità”. Tale posizionamento (largamente maggioritario anche nel Partito Democratico) è stato spesso già portato a critica. Si è rilevato come si tratti di una soluzione da un lato assolutamente subalterna agli attuali vettori di organizzazione societaria (visto che ci è impossibile intervenire sulla struttura social-lavorativa ci rifugiamo nelle battaglie per i diritti civili e chiamiamo tale spostamento “rivoluzione”, come in una sorta di risarcimento psicologico), dall’altro pericolosa nel suo indiscriminato assegnare (è proprio il caso di Theresa May) patenti di “vittima” a figure sociali che solo mediante il misticismo delle identity politics possono apparire come tali, ché oggi, scriveva Natalia Ginzburg (aprile ’73), nessuno ama “essere nel numero dei privilegiati e tutti desiderano appartenere al numero degli oppressi”.
Si tratta infatti di un approccio che opera su due fronti di pensiero fra loro apparentemente in contraddizione: da un lato si dichiara nullo (anti-essenzialismo) il concetto di “identità” (abbiamo solo identità fluide, liquide, ecc.), dall’altro si ricorre ad un potenziamento di tale concetto, in questo caso il genere, per dare spiegazione ad alcuni fenomeni.
Leggi tutto
Carlo Clericetti: La Germania mal guidata rischia il declino
La Germania mal guidata rischia il declino
di Carlo Clericetti
 Il grafico
è semplicissimo, appena due linee. L’ha pubblicato su Twitter
Christian Odendahl (@OdendahlC.), capo
economista del Centre
for European Reform, accompagnato dalle poche parole
caratteristiche del mezzo. Ma è quanto basta per far capire
l’assurdità della politica economica tedesca, quella che
Berlino e i suoi alleati hanno di fatto imposto a tutta
l’Unione
europea.
Il grafico
è semplicissimo, appena due linee. L’ha pubblicato su Twitter
Christian Odendahl (@OdendahlC.), capo
economista del Centre
for European Reform, accompagnato dalle poche parole
caratteristiche del mezzo. Ma è quanto basta per far capire
l’assurdità della politica economica tedesca, quella che
Berlino e i suoi alleati hanno di fatto imposto a tutta
l’Unione
europea.
Prima di parlare di questo è bene sapere che questo think-tank britannico, nella sua presentazione, si definisce “pro-European but not uncritical”, europeista ma non acritico, considera l’integrazione europea “largely beneficial” ma ritiene che “per molti aspetti l’Unione non funzioni bene”. Ne consegue che le sue intenzioni sono di fare critiche costruttive, questo centro non è un nemico dell’UE.
Ma torniamo al grafico, che mostra gli andamenti dei tassi d’interesse sul Bund, il titolo tedesco a dieci anni, e degli investimenti pubblici in Germania.
“Buongiorno dalla Germania – scrive ironicamente Odendahl – dove siamo pagati per prendere in prestito i soldi eppure i nostri investimenti pubblici sono all’incirca quanti erano dieci anni fa”. Avrebbe potuto dire venti anni fa, e anche aggiungere che ancora prima, nel 1991, quando i tassi sul debito erano quasi al 9%, gli investimenti pubblici erano stati più alti di circa un punto di Pil.
Gli ultimi dati congiunturali della Germania sono pessimi. Ad aprile le produzione industriale è calata dell’1,9% sul mese precedente e dell’1,8% su base annua, ma quella dell’industria in senso stretto (escluse cioè energia e costruzioni) ha segnato un -2,5. La Bundesbank ha tagliato le stime della crescita di un intero punto, dall’1,6 allo 0,6%, riducendo anche quelle per l’anno prossimo. Se per crescere ci si affida solo alle esportazioni, quando succede qualcosa nel resto del mondo – come ora con la guerra dei dazi – si subisce un contraccolpo pesante. Insieme a questi dati arriva infatti anche quello dell’export, calato del 3,7% sul mese precedente.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Il bullismo contro Savona
Il bullismo contro Savona
di Giuseppe Masala*
Trovo davvero sconcertante il tono da bulli da osteria con il quale fanatici europoidi senza alcuna cognizione di economia irridono Paolo Savona per il discorso tenuto oggi alla Consob.
Pietra dello scandalo per i soliti quattro mentecatti ignoranti è la seguente frase: «Se la fiducia nel Paese è solida e la base di risparmio sufficiente, livelli di indebitamento nell’ordine del 200% rispetto al Pil non contrastano con gli obiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica». Ovviamente l'hanno interpretata come l'intento di portare il debito pubblico al 200% rispetto al Pil. Sbagliano naturalmente, non riuscendo ad interpretarla correttamente per assenza della minima cognizione di economia: si, il Professor Savona ha scritto che si può portare il debito anche al 200% per raggiungere gli obbiettivi economici e sociali perseguiti dalla politica (che per inciso dovrebbero essere quelli scritti nella Costituzione) ma se e solo se la base del risparmio è sufficiente per farlo. Ovverosia senza la necessità di impiegare risparmio proveniente dall'estero e conseguentemente destabilizzando altri sistemi finanziari. Un'affermazione del tutto logica e del tutto rispettosa del paradigma degli squilibri (o se preferite degli equilibri) sanciti anche a Bretton Woods oltre che rispettosa dei dettami della nostra Costituzione (che stava a cuore a tutti i nostri grandi economisti a partire da Federico Caffè). Anche l'evidenza storica ed empirica gli dà assolutamente ragione: al mondo abbiamo sistemi paese come l'Argentina che non riescono a reggere un debito pari al 50% del Pil e altri come il Giappone che riescono a reggere tranquillamente un debito pari al 250% del pil.
Leggi tutto
Paul Mason: La fine del neoliberismo sta arrivando
La fine del neoliberismo sta arrivando
Le sue ideologie stanno perdendo ogni significato
di Paul Mason
Pubblichiamo un estratto dall’ultimo saggio di Paul Mason, Il futuro migliore (Il Saggiatore)
La commercializzazione strisciante della cultura, del sesso e del tempo libero è sempre stata insita nella logica del capitalismo. Ma nell’era neoliberista non avveniva più in modo graduale: negli ultimi trent’anni è accaduto qualcosa di inedito alla persona media e all’insieme di idee che mediamente popolavano la testa della gente, qualcosa che ha raggiunto il suo apice durante la frenesia speculativa che ha preceduto il 2008.
L’ideologia, nell’interpretazione dei contestatori del capitalismo, è un insieme di idee che mascherano la realtà. È creata da ciò che vediamo e sentiamo, e rafforzata dal fatto che la classe dirigente controlla il flusso di informazioni.
Così, per esempio, in Unione Sovietica alle persone veniva detto (e se lo dicevano fra loro) che vivevano sotto il «socialismo effettivamente esistente», mentre la realtà era fatta di dittatura, povertà, miseria e disuguaglianza.
Le ideologie, in genere, si definiscono in contrasto con alternative chiare e visibili. Pertanto, dal momento che mascherano una verità più profonda e nascosta, le persone istruite e curiose possono immaginare un modo per sottrarsi alla loro influenza, specie se esiste un contropotere organizzato come il movimento operaio che dice: parti dal presupposto che il tuo capo dice solo cazzate.
Leggi tutto
Mario Tronti: Pensiero, parola, lotta
Pensiero, parola, lotta
di Mario Tronti
Nanni Balestrini. Lo sperimentalismo e le azioni di una figura controcorrente che dava «Istruzione preliminari»
Nella figura di Nanni Balestrini si riassume un’intera stagione di storia e di cultura, italiana ed europea. Fu il tempo degli intellettuali militanti: dentro una temperie di lotte operaie e giovanili che fecero epoca e che segnarono il destino delle successive generazioni.
Fino all’esaurirsi di quella spinta di liberazione sotto i colpi di una feroce vendetta di sistema. Il grido disperato di Nanni, a riflusso appena avviato, che si legge ne Gli invisibili:«non è possibile che fuori non c’è più nessuno…. dove siete mi sentite non sento non vi sento non sento più niente», segnerà poi il seguito del tempo che è arrivato stancamente fino a noi e ancora oggi più crudamente ci opprime.
E in Istruzioni preliminari, la poesia che lesse a cinquant’anni dal 68, solo in apertura riparte da quel grido: «Il nostro mondo sta scomparendo/i tramonti succedono ai tramonti/…. le vecchie certezze se ne vanno/in una realtà caotica ostile immensa». Perché in chiusura lancia, all’opposto, una indicazione, una istruzione appunto, preliminare: «contro l’abuso la convenzione lo svuotamento di senso/non più dominanti e dominati ma forza contro forza/…. l’attacco va minuziosamente preparato/secondo una prospettiva rivoluzionaria».
Ecco, dopo tutto ciò che da allora è stato, dopo le repliche della cronaca più che della storia, quella figura di intellettuale militante, che Nanni rappresentava, non ha marcato abiure semmai conferme, non pentimenti semmai approfondimenti.
Leggi tutto
Eros Barone: Il più grande filosofo del Novecento

Il più grande filosofo del Novecento
di Eros Barone
Una teoria è tanto più convincente quanto più semplici sono le sue premesse, quanto più varie sono le cose che essa collega, quanto più esteso è il suo campo di applicazione.
Albert Einstein
Se quella di ‘classico’ non si riduce ad essere la qualificazione che mèrita soltanto chi è vissuto in un’epoca più o meno lontana dal presente, ma è innanzitutto la nota distintiva che designa una di quelle persone che, nascendo e svolgendosi, hanno conseguito un’altezza non effimera nel campo della grandezza umana, allora non vi è dubbio che Albert Einstein faccia parte della schiera dei ‘classici’, mentre è da escludere che la relativa vicinanza nel tempo possa generare un errore di prospettiva nella nostra valutazione.
Ma vi è di più: Einstein infatti, a distanza di oltre un secolo da quel 1905, ‘annus mirabilis’ in cui furono pubblicati i suoi primi rivoluzionari lavori sui moti browniani, sull’effetto fotoelettrico e sulla teoria della relatività ristretta, è da considerare ‘pleno jure’ non solo una straordinaria figura di scienziato, ma altresì come il più grande filosofo del Novecento.
Leggi tutto
Hits 3841
Hits 3795
Hits 3455
Hits 2981
Hits 2857
Hits 2718
Hits 2580
Hits 2301
Hits 2171
Hits 2045
tonino

Carlo Galli: Interventi su Machiavelli
Interventi su Machiavelli
di Carlo Galli
* * * *
 Non ci resta che Machiavelli
Non ci resta che Machiavelli
Che sia stato il consigliere del Male (Old Nick, il vecchio Nicolò, era il diavolo), oppure l’eroico suscitatore di energie politiche nazionali o sociali (da De Sanctis a Gramsci), Machiavelli ha scoperto il campo della politica moderna come un magma ribollente di energie e di sfide, di crisi e di catastrofi. Dopo la sua morte, nel 1527, che coincide con il tracollo del sistema politico italiano, il conflitto per l’egemonia europea tra Francia, Spagna e Impero diviene un susseguirsi di guerre di religione da cui l’Europa inizierà a uscire solo alla metà del XVII secolo. La via dell’ordine sarà allora il razionalismo individualistico, la teoria del contratto, la politica dei diritti e della rappresentanza, la sovranità dello Stato nazionale. Sarà il liberalismo, la democrazia, il socialismo. E il pensiero adeguato a questo sforzo di ordine sarà, oltre alla filosofia costruttiva dell’illuminismo, quella progressiva e rivoluzionaria del marxismo, e, più vicino a noi, la scienza politica, capace di misurare e catalogare le istituzioni, i partiti, i sindacati, la partecipazione; di decifrare il funzionamento dei rapporti tra pubblico, sociale, privato; di studiare i nessi fra economia, psicologia di massa, politica.
È questo ordine liberale del mondo a essere oggi in crisi, con le sue certezze, le sue ideologie, le sue previsioni. Tramontata la filosofia dialettica della rivoluzione e del progresso, anche il pensiero liberale e democratico ha sempre meno presa sugli sviluppi reali della contemporaneità. La scienza politica, poi, è più a suo agio davanti ai normali processi delle istituzioni democratiche che non nella fase della loro crisi.
Sta qui il vero significato dell’attenzione a Machiavelli, oggi. Con lui e attraverso di lui si retrocede al momento magmatico in cui la politica moderna si è presentata in tutta la sua potenza, prima che prendessero forma le soluzioni ordinative che hanno costituito l’ossatura della storia degli ultimi trecento anni, e che oggi vacillano.
Leggi tutto
Per una teoria materialistica dell’errore, degli opposti e della soggettivitàEros Barone:

Per una teoria materialistica dell’errore, degli opposti e della soggettività
di Eros Barone
 Parvus error in principio magnus est in
fine.
Parvus error in principio magnus est in
fine.
Tommaso di Aquino, De ente et essentia.
Io fui già di opinione di non vedere, col pensare assai, più di quello che io vedessi presto; ma con la esperienza ho cognosciuto essere falsissimo: per che fatevi beffe di chi dice altrimenti. Quanto più si pensano le cose tanto più si intendono e fanno meglio.
Francesco Guicciardini, Ricordi.
-
“Errare humanum est”
Nell’introdurre un problema schiettamente dialettico, qual è quello dell’errore, conviene senz’altro premettere una sintetica esposizione del modo in cui tale problema è stato affrontato e risolto nel corso della storia del pensiero filosofico. La distinzione concettuale da cui è opportuno prendere le mosse è quella tra errore pratico ed errore teoretico. Tralasciando il primo tipo di errore, a cui sarà riservata essenzialmente la trattazione svolta in questo scritto, va preso in considerazione il secondo tipo, cioè l’errore teoretico, che consiste nel ritenere vera una proposizione falsa o falsa una proposizione vera, laddove questo tipo di errore concerne l’assenso che viene dato al giudizio e collega, quindi la volontà e l’intelletto. 1
La filosofia greca, ispirandosi prevalentemente all’identità, posta da Socrate, tra scienza e virtù, ha in generale identificato l’errore etico e quello teoretico, talché nessuno erra volontariamente, poiché, come afferma Platone, la conoscenza della verità è la condizione della felicità individuale (cfr. Gorgia ed Eutidemo). Fondamentale nella storia del pensiero dialettico, oltre che nella ricerca filosofica sulla genesi dell’errore, sarà poi, in polemica sia con la scuola eleatica che affermava l’impossibilità di dire e di pensare ciò che non è, sia con i sofisti che riducevano il vero e il falso a un effetto dell’arte retorica, la scoperta platonica del concetto di “non essere” (o differenza) in senso relativo, che sta al centro del Teeteto e del Sofista.
Dal canto loro, Aristotele e le scuole filosofiche dell’età ellenistica, fra le quali per l’acume e la profondità manifestate nell’analisi della questione dell’errore merita di essere citato lo scetticismo, imposteranno tale questione collegandola prevalentemente con il problema se siano i sensi o l’intelletto (oppure entrambi, secondo quanto dimostrato nei tropi scettici) 2 a determinare giudizi falsi.
Leggi tutto
Boaventura Antunes: La fine della «società del lavoro» e della «società del denaro»
La fine della «società del lavoro» e della «società del denaro»
di Boaventura Antunes
Introduzione al dibattito sul libro di Yuval Noah Harari, "Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità"
 Buona sera a tutte le persone
presenti. Prima di passare alla discussione circa le idee che
si trovano alla base del libro di Harari,
vorrei introdurre il tema. In tre parti. Per primo, una breve
presentazione dell'autore. In secondo luogo, quelle che sono
le linee essenziali
dell'opera. E, per finire, un abbozzo di apprezzamento
critico.
Buona sera a tutte le persone
presenti. Prima di passare alla discussione circa le idee che
si trovano alla base del libro di Harari,
vorrei introdurre il tema. In tre parti. Per primo, una breve
presentazione dell'autore. In secondo luogo, quelle che sono
le linee essenziali
dell'opera. E, per finire, un abbozzo di apprezzamento
critico.
Yuval Noah Harari nasce nel 1976 in Israele, nei pressi di Haifa, in una famiglia di ebrei laici con ascendenti in Libano e nell'Europa orientale. Si è sposato a Toronto, in Canada, in quanto in Israele non è possibile sposarsi con una persona dello stesso sesso, sebbene poi lo Stato riconosca questi matrimoni che sono avvenuti all'estero. Vive insieme al marito nei pressi di Gerusalemme in un "Moshav" (comunità agricola e residenziale simile al Kibbutz, ma che ammette la proprietà privata della terra, in lotti uguali). Egli ritiene che il suo orientamento sessuale minoritario possa averlo aiutato a mettere in discussione le conoscenze e le idee circa la vita, il mondo e l'umanità che vengono date per scontate. Pratica la "Vipassana", medita due ore al giorno e compie un ritiro annuale di almeno un mese l'anno. Ha aderito al veganesimo, asserisce, in virtù dei suoi studi sui maltrattamenti inflitti dagli esseri umani agli animali. Dal mese di gennaio di quest'anno ha deciso di fare a meno dello smartphone. Del marito, e suo manager, dice che è il suo «Internet di tutte le cose».
Avendo iniziato i suoi studi di storia specializzandosi in storia militare e in storia medievale, si è poi dedicato alla storia mondiale ed ai processi di Macrostoria [N.d.T.: Per macrostoria si intende il lavoro di storiografia che analizza gli avvenimenti storici prendendo in considerazione gli elementi di un contesto più ampio, come l'ambiente geografico, l'economia, le ideologie e la cultura]. Ha conseguito il dottorato ad Oxford, ed è attualmente professore nell'Università Ebraica di Gerusalemme. Il suo libro "Sapiens. Da animali a dèi. Breve storia dell'umanità" ha avuto un seguito in "Homo Deus. Breve storia del futuro" ed in "21 lezioni per il XXI secolo" [N.d.T.: tutti editi in Italia da Bompiani].
Leggi tutto
coniarerivolta: Delocalizzare nuoce gravemente alla salute (dei lavoratori)
Delocalizzare nuoce gravemente alla salute (dei lavoratori)
di coniarerivolta
Nei giorni scorsi, la multinazionale Unilever ha aperto le procedure di licenziamento di 76 lavoratori dello stabilimento di Sanguinetto, in provincia di Verona. L’azienda ha deciso di delocalizzare la produzione del dado Knorr, che precedentemente aveva luogo in quello stabilimento, in Portogallo. Negli stessi giorni la Whirlpool, multinazionale statunitense di elettrodomestici ha dichiarato di voler lasciare gli stabilimenti di Napoli per delocalizzare in Polonia lasciando per strada oltre 400 lavoratori! Queste notizie drammatiche hanno acceso i riflettori su un fenomeno, quello delle delocalizzazioni, sempre di più all’ordine del giorno. Per capire le ragioni per cui avvengono le delocalizzazioni, dobbiamo andare al di là della retorica neoliberista, in base alla quale il fenomeno in questione, fornendo un incentivo per i policy-maker affinché ammodernino le proprie economie, sarebbe senz’altro salutare. In realtà, come vedremo, le delocalizzazioni non sono altro che uno degli strumenti attraverso i quali si esercita lo sfruttamento non solo dei lavoratori, ma anche dell’ambiente.
Ma facciamo un passo indietro e chiediamoci in cosa consista una delocalizzazione. Con questo termine si designa il fenomeno per il quale le imprese di un determinato paese trasferiscono la produzione, o parti di essa, in un altro paese al fine di trarne un vantaggio.
Leggi tutto
Ennio Abate: Negri su Balestrini
Negri su Balestrini
di Ennio Abate
Su “il manifesto” dell’8 giugno 2019 (qui) è comparso un ricordo di Nanni Balestrini scritto da Antonio Negri. L’ho letto, riletto, meditato e ho scritto questi appunti critici. [E.A.]
1. Non capisco come possa aver fatto Balestrini a lasciare nel suo lavoro di poeta «l’anima accanto, fuori dalla poesia». Non ci riuscirono i futuristi e penso che – ad indagare a fondo i suoi testi – non sia riuscito neppure lui.
2. Né afferro come abbia potuto anche essere « produttore di riviste politiche» senza che ci fosse «un bisticcio fra Nanni e i responsabili di un qualsiasi lavoro politico che lui avesse nelle sue mani di editore». Sarebbe qualcosa di miracoloso. Non chiedo prove. Ma resto stupefatto. Perché, pur avendo – io e tanti altri che conosco – desiderato e tentato negli ultimi decenni (dagli ’80 in poi) di fare riviste “cooperanti”, non ci siamo riusciti. Non voglio cercare maliziosamente il pelo nell’uovo (la «generosità» di Balestrini, l’ottima collaborazione tra lui e Negri. E altri pure). Chiedo solo una spiegazione accettabile del “miracolo”.
3. Cos’è la benedetta/maledetta «cultura sovversiva»? A me pare manifestazione di nicchia, rispettabile e da praticare senza retorica; e però, se non da tutti tollerata, abbastanza sopportata dai potenti e loro funzionari, perché in buona parte resta “nei limiti” e finisce per lustrare il “pluralismo democratico”.
Leggi tutto
Giacomo Bottos: Il ruolo dell’Italia: a confronto con Romano Prodi e Lucio Caracciolo
Il ruolo dell’Italia: a confronto con Romano Prodi e Lucio Caracciolo
di Giacomo Bottos
Riproponiamo il testo dell’intervento del direttore di Pandora Rivista Giacomo Bottos nell’ambito dell’iniziativa “Il posto dell’Italia nell’(anti)Europa”, presentazione congiunta del numero 7 (“Italia”) di Pandora Rivista e del numero 4/2019 (“Antieuropa. L’impero europeo dell’America”) di Limes, rivista italiana di geopolitica, ospitata dalla biblioteca dell’Archiginnasio di Bologna e a cui hanno partecipato Romano Prodi e Lucio Caracciolo con la moderazione di Federico Petroni
Questa discussione affronta temi cruciali e molto dibattuti come il ruolo dell’Italia e il suo posto in Europa. Vorremmo però provare a darle un taglio e una direzione coerente con l’impostazione alla quale, come rivista Pandora, abbiamo sempre cercato di tenere fede. Il nostro intento è sempre stato quello di trattare temi – di carattere economico, sociale, geopolitico, storico-filosofico – che hanno certamente una grande rilevanza politica, ma di farlo senza mai aderire completamente all’attualità e alla contingenza. E questo per una scelta precisa, che deriva dalla convinzione che oggi spesso manchino in Italia i luoghi e le forme in cui possa avvenire una riflessione di medio e lungo termine sulle grandi questioni e sulle priorità da affrontare.
Sembra spesso mancare una consapevolezza, un accordo, su quali siano le priorità del Paese nel medio e nel lungo periodo, in un orizzonte che vada oltre la prossima scadenza elettorale. Questo è proprio uno dei temi su abbiamo avuto il piacere di confrontarci con Lucio Caracciolo, nell’intervista che apre il numero 7 di Pandora, dedicato appunto all’Italia.
Leggi tutto
Bruno Guigue: Democrazia genocida
Democrazia genocida
di Bruno Guigue* | afrique-asie.fr
Esprimendosi dinanzi ai diplomati dell'accademia militare di West Point, il vicepresidente americano Mike Pence ha annunciato loro che presto si dovranno battere "contro i terroristi, in Afghanistan e in Iraq" , ma anche "contro la Corea del Nord che continua a minacciare la pace", "contro la Cina che sfida la nostra presenza nella regione" e "contro la Russia aggressiva, che cerca di ridefinire le frontiere con la forza". In altre parole, il sig. Pence parla come se gli stati sovrani citati nella sua dichiarazione avessero qualcosa in comune con le organizzazioni criminali che Washington afferma combattere incessantemente dagli attentati dell'11 settembre 2001. Un'amalgama stupefacente, una minaccia militare appena velata, l'arroganza di uno Stato che si crede custode a vita di uno imperium planetario, questa dichiarazione accorpa tutti i difetti simbolici dell'ideologia yankee applicata al resto del mondo.
Dal momento che la "nazione eccezionale" vuole combattere tutti coloro che la irritano, sarebbe molto più semplice indicare contro chi non si prevede alcuna azione militare, risparmiando tempo. Daltronde, il mondo non è forse a sua disposizione, oggetto passivo delle sue iniziative salvifiche e dei suoi impulsi purificatori? Come dispensatore di una giustizia immanente adattata a sua misura, la nazione del "destino manifesto" non pone limiti fisici alla sua aura benefica. L'extraterritorialità è la sua seconda natura.
Leggi tutto
Vincenzo Morvillo: Berlinguer, se questo è un comunista
Berlinguer, se questo è un comunista
di Vincenzo Morvillo
 “Ce ne fossero di uomini come
lui! Un comunista vero! Un uomo mai dimenticato!
Ha lasciato un vuoto incolmabile! Un dolore tremendo, la
sua morte! Un comunista equilibrato, che si opponeva al
neofascismo e al centrosinistra! Un
gigante, rispetto ai politici di oggi!”
“Ce ne fossero di uomini come
lui! Un comunista vero! Un uomo mai dimenticato!
Ha lasciato un vuoto incolmabile! Un dolore tremendo, la
sua morte! Un comunista equilibrato, che si opponeva al
neofascismo e al centrosinistra! Un
gigante, rispetto ai politici di oggi!”
Orbene, sono solo alcune delle tante dichiarazioni melense, celebrative, ai limiti dell’agiografia, che, nei giorni scorsi, si sono potute leggere sui social, per ricordare il segretario del Pci, Enrico Berlinguer. Morto l’11 giugno del 1984. Trentacinque anni or sono, dunque.
E tranne l’ultima affermazione, con cui, più o meno, si può concordare (come per tutti i politici dell’epoca rispetto agli attuali), per il resto ci permettiamo di dissentire su tutta la linea.
Berlinguer, infatti, al netto di infantili accenti romantici e malinconici, o di memorie preda di canagliesche nostalgie adolescenziali, fu colui che portò a termine quel lento processo disnaturamento socialdemocratico del Partito Comunista Italiano, cominciato, a dire il vero, già immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, con Palmiro Togliatti.
E lo fece, Berlinguer, sulla pelle della classe operaia e nella maniera più brutale e meschina possibile, per un comunista. Venendo, cioè, a patti con Chiesa e padroni. Patti che presero, com’è noto, l’altisonante nome di Compromesso Storico. Ma anche piegandosi alle ragioni dell’Imperialismo Usa. Ci ricordiamo tutti la dichiarazione sconcertante sull’Ombrello della Nato, alla cui ombra l’Enrico si sarebbe sentito “più sicuro”!
Comunque, non vogliamo nasconderci e ben sappiamo che simili giudizi severi, su un uomo tanto amato, seppur contraddittorio, non sono condivisi da tutti e possono suscitare qualche polemica. Crediamo, tuttavia, che, specie in questi anni così complicati per la sinistra e il movimento comunista tutto, ci sia bisogno di fare chiarezza. Di essere divisivi, almeno nella memoria. Non unitari. Schiettamente e anche duramente divisivi. Perché, se la sinistra ha imboccato la china di una sconfitta storica che ha, ormai, toccato forse il fondo, lo si deve anche a uomini come Berlinguer. E a quel Pci statolatra e statalista, fattosi, poi, esso stesso Stato. Senza cambiarne una sola virgola.
Leggi tutto
Andrea Fumagalli, Stefano Lucarelli, Elena Musolino, Giulia Rocchi: Il digital labour all’interno dell’economia delle piattaforme
Il digital labour all’interno dell’economia delle piattaforme
Il caso di Facebook
di Andrea Fumagalli, Stefano Lucarelli, Elena Musolino, Giulia Rocchi
La versione originale inglese di questo saggio è stata pubblicata sulla rivista Sustainability, giugno 2018. Effimera.org ringrazia gli autori per la traduzione in italiano del testo
 1. Introduzione
1. Introduzione
Nonostante lo scoppio della bolla Internet alla fine degli anni ’90, la diffusione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) continua a segnare gli anni 2000. Soprattutto negli ultimi anni abbiamo assistito ad una significativa accelerazione tecnologica. Diversi settori sono stati colpiti. Si tratta di industrie che hanno sempre più a che fare con la gestione della vita umana (ad esempio, lo Human Genome Project, iniziato nel 1990 e conclusosi nel 2003, ha aperto enormi spazi nella possibilità di manipolazione della vita individuale e della sua procreazione [1]). Come sottolineato da Robert Boyer “questo tipo di modello di crescita è un’estensione della continua trasformazione che è proseguita a partire dalle potenzialità dell’economia dell’informazione” [2]. Se il paradigma tecnologico dell’ICT ha colpito duramente i livelli occupazionali nell’industria manifatturiera, la nuova ondata biotecnologica rischia di avere effetti ancora maggiori sui settori terziari tradizionali e avanzati, che negli ultimi decenni hanno svolto un ruolo compensativo contro la perdita di posti di lavoro nei settori tradizionali.
Lo sviluppo di algoritmi di seconda generazione [3] permette un processo di automazione senza precedenti nella storia dell’umanità. Applicati alle macchine utensili, attraverso le tecnologie informatiche e le nanotecnologie, sono in grado di trasformarle in strumenti e mezzi di produzione sempre più flessibili e duttili. Gli algoritmi di seconda generazione si differenziano dalla prima generazione per la loro natura cumulativa di auto-apprendimento, configurando così un nuovo rapporto tra uomo e macchina. Infatti, dopo la prima fase di implementazione e creazione, grazie al comportamento umano, sono in grado di operare in una condizione quasi totale di automazione (machine learning). Le tecnologie attuali, tuttavia, non possono operare senza l’accelerazione (rispetto al recente passato) del grado di raccolta e manipolazione di una grandissima quantità di dati in spazi sempre più ristretti e con una velocità sempre maggiore. Già nel 2011, una ricerca del McKinsey Global Institute ha esaminato lo stato dei dati digitali e ha riconosciuto il grande potenziale di valore economico che questi possono creare:
Leggi tutto
Gianluca Pozzoni: Il mondo mistico del Capitale: scienza, critica e rivoluzione in Lucio Colletti
Il mondo mistico del Capitale: scienza, critica e rivoluzione in Lucio Colletti
di Gianluca Pozzoni*
Università degli Studi di Milano -
gianluca...@unimi.it
 1. Introduzione
1. Introduzione
Nel 1984, la University of California Press dava alle stampe il saggio Marxism and Totality di Martin Jay, storico delle idee a Berkeley e già autore di una imprescindibile biografia della Scuola di Francoforte intitolata L’immaginazione dialettica (1973, pubblicata in italiano nel 1979: Jay 1979). In Marxism and Totality, Jay metteva a tema, come dichiarato nel sottotitolo, le avventure di un concetto– quello di «totalità» – da Lukács a Habermas: per l’autore, la centralità di questo concetto all’interno dell’elaborazione teorica costituiva il tratto più distintivo del cosiddetto “marxismo occidentale”. Come notava già Perry Anderson (1979) nel testo che ha dato popolarità al termine[1], il “marxismo occidentale” era rappresentato prevalentemente da esponenti di estrazione borghese – con l’unica eccezione di Gramsci – la cui produzione intellettuale era caratterizzata da un taglio per lo più accademico e non rivolto immediatamente a quella “classe operaia” in cui il marxismo tradizionalmente identificava il potenziale soggetto rivoluzionario[2]. Per Jay, proprio un tale distacco era l’elemento che forniva a questi teorici marxisti la libertà di pensiero e la spregiudicatezza necessarie ad avanzare la pretesa di poter raggiungere un punto di vista complessivo sulla totalità del reale, e sulla società in primis.
Ciò che a prima vista può stupire del testo di Jay è l’inclusione nella sua rassegna di un capitolo interamente dedicato a quello che viene definito marxismo scientifico dell’Italia postbellica, ossia alla rielaborazione originale dei fondamenti della teoria marxista fornita da Galvano Della Volpe e dal suo allievo Lucio Colletti (cfr. Jay 1984, 423-461). Per quanto riguarda il secondo, in particolare, l’inclusione stessa nel campo del “marxismo occidentale” è resa immediatamente problematica dalla critica esplicita che Colletti muove a questa tradizione, considerata affine più che alternativa al “marxismo orientale” in virtù di una comune – e aborrita – ascendenza hegeliana. Nella seconda parte de Il marxismo e Hegel (1969) si legge infatti a proposito di Lukács:
Leggi tutto
Andrea Zhok: The show must go on
The show must go on
di Andrea Zhok
Ieri al Forum dei banchieri centrali a Sintra, in Portogallo, Mario Draghi ha esternato in modo sibillino, sostenendo che «Se la crisi ci ha insegnato qualcosa è che noi useremo tutta la flessibilità disponibile entro il nostro mandato per rispettare il nostro mandato». E aggiungendo poi che «nelle nostre recenti deliberazioni, i membri del Consiglio direttivo hanno espresso la loro convinzione su come riportare inflazione vicino al 2%. Proprio come il nostro quadro politico si è evoluto nel passato verso nuove sfide, così può farlo di nuovo. Nelle prossime settimane, il Consiglio direttivo delibererà su come i nostri strumenti possano ridurre il rischio di danni alla stabilità dei prezzi».
Si tratta di un discorso fumoso come pochi, in quanto da un lato sembra auspicare una politica espansiva, per superare la perdurante stagnazione, e dall'altro si appella continuamente al target del 2% inflattivo, pura istanza monetarista che vincola le istanze della produzione e dell'occupazione alla stabilità monetaria.
Ma, come in una mirabile commedia degli equivoci è giunto repentino il severo ammonimento da parte di Donald Trump, che, felicemente libero dalla logica come dall'empiria, come gli è proprio, ha tuonato contro Draghi come se quest'ultimo avesse annunciato una guerra valutaria.
Ci sarebbe da ridere, se in questo contesto ai media nazionali non fosse parso vero di poter mettere in scena uno scenario di grande conflitto, dove l'iniziativa anticiclica e popolare di quel tenerone Draghi sarebbe minacciata dal 'sovranista' (?) Trump.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Bravo Savona!
Bravo Savona!
di Leonardo Mazzei
Orrore, orrore! Il debito, il debito, quello pubblico naturalmente! L'Europa ci spezzerà le reni, dopo averlo mussolinianamente fatto con la Grecia! E ben ci starà, perché peccatori siamo!
Ad interrompere almeno per un giorno questa trista litania ci ha pensato un signore di 82 anni, Paolo Savona. Fa un po' specie che per ascoltare, finalmente, alcune note di buon senso sulla questione del debito si debba andare a leggere il discorso tenuto venerdì dal presidente della Consob. L'occasione è stata, pensate un po', l'annuale "incontro con il mercato finanziario". Un titolo che è tutto un programma.
In assenza del mitico "mercato", il parterre era costituito da più concreti banchieri e finanzieri che in quel mercato giornalmente operano. Ed il bello è che questi ultimi, con chiaro disappunto della stampa eurista, non si sono affatto turbati per quel che le loro orecchie hanno udito. Trattandosi di persone "informate dei fatti" la cosa può stupire solo gli ignoranti, una categoria ben rappresentata tra i giornalisti.
Ma cosa ha detto Savona?
In primo luogo, il mancato ministro dell'Economia - sempre ricordarsi dell'abuso compiuto da Mattarella! - ha smontato pezzo dopo pezzo la narrazione sul debito:
Leggi tutto
Andrea Colamedici e Maura Gancitano: Meno resilienza, più resistenza
Meno resilienza, più resistenza
di Andrea Colamedici e Maura Gancitano
Pubblichiamo un pezzo uscito su Linus, che ringraziamo
Ci sono espressioni che entrano nel linguaggio comune e che iniziamo a usare senza domandarci quale sia il loro reale significato e quanto, di conseguenza, ci influenzino. Una delle più diffuse e pervasive è tatuata sul dorso della mano sinistra di Gianluca Vacchi, influencer da dodici milioni di seguaci, poco sotto la scritta Enjoy e subito sopra Prendi in mano la tua vita: è la parola RESILIENZA, considerata dai più come la panacea di ogni male e la via d’uscita perfetta dai nostri tempi oscuri, complessi e faticosi. Bisogna impadronirsi della propria esistenza, non farsi sovrastare dagli avvenimenti, riuscire ad affrontare qualunque situazione spiacevole. Eppure, a guardarla bene, resilienza è la perfetta negazione di questi consigli.
Si tratta, infatti, di un termine mutuato inizialmente dall’ingegneria che ha attraversato la biologia, l’informatica, l’ecologia, la psicologia e che negli ultimi anni è finito con il descrivere la capacità di resistere agli urti, di tornare a se stessi dopo aver vissuto un trauma o una deformazione. Come i metalli che subiscono urti e manipolazioni ma poi tornano uguali a come erano prima, così siamo invitati a fare noi. Come gli Sbullonati, quei pupazzetti degli anni ‘90 ai quali si infliggevano sadicamente crash test e torture terribili, perché tanto tornavano sempre come prima (pezzo più, pezzo meno).
Essere resilienti significa, quindi, aspettare passivamente che le cose spiacevoli passino e che i tempi ridiventino floridi.
Leggi tutto
comidad: Europeisti e sovranisti ignari dei misteri della gerarchia
Europeisti e sovranisti ignari dei misteri della gerarchia
di comidad
Il ministro dello Sviluppo Economico, Luigi Di Maio, forse non ha apprezzato il colpo di fortuna che gli è capitato. Quando il governo francese ha chiesto una pausa di una settimana nella trattativa per la fusione di FCA e Renault, il presidente di FCA, John Elkann, ha invece interrotto clamorosamente la trattativa. Elkann non se ne frega nulla del governo italiano e quindi non si è reso conto del favore che gli stava facendo. In quella settimana di “pausa” chiesta dal governo francese, inevitabilmente Di Maio avrebbe finito per cedere alle pressioni che gli provenivano sia dall’esterno che dall’interno della maggioranza per inserire il governo italiano nella trattativa.
In tal modo il governo francese avrebbe avuto a disposizione un comodo capro espiatorio su cui scaricare il fallimento della trattativa. Ma Di Maio non ha avuto il tempo materiale per commettere quell’errore di ingenuità, perciò si è evitato di essere additato al ludibrio mediatico come colui che aveva fatto sfumare l’affare del secolo, mettendo sul lastrico migliaia di famiglie, eccetera. È vero che un Maurizio Landini ormai irriconoscibile continua tuttora a recriminare sull’assenza del governo nella trattativa, ma si tratta di stoccatine polemiche irrilevanti rispetto alle accuse che avrebbero potuto piovere su Di Maio. Tra l’altro Landini piange sul mancato accordo tra FCA e Renault come se fosse una iattura per i lavoratori: un’affermazione assolutamente non dimostrata e non dimostrabile in base ai dati effettivamente disponibili sull’affare; un’affermazione che dimostra semmai che per i sindacati confederali l’interesse delle multinazionali va identificato dogmaticamente con quello dei lavoratori.
Leggi tutto
Hits 3852
Hits 3806
Hits 3467
Hits 2992
Hits 2864
Hits 2724
Hits 2588
Hits 2319
Hits 2244
Hits 2102
tonino

Sergio Farris: Le asimmetrie della zona euro. Ci vuole più Europa e meno Europa?
Le asimmetrie della zona euro. Ci vuole più Europa e meno Europa?
di Sergio Farris
 Il processo di
aggregazione dei paesi europei è il portato dell’ideologia del
libero mercato, condotta ai suoi
estremi. L’unificazione monetaria rappresenta l’apice di tale
processo.
Il processo di
aggregazione dei paesi europei è il portato dell’ideologia del
libero mercato, condotta ai suoi
estremi. L’unificazione monetaria rappresenta l’apice di tale
processo.
La storia che ha condotto all’euro è una storia tutta incentrata su tentativi di ricostituire un accordo di cambio valutario dopo la cessazione del sistema di Bretton Woods, avvenuta nel 1971. Risiede alla sua base il postulato che – innanzitutto – l’integrazione dei mercati incentivi gli scambi internazionali e rechi vantaggi generalizzati; oltreciò, tale risultato si otterrebbe tramite l’abolizione di fattori di impedimento o di incertezza per gli scambi commerciali e la circolazione finanziaria.
L’euro, in particolare, è il risultato di diverse esigenze, condensate in un compromesso: da un lato la Germania – da sempre titubante per via della propria concentrazione sul pericolo dell’inflazione -, la quale ha acconsentito all’istituzione della moneta unica dopo varie proposte avanzate nei decenni, da parte francese. Pare che, alla fine, la Germania abbia acconsentito all’istituzione della moneta unica con l’occhio rivolto alla possibilità di difendersi dalle svalutazioni competitive dei vicini e, si dice, anche per ottenere il via libera alla riunificazione. Dall’altro lato la Francia, con le sue mire rivolte a contenere il potere del marco e altri paesi – come l’Italia – preoccupati dell’inflazione, dovuta anche alle svalutazioni e alle fluttuazioni dei tassi di cambio (oltre che mossa dalla richiesta padronale di frenare la dinamica salariale).
Ne è emerso un modello fondato sull’esasperazione della concorrenza e sull’ossessione per l’inflazione (i sistemi di cambio valutario fisso hanno infatti – quale costante giustificazione, il timore per l’inflazione e per i presunti danni che l’incertezza derivante dalle oscillazioni del cambio arrecherebbe alle relazioni di mercato).
Nell’ambito del mercato comune è, come si sa, consentito il libero movimento di capitali, lavoro, beni e servizi. La politica monetaria è unica, è cioè valida per l’intera unione.
Leggi tutto
Gioacchino Toni: Nemico (e) immaginario. La morte, l’oblio e lo spettro digitale
Nemico (e) immaginario. La morte, l’oblio e lo spettro digitale
di Gioacchino Toni
 Il sopraggiungere della
morte comporta per ogni essere umano un, più o meno lento,
scivolamento nell’oblio.
Per certi versi ciò che sembra spaventare maggiormente gli
esseri umani, per dirla con Antonio Cavicchia Scalamonti, è
«la morte
in quanto oblio»1 e,
proprio per
differire l’oblio, nel corso del tempo l’umanità ha tentato in
ogni modo di costruire una memoria duratura.
Il sopraggiungere della
morte comporta per ogni essere umano un, più o meno lento,
scivolamento nell’oblio.
Per certi versi ciò che sembra spaventare maggiormente gli
esseri umani, per dirla con Antonio Cavicchia Scalamonti, è
«la morte
in quanto oblio»1 e,
proprio per
differire l’oblio, nel corso del tempo l’umanità ha tentato in
ogni modo di costruire una memoria duratura.
Anche a causa dell’entrata in crisi delle promesse religiose, almeno in Occidente, il rischio di scivolare nell’oblio velocemente pare essere percepito dall’essere umano con crescente inquietudine. Risulta pertanto particolarmente interessante, in una società iperconnessa come l’attuale, interrogarsi circa il significato che assume il concetto di “immortalità” sul web.
Spunti di riflessione su tali questioni, ed in particolare sulla Digital Death, sono offerti da alcuni episodi di Black Mirror (dal 2011), produzione audiovisiva seriale ideata da Charlie Brooker che, scrive Alessandra Santoro nel libro collettivo dedicato alla serie curato da Mario Tirino e Antonio Tramontana,2 con acume e lucidità disarmante sembra «portare iperbolicamente all’esterno le paure, le dissonanze, le ferite aperte e le crepe di un mondo dominato da una crescente deriva tecnologica. Deriva che riflette non tanto una società governata dai media, quanto un futuro distopico e pessimista dominato dagli uomini attraverso i media» (p. 157).
Affrontando nel volume il lemma “Morte”, scrive Santoro: «la cultura digitale, oggi, sembra […] impegnata nel tentativo di mettere in discussione la stasi che deriva dall’interruzione che la morte porta nello scorrere del tempo, e lo fa offrendo la possibilità concreta di accumulare tracce con l’intento di conservare una memoria digitale (o eredità digitale) di quello che siamo stati e, in alcuni casi, si propone di rielaborare l’insieme dei tratti accumulati nel corso dell’esistenza nel tentativo di realizzare una sorta di immortalità digitale: far sopravvivere i defunti sotto forma di “spettro digitale”, fornendo tecnologicamente un’autonomia vivente ai nostri dati, i quali, sottratti dalla sostanza corporea che li animava e incarnando la nostra identità personale, proseguirebbero la vita, in versione digitale, che la morte ha spezzato» (pp. 159-160).
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Simmel e il denaro

Simmel e il denaro
di Salvatore Bravo
 Filosofia e pensiero
radicale
Filosofia e pensiero
radicale
Il pensiero filosofico dev’essere radicale, ovvero deve cogliere il fondamento del movimento fenomenico, solo con tale lavoro concettuale la filosofia raggiunge con lo scandaglio della filosofia la verità immanente della storia. La filosofia per sua disposizione cognitiva è amica della verità: verità eterna nella storia, e verità nella contingenza, nella congiuntura storica in cui gli esseri umano sono situati. La filosofia relativista è una contraddizione epistemologica, perché essa cerca la verità nelle sue espressioni polimorfe, nelle sue forme storiche, la insegue per il orientamento gestaltico di cui l’umanità ha sempre bisogno. La filosofia vive con gli esseri umani, è eterna come la verità, perché gli esseri umani cercano la verità, la abbattano, la fondano, la trascendono, ma l’umanità vive in tensione con la verità, dunque dove vi è filosofia, vi è umanità e verità.
Il mercato come religione dello spavento
L’attuale congiuntura storica caratterizzata dal capitalismo assoluto vorrebbe sostituire la verità e l’esercizio della ragione con il mercato, sostituire la ricerca della verità con la ricerca del mercato e per il mercato significa rompere gli ormeggi con la tradizione, per consegnarsi alla tempesta di un’impossibile navigazione. A tal fine il mercato dev’essere velato dal velo di Maya dell’ignoranza. Si dev’essere servi, e per servire il padrone è necessario renderlo incomprensibile, ipostasi, altare su cui sacrificare il logos e la verità in nome del PIL. L’imperativo categorico del mercato impone di vivere da stranieri-migranti, da creature marginali, servi che adulano il mostro che potrebbe divorarli. Il mercato per velarsi si pone come religione cosmica e pagana: tempo ciclico in cui il futuro è assente, ma l’attimo ritorna eternamente nella forma della quantità come qualità sottratta, e timore reverenziale verso il dio sconosciuto che tutto può ed a cui tutto si deve. La religione dello spavento è la condizione del mercato a briglia sciolta, la deregulation è il ricatto a cui i popoli sono sottoposti.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: La mossa di Khamenei
La mossa di Khamenei
di Pierluigi Fagan
Allora, pare che Trump abbia mandato un messaggio personale da recapitare alla guida suprema del’Iran, via ambasciatori dell’Oman. Gli iraniani hanno fatto sapere di aver trasferito il messaggio al leader e si è in attesa di risposta. Fino ad oggi la risposta alla domanda di Trump “dai ragazzi perché non ci sediamo intorno ad un tavolo a fare due chiacchiere senza impegno?”, è stata negativa. Rimarrà tale?
La situazione, in breve, è questa. Fonti del’amministrazione americana fanno volutamente trapelare al NYT che la pubblica, la notizia che gli americani stavano per bombardare l’Iran in rappresaglia all’abbattimento del drone fantasma. C’è chi come A. Negri, ed io (nel mio piccolo) con lui, non crede affatto a questa storia. E’ palese e banale per chi sa due cose due del funzionamento del potere americano che queste cose avvengono perché si vogliono far avvenire. Infatti Trump ha dovuto avvallare la sceneggiata dicendo “sono stato io a bloccare tutto perché mi sembrava sproporzionato”. Così un po’ Stranamore ed un po’ “cuore d’oro” ostaggio della fazione Deep State – Spectre, con il Pentagono evidentemente pieno di responsabili generali per lo più democratici che dicono “ma siete impazziti? non esistono interventi limitati in quella regione, se si inizia, si va a fondo e lì il fondo è molto profondo”, banale buonsenso che chiunque capisce, per altro.
Leggi tutto
Nicoletta Forcheri: Draghi e i minibot: smontare il sofisma
Draghi e i minibot: smontare il sofisma
di Nicoletta Forcheri
Dire che i “minibot” sono o moneta o debito, è come dire che una donna incinta o è donna o è incinta.
Secondo le stesse definizioni dell’istituto di Draghi,
infatti, tutta la moneta è sia debito sia titolo. La BCE
definisce tutti gli
aggregati monetari come “una passività”, con un grado più o
meno elevato di liquidità secondo il bene sottostante, in
cui si può convertire. Cioè si può tranquillamente affermare,
in linea con quanto affermato dalle autorità monetarie, che
tutta la moneta è sia debito sia titolo. 
Leggi tutto
Moreno Pasquinelli: La profezia di Bagnai e il dilemma sovranista
La profezia di Bagnai e il dilemma sovranista
di Moreno Pasquinelli
Di acqua ne è passata sotto i ponti...
I veterani del sovranismo, siamo in pochi per la verità, si ricorderanno della polemica tra noi e Alberto Bagnai dopo che il nostro, nel gennaio 2013 sottoscrisse il Manifesto di solidarietà europea. Quel Manifesto (firmato col fior fiore di economisti liberisti) sosteneva una tesi fantasmagorica, quella che per salvare la "integrazione europea", occorreva «Un nuovo sistema di coordinamento delle valute europee, volto alla prevenzione di guerre valutarie e di eccessive fluttuazioni dei cambi fra i paesi europei». Concludeva quindi con la proposta di «una segmentazione controllata dell’Eurozona attraverso l’uscita, decisa di comune accordo, dei paesi più competitivi», quindi non dell'Italia badate, bensì proprio della Germania.
Restammo stupefatti dal sodalizio tra un economista che rivendicava fiero il suo keynesismo e incalliti liberisti. Toccò proprio a me — Le divergenze tra il compagno Bagnai e noi — condannare quell'errore, disvelandone le radici. Il nostro ci prese a pesci in faccia bollandoci come Marxisti dell'Illinois. Contro il sottoscritto Bagnai fu spietato:
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Europa senza respiro
Europa senza respiro
di ilsimplicissimus
Non saprei se l’Europa che ci minaccia di procedura d’inflazione per qualche decimale in più di spesa, precisamente lo 0,7 sia più patetica, più assurdamente maligna o più fuori del mondo: ignara del fatto che ci troviamo in una condizione di straordinaria tensione mondiale dopo il golfo del Tonchino 2 messo in piedi da Washington, attraversata da incessanti guerre di lobby, da lotte al coltello per le poltrone e da uno scontro durissimo tra Francia e Germania, non si accorge di imbarcare acqua da tutte le parti e di stare affondando cercando un ossigeno che non c’è più. Di fatto l’eurogruppo delle sanzioni dei giorni scorsi è stato un fallimento come ha detto Wolfgang Munchau, forse il più noto e autorevole editoralista di FT: “L’eurogruppo non manca mai di deludere. Il bilancio della zona euro ora è essenzialmente morto. E non ci sono progressi nemmeno sull’unione bancaria”. La situazione è tale che persino la Spagna di solito ubbidiente nella sua qualità di semicolonia industriale e turistica tedesca, rialza la testa e per bocca della ministra delle finanze di Madrid, Nadia Calvino, dice che se non ci sarà un bilancio di stabilità e anti ciclico, allora dirà no.
Insomma uno spettacolo veramente desolante che da una parte vede all’opera senza alcuna mascheratura i massacratori sociali a mezzo euro e non nasconde più di tanto il fatto che i conflitti nazionali vengano coperti con un falso europeismo.
Leggi tutto
Roberto Finelli: Paradigma della Tecnica e paradigma del Capitale
Paradigma della Tecnica e paradigma del Capitale
Editoriale del n. 6 di Consecutio rerum
di Roberto Finelli*
 Il numero 6 di «Consecutio rerum» è dedicato a
Techne,
Tecnica, Tecnologia, con lo scopo di riaprire un
discorso di antropologia critica sulla nostra
contemporaneità, alla luce della
gigantesca rivoluzione digitale che sta connotando sempre più
il nostro vivere sociale e individuale.
Il numero 6 di «Consecutio rerum» è dedicato a
Techne,
Tecnica, Tecnologia, con lo scopo di riaprire un
discorso di antropologia critica sulla nostra
contemporaneità, alla luce della
gigantesca rivoluzione digitale che sta connotando sempre più
il nostro vivere sociale e individuale.
A proposito di questa tematica va ricordato che alla fine degli anni ’70 del secolo scorso il marxismo e gli studi su Marx scomparvero improvvisamente e improvvidamente dall’ambito degli insegnamenti e delle ricerche universitarie italiane e, di conseguenza, dal dibattito culturale e politico dell’intero paese. Le cause di quella decadenza ed estinzione di quella che era stata una vera e propria Weltanschauung, una organica visione del mondo, nella cui koinè di valori, di linguaggio, di costumi e pratiche, una certa parte, più avanzata e civilmente più impegnata, della popolazione italiana si era riconosciuta, sono state di diversa e complessa natura.
Nel nostro ambito, che è quello di una rivista filosofica, oltre alle insufficienze del marxismo storicistico italiano, che da Antonio Labriola in poi si era voluto troppo autosufficiente e in sé concluso, e dello stalinismo democratico che limitava profondamente il dibattito delle idee nel PCI, vale ricordare due di quelle cause, più propriamente teoretiche e filosofiche: da un lato l’estenuazione della scuola dellavolpiana, insidiata fin dal suo sorgere da una troppo semplicistica riduzione della tradizione dialettica e della filosofia di Hegel a una presunta tematica occultamente religiosa e arcaicamente neoplatonica, e dall’altro, per quello che qui maggiormente c’interessa, dalla repentina sostituzione delle analisi di Marx, sull’organizzazione moderna del lavoro di fabbrica e sulla tecnologia nella sua intrinseca dipendenza dall’accumulazione del Capitale, con la teoria della tecnica, avanzata da Martin Heidegger, come rivelazione e destinazione dell’Essere.
Già l’incapacità di elaborare criticamente i limiti e le aporie della tradizione dialettica aveva spinto buona parte dell’intellettualità di sinistra durante la prima metà degli anni ’70, a gettarsi nelle braccia di L. Althusser, senza avere la chiara consapevolezza di quanto lacanismo ci fosse alle spalle del pensatore francese e senza ben comprendere quanto il processo senza soggetto e la critica strutturalista alla totalità dialettica di L. Althusser implicasse una rinuncia definitiva a intendere il Capitale come Soggetto Unitario della modernità e la sua destinazione strutturale a generare processi di totalitarismo sociale.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Lettera aperta a Roberto Fico, presidente della camera dei deputati
Lettera aperta a Roberto Fico, presidente della camera dei deputati
di Fulvio Grimaldi
 “Se libertà
significa qualcosa, significa il diritto di
dire alla gente ciò che non desidera sentire”(George
Orwell)
“Se libertà
significa qualcosa, significa il diritto di
dire alla gente ciò che non desidera sentire”(George
Orwell)
Caro Presidente Roberto Fico,
Ti scrivo da elettore e sostenitore dei 5 Stelle, sperando nel grado di credibilità che mi potrebbero conferire sessant’anni di professione giornalistica, con oltre 150 processi per reati di stampa in regime democristo-pidino, e che Alessandro Di Battista ha avuto la generosità di accreditare inserendomi in un elenco di “giornalisti liberi”.
Molti, nell’attuale temperie di neolingue e di capovolgimento di molti termini lessicali, ti definiscono “il Cinque Stelle rosso”, quello di sinistra. Credo che, provenendo da fonti che di sinistra sanno quanto un Aglianico del Cilento sa di patata irlandese, o da altre che il rosso hanno iniziato, ere or sono, a confonderlo con l’arcobaleno a stelle e strisce, anche tu nutra qualche riserva sul cappello messoti in capo.
Tanto più che tue parole e tuoi fatti all’origine di quell’abbaglio nei tanti che campano la vita affetti da compulsione ossessiva di sbattere fuori dall’universo mondo il Movimento a cui appartieni, ma salvando te, di sinistro o rosso nel senso incontaminato, museale, del termine, a me pare non abbiano niente. A dispetto del pugno chiuso, oggi spesso simbolo dei golpe striscianti Usa (vedi Otpor).
Rottura tra Camera italiana e Camera egiziana
Paradosso? Forse che sì, forse che no. Vediamo. Il tuo gesto di maggiore risonanza, accanto alla cauta discrezione osservata dai tuoi amici e colleghi, è stata la rottura dei rapporti tra la Camera che presiedi e il parlamento egiziano. Non so se un tale gesto di portata geopolitica spettasse alle tue competenze. Forse, prevaricava opinioni difformi di qualche eletto. In ogni caso spostava da una Camera di eletti, la tua, su un’altra camera di eletti materia di esclusiva attinenza giudiziaria. Cosa c’entrano i deputati egiziani con il caso Regeni, se non in termini puramente pubblicitari e demagogici?
Leggi tutto
Roberto Romano, Vincenzo Comito: Fca-Renault: gli attori palesi e quelli occulti
Fca-Renault: gli attori palesi e quelli occulti
di Roberto Romano, Vincenzo Comito
La creazione di un gigante dell’auto avrebbe favorito un’Europa che rischia ora un grave ridimensionamento economico e politico. Ma oltre ai ritardi tecnologici, all’inazione italiana ammantata di iperliberismo, al nazionalismo autodistruttivo francese, ci sono due attori occulti nell’affare mancato: Stati Uniti e Germania
 La vicenda FCA-Renault
presenta molti aspetti, alcuni dei quali, probabilmente non
dei meno importanti, si
sono forse risolti dietro le scene.
La vicenda FCA-Renault
presenta molti aspetti, alcuni dei quali, probabilmente non
dei meno importanti, si
sono forse risolti dietro le scene.
Qualcuno, come il ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire,ora auspica, o fa finta di auspicare, che FCA e Renault si rimettano di nuovo al tavolo delle trattative, cosa che dal punto di vista economico avrebbe una sua logica, ma che ci sembra un’ipotesi inverosimile, almeno nel breve termine, mentre l’auspicio sembra forse solo servire a mascherare i grossolani fallimenti dello stesso ministro.
Comunque, le due impreseprotagoniste della vicenda hanno a suo tempo sottovalutato,come ha affermato ad esempio il professor Giuseppe Berta (Franchi, 2019), gli aspetti geopolitici dell’intesa, che oggi sono nel mondo in generale più importanti di quelli dell’economia e della sua logica. Gli Stati sono tornati, per molti versi, a dettare le loro condizioni.
A tale proposito appare opportuno in effetti ricordare che, accanto alle quattro imprese del settore in qualche modo coinvolte nell’affare, ci sono altri attori presenti sulla scena del dramma, gli Stati. Essi sono ufficialmente tre, ma dietro le quinte si intravedono almeno altri due protagonisti parecchio ingombranti.
Ricordiamo in ogni caso che il tutto si svolge mentre le case dell’auto cercano faticosamente di adattarsi ad un settore che appare sotto assedio (Ewing, 2019), tra guerre commerciali, spostamento dell’asse geografico del settore, preoccupazioni climatiche, innovazione tecnologica, nuovi modi di utilizzo delle vetture.
Gli attori palesi
-L’Italia
Per quanto riguarda il nostro paese è molto semplice riferire quanto è accaduto. Il governo italiano e i suoi rappresentanti, con un comportamento del tutto opposto a quello francese, stando almeno alle dichiarazioni ufficiali non hanno sostanzialmente espresso alcuna volontà, non hanno emesso alcuna dichiarazione ufficiale su di una questione che riguardava quella che è ancora oggi la più grande impresa industriale operante in Italia, che poi, con tutto il settore della componentistica e dei servizi che si trascina dietro, impiega centinaia di migliaia di persone.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: Chi sono gli incendiari di petroliere
Chi sono gli incendiari di petroliere
di Manlio Dinucci
L’arte della guerra. Il vice-premier Matteo Salvini incontra a Washington il segretario di Stato Mike Pompeo mentre gli Stati uniti preparano una nuova escalation in Medio Oriente
Mentre gli Stati uniti preparano una nuova escalation in Medio Oriente, accusando l’Iran di attaccare le petroliere nel Golfo di Oman, il vice-premier Matteo Salvini incontra a Washington il segretario di Stato Mike Pompeo, uno degli artefici di tale strategia, assicurandogli che «l’Italia vuole tornare a essere nel continente europeo il primo partner della più grande democrazia occidentale».
Aggancia così l’Italia all’operazione lanciata da Washington. L’«incidente del Golfo di Oman», casus belli contro l’Iran, ricalca «l’incidente del Golfo del Tonchino» del 4 agosto 1964, usato come casus belli per bombardare il Nord Vietnam, accusato di aver attaccato un cacciatorpediniere Usa (accusa risultata poi falsa). Oggi, un video diffuso da Washington mostra l’equipaggio di una presunta motovedetta iraniana che, in pieno giorno, rimuove dalla fiancata di una petroliera una mina inesplosa per cancellare la sua provenienza (dato che la mina avrà avuto la scritta «made in Iran»).
Con queste «prove», che costituiscono un vero e proprio insulto all’intelligenza, Washington cerca di camuffare lo scopo dell’operazione. Essa rientra nella strategia per il controllo delle riserve mondiali di petrolio e gas naturale e dei relativi corridoi energetici.
Leggi tutto
Paolo Di Remigio: Un articolo sorprendente: sulla didattica delle competenze
Un articolo sorprendente: sulla didattica delle competenze
di Paolo Di Remigio
L’articolo di Magni pubblicato di recente su Roars[1] inizia con l’allineare critiche radicali contro la didattica delle competenze: da quelle di Angelique del Rey, per cui essa sussume il sapere sotto la categoria totalizzante dell’utile, disturba la didattica effettiva e trascura i valori dell’educazione del cittadino, a quelle di Diana Ravitch, per cui frammenta il curricolo scolastico approfondendo le discriminazioni sociali e abbassando il livello culturale; fa così credere al lettore distratto che sia stato scritto con l’intenzione di assestarle il colpo di grazia. È però un’apparenza. Il punto di vista definitivo di Magni, in sostanziale contrasto con le osservazioni iniziali, è che “una didattica per competenze dovrebbe affiancare, non sostituire, la didattica fondata sul postulato della ‘trasmissione’ di conoscenze attualmente in uso”. Non è vero dunque quanto Angelique del Rey e Diane Ravitch scrivono; il male sarebbe invece la didattica della trasmissione ancora in uso e il rimedio sarebbe affiancarla con la didattica delle competenze
Contraddirsi è affermare la verità della congiunzione del vero e del falso. Magni sembra contraddirsi in quanto sembra concepire la didattica delle competenze prima come indesiderabile poi come desiderabile. Di fatto, però, la critica della didattica delle competenze è debole già dall’inizio. La contraddizione è dunque soltanto apparente.
Leggi tutto
Dante Barontini: Debito pubblico, l’acchiappafantasmi
Debito pubblico, l’acchiappafantasmi
di Dante Barontini
Cosa hanno in comune Alberto Bagnai, Paolo Savona e Luis de Guindos Jurado? In generale sono tre apprezzati economisti, politicamente assolutamente non hanno nulla a che vedere l’uno con l’altro. I primi due, oltre a far parte della maggioranza o del governo gialloverde (Savona la lascito il posto di ministro per guidare la Consob), sono considerati degli euroscettici piuttosto decisi, il terzo è vicepresidente della Bce, e quindi parte integrante dell’establishment “europeista”.
E naturalmente nessuno dei tre riscuote le nostre simpatie.
Eppure nelle ultime 48 ore questi tre signori hanno detto tutti la stessa identica cosa su un punto decisivo che sia la “classe politica” (scusateci il termine) sia il sistema dei media mainstream si è ben guardata dal cogliere. Meglio nasconderla, sennò si vedrebbe troppo bene di che impasto fangoso siano fatti i trattati europei ed anche le velleità “trattativiste” di questo governo.
Come abbiamo scritto spesso, la contrapposizione tra “europeisti” e “sovranisti” è una recita a soggetto. Ed entrambi rispettano con precisione il ruolo che è stato loro dato, per non rompere questa sceneggiata che immobilizza la possibile consapevolezza del “popolo”.
Qual’è questo segreto inconfessabile?
Una quisquilia: il livello del debito pubblico è l’unico parametro negativo tra i fondamentali economici di questo paese. Ma quando “i mercati” debbono considerare la solidità dei conti pubblici e la solvibilità di uno Stato, sono soliti considerare diversi altri fattori altrettanto – se non più – importanti del debito pubblico.
Leggi tutto
Guido Battisti: Occidentali, ancora uno sforzo!
Occidentali, ancora uno sforzo!
di Guido Battisti
Paolo Bartolini, Stefania Consigliere: Strumenti di cattura. Per una critica dell’immaginario tecno-capitalista, Jaca Book – Dissidenze – p.188 – €. 20,00
Stefania Consigliere è ricercatrice in antropologia all’Università di Genova dove si è formata alla scuola del professore Antonio Guerci. La sua crescita personale e professionale è profondamente debitrice alla lunga collaborazione con Piero Coppo, importante studioso e punto di riferimento in Italia per la disciplina dell’Etnopsichiatria, nonché amico del compianto Giorgio Cesarano. Dalla lettura delle sue pubblicazioni risalta una non comune conoscenza in vari campi di studio (confinanti ma spesso resi non comunicanti tra loro dalla scienza accademica), insieme all’altrettanto inconsueto e contagioso entusiasmo di chi sperimenta profondamente in sé la potenza di ciò che intende trasmettere con il suo lavoro di studioso.
il Laboratorio “archeologia filosofica” ha avuto il piacere di conoscere di persona Stefania e di averla ospite in un incontro informale avvenuto qualche mese fa in un suggestivo ambiente ricavato da uno scantinato, romanticamente bohémien e carbonaro. In quel contesto si sono poste le basi per una possibile collaborazione con questa amica, in virtù di una sensibile comune intesa intorno all’urgenza di aprire quelle porte della percezione che la modernità capitalista ha preteso di svalutare come residuo di un passato oscurantista o, peggio ancora, di sigillare per sempre dopo averle sepolte sotto cumuli di macerie e montagne di cadaveri.
Leggi tutto
Hits 3873
Hits 3819
Hits 3485
Hits 3010
Hits 2890
Hits 2737
Hits 2605
Hits 2399
tonino

Antonio Lettieri: Con le elezioni sconfitta la politica europea

Con le elezioni sconfitta la politica europea
di Antonio Lettieri
I risultati elettorali testimoniano il fallimento della linea adottata negli ultimi dieci anni. Un cambiamento radicale è richiesto e possibile. Ma rimane incerto
 Uno dei
meriti più evidenti di un regime democratico è che il
periodico
svolgimento delle elezioni consente di definire la continuità
o l'alternanza dei governi. Ciò è particolarmente evidente nel
sistemi bipartisan come negli Stati Uniti e, con alcune
variazioni, in Giappone e, fino in tempi recenti, in Germania
nel Regno Unito, dove uno dei
due partiti principali può, da solo o in coalizione con un
secondo partito, formare un nuovo governo.
Uno dei
meriti più evidenti di un regime democratico è che il
periodico
svolgimento delle elezioni consente di definire la continuità
o l'alternanza dei governi. Ciò è particolarmente evidente nel
sistemi bipartisan come negli Stati Uniti e, con alcune
variazioni, in Giappone e, fino in tempi recenti, in Germania
nel Regno Unito, dove uno dei
due partiti principali può, da solo o in coalizione con un
secondo partito, formare un nuovo governo.
Nel caso dell'Unione europea, la maggioranza del Parlamento europeo è stata stabilmente formata, nel corso di 40 anni, da due partiti dominanti: il conservatore e il socialdemocratico. La novità è che con le elezioni di maggio questi due partiti per la prima volta non hanno più la maggioranza assoluta. Una svolta storica importante. Ma che non impedisce la creazione di una nuova maggioranza, ricorrendo a uno o due partiti collaterali su una piattaforma comune sostanzialmente orientata alla continuità della vecchia politica europea.
Tomasi di Lampedusa, autore del "Gattopardo", avrebbe potuto ribadire, riferendosi alle elezioni europee di maggio, che "se vogliamo che le cose rimangano come sono, le cose dovranno cambiare".
Qualche interrogativo
Ma i risultati elettorali ci forniscono effettivamente un quadro in grado di avvalorare una prospettiva di pura continuità? Se diamo uno sguardo ai principali quattro paesi dell’Unione europea, che da soli comprendono la maggioranza della sua popolazione, i colori diventano molto più sfumati e il futuro molto meno certo.
Per cominciare, in Gran Bretagna il Brexit Party di Nigel Farage ha stravinto la prova elettorale col 31 per cento dei voti. Non sappiamo se l'uscita della Gran Bretagna dall'UE sarà decisa entro il prossimo autunno o se sarà aperto un nuovo negoziato. Ma qualcosa di nuovo è già successo: i Laburisti e i Conservatori, da oltre mezzo secolo tra i protagonisti della politica europea, escono dalla prova elettorale con la più grave sconfitta della loro storia.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Giochi di specchi ed equivoci: il caso della Lega
Giochi di specchi ed equivoci: il caso della Lega
di Alessandro Visalli
 Il 4 marzo 2018 una improvvisa
slavina si è
staccata dal ghiacciaio della sinistra che da lungo tempo
rimandava sinistri scricchiolii. In una elezione che
sperimentava non a caso un sistema
elettorale più vicino al proporzionale abbandonato da decenni
tutti i partiti della “seconda repubblica” sono arretrati di
schianto. Sia i partiti di centro, vagamente colorati a
sinistra o a destra più che altro per estetica, sia i partiti
della anemica sinistra
‘radicale’. Tutta la sinistra è arrivata a qualcosa come il
15% degli elettori e alcune parti non sono entrate neppure in
parlamento.
Il 4 marzo 2018 una improvvisa
slavina si è
staccata dal ghiacciaio della sinistra che da lungo tempo
rimandava sinistri scricchiolii. In una elezione che
sperimentava non a caso un sistema
elettorale più vicino al proporzionale abbandonato da decenni
tutti i partiti della “seconda repubblica” sono arretrati di
schianto. Sia i partiti di centro, vagamente colorati a
sinistra o a destra più che altro per estetica, sia i partiti
della anemica sinistra
‘radicale’. Tutta la sinistra è arrivata a qualcosa come il
15% degli elettori e alcune parti non sono entrate neppure in
parlamento.
Si è trattato di una molla che si stava caricando almeno da dieci anni, mentre parte maggioritaria della popolazione italiana veniva respinta sul margine del sistema economico e perdeva ogni possibilità di controllare le proprie vite. È scivolata verso il basso almeno il 20% della popolazione italiana, in soli dieci anni e quindi in modo assolutamente percepibile, cosa che ha condotto i tranquilli e garantiti ad essere per la prima volta da decenni la minoranza del paese.
La rivolta degli elettori (Spannaus, 2016) che ha portato nel mondo alla Brexit, alla vittoria di Trump, all’esito delreferendum che ha interrotto la carriera politica di Renzi, ed ancora prima aveva fornito l’avvertimento inascoltato dell’avanzata del M5S nel 2013, le elezioni francesi con la dissoluzione dei socialisti e la contrapposizione élite/popolo rappresentata dallo scontro al ballottaggio tra Macron e Le Pen (con France Insoumise vicina all’impresa), era in movimento.
Dal 2016 il sistema politico europeo, insomma, è entrato in una fase di instabilità che è disponibile ad esiti diversi per piccoli spostamenti di umore. A “botta calda” Carlo Formenti parlò di rabbia delle ‘periferie’ in particolare verso le sinistre che si sono rifugiate nella difesa dei vincenti. Ovvero delle classi colte e benestanti che vedono la mondializzazione come un destino ed un progresso semplicemente perché ne traggono cospicui benefici.
Leggi tutto
Giulio M. Cavalli: “Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015)” di Mario Tronti
“Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015)” di Mario Tronti
di Giulio M. Cavalli
Recensione a: Mario Tronti, Il demone della politica. Antologia di scritti (1958-2015), a cura di Matteo Cavalleri, Michele Filippini e Jamila M. H. Mascat, Il Mulino, Bologna, 2017, pp. 656 (scheda libro)
 La
recensione che qui presentiamo inaugura una collaborazione
con Prospettive italiane,
gruppo di ricerca promosso da alcuni studenti di filosofia
dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Questa
recensione traccia, seguendo le diverse sezioni
dell’antologia in questione, un profilo complessivo del
percorso filosofico-politico di
Mario Tronti. Sarà successivamente integrata da una serie di
articoli che approfondiranno le diverse fasi del suo
pensiero, qui delineate nelle
loro linee generali.
La
recensione che qui presentiamo inaugura una collaborazione
con Prospettive italiane,
gruppo di ricerca promosso da alcuni studenti di filosofia
dell’Alma Mater Studiorum-Università di Bologna. Questa
recensione traccia, seguendo le diverse sezioni
dell’antologia in questione, un profilo complessivo del
percorso filosofico-politico di
Mario Tronti. Sarà successivamente integrata da una serie di
articoli che approfondiranno le diverse fasi del suo
pensiero, qui delineate nelle
loro linee generali.
* * * *
Ospitata nella collana «XX secolo» diretta da Carlo Galli e Alberto De Bernardi per i tipi del Mulino, Il demone della politica è la prima antologia ragionata e sistematica degli scritti di Mario Tronti (Roma, 1931), uno tra i maggiori intellettuali italiani del secondo Novecento. L’antologia, curata da Matteo Cavalleri, Michele Filippini e Jamila M. H. Mascat, dal punto di vista editoriale ha il grande merito di fornire per la prima volta una panoramica completa dell’evoluzione del pensiero trontiano fin dai primi interventi nel dibattito marxista italiano (1958-1959), raccogliendo in tutto ventinove testi, molti dei quali difficilmente reperibili perché sparsi in riviste e collettanee, attentamente annotati e preceduti da un’utilissima introduzione a sei mani.
I curatori hanno opportunamente suddiviso gli scritti in quattro sezioni, che seguono un ordine cronologico che è anche tematico, e che si configurano quindi come le quattro principali tappe evolutive del pensiero di Tronti. La sezione più ampia è dedicata agli scritti immediatamente successivi alla stagione operaista, quasi a voler ricordare al lettore che Tronti non è stato soltanto «il padre nobile dell’operaismo italiano» (p. 11), ma un filosofo a tutto tondo, tanto radicale – come si vedrà – da mettere più volte in questione le sue stesse idee con estrema lucidità. Quando ci si trova davanti a un percorso intellettuale così complesso e tortuoso è allora quanto mai opportuno, come dichiarano in apertura i curatori, «offrire un’immagine quanto più completa possibile dell’itinerario dell’autore, segnalandone continuità e discontinuità, senza per questo pretendere una coerenza assoluta della traiettoria trontiana o, inversamente, sviluppare una critica serrata di ogni suo passaggio» (p. 11).
Leggi tutto
Lorenzo Vita: L’Europa è sempre più fragile: ecco perché si sta sgretolando
L’Europa è sempre più fragile: ecco perché si sta sgretolando
di Lorenzo Vita
Il problema non sono le superpotenze. Non è Donald Trump, che dagli Stati Uniti attacca euro ed Unione europea. Non è la Cina, che con Xi Jinping e la sua Nuova Via della Seta ha avviato da tempo un processo di inserimento in Europa. E il problema non è la Russia, dopo che per anni Vladimir Putin è stato accusato di essere la centrale del mondo sovranista ed euroscettico. Il vero problema dell’Europa è l’Europa stessa, con un insieme di governi sempre più deboli, Paesi ingestibili, leader che pensano a se stessi e popolazioni sempre più stanche di esecutivi che hanno perso qualsiasi contatto con la realtà. Se a queste premesse si aggiunge una Unione europea delegittimata, i vertici dell’Ue in scadenza, i partiti sovranisti in ascesa e una possibile coalizione a Strasburgo del tutto eterogenea e fatta di leader indeboliti (Angela Merkel ed Emmanuel Macron in primis), il quadro che ne scaturisce è sempre più nefasto.
Dal punto di vista nazionale, le cose non vanno affatto bene. Non c’è un Paese in Europa che possa dirsi al sicuro da crisi interne, debolezza dei propri leader o con l’avvento di partiti di rottura che hanno creato le premesse per coalizioni eterogenee e fragili. Come scritto su Il Sole 24 Ore, che riporta le dichiarazioni di Eric Maurice, capo dell’ufficio di Bruxelles della Fondazione Schuman, “è in effetti una della caratteristiche di questa fase politica. Abbiamo a che fare sempre più spesso con coalizioni che comprendono quasi tutta la scena politica, o comunque numerosi tendenze politiche”.
Leggi tutto
F.S.: Molto si decide dalle parti di Hormuz
Molto si decide dalle parti di Hormuz
di F.S.
Al momento non si può escludere nulla su quanto avvenuto nel Golfo dell’Oman. Quel che è certo è che si apre una nuova fase politica e geopolitica nella contesa strategica globale. Qui interessa analizzare l’elemento politico globale in movimento.
Unico dato di fatto, al momento, è che si avvantaggiano le reciproche fazioni “radicali”; sia lo stato profondo statunitense sempre più stanco dell’approccio geopolitico da manager usato da Trump nelle sue “negoziazioni” bilaterali, sia le correnti interne più patriottiche della repubblica persiana, espressioni delle campagne povere, della piccola borghesia del bazar provinciale e del feudo ahmadinejadista di Mashad, per le quali il deal Rohani Obama fu sin dall’inizio un trattato capestro che avrebbe portato — come ha in effetti portato — acqua al solo mulino dell’imperialismo occidentale sulla pelle del popolo persiano.
Da tali frazioni l’accordo di Vienna del 14 luglio 2015 fu paragonato al Trattato di Turkmenchaydel 1828, in seguito al quale gli zaristi russi portarono via al popolo persiano i propri territori settentrionali. Anche il generale Qasem Soleimani, che non ha mai fatto fronte comune con gliahmadinejadisti e con il Basiji, ebbe parole durissime per Rohani.
Avevo già avuto modo di specificare, mesi fa, come fazioni sioniste e neoconservatives considerassero attualmente l’Iran il vero hard front. Ciò, come ho spesso ribadito su SOLLEVAZIONE, di contro alla vulgata generale, la contesa globale si disputa nel Mediterraneo e nel Grande Medio Oriente, non nell’Indo-Pacifico.
Leggi tutto
Francesco Piccioni: La scialuppa tra le corazzate Usa-Ue-Cina
La scialuppa tra le corazzate Usa-Ue-Cina
di Francesco Piccioni
Il primo comandamento, se si vuol capire qualcosa di quel che accade nella “politica” – e soprattutto nella geopolitica internazionale – è lasciar perdere le dichiarazioni dei politici. Non perché siano completamente insignificanti, ma non in genere menzogna e propaganda. Dicono molto della disinvoltura e sfrontatezza dei singoli, quasi nulla su quel che matura in pentola.
Figuriamoci poi quando bisogna occuparsi di “leader” che vanno negli States e non trovano di meglio che farsi un selfie da Washington, strepitando di essere sulla “scalinata di Rocky” (un film, mica una battaglia storica), che tutti sanno trovarsi a… Philadelphia.
Sia chiaro: se Salvini è andato negli Usa ci sono ragioni importanti, ma non sono quelle che dice perché i giornalari ci sguazzino come girini nella pozzanghera.
Meglio dunque guardare chi l’ha ricevuto: Mike Pompeo, segretario di Stato, ossia il ministro degli esteri. E c’è in effetti una logica evidente nel fatto che il ministro degli esteri della superpotenza fin qui dominante riceva un vice-presidente del consiglio e ministro di polizia di un paese facente parte da oltre 70 anni dell’inner circle degli alleati più servili. Un esponente del comando imperiale che istruisce un aspirante vicerè locale, volenteroso ma pasticcione (pensate che diceva di “di sentirsi a casa sua”… a Mosca!).
Leggi tutto
Eros Barone: Berlinguer, quella brava persona che ha affossato il comunismo italiano

Berlinguer, quella brava persona che ha affossato il comunismo italiano
di Eros Barone
La campagna celebrativa dedicata a Enrico Berlinguer, che si rinnova ad ogni decennale della sua scomparsa, è tutta giocata, sotto la spinta del Pd e della stampa borghese, in chiave anticomunista.
Sennonché può essere utile, per correggere il tiro e pervenire ad un giudizio storicamente corretto, richiamare i capisaldi del revisionismo berlingueriano: il compromesso storico, la democrazia come valore universale, l’eurocomunismo, l’accettazione dell’“ombrello” della Nato, l’adesione alla Ue ed infine la tesi sull’“esaurimento della spinta propulsiva della rivoluzione sovietica”. Le riflessioni di Berlinguer sull’austerità e sulla questione morale non hanno la stessa forza né possono in qualche modo compensare l’effetto devastante dei suddetti capisaldi. Del resto, se si accetta il capitalismo come orizzonte intrascendibile dell’azione politica, non ci si può meravigliare che prosperino clientele e corruzione: una volta posto il profitto come valore predominante, queste sono le necessarie conseguenze.
Cominciamo dal compromesso storico, cioè dai tre scritti di Berlinguer pubblicati su “Rinascita” tra il 28 settembre ed il 12 ottobre 1973 in séguito all’eroica morte del presidente del Cile, Salvador Allende, per mano dei golpisti di Pinochet al servizio degli Usa. Berlinguer non si rende conto che la democrazia borghese esiste solo se la borghesia controlla il potere, talché, quando questo viene eroso, come nel Cile di Allende, e il popolo riesce in qualche modo ad acquisire un certo potere sul piano istituzionale, la borghesia non esita a liquidare le regole formali che essa stessa ha stabilito, adottando metodi violenti e terroristici.
Leggi tutto
Hits 3894
Hits 3848
Hits 3509
Hits 3035
Hits 2901
Hits 2755
Hits 2624
Hits 2214
tonino

Nancy Fraser: “Il neoliberismo mina la riproduzione sociale”
“Il neoliberismo mina la riproduzione sociale”
Intervista a Nancy Fraser
Nancy Fraser è una filosofa e teorica femminista statunitense. Si è occupata di filosofia politica ed etica normativa. Insegna scienze politiche e sociali a New York. Ha scritto insieme a Axel Honneth “Redistribuzione o riconoscimento?” un importante testo di filosofia politica contemporanea. Di recente ha pubblicato insieme a Cinzia Arruzza e Tithi Bhattacharya Femminismo per il 99%. Un Manifesto (Laterza)
 Innanzitutto grazie di essere con noi.
Innanzitutto grazie di essere con noi.
Grazie a voi.
Per iniziare, potresti dirci qualcosa riguardo al tuo percorso politico e intellettuale? Quali sono state le tue esperienze formative?
Certo. Sono una sessantottina, cresciuta a Baltimora, nel Maryland, che è una città in cui vigevano le leggi Jim Crow, leggi di segregazione razziale. L’esperienza politica formativa della mia gioventù è stata la battaglia per la desegregazione – che è un classico percorso della new left. Ho fatto parte del movimento per i diritti civili durante le scuole medie e superiori. All’università, bhe anche prima di iniziarla, ho partecipato al movimento contro la guerra in Vietnam, nell’ala di sinistra, anti imperialista, poi agli Studenti per una Società Democratica (SDS) ed infine il femminismo e così via. Durante questo percorso sono diventata una marxista non ortodossa e ho fatto attività politica per un po’ dopo aver terminato l’università. Poi ho deciso di tornare all’università per un dottorato in filosofia, ma ho portato con me la mia nuova visione di sinistra e devo dire che non penso che il mio impegno e i miei valori fondamentali siano cambiati dagli anni ‘60 ad oggi. Poi ho iniziato a lavorare sulla democrazia, i diritti sociali, il multiculturalismo, la redistribuzione, il riconoscimento, la critica al capitalismo, la teoria femminista, ecc.
Oggi sei a Bologna per presentare ‘Femminismo per il 99%: un manifesto’. Qual è lo scopo del manifesto e a chi è rivolto?
Penso che sia rivolto a un pubblico eterogeneo. Il caso più ovvio è rappresentato da chi è già coinvolto o interessato al femminismo e a quanti si stiano proponendo un cambio di direzione, una rottura con il femminismo liberale mainstream e una svolta verso un femminismo che sia davvero anticapitalista e di sinistra.
Leggi tutto
Andrea Fumagalli: Minibot, debito pubblico e monete complementari: di che cosa stiamo parlando?
Minibot, debito pubblico e monete complementari: di che cosa stiamo parlando?
di Andrea Fumagalli
 La
discussione che si è aperta sui cosiddetti Minibot può
consentire di fare
un minimo di chiarezza sui due temi sempre più spesso
all’ordine del giorno: il finanziamento del debito pubblico e
i ruoli che la moneta
può svolgere oltre a quelli tradizionali di mezzo di scambio e
di unità di conto.
La
discussione che si è aperta sui cosiddetti Minibot può
consentire di fare
un minimo di chiarezza sui due temi sempre più spesso
all’ordine del giorno: il finanziamento del debito pubblico e
i ruoli che la moneta
può svolgere oltre a quelli tradizionali di mezzo di scambio e
di unità di conto.
Il finanziamento del debito pubblico, prima dell’avvento delle teorie monetariste e del monopolio di emissione della moneta da parte della Banca Centrale Europea (BCE), poteva contare su due strumenti, fra loro complementari: il ricorso ai mercati finanziari tramite la vendita di titoli di Stato (di diversa natura e durata) per rifinanziare i titoli venuti a cadenza e/o finanziare nuovo deficit e le Operazioni di Mercato Aperto, ovvero il finanziamento diretto da parte della Banca Centrale. Lo Stato italiano era l’unico soggetto economico che poteva, infatti, disporre di un conto corrente presso la Banca Centrale (definito Conto Corrente di Tesoreria), a cui attingere nei casi di necessità senza ricorrere ai mercati finanziari. Tale possibilità implicava la creazione di nuova moneta pari all’ammontare del debito creato.
Alla fine degli anni Settanta, in seguito ai diktat delle teorie monetariste che predicavano l’esistenza di un nesso diretto di causa ed effetto, tra creazione di moneta e dinamica inflazionistica, e quindi dopo il noto divorzio tra Banca d’Italia e Ministero del Tesoro (come si chiamava allora l’odierno Ministero dell’Economia), la possibilità di un finanziamento del debito da parte della Banca Centrale viene meno, sino a scomparire del tutto con l’introduzione dell’Euro e con la costituzione della BCE.
Come ci ricorda Massimo Amato in un recente articolo pubblicato su Valori.it, l’attuazione di politiche di Quantitative Easing adottate dalla BCE ha creato un elevato aumento di creazione di moneta: “La crisi di liquidità del 2008 è stata curata con iniezioni di liquiditàsenza precedenti. La quantità di moneta è pressoché triplicata in Europa, eppure il target dell’inflazione del 2% non è stato ancora raggiunto”.
Leggi tutto
George Caffentzis: Trump e il “momento fascista” del capitalismo
Trump e il “momento fascista” del capitalismo
di George Caffentzis*
Molti provvedimenti di Trump sono in continuità con quelli di Obama, ma va analizzata con attenzione la teoria economica su cui si basa, che dà espressione politica allo spirito del capitalismo del nostro tempo
 Malgrado
l’introduzione di rigide misure di austerità, applicate
soprattutto seguendo le direttive del Washington Consensus
[espressione coniata nel 1989 dall’economista John Williamson
per indicare una serie
di indicazioni del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale destinate ai paesi in crisi, ndt],
sembra che il sistema
capitalistico globale sia entrato in un periodo di
stagnazione, caratterizzato dalla caduta del tasso di
profitto, dalla riluttanza delle grandi
compagnie a investire, e dall’introduzione da parte dei
governi di tassi di interesse molto bassi o vicini allo zero.
Tutto ciò è
sorprendente, dal momento che la fine della Guerra Fredda, nel
1989, avrebbe dovuto dare il via a un periodo di prosperità
capitalista. Invece,
come abbiamo visto, il sistema è entrato in una crisi
prolungata su più fronti, ravvivando la discussione sulla
«stagnazione
secolare» tra gli economisti al massimo livello.
Malgrado
l’introduzione di rigide misure di austerità, applicate
soprattutto seguendo le direttive del Washington Consensus
[espressione coniata nel 1989 dall’economista John Williamson
per indicare una serie
di indicazioni del Fondo Monetario Internazionale e della
Banca Mondiale destinate ai paesi in crisi, ndt],
sembra che il sistema
capitalistico globale sia entrato in un periodo di
stagnazione, caratterizzato dalla caduta del tasso di
profitto, dalla riluttanza delle grandi
compagnie a investire, e dall’introduzione da parte dei
governi di tassi di interesse molto bassi o vicini allo zero.
Tutto ciò è
sorprendente, dal momento che la fine della Guerra Fredda, nel
1989, avrebbe dovuto dare il via a un periodo di prosperità
capitalista. Invece,
come abbiamo visto, il sistema è entrato in una crisi
prolungata su più fronti, ravvivando la discussione sulla
«stagnazione
secolare» tra gli economisti al massimo livello.
Quali sono state e quali sono le cause di questo declino? Io sostengo che la politica economica dell’amministrazione Trump sia una risposta a questa stagnazione. Che dietro al suo comportamento fuori dalle righe ci sia la decisione di incrementare i patrimoni del capitalismo statunitense, restaurarne l’egemonia e stimolare la crescita del sistema capitalistico sotto la bandiera del «Make America Great Again» (Maga).
Per sostenere questa tesi prendo in esame due elementi del pensiero politico ed economico di Trump sulla moneta e lo scambio, e cioè il suo supporto al ripristino del sistema aureo [un sistema monetario nel quale il valore della moneta è fissato dall’oro, ndt] e la sua determinazione nel porre fine alla cosiddetta «santità del contratto».
Trump è un normale politico capitalista?
È stato fatto notare che, sotto molti aspetti, le politiche di Trump sono in continuità con quelle dell’amministrazione Obama, che a loro volta, al contrario delle apparenze, non si erano allontanate molto dal Washington Consensus. Ci sono elementi significativi di continuità tra Obama e l’amministrazione Trump – così come c’erano tra l’amministrazione Carter e quella Reagan.
Leggi tutto
Antitesi: Sul protezionismo
Sul protezionismo
Antitesi n.6
La guerra commerciale è parte della guerra imperialista
 “Gli Usa stanno aprendo il fuoco sul mondo”.
Così recitava, a inizio luglio, il comunicato del ministero
del commercio della Cina, in riferimento ai dazi varanti da
Trump contro Pechino.
Effettivamente, le misure protezioniste varate dall’attuale
presidenza degli Usa hanno decisamente rappresentato una
svolta nelle relazioni
economiche internazionali, aggravando la contraddizione tra
potenze imperialiste, in primis quelle tra Washington e
Pechino, e ponendo in discussione
come non mai negli ultimi decenni la concezione globalista e
liberoscambista del capitalismo.
“Gli Usa stanno aprendo il fuoco sul mondo”.
Così recitava, a inizio luglio, il comunicato del ministero
del commercio della Cina, in riferimento ai dazi varanti da
Trump contro Pechino.
Effettivamente, le misure protezioniste varate dall’attuale
presidenza degli Usa hanno decisamente rappresentato una
svolta nelle relazioni
economiche internazionali, aggravando la contraddizione tra
potenze imperialiste, in primis quelle tra Washington e
Pechino, e ponendo in discussione
come non mai negli ultimi decenni la concezione globalista e
liberoscambista del capitalismo.
Infatti, secondo l’ideologia neoliberista, affermatasi a partire dalla fine degli anni settanta del secolo scorso come ispiratrice delle agende economiche delle principali potenze imperialiste, la libera circolazione di merci e capitali aldilà delle frontiere degli Stati è alla base dello sviluppo capitalistico mondiale e delle singole nazioni. Si tratta di un dogma che rientrava in quella sorta di “pensiero unico” liberista diventato definitivamente egemone sopratutto dopo il crollo dell’Urss e l’affermazione degli Usa come incontrastata potenza globale. In realtà, il liberoscambismo rientrava in una svolta delle strategie economiche capitalistiche, resa necessaria dalla fase di crisi apertasi all’inizio degli anni settanta e al fallimento, nel contrastarla, delle politiche keynesiane. [1] Attraverso la libera circolazione di merci e di capitali a livello globale, abbattendo limiti, tariffe e regolamentazioni, la borghesia imperialista si riproponeva il conseguimento di più ampi margini di valorizzazione del capitale, conquistando nuovi mercati, nuova forza lavoro e aprendo spazi alla circolazione finanziaria, via via più deregolamentata, per ottenere remunerazione fittizia dei capitali nella fase in cui il plusvalore e il profitto nell’economia reale tendevano a cadere.
Il protezionismo alle origini del capitalismo
Non sempre, però, il liberoscambismo ha contrassegnato il procedere dell’economia capitalistica. Fin dagli albori del capitalismo, la libera circolazione di merci e capitali si è alternata a misure per limitarla, di modo che i capitalisti di un singolo paese (cioè una singola formazione capitalistica nazionale), potessero tutelare i propri profitti a danno degli altri.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Cosa accadrà adesso?
Cosa accadrà adesso?
di Leonardo Mazzei
 Cresce in Europa
l'interesse per le vicende italiane dopo le elezioni
europee. Cosa accadrà adesso?
Ci saranno elezioni anticipate? Quali sono le vere
intenzioni del governo giallo-verde riguardo all'Unione
europea? Davvero saranno lanciati i
MiniBoT? Reggerà l'alleanza M5s Lega? Di che natura è il
populismo di Salvini? A queste ed altre domande poste dal
sito in lingua
tedesca EUREXIT risponde Leonardo
Mazzei
del Comitato centrale di P101.
L'intervista è di Wilhelm Langthaler.
Cresce in Europa
l'interesse per le vicende italiane dopo le elezioni
europee. Cosa accadrà adesso?
Ci saranno elezioni anticipate? Quali sono le vere
intenzioni del governo giallo-verde riguardo all'Unione
europea? Davvero saranno lanciati i
MiniBoT? Reggerà l'alleanza M5s Lega? Di che natura è il
populismo di Salvini? A queste ed altre domande poste dal
sito in lingua
tedesca EUREXIT risponde Leonardo
Mazzei
del Comitato centrale di P101.
L'intervista è di Wilhelm Langthaler.
* * * *
Le elezioni europee hanno rovesciato i rapporti di forza nel governo populista. Perché è avvenuto?
I rapporti di forza interni si sono invertiti, ma la maggioranza giallo-verde ha perfino guadagnato consensi. Alle elezioni politiche del 2018 aveva il 50,03% dei voti, alle europee ha ottenuto il 51,40%. Considerato che per il governo non è certo stato un anno facile, si tratta di una differenza minima ma significativa.
Credo che il rovesciamento dei consensi sia da attribuirsi a tre fattori. In primo luogo la Lega ha potuto incassare molti consensi grazie allo stop all'immigrazione clandestina nel Mediterraneo. In secondo luogo, mentre il Reddito di cittadinanza ha prodotto una forte delusione nell'elettorato M5S, l'intervento sulle pensioni — "Quota 100" — voluto in primo luogo dalla Lega, ha spinto molti lavoratori a votare per la prima volta questo partito. In terzo luogo, non bisogna dimenticarsi del ruolo dei media, che per un anno intero hanno fatto ricorso ad ogni argomento per attaccare i Cinque Stelle ancor più che il governo nel suo insieme.
Come se non bastasse, Di Maio ha sbagliato tutto nell'ultima parte della campagna elettorale quando, per dimostrare la propria autonomia da Salvini, ha operato una sorta di "svolta a sinistra". Purtroppo questa sterzata includeva anche un profilo assai più europeista di quello tradizionale del movimento. Una mossa pagata nelle urne.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: Iran: è guerra all’Eurasia
Iran: è guerra all’Eurasia
Stranamore, stranammorati, stranamorini
di Fulvio Grimaldi
 Hannibal ante portas?
Non è più procurato allarme
Hannibal ante portas?
Non è più procurato allarme
Ne va della potenza egemonica, dell’eccezionalismo, del “Destino manifesto”, della globalizzazione a direzione unica, del governo mondiale, della controffensiva colonialista fondata su migrazioni che svuotano di energie umane e professionali il Sud da predare. Il Golfo Persico è il pettine al quale questi nodi vengono. E quando gli scienziati nucleari mettono l’orologio dell’Apocalisse a due minuti da mezzanotte, più o meno dove stava nell’immediato post-Hiroshima e Nagasaki, c’è stavolta poco da parlare di procurato allarme.
Chi segue meticolosamente le uniche fonti di notizie e analisi affidabili, che ormai sono quasi solo in rete (finchè dura e Facebook chiude un occhio), legge e vede da almeno un paio di lustri l’annuncio dell’imminente terza e ultima guerra mondiale. Giulietto Chiesa, addirittura, annunciava l’imminenza del conflitto totale fin dai primi anni del nuovo millennio. Al punto che, ripetuta in conferenza su conferenza, intervista su intervista, la funesta certezza decadeva in giaculatoria a cui più nessuno dava peso. Una specie di al lupo al lupo che si inseriva inconsapevolmente in una strategia della paura, anzi del panico, che pian piano sfiancava e distraeva da ogni altro fronte di lotta. Tipo il capitalismo. Un po’ come la questione climatica da GretaThunberg universalizzata in minaccia globale, peraltro priva di responsabilità identificate, che tutte le altre riassume (e annulla) in sé. Qualcuno ha parlato di nuovo oppio dei popoli, come quello, che mai si è cessato di fumare, della religione.
False Flag, la bandiera dell’Occidente
Tuttavia, a partire dalle micce posate nel Golfo Persico da chi conduce guerre e genocidi, e ne campa, da trecento anni a queste parti, il tema ha acquistato una pregnanza senza precedenti, anche perché si appoggia ad accadimenti analoghi che in molti casi alla guerra guerreggiata hanno portato. Parliamo di provocazioni, oggi dette “False Flag”, messe in atto onde vantare davanti all’opinione pubblica un buon, anzi un irrinunciabile, motivo per commettere qualche grossa efferatezza, altrimenti impossibile da giustificare. A molti verranno in mente le nostre stragi di Stato, da Piazza Fontana, attribuito ad anarchici, a Moro fatto far fuori alle BR, e agli attentati della “trattativa”, con manovalanza mafiosa e, a monte, Gladio, servizi nostri e atlantici, la cupola anti-Urss.
Leggi tutto
Domenico Moro: Come l’euro alimenta la divergenza tra i paesi europei
Come l’euro alimenta la divergenza tra i paesi europei
di Domenico Moro
Relazione all’assemblea “Ue e euro: dalle promesse di pace e stabilità alla realtà dei trattati e dell’austerità”, presso l’Istat, il 12 giugno 2019
 L’integrazione
economica e valutaria europea (Uem), secondo i suoi artefici,
avrebbe dovuto condurre alla convergenza tra le economie
dell’Europa ed essere di aiuto nell’affrontare le crisi
economiche. In
realtà, a distanza di vent’anni dall’introduzione della moneta
unica, le divergenze tra i Paesi europei si sono accresciute.
Inoltre, a più di dieci anni dallo scoppio della crisi
economica si è dimostrato come le economie europee siano
ancora stagnanti e anzi
sempre pronte a ripiombare nella crisi. Di recente, infatti,
l’Istat ha valutato come probabile una nuova contrazione del
Pil italiano nel
secondo semestre dell’anno in corso1.
L’integrazione
economica e valutaria europea (Uem), secondo i suoi artefici,
avrebbe dovuto condurre alla convergenza tra le economie
dell’Europa ed essere di aiuto nell’affrontare le crisi
economiche. In
realtà, a distanza di vent’anni dall’introduzione della moneta
unica, le divergenze tra i Paesi europei si sono accresciute.
Inoltre, a più di dieci anni dallo scoppio della crisi
economica si è dimostrato come le economie europee siano
ancora stagnanti e anzi
sempre pronte a ripiombare nella crisi. Di recente, infatti,
l’Istat ha valutato come probabile una nuova contrazione del
Pil italiano nel
secondo semestre dell’anno in corso1.
Tutti gli indicatori più importanti ci mostrano come la divergenza tra Germania, da una parte, e gran parte dei Paesi dell’area euro si sia accresciuta. Di particolare evidenza è la divergenza tra Germania e Italia. Per quanto riguarda il Pil pro capite, calcolato a prezzi costanti e a parità di potere d’acquisto, la differenza, che nel 1998 era minima, nel 2018 è più che decuplicata. Infatti nel 1998 il Pil pro capite italiano rappresentava il 119,2% del Pil pro capite della Ue mentre quello della Germania era il 121,7%, con una differenza di poco più di due punti percentuali. Nel 2018, invece, il Pil italiano rappresentava appena il 93,7% del Pil Ue, mentre quello tedesco di attestava al 120,8%, con una differenza di 27 punti (Graf.1).
Graf. 1 – Confronto Italia Pil Pro capite a prezzi costanti e a parità di potere d’acquisto (in % su Pil pro capite Ue; Fonte: nostre elaborazioni su dati Oecd)
Leggi tutto
Massimo De Carolis: Keynes, il costo morale del rischio
Keynes, il costo morale del rischio
di Massimo De Carolis
Avere presagito, fin dall’alba, il tramonto del neoliberalismo riporta all’attualità la «Teoria generale dell’occupazione» del grande economista inglese, ora in un Meridiano con testi inediti
 All’indomani di una
crisi economica globale,
tuttora lontana dall’aver esaurito la sua spinta
destabilizzante, non può sorprendere che un’opera come la
Teoria generale
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta torni oggi
alla ribalta, accendendo di nuovo l’interesse non solo degli
economisti
di professione, ma di chiunque si sforzi di capire cosa stia
succedendo nel mondo. Dopotutto, il trattato di Keynes era
nato a sua volta
sull’onda della grande depressione, quando il dissesto
dell’economia globale e l’avanzata dei totalitarismi avevano
reso non solo
legittimo, ma addirittura urgente un programma di completo
rivoluzionamento delle teorie economiche e delle politiche di
stampo liberale.
All’indomani di una
crisi economica globale,
tuttora lontana dall’aver esaurito la sua spinta
destabilizzante, non può sorprendere che un’opera come la
Teoria generale
dell’occupazione, dell’interesse e della moneta torni oggi
alla ribalta, accendendo di nuovo l’interesse non solo degli
economisti
di professione, ma di chiunque si sforzi di capire cosa stia
succedendo nel mondo. Dopotutto, il trattato di Keynes era
nato a sua volta
sull’onda della grande depressione, quando il dissesto
dell’economia globale e l’avanzata dei totalitarismi avevano
reso non solo
legittimo, ma addirittura urgente un programma di completo
rivoluzionamento delle teorie economiche e delle politiche di
stampo liberale.
Per Keynes erano almeno due i mitologemi da cui il pensiero economico andava rapidamente affrancato: da un lato, la fiducia cieca nella «mano invisibile» del mercato e nella sua supposta capacità di autoregolazione; dall’altro la certezza dogmatica che non potesse esistere una disoccupazione del tutto involontaria, perché il sistema tenderebbe in ogni caso a stabilizzarsi al livello ottimale, nel quale tutte le risorse sono utilizzate al meglio. In quegli anni di crisi, questi due pregiudizi erano platealmente smentiti dai fatti. Entrambi erano però talmente radicati nell’edificio dell’economia di mercato, che solo un ripensamento sistematico dell’intero castello, compresa la sua «cittadella» centrale, poteva consentire di sfatarli senza dover rinunciare a ogni forma plausibile di razionalità economica e senza rischiare, così, di spingere il liberalismo verso la bancarotta.
Rimosso negli anni ’80
Sotto il profilo teorico, la Teoria generale fu l’apice di un percorso lungo e articolato, di cui il Meridiano Mondadori appena uscito (Teoria generale dell’occupazione, dell’interesse e della moneta, a cura di Giorgio La Malfa e Giovanni Farese, pp. 1328, euro 80,00) offre un panorama completo, grazie alla preziosa ricostruzione introduttiva di Giorgio La Malfa e all’ampio corredo di testi brevi, che precedono e seguono l’opera maggiore, molti dei quali inediti in lingua italiana. Sotto il profilo invece strettamente pratico, i frutti della rivoluzione keynesiana non maturarono che nel Dopoguerra, nei trent’anni «gloriosi» durante i quali, in tutto l’Occidente, i parametri economici registrarono un balzo in avanti senza precedenti.
Leggi tutto
Hits 2920
Hits 2779
Hits 2651
Hits 2281
Hits 1889
Carlo Lozito: Intelligenza artificiale: dannazione o liberazione del lavoratore?
Hits 1863
Alberto Bradanini: La Nuova Era cinese tra declino Usa e debolezze Ue
Hits 1849
tonino

coniarerivolta: Per un salario minimo dignitoso, contro lavoro povero e sfruttamento
Per un salario minimo dignitoso, contro lavoro povero e sfruttamento
di coniarerivolta
 Al Senato è in discussione un disegno
di
legge, di iniziativa del Movimento 5 Stelle e a prima
firma della senatrice Nunzia Catalfo, che mira ad introdurre
un salario minimo orario in
Italia, uno dei pochi paesi europei ancora sprovvisti di una
legge che fissi una soglia minima alle retribuzioni. Secondo i
promotori, il disegno di
legge darebbe piena attuazione all’articolo 36 della
Costituzione, che stabilisce che ciascun lavoratore ha diritto
a una «retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa».
Al Senato è in discussione un disegno
di
legge, di iniziativa del Movimento 5 Stelle e a prima
firma della senatrice Nunzia Catalfo, che mira ad introdurre
un salario minimo orario in
Italia, uno dei pochi paesi europei ancora sprovvisti di una
legge che fissi una soglia minima alle retribuzioni. Secondo i
promotori, il disegno di
legge darebbe piena attuazione all’articolo 36 della
Costituzione, che stabilisce che ciascun lavoratore ha diritto
a una «retribuzione
proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni
caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia
un’esistenza libera e dignitosa».
Il disegno di legge è suscettibile di essere modificato anche radicalmente attraverso gli emendamenti che già sono stati o saranno proposti dai parlamentari. Nonostante ciò, è interessante analizzare la discussione nata attorno alla proposta Catalfo, i vantaggi che potrebbero derivare dall’introduzione di un simile istituto nel nostro Paese e le eventuali insidie per i lavoratori che questo disegno di legge nasconde.
Ma cosa prevede questa proposta? In estrema sintesi, in base al dettato del disegno di legge (articolo 2), affinché si possa parlare di retribuzione complessiva proporzionata e sufficiente, il trattamento economico complessivo, proporzionato alla quantità e qualità del lavoro prestato, non deve essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni, il cui ambito di applicazione sia maggiormente connesso e obiettivamente vicino in senso qualitativo all’attività svolta dai lavoratori anche in maniera prevalente e comunque non inferiore a 9 euro all’ora al lordo degli oneri contributivi e previdenziali.
Questa definizione, così come i rimanenti articoli del disegno di legge, presenta dei punti discutibili. Da un lato, la proposta depositata al Senato sembra offrire preziose sponde che potrebbero rivelarsi utili per conquistare maggiori tutele per i lavoratori, in particolare con riferimento ai cosiddetti ‘lavoratori poveri’, ossia quelli caratterizzati dai salari più bassi.
Leggi tutto
Guglielmo Forges Davanzati: La disoccupazione giovanile e la proposta di Stato innovatore di prima istanza
La disoccupazione giovanile e la proposta di Stato innovatore di prima istanza
di Guglielmo Forges Davanzati
 L’aumento della disoccupazione
giovanile, secondo la visione dominante, è da imputarsi al
mancato incontro fra la domanda di lavoro espressa dalle
imprese e l’offerta di lavoro proveniente dai lavoratori.
Questi ultimi – si
sostiene – ricevono da scuola e Università una formazione
generalista, eccessivamente calibrata sull’acquisizione di
conoscenze e
poco attenta alla trasmissione di competenze. Le competenze –
il saper fare – sono (o sarebbero) quelle di cui le imprese,
in
un’ottica di breve periodo, hanno bisogno. La linea di
politica economica che ne discende fa riferimento alla
necessità di riformare i
sistemi formativi per renderli funzionali alla produzione di
forza-lavoro ‘occupabile’.
L’aumento della disoccupazione
giovanile, secondo la visione dominante, è da imputarsi al
mancato incontro fra la domanda di lavoro espressa dalle
imprese e l’offerta di lavoro proveniente dai lavoratori.
Questi ultimi – si
sostiene – ricevono da scuola e Università una formazione
generalista, eccessivamente calibrata sull’acquisizione di
conoscenze e
poco attenta alla trasmissione di competenze. Le competenze –
il saper fare – sono (o sarebbero) quelle di cui le imprese,
in
un’ottica di breve periodo, hanno bisogno. La linea di
politica economica che ne discende fa riferimento alla
necessità di riformare i
sistemi formativi per renderli funzionali alla produzione di
forza-lavoro ‘occupabile’.
Il fatto che alcune imprese, in alcuni particolari segmenti del mercato del lavoro, trovino (o denuncino) difficoltà nel reperire manodopera con il livello e la qualità della formazione richiesta non implica che l’intera disoccupazione giovanile in Italia (superiore al 60% in alcune regioni del Sud) dipenda dal mismatch fra competenze offerte e competenze richieste. Per smentire questa tesi, può essere sufficiente considerare che oltre il 40% delle imprese italiane dichiara di non occupare – o non intendere assumere – laureati, a fronte del 18% della Spagna e del 20% della Germania.
La disoccupazione giovanile italiana – da molti anni superiore alla media europea – dipende essenzialmente dal combinato di un calo di lungo periodo della domanda aggregata (calo si è manifestato con la massima intensità a seguito dello scoppio della prima crisi, nel 2007-2008, e che ha avuto impatti anche sulla disoccupazione di individui in età adulta e anche sulla disoccupazione di lungo periodo) e dalla crescente fragilità della nostra struttura produttiva, particolarmente nel Mezzogiorno. La disoccupazione giovanile è aumentata sia perché le imprese hanno trovato conveniente, in una fase recessiva, non licenziare lavoratori altamente qualificati per non dover sostenere i costi della formazione dei neo-assunti, sia per il blocco delle assunzioni nel pubblico impiego.
La teoria del mismatch fa propria una visione della formazione economicistica, funzionalista e di breve periodo: il sistema formativo – stando a questa visione – deve essere sottostare a vincoli propriamente economici.
Leggi tutto
di Alessandro Della Corte, Stefano Isola e Lucio Russo
 Ricorre quest’anno il
cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, e lo
ricordiamo formulando una domanda i
cui legami con quell’evento speriamo appariranno più chiari
nel seguito.
Ricorre quest’anno il
cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna, e lo
ricordiamo formulando una domanda i
cui legami con quell’evento speriamo appariranno più chiari
nel seguito.
Perché l’ideale platonico di un potere legittimato soltanto dalle superiori conoscenze dei suoi detentori sembra oggi tornato così seducente?
Alcune ragioni ci sembrano abbastanza ovvie. Il crollo del livello culturale medio della classe politica dà origine per reazione a una fisiologica ribellione contro “l’ignoranza al potere”, che facilmente può generare o alimentare l’ideale platonico.
Un tale ideale diviene particolarmente comprensibile, anche se non necessariamente condivisibile, ammettendo di vivere in un mondo che soltanto gli “scienziati” possono comprendere e modificare. Ciò darebbe loro il diritto, si potrebbe sostenere, di decidere anche per i non-scienziati, ovvero per coloro che per ignoranza non sono in grado di discernere la verità dietro le apparenze e conseguentemente agiscono come gli incatenati nella caverna platonica.
Un mondo di questo tipo è stato immaginato molte volte nella storia. Ad esempio da Francesco Bacone, il quale vedeva negli scienziati i soli esseri dotati di un sapere in grado di trasformare la realtà e di assicurare una vita migliore all’intera umanità. Idee di questo tipo, per altro, hanno avuto largo spazio tra la fine del XVII e il XVIII secolo, grazie alle società scientifiche impegnate, tra le altre cose, ad applicare la scienza a problemi che interessavano gli Stati nazionali, nonché alla stessa visione strategica tipica del dispotismo illuminato.
D’altra parte, al tempo in cui viveva Platone, e ancora in quello di Bacone, gli esseri umani si muovevano con una certa fiducia in un mondo regolato da una molteplicità di fattori: la cultura, il linguaggio, la politica, le istituzioni, le arti, le attività pratiche, etc., e anche chi non riteneva desiderabile l’ideale platonico, difficilmente poteva crederlo una reale minaccia per la libertà e la dignità umane. E questo anche perché quell’ideale, e il mondo che lo avrebbe potuto legittimare, non poteva stabilirsi se non come una proiezione dell’immaginazione, poiché l’insieme delle possibilità d’intervento tecnico sul mondo era incommensurabile con la varietà dell’esperienza umana, per orientarsi nella quale si continuava ad avvalersi perlopiù del senso comune e del linguaggio quotidiano.
Leggi tutto
Andrea Zhok: "Noi europei"
"Noi europei"
di Andrea Zhok
Tra i numerosi argomenti a tema 'migranti' che ho sentito questi giorni uno di quelli che ho trovato più irritanti è stato quello di un amico che spiegava come "noi europei", in quanto residenti in una terra ricca, avevamo il dovere morale di aiutare i migranti dall'Africa.
L'irritazione qui è dovuta al fatto che l'argomento mette un'intenzionale confusione verbale al servizio di una severa reprimenda morale.
Si presenta agli occhi del lettore qualcosa di simile all'intuizione morale di San Martino che divide il suo mantello per aiutare il mendicante, e si incita allo sdegno nei confronti di chi resisterebbe a tale intuizione (definendolo, per inciso, con una chiusa ineffabile, "nazista contemporaneo".)
Ora, cercando di raffreddare gli animi di fronte alle oramai usuali accuse di 'nazismo' che alcuni settori si sentono in diritto di rivolgere a chi non la pensa come loro, esaminiamo brevemente questo argomento.
La confusione mentale è costruita intorno all'espressione "noi europei", in cui si costruisce ad hoc un'entità fittizia, cui si attribuisce inoltre una volontà e capacità d'azione unitarie, parimenti fittizie.
Nel "noi europei", senza perdere troppo tempo in quisquiglie, vengono fatti dunque rientrare i bambini di Scampia o di Metaxourgeio, e quelli di Zurigo o Monaco.
Leggi tutto
Gianpasquale Santomassimo: Quando è cominciato il delirio del cosmopolitismo nella sinistra italiana?
Quando è cominciato il delirio del cosmopolitismo nella sinistra italiana?
di Gianpasquale Santomassimo
Quando è cominciato il delirio del cosmopolitismo nella sinistra italiana? Da quando questa penosa caricatura delle vecchie fantasie ottocentesche dell’anarchismo per cui nostra patria dovrebbe essere il mondo intero è divenuta l’ideologia ufficiale dominante nel piccolo mondo, sempre più ristretto, della sinistra moderata e radicale? Probabilmente si sarebbe tentati di rispondere che nasce con la seconda repubblica e col trattato di Maastricht, in stretta connessione con l’accettazione dell’europeismo quale orizzonte obbligato, di natura politica economica e finanche religiosa (di religiosità laica al principio, poi religione vera e propria, con i suoi misteri, i suoi officianti, i dogmi, il senso di terrore e tremore che deve incutere ai reprobi).
Ma in realtà non è proprio così. Per una prima fase apparve importante, quasi centrale, riaffermare l’identità italiana. Rispondendo all’affermazione leghista nel Nord, nelle forme secessioniste che allora connotavano la Lega di Bossi, si aprì un dibattito lungo e impegnativo, che coinvolse anche e soprattutto la sinistra. Cosa poteva accadere “Se cessiamo di essere una nazione”? Era il titolo del libro di Gian Enrico Rusconi del 1993 che inaugurò la discussione, che fu lunga e a tratti intensa, e che vide emergere anche elaborazioni di portata non trascurabile. Ricorderei soprattutto “Patria. Circumnavigazione di una idea controversa” di Silvio Lanaro del 1996, che giungeva a un punto di vista a mio avviso di grande chiarezza storica, largamente condivisibile e di grande attualità, non solo legata a quel dibattito.
Leggi tutto
Piemme: Bagnai, Brancaccio e Bankitalia
Bagnai, Brancaccio e Bankitalia
di Piemme
In coda alla critica di Brancaccio ai MiniBoT, da noi pubblicata ieri, un nostro lettore ha commentato:
«Dai, se uno non riesce nemmeno a entrare a via Nazionale e a sfrattare i vecchi inquilini, ma come spera di uscire dall'euro? Le mezze misure di Varou-fikis già abbiamo visto che risultati hanno dato! Borghi vuole seguire la stessa strada? No grazie! Molto meglio il Brancaccio leninista che ci invita a prendere palazzo Koch».
Premesso che le "mezze misure" di Varoufakis non vennero mai adottate dal governo Tsipras, siamo d'accordo che occorre "sfrattare i vecchi inquilini" (tutti di indefessa fede eurista) per quindi "prendere Palazzo Koch", ovvero riportare Bankitalia sotto controllo pubblico. Nella partita a scacchi con Bruxelles e Francoforte questa mossa, equivarrebbe, come chiunque può capire, come fare scacco matto — sarebbe insomma la sanzione definitiva dell'uscita. Non per questo, come abbiamo segnalato, quello dei MiniBoT sarebbe un "falso problema". A certe condizioni potrebbe essere una mossa difensiva per poi quindi mettersi nelle condizioni portare lo scacco matto.
Forse ci sbagliamo ma il giudizio stroncante di Brancaccio sui MiniBoT ne implica uno politico a monte, la radicale sfiducia non solo nell'attuale compagine governativa giallo-verde e, anzitutto, nel gruppo di economisti di Salvini, Bagnai e Borghi anzitutto. Egli pare escludere che essi abbiano un "Piano B" di uscita ove il "Piano A" di cambiare i Trattati fallisse (detto per inciso: noi pensiamo che fallirà).
Leggi tutto
Federico Gonzato: “Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo” di Marco Delmastro e Antonio Nicita
“Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo” di Marco Delmastro e Antonio Nicita
Recensione di Federico Gonzato
Marco Delmastro e Antonio Nicita, Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo, Il Mulino, Bologna 2019, pp. 168, euro 11 (scheda libro)
«Il mondo sta diventando un computer. L’informatica è sempre più connessa a tutto quello che facciamo, a ogni aspetto della nostra vita quotidiana». A leggerlo, questo virgolettato pare la citazione di un romanzo fantascientifico di quelli, per intenderci, alla Aldous Huxley o alla Ray Bradbury. Invece, questa frase, all’apparenza distopica ma in realtà quanto mai attuale, è tratta dall’intervento di Satya Nadella, CEO di Microsoft, tenutosi all’Università Bocconi lo scorso 30 maggio. In viaggio in Italia in occasione del Microsoft Innovation Summit, Nadella ha stretto accordi con una serie di grandi attori italiani del settore delle comunicazioni: Microsoft fornirà loro le più avanzate tecnologie di data analytics, machine learning e intelligenza artificiale.
Ma di cosa parliamo quando facciamo riferimento a questi termini, magari così complessi e all’apparenza lontani dalle nostre vite? Cosa intendiamo quando parliamo di rivoluzione o capitalismo digitale? Quali sono le sfide, e i rischi, che pone di fronte a noi l’innovazione tecnologica? Queste le domande che si pongono due economisti, Marco Delmastro e Antonio Nicita.[1] Dalla loro riflessione è nato un libro: Big data. Come stanno cambiando il nostro mondo (Il Mulino, 2019).
Leggi tutto
Giuseppe Masala: Il parere di Visco sulla Libra di Facebook
Il parere di Visco sulla Libra di Facebook
di Giuseppe Masala
Quando ascolti i banchieri centrali della UE sulle cryptovalute hai un forte senso di spaesamento. Non capisci se ci fanno o se ci sono. Innanziutto salta all'occhio la denominazione di bitcoin come un "cryptoasset" ma asset di cosa? E' un obbligazione? No. E' un azione che rappresenta una quota di capitale di un azienda? No. E' un titolo che rappresenta un barile di petrolio o un metrocubo di metano? No. E' un titolo che rappresenta una tonnellata di grano o di riso? No. Alla base del suo valore non vi è assolutamente nulla. Dunque non è un asset. E' invece un insieme di segni che rappresentano valore sulla base di un valore non economico: la fiducia.
Se le monete tradizionali vedono la loro fiducia basata sull'autorevolezza degli stati che le emettono le cryptomonete vedono alla base della fiducia la forza della matematica (la crittografia è matematica) e della tecnologia che danno la sicurezza a chi le usa dell'impossibilità che possano essere falsificate da terzi. Questa che ho appena dato è la definizione ontologica di moneta. Per capirci, quella che non conoscono gli economisti e che bisogna chiedere ai filosofi e ai semiologi (che di moneta capiscono molto anche se gli economisti non se ne accorgono perchè accecati dalla sicumera e dalla presunzione).
Mentre dal punto di vista funzionale la cryptomoneta è misura di valore, riserva di valore e intermediario degli scambi. Esattamente come le monete di stato a corso legale.
Leggi tutto
Potere Al Popolo!: Potere al Popolo: sintesi, analisi e proposte della 6° Assemblea Nazionale
Potere al Popolo: sintesi, analisi e proposte della 6° Assemblea Nazionale
di Potere Al Popolo!
 Domenica
scorsa Potere al Popolo ha convocato a Roma la sua sesta
Assemblea Nazionale per
fare il punto su quanto fatto finora e sulle sfide che ci
attendono. L’Assemblea è riuscita ogni oltre previsione: più
di 500
persone sono venute da tutta Italia e anche dai nodi esteri
a portare, in quasi 50 interventi, un patrimonio di idee,
proposte, esperienze e
umanità, hanno condiviso rabbia e gioia, ingiustizie e lotte
vincenti, con spirito positivo e con il sentimento di stare
costruendo una
comunità e uno strumento utile per tutti gli sfruttati.
Insieme abbiamo rinnovato quell’impegno a “fare tutto al
contrario”
rispetto a quello che abbiamo visto nella politica italiana
di questi anni.
Domenica
scorsa Potere al Popolo ha convocato a Roma la sua sesta
Assemblea Nazionale per
fare il punto su quanto fatto finora e sulle sfide che ci
attendono. L’Assemblea è riuscita ogni oltre previsione: più
di 500
persone sono venute da tutta Italia e anche dai nodi esteri
a portare, in quasi 50 interventi, un patrimonio di idee,
proposte, esperienze e
umanità, hanno condiviso rabbia e gioia, ingiustizie e lotte
vincenti, con spirito positivo e con il sentimento di stare
costruendo una
comunità e uno strumento utile per tutti gli sfruttati.
Insieme abbiamo rinnovato quell’impegno a “fare tutto al
contrario”
rispetto a quello che abbiamo visto nella politica italiana
di questi anni.
Dopo un anno e mezzo, infatti, non ci è passata la voglia – e anzi pensiamo sia sempre più necessario – essere diversi da quella politica fatta di molte chiacchiere e pochi fatti, molto verticismo e poca partecipazione, molto opportunismo e poco spirito di servizio, molti personalismi e poco senso del collettivo, molta ideologia e poca concretezza, molta immagine e propaganda e poca sostanza, molti litigi e poca voglia di pratiche comuni…
In quest’anno e mezzo di vita abbiamo toccato con mano che “fare tutto al contrario” è davvero possibile, che è possibile costruire un nuovo tipo di organizzazione, far partecipare le persone e anche ottenere vittorie. Certo, ci siamo sempre più convinti che occorra essere onesti sulle tante difficoltà che un progetto come il nostro deve affrontare, ma anche che bisogna cercare sempre l’aspetto che possa volgerle al positivo.
Stiamo facendo ed accumulando esperienze sul campo, spesso in modo diversificato, stiamo aggregando nuove persone, molte delle quali giovani o nuove alla politica, stiamo cercando di radicarci sui territori aprendo Case del Popolo, ricomponendo settori della società lì dove le classi dominanti hanno lavorato a dividere, disgregare, contrapporre. Stiamo cercando di migliorare il nostro programma attraverso 13 tavoli di lavoro nazionali e, dopo le ultime elezioni amministrative in cui abbiamo eletto consiglieri, abbiamo iniziato a sperimentare anche il lavoro nelle istituzioni di prossimità. Ma siamo perfettamente consapevoli che tantissimo resta ancora da fare per diventare un’opzione credibile agli occhi delle classi popolari.
Le pagine che seguono sintetizzano appunto le analisi e le proposte emerse dall’Assemblea Nazionale per riuscire a crescere, organizzarsi meglio, risultare più incisivi.
Leggi tutto
Michael Roberts: Economia per l'estate
Economia per l'estate
di Michael Roberts
 La scorsa settimana, Martin Wolf,
il giornalista di economia del Financial Time, ha fatto
l'elenco dei nuovi libri di economia da lui
raccomandati per lettura estiva. Ha cominciato con "Austerità.
Quando funziona e quando no", di Francesco
Giavazzi,
Alberto Alesina e Carlo Favero (Rizzoli). Wolf lo ha
commentato dicendo che «questo un libro
estremamente importante. Il libro fa
uso di prove empiriche che permettono di valutare gli
effetti dell'austerità fiscale messa in atto attraverso i
tagli alla spesa in
contrapposizione all'aumento delle tasse. Conclude dicendo
che gli effetti negativi dei tagli alla spesa sono
inferiori rispetto a quelli causati
dall'aumento delle tasse. Inoltre, i programmi basati
sulla spesa sono più efficaci ai fini della riduzione
della crescita del debito di quanto
lo sia l'aumento delle tasse. Tuttavia, va notato che i
costi vengono valutati solo in termini di produzione
cumulativa, e viene pertanto ignorato
quello che è l'impatto distributivo del taglio alla spesa
rispetto all'aumento delle tasse». Alesina e
gli altri sono stati
a capo dei sostenitori dell'impatto positivo che l'«austerità»
avrebbe sulla crescita economica, in
contrasto con la montagna di prove provenienti dal FMI e dalle
altre fonti che sostengono che le politiche di austerità non
hanno aiutato
(piuttosto ostacolato) la ripresa economica in nessuna delle
maggiori economie capitaliste.
La scorsa settimana, Martin Wolf,
il giornalista di economia del Financial Time, ha fatto
l'elenco dei nuovi libri di economia da lui
raccomandati per lettura estiva. Ha cominciato con "Austerità.
Quando funziona e quando no", di Francesco
Giavazzi,
Alberto Alesina e Carlo Favero (Rizzoli). Wolf lo ha
commentato dicendo che «questo un libro
estremamente importante. Il libro fa
uso di prove empiriche che permettono di valutare gli
effetti dell'austerità fiscale messa in atto attraverso i
tagli alla spesa in
contrapposizione all'aumento delle tasse. Conclude dicendo
che gli effetti negativi dei tagli alla spesa sono
inferiori rispetto a quelli causati
dall'aumento delle tasse. Inoltre, i programmi basati
sulla spesa sono più efficaci ai fini della riduzione
della crescita del debito di quanto
lo sia l'aumento delle tasse. Tuttavia, va notato che i
costi vengono valutati solo in termini di produzione
cumulativa, e viene pertanto ignorato
quello che è l'impatto distributivo del taglio alla spesa
rispetto all'aumento delle tasse». Alesina e
gli altri sono stati
a capo dei sostenitori dell'impatto positivo che l'«austerità»
avrebbe sulla crescita economica, in
contrasto con la montagna di prove provenienti dal FMI e dalle
altre fonti che sostengono che le politiche di austerità non
hanno aiutato
(piuttosto ostacolato) la ripresa economica in nessuna delle
maggiori economie capitaliste.
Quando Alesina e gli altri hanno pubblicato per la prima volta un documento a tal proposito, hanno calcolato che «gli aggiustamenti fiscali basati sui tagli alla spesa erano stati assi meno costosi, in termini di perdita di produzione, di quelli basi sull'aumento delle tasse. [...] gli aggiustamenti basati sulla spesa generavano recessioni assai piccole, con un impatto sulla crescita del prodotto non significativamente diversa da zero.» E «Le nostre conclusioni sembrano pertinenti a degli aggiustamenti fiscali sia prima che dopo la crisi finanziaria. Non possiamo respingere l'ipotesi secondo la quale gli effetti degli aggiustamenti fiscali, soprattutto in Europa nel 2009-13, siano stati indistinguibili da quelli precedenti».
Leggi tutto
Stefano Paterna: L’italia nell’attuale congiuntura socio-economica
L’italia nell’attuale congiuntura socio-economica
Intervento a nome del collettivo la Città futura
di Stefano Paterna
 Duecento anni fa nasceva un uomo che ha
cambiato il mondo. E lo ha cambiato
perché per la prima volta ha posto l’umanità e la sua storia,
le sue lotte, su di un fondamento scientifico, materiale.
Quest’uomo, iconoclasta, sottilissimamente sarcastico (“di
certo, io non sono marxista!”) è stato filosofo, ma era
sommamente
scontento della filosofia: “I filosofi hanno variamente
interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo”; è stato
economista, ma
era piuttosto insoddisfatto dell’economia borghese, nonostante
la sua ammirazione per Adam Smith e David Ricardo; è stato un
grande
organizzatore politico, ma era pronto a gettare tutto nel
macero, nel momento in cui l’organizzazione non fosse più
stata funzionale
all’obiettivo: la Rivoluzione proletaria internazionale! Non
conosceva cioè la grande malattia dei comunisti della nostra
epoca:
il patriottismo della sigla! Non aveva quindi
nessun gusto per la “politique politicienne”, anzi la
politica
voleva abolirla, insieme allo Stato e alla società divisa in
classi.
Duecento anni fa nasceva un uomo che ha
cambiato il mondo. E lo ha cambiato
perché per la prima volta ha posto l’umanità e la sua storia,
le sue lotte, su di un fondamento scientifico, materiale.
Quest’uomo, iconoclasta, sottilissimamente sarcastico (“di
certo, io non sono marxista!”) è stato filosofo, ma era
sommamente
scontento della filosofia: “I filosofi hanno variamente
interpretato il mondo, ora si tratta di cambiarlo”; è stato
economista, ma
era piuttosto insoddisfatto dell’economia borghese, nonostante
la sua ammirazione per Adam Smith e David Ricardo; è stato un
grande
organizzatore politico, ma era pronto a gettare tutto nel
macero, nel momento in cui l’organizzazione non fosse più
stata funzionale
all’obiettivo: la Rivoluzione proletaria internazionale! Non
conosceva cioè la grande malattia dei comunisti della nostra
epoca:
il patriottismo della sigla! Non aveva quindi
nessun gusto per la “politique politicienne”, anzi la
politica
voleva abolirla, insieme allo Stato e alla società divisa in
classi.
Quest’uomo, perché di uomo si tratta con le sue fisime, i suoi limiti e i suoi abbagli (non avrebbe scommesso un centesimo su una rivoluzione socialista in Russia) non avrebbe amato questo elogio: di sé diceva che “nulla di ciò che è umano mi è estraneo” e in un elogio commemorativo c’è sempre qualcosa di falso, di divinizzatorio. No, Marx non sarebbe stato contento di elogi e bicentenari. Ma noi da “buoni marxisti” non siamo obbedienti nemmeno alle sue opinioni.
Quest’uomo, dicevo, dall’89 è stato variamente oltraggiato, deriso, liquidato (Marx è morto), salvo poi essere recuperato dai suoi avversari di classe (e perfino da un alto prelato della Chiesa Cattolica tedesca) perché incapaci altrimenti di comprendere la crisi mondiale in cui siamo tutti riprecipitati dal 2008 in poi. Crisi che gli apologeti del capitalismo hanno pudicamente definito “finanziaria”, ma che è evidentemente ciò che Marx aveva visto più di 150 anni fa: ovvero una enorme crisi di sovrapproduzione, e ciò mentre milioni di esseri umani in Africa, America Latina e Asia (ma anche nel famoso “Primo Mondo” ormai) non hanno di che vivere: quando cioè viene negata loro, in nome delle ragioni superiori del mercato, la salute, il lavoro, la cultura. Questo è, al rovescio, l’orribile “elogio” che la borghesia fa a Karl Marx!
Leggi tutto
Alexander Damiano Ricci: Red Carpet Courts: le cause delle multinazionali contro gli Stati valgono 623 miliardi di dollari
Red Carpet Courts: le cause delle multinazionali contro gli Stati valgono 623 miliardi di dollari
di Alexander Damiano Ricci
Cause legali per un valore complessivo di 623 miliardi di dollari americani.
È il volume di denaro colossale “chiamato in causa” da multinazionali e investitori internazionali, a livello globale, nel quadro dei procedimenti presso i tribunali di Risoluzione delle controversie tra investitori e Stati (ISDS: Investor-state dispute settlement).
A rivelare i nuovi numeri del fenomeno ISDS dalla sua nascita ad oggi, è il rapporto Red Carpet Courts – 10 stories of how the rich and powerful hijacked justice, pubblicato lunedì 24 giugno e siglato da quattro organizzazioni non-governative internazionali: Friends of the Earth Europe (FoEE), Friends of the Earth Europe International (FoEI), the Transnational Institute (TNI) e Corporate Europe Observatory (CEO).
Ciliegina sulla torta: i 623 miliardi fanno riferimento “soltanto” al 70 per cento delle cause per cui è possibile accedere agli atti. I procedimenti ISDS sono infatti – almeno durante il loro svolgimento – tutelati da segretezza assoluta.
Ma cosa sono questi tribunali di Risoluzione?
Gli ISDS nascono verso la fine degli anni ‘50 – in piena fase di “decolonizzazione” – come strumento di garanzia per gli investitori internazionali nei confronti di misure protezionistiche ed espropriazioni attuate da governi di Paesi in via di sviluppo.
Leggi tutto
Cristina Quintavalla, Antonio De Lellis: Il debito italiano si può ripudiare?
Il debito italiano si può ripudiare?
di Cristina Quintavalla, Antonio De Lellis*
Alla fine la realtà si impone sull’ideologia. Pubblichiamo questo pezzo-recensione che parla di debito pubblico, sua formazione, rimborsabilità, ecc, non perché dica cose originalissime, ma per il luogo in cui è apparso. il manifesto, fin quando ne hanno fatto parte Valentino Parlato e Galapagos, era attentissimo ai problemi dell’economia – alla “struttura” dei rapporti sociali; ed anche quando si potevano non condividere alcune (molte) posizioni politiche, era comunque un’ottima fonte di informazione e formazione culturale di quella che veniva allora chiamata “sinistra”.
Poi il buio. In senso letterale, come scomparsa dei temi economici (e a maggior ragione la loro analisi critica) e prevalere di un “sentito dire” fondamentalmente “europeista” (basti vedere il trattamento riservato a La France Insoumise o ai gilets jaunes).
Scrivere, su quel giornale, sebbene nell’ambito della recensionead un libro, che il debito pubblico è una trappola strutturata da multinazionali, finanza e UE (lato Bce, in questo caso); che bisognerebbe rompere quei “contratti” (trattati) controfirmati da dirigenti politici “democratici” non si sa se più incompetenti o complici; e che neanche Salvini, nonostante la retorica quotidiana, è in realtà interessato a rompere alcunché…
Beh, è una novità che si spiega solo con la forza dirompente, paziente e implacabile della realtà sull’ideologia. Che, ricordiamo è “falsa coscienza” [redaz.]…
Leggi tutto
Ann Pettifor: Le entrate fiscali finanziano la spesa pubblica?
Le entrate fiscali finanziano la spesa pubblica?
di Ann Pettifor
L’economista britannica Ann Pettifor spiega molto efficacemente come il riequilibrio dei conti pubblici non possa essere il risultato di aumenti delle tasse e di tagli di spese, non solo perché tali politiche restrittive drenano risorse dall’economia reale e impoverendola riducono lo stesso gettito fiscale, ma anche perché le imposte e le tasse non sono proprio da considerare come la fonte del finanziamento pubblico. La spesa pubblica si finanzia con l’emissione dei titoli del debito pubblico, fornendo così un rifugio sicuro all’impiego dei risparmi dei cittadini, ed è essa stessa poi a generare il reddito e quindi le entrate fiscali necessarie a rimborsare i titoli emessi
Nella sua edizione del 25 gennaio l’Economist ha pubblicato un pezzo sulla base imponibile britannica. L’articolo inizia con un riferimento al discorso di Denis Healey alla conferenza dei laburisti del 1973, in cui egli prometteva aumenti fiscali che sarebbero stati accolti con “alte grida di dolore” da parte di tutti, non solo dei ricchi. Si dà il caso che la scorsa settimana abbia passato in rassegna l’elenco dei cancellieri laburisti. Con l’eccezione di Hugh Dalton, erano tutti economicamente ortodossi, e quasi tutti hanno fatto ricorso all’aumento delle tasse e al taglio della spesa pubblica. In altre parole, credevano che i bilanci pubblici fossero come i bilanci delle famiglie e che la spesa pubblica potesse essere finanziata solo aumentando le tasse. Ritenevano che fosse indispensabile essere ricordati come cancellieri “prudenti”, impegnati a “riequilibrare i conti del governo” – prima di tutto.
Leggi tutto
Fernanda Mazzoli: Il problema non è chi taglia il traguardo: il problema è il traguardo
Il problema non è chi taglia il traguardo: il problema è il traguardo
di Fernanda Mazzoli
Nella Scuola si vuole imporre come traguardo il passaggio dalla formazione della personalità umana alla formazione del capitale umano
Il dibattito sviluppatosi negli ultimi mesi intorno alla richiesta di autonomia differenziata inoltrata da diverse regioni italiane tocca nodi culturali ed etici che vanno ben al di là della questione in oggetto, già di per sé piuttosto rilevante.[1]
Uno di questi è rappresentato da una delle obiezioni più ricorrenti da parte di chi si oppone a questo processo di progressiva messa in discussione dell’unità nazionale: anche qualora venga garantita la tenuta di un quadro unitario di massima, attraverso i LEP (Livelli Essenziali di Prestazione), si corre, comunque, il rischio di un Paese a due velocità, corrispondenti grossomodo ai due poli, prima ancora che geografici, sociali ed economici Nord/Sud. Il trattenimento in loco di una quota maggiore del gettito fiscale prodotto da ogni regione riduce la fiscalità generale e, quindi, la possibilità di una ridistribuzione che riequilibri le differenze fra regioni con capacità produttive diverse, soprattutto in merito all’erogazione di tutta una serie di servizi legati alla cittadinanza. Il divario tra Nord e Sud, tra territori ricchi e territori poveri si troverà, così, ad essere accentuato, in dispregio al dettato costituzionale. Tutto vero e tutto giusto ed è, questa, una delle ragioni – ce ne sono, infatti, molte alter – di ripulsa di questa sciagurata proposta, resa possibile dalla riforma del Titolo V della Costituzione, voluta dal governo Amato nel 2001.
Leggi tutto
Marco Cedolin: Le multinazionali del petrolio investono miliardi per fingere di vestirsi di verde
Le multinazionali del petrolio investono miliardi per fingere di vestirsi di verde
di Marco Cedolin
Quando ci si trova di fronte ad un problema insormontabile, le uniche alternative sono quelle di arrendersi all’evidenza o tentare di cavalcarlo trasformandolo in un’opportunità.
Le multinazionali del petrolio, per nulla intenzionate a estinguersi in un futuro dove l’inquinamento e i cambiamenti climatici promettono di farla da padrone e i combustibili fossili siedono in prima fila al banco degli imputati, hanno senza dubbio realizzato come l’unica scelta fattibile fosse la seconda e occorresse attivarsi in fretta per perseguirla. Così, accanto agli sforzi ciclopici profusi nell’intento d’influenzare l’agenda politica mondiale, affinché ogni progetto che potesse ledere i loro interessi restasse impaludato nelle sabbie mobili della burocrazia e le controversie all’interno del mondo scientifico venissero esacerbate, producendo un immobilismo che potesse giocare a loro favore, hanno pensato bene di proporsi in prima persona come improbabili attori di una “rivoluzione verde” che per forza di cose non potrà mai essere nelle loro corde.
Molto spesso infatti, in TV e sui giornali, capita d’imbattersi in spot entusiastici, dove proprio le multinazionali che da sempre avvelenano il pianeta si presentano come anime candide intrise di sincero spirito ecologista, che si spendono con tutte le proprie forze nella creazione di un futuro dove l’attenzione per l’ambiente e le problematiche della biosfera venga anteposta alla logica del profitto, nel bene dell’interesse collettivo.
Leggi tutto
Hits 3911
Hits 2947
Hits 2663
Hits 2336
Hits 2089
Hits 1930
Hits 1904
Hits 1879
tonino

Guido Salerno Aletta: Tra cronaca e Storia: perchè scricchiola l’asse franco-tedesco
Tra cronaca e Storia: perchè scricchiola l’asse franco-tedesco
di Guido Salerno Aletta
 Distrarre “gli itagliani” dai problemi veri è
facilissimo,
basta scegliersi un diversivo facile facile. Farli
appassionare alle vicende internazionali, invece, è
difficilissimo; anche se sono queste,
quasi sempre, le vere cause di problemi che poi ci si
affanna a scaricare sui più deboli.
Distrarre “gli itagliani” dai problemi veri è
facilissimo,
basta scegliersi un diversivo facile facile. Farli
appassionare alle vicende internazionali, invece, è
difficilissimo; anche se sono queste,
quasi sempre, le vere cause di problemi che poi ci si
affanna a scaricare sui più deboli.
Il conflitto attuale nell’Unione Europea per rinnovare tutte le cariche istituzionali principali è accuratamente tenuto lontano dai riflettori. Intanto perché mostra con enorme evidenza il fatto che questo governo, a Bruxelles, conta quanto il due coppe quando regna denari. E molto perché – dal tourbillon delle cariche di rilievo – questo governo è di fatto escluso. Sarebbe difficilissimo anche per dei mentitori professionali come loro, infatti, far passare come “vittoria” la perdita di ben tre poltrone importanti (presidente del Parlamento europeo, pesidente della Bce, “ministro degli esteri” europeo) senza alcuna compensazione.
Ma c’è molto di più in ballo, e determinerà il corso dei prossimi anni.
Questa analisi dell’attento Guido Salerno Aletta smonta molta retorica “europeista”, indicando interessi, esigenze, rapporti di forza che si tende invece a nascondere sotto la maschera dell’”Europa unita”. Cugini coltelli, nel migliore dei casi. Perché nella logica del capitale multinazionale non ci sono valori né leggi, solo occasioni di business oppure perdite.
Buona lettura [redaz.].
*****
Un passato senza futuro: era il 19 giugno 2018, appena un anno fa, quando Francia e Germania firmarono congiuntamente la Dichiarazione di Mesenberg, un testo dal titolo promettente e dai contenuti ancor più accattivanti: “Rinnovare gli impegni europei di sicurezza e prosperità”. Era già un compromesso rispetto alle ambizioni francesi, ma almeno sembrava una via di uscita dalla morta gora in cui l’Unione si era trascinata per anni.
Parole incise sul marmo, un epitaffio verrebbe da dire oggi: già dalle prime parole, infatti, si capiva che il vento del neo-liberismo, quello delle riforme strutturali a tutti i costi, non era affatto calato. Enfasi assoluta:
Leggi tutto
Tomaso Montanari: Contro Zeffirelli: la necessità del dissenso
Contro Zeffirelli: la necessità del dissenso
di Tomaso Montanari
Pubblichiamo un testo che ancora solo pochi anni fa sarebbe sicuramente stato pubblicato come editoriale di prima pagina da qualche grande quotidiano italiano o sarebbe stato al centro dei principali talk show. Quantum mutatus ab illo! Ormai il conformismo culturale e politico ha talmente saturato la vita del paese, che un articolo esemplare nella valutazione di meriti e mediocrità culturali e nella semplicità di adesione ai valori della nostra Costituzione, trova spazio solo in testate minoritarie di resistenza eretica democratica. (pfd'a)
 Vorrei provare a tracciare un provvisorio
bilancio della vicenda (sgradevole, ma
in fondo assai istruttiva) provocata dal cortocircuito tra una
mia frase iconoclasta contro il defunto Zeffirelli e l’uscita
di un mio testo tra
le tracce della maturità. Una vicenda sfociata nel dubbio
privilegio di un attacco personale contro di me da parte del
ministro Salvini, e
dunque nell’immancabile pestaggio mediatico da parte
dell’ormai larghissima corte di boia, capre e ballerine che
circonda (più o
meno consapevolmente) il Ministro della Paura.
Vorrei provare a tracciare un provvisorio
bilancio della vicenda (sgradevole, ma
in fondo assai istruttiva) provocata dal cortocircuito tra una
mia frase iconoclasta contro il defunto Zeffirelli e l’uscita
di un mio testo tra
le tracce della maturità. Una vicenda sfociata nel dubbio
privilegio di un attacco personale contro di me da parte del
ministro Salvini, e
dunque nell’immancabile pestaggio mediatico da parte
dell’ormai larghissima corte di boia, capre e ballerine che
circonda (più o
meno consapevolmente) il Ministro della Paura.
Il fulcro su cui ruota tutta questa vicenda ha un nome: dissenso. L’orizzonte che essa dischiude è, invece, quello del conflitto.
1. Necessità del dissenso
Come ho spiegato altrove tutto parte da un mio tweet.
Si può avere naturalmente un’opinione assai critica verso l’uso dei social media. Io stesso mi sono chiesto se sia giusto usare un mezzo che per sua natura impedisce riflessioni articolate, e produce una buona dose di fraintendimenti ed equivoci. Ma alla fine penso che sì, che sia giusto starci. Da papa Francesco a Salvini, è anche lì che si combatte una battaglia di opinione e di pensiero.
Ed è del resto la dinamica stessa di questa vicenda a dimostrare che anche un tweet può essere uno strumento utile, se il fine è la ricostruzione di un qualche pensiero critico diffuso.
L’aspetto più clamoroso della vicenda è proprio l’esiguità di quelle due mie righe di fronte alle centinaia di pagine e di spazio mediatico dedicati all’esaltazione di Franco Zeffirelli.
La morale è che il sistema non è disposto a tollerare nemmeno quelle due righe: nemmeno un atomo di dissenso. Il senso comune su cui poggia il consenso al potere è così fragile, sul piano razionale e argomentativo, che non si può permettere che qualcuno dica che il re è nudo.
Il dissenso è dunque pericoloso: e diventa pericolosissimo quando chi lo esprime rischia di acquistare autorevolezza mediatica, per esempio attraverso la sua inclusione nel ‘canone’ della maturità (tanto più insopportabile perché fatta da ‘burocrati’ ministeriali di un ministero controllato dalla Lega!). Ed è proprio allora che scatta il pestaggio.
Leggi tutto
Ivan Mikhajlovič Syroežin: Pianificabilità, pianificazione, piano
Pianificabilità, pianificazione, piano
di Ivan Mikhajlovič Syroežin
II parte – Pianificazione
Capitolo 4. L’autoregolamentazione nei sistemi economici (parte I)
 Cari compagni,
Cari compagni,
non potevo non iniziare questa seconda parte di lavoro con la foto di questo nonnino, dall’aria simpatica, ritratto con la sia nipotina. Il suo nome non dirà nulla a nessuno ma, siccome proprio nessuno non fu, è il caso che cominci a dire qualcosa a qualcuno, specialmente a chi come noi è ormai da un anno in parete e, moschettone dopo moschettone, sta puntando alla stessa cima da lui scalata più e più volte.
Si chiamava Nikolaj Konstantinovič Bajbakov (7 marzo 1911, Sabunçu, Impero Russo, attuale Azerbaigian, 31 marzo 2008, Mosca), uno che dal 1963 poteva permettersi di girare con, appuntata sulla giacca, una delle massime onorificenze dell’URSS, il premio Lenin (Лeнинская прeмия) e, dal 1981, la massima onorificenza sovietica in assoluto: Eroe del lavoro socialista (Герой Социалистического Труда), al netto di tutte le altre onorificenze conferitegli nella sua lunga vita.
La foto che segue lo ritrae nel lontano 26 giugno 1972, sul posto di lavoro. È il secondo da sinistra attorniato, oltre che dall’interprete e dalle immancabili alte cariche, anche da un ospite straniero che non ha bisogno di presentazioni.
Ebbene si: quel giorno Fidel Alejandro Castro Ruiz (1926-2016) stava visitando il Centro principale di calcolo del Gosplan dell’URSS (Главный вычислительный центр Госплана СССР1) e, a fianco, aveva il Presidente del Gosplan stesso, vicepresidente del Consiglio dei ministri dell’URSS, Nikolaj Bajbakov. Di quell’incontro è lo stesso Bajbakov, nelle sue memorie, a fornirci dettagli concreti, come la sua raccomandazione a Fidel, per esempio, di non puntare sulla monocoltura o di differenziare i salari operai in base al merito. È un libro prezioso, come tutte le autobiografie di personaggi di un certo spessore, scritto nel 1998, negli anni più neri della neonata Federazione Russa2.
Leggi tutto
Christian Marazzi: Impurità
Impurità
di Christian Marazzi
“In economia, la maggioranza ha sempre torto”. A scriverlo è stato JohnKenneth Galbraith, un brillante economista statunitense, autore diimportanti studi sul capitalismo americano (American Capitalism, 1952) esulla tendenza al gigantismo disfunzionale delle corporationsmultinazionali (The New Industrial State, 1967).
Alla attualità del suopensiero, pochi giorni fa Rana Foroohar ha dedicato un articolo sulFinancial Times (“Old economists can teach us new tricks”, 3 giugno2019) che merita di essere ripreso. Il nucleo centrale del pensiero diGalbraith è che i mercati privati, diversamente da quanto insegnatonelle facoltà di economia e professato dalla maggioranza dei politici, non sanno allocare in modo efficiente le risorse. Pertanto, l’intervento pubblico è necessario, specie laddove, come nella sanità, nelleinfrastrutture, nel settore scolastico, nell’ambiente, nelledisuguaglianze sociali, il settore privato non interviene per mancanzadi incentivi finanziari.
All’idea, sempre della maggioranza, che “privato è bene, pubblico è male”, Galbraith fece osservare che l’inefficienza organizzativa delle grandi imprese, al pari se non più dell’apparato pubblico, ha effetti negativi sull’innovazione e sullo zelo imprenditoriale. È il caso di dire che in economia è meglio scoprire vecchie verità che inventare nuove stupidaggini.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Verso le elezioni?
Verso le elezioni?
di Leonardo Mazzei
Ci sarà o meno l'accordo con l'Ue per fermare la "procedura d'infrazione"?
La questione è fondamentale, ma c'è un altro bivio decisivo che ci indicherà la direzione della politica italiana: si andrà oppure no alle elezioni anticipate a settembre?
Dalla risposta a questa seconda domanda dipende infatti anche il futuro del confronto-scontro con l'UE. Solo compattandosi il governo potrà andare avanti, e solo in quel caso possiamo ragionevolmente prevedere una certa capacità di resistenza all'attacco di Bruxelles e Francoforte. Se invece il governo cadrà, aprendo la strada alle elezioni anticipate, le èlite euriste avranno segnato un primo punto (quanto decisivo lo diranno solo i fatti) a loro favore.
Alle elezioni europee abbiamo motivato il nostro voto alle liste M5S solo ed esclusivamente sulla base di un ragionamento, ed un obiettivo, semplice semplice: quello di impedire che un successo troppo ampio della Lega spingesse quel partito al ritorno alle vecchie alleanze, quindi alla caduta del governo gialloverde, dunque alla fine dell'esperienza populista sostituita da una riemersione, per quanto debole e contraddittoria, del bipolarismo.
Vista da chi è ossessionato dalla modesta figura di Matteo Salvini, questa differenza tra populismo e bipolarismo può sembrare una cosa del tutto secondaria. Tanto, pensano costoro, a guidare questo od il futuro governo sarebbe sempre il fidanzato della figlia di Verdini. Dunque, perché preoccuparsene?
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: L'angelo della storia
L'angelo della storia
di Pierluigi Fagan
Ogni tanto, come saprete, torno a studiare la c.d. “nascita delle società complesse”, in particolare il caso a noi più vicino ovvero quello del Vicino Oriente mesopotamico. Sono in gioco le “origini” della gerarchia sociale, dell’ineguaglianza, del ruolo dell’economia nella strutturazione della società, l’immagine di mondo ed i suoi amministratori, la nascita dello Stato e della guerra sistematica. Insomma il “pacchetto” che contraddistingue le nostre società contemporanee.
L’indagine ha molti motivi per esser condotta, ma oggi ha anche una attualità in più. Un terremoto demografico come quello che si è prodotto tra inizi ‘900 ed oggi o anche meglio, dal 1950 ad oggi, disegna un “mondo” completamente diverso dal precedente. Poiché storicamente le “novità” si producono quasi sempre nel contesto ovvero esternamente alle società, sebbene poi noi si legga le trasformazioni come interne a queste (in realtà sono “adattamenti”), le “cause” dei cambiamenti profondi sono per lo più esterne.
Uno spazio fisico fisso (il mondo) che triplica la sua densità in settanta anni (1950-2020 da 2,5 a 7,5 miliardi di individui e da 70 a 200 Stati) è un terremoto di contesto che ha, e sempre più avrà, molte ripercussioni sull’organizzazione della nostra vita associata. Quindi il come si originò lo standard attuale torna d’attualità per provare a capire come potrebbe evolversi.
Leggi tutto
comidad: Dalla reductio ad Hitlerum alla reductio ad Salvinum
Dalla reductio ad Hitlerum alla reductio ad Salvinum
di comidad
Lo strano scandalo che ha investito il Consiglio Superiore della Magistratura sta avendo un esito paradossale. Ne sta infatti uscendo rafforzato il mito della “indipendenza” della magistratura o, quantomeno, della necessità assoluta di tale indipendenza, dato che l’infezione sarebbe partita dai politici. L’entità infetta che attenta all’indipendenza delle istituzioni che trovano il loro prestigio nella propria indipendenza (magistratura, Banca d’Italia), sarebbe appunto la “politica”.
L’aspetto curioso è che i magistrati presunti corrotti appartengono ad una associazione che si chiama “Magistratura Indipendente”, una corrente di destra, poiché l’indipendenza della magistratura negli anni ’60 era uno slogan della destra. A trionfare nell’attuale scontro interno alla magistratura sono le correnti di “sinistra”, come “Magistratura Democratica”, che sono diventate adesso proprio loro i principali alfieri di quella indipendenza, negando quindi quello che era il loro assunto quaranta anni fa, cioè l’ipocrisia del negare che l’azione giudiziaria risenta di un movente di parte. L’ipocrisia trionfa a 360 gradi e la politica viene additata come il corpo estraneo da esorcizzare. Per “indipendenza” infatti si intende sempre prendere le distanze da quelle cose losche che sono i partiti e gli uomini politici, mentre le lobby private non sono un problema.
Per denigrare meglio qualcosa o qualcuno, occorre esaltarne ed esagerarne l’importanza e oggi è il caso della “politica”, cioè una categoria che in realtà ha sempre meno presa sugli aspetti decisivi del potere, a cominciare dalla gestione del denaro.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: ONG. È solo il capitalismo
ONG. È solo il capitalismo
di Alessandro Visalli
Poche semplici questioni:
- L’attuale assetto del mondo è retto dagli squilibri,
- Ogni squilibrio determina, nella logica indefettibile del sistema, una domanda
- Il capitalismo è un sistema senza testa e decentrato che traduce spontaneamente ogni domanda in una occasione di profitto
- Quando il capitalismo produce una soluzione l’unico scopo è generare profitto, tutto il resto, incluso la domanda è solo un mezzo
Veniamo al sottocaso della gestione della domanda costituita dallo squilibrio di ricchezza media, o percepita, tra due aree del mondo contigue.
- Essa si traduce in un capillare, spontaneo, flusso di persone dal luogo a minore ricchezza a quello a maggiore.
- Questa domanda è funzione del premio atteso e della difficoltà dell’atto,
Ma quale altro squilibrio genera una domanda che può essere messa in connessione, e dunque produrre una soluzione?
- l’enorme ineguaglianza, crescente, produce nel mondo occidentale una massa di denaro libero e disponibile,
Leggi tutto
La rete intrappola la democrazia
di Antonio Cecere
Paolo Ercolani è tornato, in Figli di un io minore (Marsilio 2019), a riesaminare, da una prospettiva alternativa a quella popperiana, il rapporto fra democrazia e conoscenza. Vi si collega una proposta di costruzione di una nuova società della conoscenza che merita di essere attentamente valutata
 A distanza di sette anni da L’ultimo di
Dio (Dedalo 2012),
Paolo Ercolani torna ad approfondire un tema essenziale per il
dibattito intellettuale e politico dei nostri giorni: la
democrazia intrappolata nella
rete. Il filosofo romano è impegnato da anni nello
studio e nell’analisi dei processi politici e dei cambiamenti
in seno alle
democrazie occidentali in virtù dell’impatto dei nuovi media.
A distanza di sette anni da L’ultimo di
Dio (Dedalo 2012),
Paolo Ercolani torna ad approfondire un tema essenziale per il
dibattito intellettuale e politico dei nostri giorni: la
democrazia intrappolata nella
rete. Il filosofo romano è impegnato da anni nello
studio e nell’analisi dei processi politici e dei cambiamenti
in seno alle
democrazie occidentali in virtù dell’impatto dei nuovi media.
In questo saggio l’analisi si allarga a tematiche antropologiche e pedagogiche, frutto di anni di confronti con studenti e di una propria esperienza diretta nel mondo virtuale dei social networks.
Il libro è suddiviso essenzialmente in due parti: una prima è costituita da un’importante prefazione di Luciano Canfora e dai sei capitoli che l’autore ha strutturato in modo che siano leggibili anche da un pubblico non specialista; nella seconda parte, pensata per un circuito di studiosi, l’autore elabora un impianto di note molto consistente e soprattutto una bibliografia aggiornatissima e di grande respiro internazionale.
Nella prefazione (pp. 7-9) Luciano Canfora mette in evidenza l’argomento più radicale e corrosivo del saggio di Ercolani, ovvero l’idea che il suffragio universale, vero totemdelle democrazie moderne, abbia mostrato tutta la sua natura superflua, confermando la teoria secondo la quale la rete, il massimo strumento di comunicazione di massa, non produca maggioranze rivoluzionarie, ma, al contrario, sia un veicolo di consolidamento per le élite più reazionarie.
Nel primo capitolo (pp. 27-84), L’uomo senza pensiero, Ercolani fa i conti con la vulgata popperiana che tanto aveva contribuito a fomentare illusioni circa l’avvento di una società aperta, quando il web cominciò a mostrare la propria vocazione di strumento di massa. L’autore, grazie a una scrittura agile e comprensibile, ma allo stesso tempo tagliente, riesce a cogliere con precisione tutte le più evidenti contraddizioni fra le speranze dei primi osservatori del fenomeno web negli anni ottanta e la realtà dei giorni nostri. L’aver puntato sulla difficoltà del libero pensiero nella società attuale pone l’analisi del testo all’interno della già consistente letteratura sociologica di un maestro come Edgar Morin, il quale aveva già notato come lo «Tsunami di informazioni», che piovono ogni giorno sui nostri dispositivi tecnologici, invece che favorire riflessioni e partecipazione al dibattito pubblico, favorisce una passiva acquisizione di slogan buoni per un atteggiamento da sostenitore di idee altrui.
Leggi tutto
Fabio Ciabatti: Contraddizioni in seno al populismo
Contraddizioni in seno al populismo
di Fabio Ciabatti
Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli e Loris Caruso (a cura di), Popolo chi?, Ediesse, Roma 2019, pp. 214, € 13,39
 Dagli anni ’80 del secolo scorso
le classi popolari sono scomparse dal discorso pubblico mainstream
come soggetto autonomo, capace di parlare con una propria
voce. Eppure, come ogni rimosso, il popolo riemerge come
fantasma cui attribuire tutti
i mali del presente: l’elezione di Trump, la vittoria della
Brexit, l’affermazione elettorale di Lega, la crescita del
razzismo e chi
più ne ha più ne metta. “Popolo sei ‘na monnezza!” verrebbe da
dire insieme all’ingenuo fraticello interpretato
da Alberto Sordi nel film Nell’anno del Signore.
Dagli anni ’80 del secolo scorso
le classi popolari sono scomparse dal discorso pubblico mainstream
come soggetto autonomo, capace di parlare con una propria
voce. Eppure, come ogni rimosso, il popolo riemerge come
fantasma cui attribuire tutti
i mali del presente: l’elezione di Trump, la vittoria della
Brexit, l’affermazione elettorale di Lega, la crescita del
razzismo e chi
più ne ha più ne metta. “Popolo sei ‘na monnezza!” verrebbe da
dire insieme all’ingenuo fraticello interpretato
da Alberto Sordi nel film Nell’anno del Signore.
Ma è proprio così? Gli autori del libro Popolo chi?sostengono che si tratta di una rappresentazione decisamente unilaterale. E lo fanno dopo aver ascoltato la voce di quelle classi popolari in nome delle quali molti si sentono autorizzati a sproloquiare. Il testo, curato da Niccolò Bertuzzi, Carlotta Caciagli e Loris Caruso, rappresenta il risultato di una ricerca basata su 60 interviste in profondità realizzate in quartieri e aree popolari di Milano, Firenze, Roma e Cosenza. Secondo gli autori non esiste un popolo pronto a consegnarsi nelle mani del populismo di destra. Piuttosto, il quadro che emerge viene riassunto con una parola: “contraddizione”. Vediamo brevemente perché.
L’inchiesta rimarca l’importanza della sfera lavorativa nella vita delle persone. “Sfruttato, precarizzato o intermittente, il lavoro (e la sua mancanza) costituisce una parte centrale nella realtà quotidiana di tutti gli intervistati, rappresentando … la fonte principale della loro sofferenza”.1 Di fronte a questa situazione, però, prevale la rassegnazione e la paura. Non si pensa che un’azione collettiva possa cambiarla. La maggioranza delle persone, infatti, non vive questi problemi come immediatamente sociali o, in senso lato, politici. Le sofferenze esperite nel luogo di lavoro sono considerate come mali privati sconnessi dal vissuto e dalle sofferenze delle altre persone che condividono le stesse condizioni. In breve il lavoro è centrale, ma non produce identità sociale e mobilitazione.
Ma dovendo pensare ad un conflitto chi dovrebbe essere la vera controparte? Chi comanda davvero, secondo gli intervistati, non sono i politici, ma i grandi imprenditori, i banchieri e i finanzieri. Eppure nei loro confronti non vengono pronunciate parole di disapprovazione.
Leggi tutto
Mimmo Porcaro: Note sulla fase politica
Note sulla fase politica
di Mimmo Porcaro
 1.
1.
Nonostante sia numericamente ben possibile assicurare la continuità di gestione dell’Ue (magari peggiorandola, grazie ai liberali), i risultati elettorali (in particolare quelli francesi, italiani ed inglesi) indicano il persistere di una seria crisi di consenso. Per quel che conta, il parlamento di Strasburgo deciderà quel che vuole, ma i “fuochi” di crisi restano accesi in tutte le più grandi nazioni del continente, anche nella sempre più frammentata Germania. Purtroppo questa crisi non è gestita dalle forze neosocialiste. Le elezioni hanno meritatamente punito Tsipras, ma hanno anche duramente colpito, o ulteriormente indebolito, le posizioni oscillanti ed incerte di Corbyn, di France Insoumise e di Podemos. Se è positiva la conferma della protesta popolare contro l’Unione, questa considerazione viene bilanciata dal fatto che tale protesta è ormai stabilmente egemonizzata dalla destra. Destra che peraltro non pare avere al momento né la volontà né la possibilità di usare la propria influenza per fini diversi da quelli di una rinegoziazione intra-Ue. Questo è il significato immediato (e negativo) delle elezioni europee.
2.
Sarebbe peraltro sbagliato leggere la situazione attuale semplicemente come scontro tra (grande) capitalismo globalista e (piccolo) capitalismo sovranista. E’ ormai iniziata da tempo l’inversione della globalizzazione, per cui si può dire che tutti i gruppi capitalistici, pur giocando ancora, in modi diversi, sull’apertura dei mercati, per tutelare i propri interessi fanno ricorso in maniera crescente alla logica territoriale. Ciò non vale solo per Trump. Vale anche per l’Unione: qui i due stati leader, da sempre gelosi della propria sovranità, disegnano un progetto di cooperazione economica che prevede la parziale chiusura del territorio dell’Unione stessa ad iniziative “straniere”, e la tutela di campioni nazional-continentali.
Leggi tutto
Marco Palazzotto: Dalla questione meridionale all'autonomia differenziata*
Dalla questione meridionale all'autonomia differenziata*
di Marco Palazzotto
Ai meridionali sono stati affibbiati da secoli gli appellativi di corrotti, parassiti e mafiosi, eppure oggi la Lega di Salvini Premier raccoglie largo consenso al Sud, come si è visto alle ultime elezioni europee. Il 23% circa degli elettori meridionali che ha votato per la Lega però non sa di stare peggio, a livello aggregato, dopo un anno di governo gialloverde. Ad esempio l’ISTAT rileva che nel 2018 l’incidenza della povertà assoluta è stata maggiore nel Mezzogiorno sia per le famiglie (da 8,5% del 2016 al 10,3%) sia per gli individui (da 9,8% a 11,4%)[1]. La Banca d’Italia rileva che il tasso di disoccupazione aumenta al 22,3% in Sicilia, più del doppio della media nazionale[2].
Le cause ovviamente sono politiche e non sono - a parere di chi scrive - ascrivibili alla fannullaggine del popolo meridionale o alla sola presenza della criminalità (che è comunque effetto che si scambia con la causa), dacché le politiche economiche continuano a non aiutare la gente del Sud.
Mauro Gallegati rilevava qualche giorno fa sulle colonne del Manifesto che la Corte dei Conti registra una pressione fiscale maggiore al Sud e una contemporanea diminuzione di trasferimenti di risorse pubbliche[3].
Insomma la questione meridionale rimane, anche se è ormai scomparsa dai dibattiti politici.
Se è vero che la Sicilia, e in generale il Meridione, è stata la culla della criminalità organizzata di stampo mafioso, non possiamo però approcciarci al fenomeno con l’ottica convenzionale che vede lo Stato da una parte e la criminalità dall’altra, in contrapposizione.
Leggi tutto
Militant: Consigli per gli acquisti. Attraverso questo mare di cemento. Immaginario, rudimenti pop e casi di forza maggiore
Consigli per gli acquisti. Attraverso questo mare di cemento. Immaginario, rudimenti pop e casi di forza maggiore
di Militant
“Da più di tre lustri, lo Jacob agisce a casaccio. Seguendo un rigido piano quinquennale”
L’abbiamo letto e riletto questo libro. E’ un testo che si presenta al limite dell’ambiguo, pericoloso, pieno di stonature. Ci sono forzature, approssimazioni, letture di pancia e istintive, ma più si legge e più ci si rende conto che è frutto di un’urgenza e di una necessità assolutamente positive: la sinistra di classe, i compagni, devono fare i conti con la loro storia, con la storia delle loro scelte, con l’egemonia di pensiero dominante in cui loro stessi si sono fatti coinvolgere, che hanno tollerato o che non sono stati in grado di decostruire. E per essere decostruita, le belle e sagge parole non bastano, forse bisogna andarci giù di machete, bisogna farsi dire ma cosa diavolo state dicendo!, bisogna affondare nell’eresia e costringere tutti quelli che lottano per cambiare lo stato di cose presenti a fare i conti con le macerie sotto cui (ci) siamo sotterrati. Macerie e cemento sono, e così non potrebbe essere altrimenti, il campo in cui si deve muovere la sinistra di classe per ricominciare ad esistere. Lo cerca di fare il laboratorio politico Jacob di Foggia, nato nel 2003, che firma questo lavoro nel quale si ripercorrono gli anni della sua esistenza fino ad oggi, intrecciando vicende locali con appuntamenti nazionali, saltando dalle vicende del Foggia calcio alla nascita del Csoa Scuria nel 2014, tra citazioni intellettuali, botte con i fascisti e tradizioni popolari.
Leggi tutto
Robert Skidelsky: L'austerità non è stata ancora legittimata
L'austerità non è stata ancora legittimata
di Robert Skidelsky
Alberto Alesina, professore all'Università di Harvard, è tornato sul dibattito intorno al deficit di bilancio, l'austerità e la crescita, Nel 2010, Alesina aveva detto ai ministri delle finanze europee che «in passato, forti riduzioni dei deficit di bilancio erano state accompagnate, e immediatamente seguite, da una crescita sostenuta, piuttosto che da recessioni, perfino a breve termine». Oggi, insieme ai suoi colleghi economisti, Carlo Favero e Francesco Giavazzi, Alesina ha scritto un nuovo libro, dal titolo "Austerità. Quando funziona e quando no" (Rizzoli), che ha recentemente ricevuto una recensione favorevole dal suo collega di Harvard, Kenneth Rogoff. Libro nuovo, canzone vecchia. In poche parole, la conclusione alla quale sono arrivati gli autori è che «in termini di produzione, in alcuni casi, il costo diretto dei tagli alla spesa è più che compensato dall'aumento delle altre componenti della domanda aggregata». L'implicazione di una tale affermazione, è che l'austerità - la quale, anziché espanderlo, taglia il deficit di bilancio - può essere la politica corretta da mettere in atto durante una recessione. Il precedente lavoro di Alesina su questo argomento, scritto insieme a Silvia Ardagna, è stato criticato dal Fondo Monetario Internazionale e da altri economisti a causa della sua difettosa econometria e delle sue conclusioni esagerate. E anche questo nuovo libro, che analizza 200 piani di austerità pluriennale, realizzati in 16 paesi dell'OCSE tra il 1976 e il 2014, servirà senz'altro a tenere occupati i torturatori dei numeri.
Leggi tutto
Geraldina Colotti: Venezuela, avvoltoi 2.0
Venezuela, avvoltoi 2.0
di Geraldina Colotti
A sei mesi dalla comparsa dell'avatar Juan Guaidó, scelto dagli USA per imporre al Venezuela un nuovo gioco di guerra, a che punto stanno le cose? Di sicuro l'immagine dell'autoproclamato si va diluendo come un puntino fastidioso, ancorché persistente. Un rumore di fondo, sempre meno adatto a rappresentare la propria utenza, foss'anche come comunità virtuale: quella venduta dai media come un'alleanza, pur essendo composta da bande fameliche in lotta per il bottino.
Ancora una volta, il governo bolivariano ha dato prova di grande avvedutezza, sia sul piano interno che su quello internazionale. Nel complesso e difficile contesto internazionale, fatta la tara fra costi e ricavi, lasciar cuocere l'autoproclamato nel suo brodo di discredito, si è rivelata una buona strategia. Ha mostrato l'inconsistenza del personaggio e quella del progetto virtuale che gli hanno voluto cucire addosso i suoi padrini multinazionali: quegli stessi che ora se lo rimpallano con un imbarazzo sempre crescente, come emerge dalle varie dichiarazioni provenienti dagli USA o dalle definizioni che lo derubricano da presunto presidente “incaricato” a presidente dell'Assemblea Nazionale (“in ribellione”).
E così, persino le inchieste più partigiane, come quella compiuta il 2 giugno da Datincorp, devono ammettere che “ Guaidó sta scendendo nelle aspettative dei venezuelani”.
Leggi tutto
Gianpasquale Santomassimo: Dopo la catastrofe
Dopo la catastrofe
di Gianpasquale Santomassimo
Ci troviamo all’interno di un sommovimento, in atto da tempo, che riguarda tutto l’Occidente e che in Europa assume i contorni più esplosivi. Chi si lamenta ogni giorno per avere Salvini al governo non può immaginare cosa significhi essere governati da Trump negli Usa, da Bolsonaro in Brasile, ma anche da Orbàn in Ungheria e in Polonia dal clericalismo reazionario. Per non parlare, fatte le debite distinzioni, di Erdogan o Putin.
Usare termini vaghi e impressionistici come “onda nera” rende bene l’idea di una incapacità della cultura della sinistra di tentare di tematizzare razionalmente il fenomeno in atto, dimenticando, fra l’altro, che di questa “onda” sono parte milioni di persone che spesso votavano a sinistra fino a ieri o all’altro ieri.
In estrema sintesi, potremmo dire che si è sgretolata e si sta inabissando tutta la visione del mondo della cultura liberal che è stata lungamente egemonica dopo l’Ottantanove, che ha interpretato la globalizzazione come un fenomeno naturale che non andava governato ma assecondato e accelerato, dando per acquisita l’estinzione in atto degli Stati nazionali e senza porsi troppi pensieri sugli sconfitti e i perdenti, cui si rivolgeva l’invito, benevolo ma pressante, ad adeguarsi.
Una visione del mondo che è stata acquisita in pieno da ciò che si è autoproclamata “sinistra” nel trentennio alle nostre spalle, tanto nella versione “moderata” che in quella “radicale”, distinte a ben vedere soprattutto dall’intensità della rivendicazione dello stesso orizzonte.
Leggi tutto
Hits 3928
Hits 2961
Hits 2673
Hits 2370
Hits 2099
Hits 1951
Hits 1906
Hits 1886
Hits 1869
Hits 1850
tonino
tonino

coniarerivolta: La riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità: come si perfeziona l’austerità
La riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità: come si perfeziona l’austerità
di coniarerivolta
 La crisi che ha messo in ginocchio
l’Italia insieme all’intera periferia d’Europa si sviluppa su
due livelli. Un primo
livello è quello della lotta senza quartiere contro i diritti
e i salari dei lavoratori, una battaglia che ogni giorno erode
pezzi di stato
sociale sotto la scure dell’austerità, retribuzioni e tutele
del lavoro date in pasto all’accumulazione del profitto, tempi
e ritmi
di vita sacrificati sotto il ricatto della precarietà. Questo
è l’aspetto del problema di immediata percezione, quello che
molti
di noi sperimentano sulla propria pelle, che incide
direttamente sulle nostre vite. Il secondo livello è
caratterizzato dal fatto che questa
lotta di classe contro i lavoratori non è improvvisata ma si
articola in una strategia. E le strategie, come ben sappiamo,
si disegnano a
tavolino e poi si traducono in azioni coordinate. Esiste,
dunque, un piano della crisi in cui lo sfruttamento viene
organizzato, in cui il dominio
esercitato dai mercati sulle nostre vite definisce le
istituzioni necessarie alla sua realizzazione, un piano che in
questa parte del mondo assume la
forma storica dell’Unione Europea, dei suoi trattati, delle
sue regole e dei suoi strumenti operativi. Vale la pena, ogni
tanto, sollevare lo
sguardo dalle nostre battaglie quotidiane e provare ad
anticipare le mosse del nemico; provare a decifrare i piani di
chi lo sfruttamento lo impone
dall’alto per essere in grado di opporre al sistema basato su
povertà, precarietà e disoccupazione una strategia politica
altrettanto solida e articolata – per passare, al momento
giusto, al contrattacco.
La crisi che ha messo in ginocchio
l’Italia insieme all’intera periferia d’Europa si sviluppa su
due livelli. Un primo
livello è quello della lotta senza quartiere contro i diritti
e i salari dei lavoratori, una battaglia che ogni giorno erode
pezzi di stato
sociale sotto la scure dell’austerità, retribuzioni e tutele
del lavoro date in pasto all’accumulazione del profitto, tempi
e ritmi
di vita sacrificati sotto il ricatto della precarietà. Questo
è l’aspetto del problema di immediata percezione, quello che
molti
di noi sperimentano sulla propria pelle, che incide
direttamente sulle nostre vite. Il secondo livello è
caratterizzato dal fatto che questa
lotta di classe contro i lavoratori non è improvvisata ma si
articola in una strategia. E le strategie, come ben sappiamo,
si disegnano a
tavolino e poi si traducono in azioni coordinate. Esiste,
dunque, un piano della crisi in cui lo sfruttamento viene
organizzato, in cui il dominio
esercitato dai mercati sulle nostre vite definisce le
istituzioni necessarie alla sua realizzazione, un piano che in
questa parte del mondo assume la
forma storica dell’Unione Europea, dei suoi trattati, delle
sue regole e dei suoi strumenti operativi. Vale la pena, ogni
tanto, sollevare lo
sguardo dalle nostre battaglie quotidiane e provare ad
anticipare le mosse del nemico; provare a decifrare i piani di
chi lo sfruttamento lo impone
dall’alto per essere in grado di opporre al sistema basato su
povertà, precarietà e disoccupazione una strategia politica
altrettanto solida e articolata – per passare, al momento
giusto, al contrattacco.
Per questo è utile analizzare il disegno di riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità (MES) discusso nei giorni scorsi dall’Eurogruppo (l’organo che riunisce i Ministri delle finanze dei 19 Stati che adottano l’euro) e destinato a perfezionare ulteriormente il dominio dei cosiddetti mercati sulla politica, e dunque sull’organizzazione della nostra società, attraverso un più capillare e pervasivo sistema di controllo delle economie nazionali da parte delle istituzioni europee. Il MES è la versione più recente del ‘fondo salva Stati’ istituito in varie successive configurazioni per gestire la crisi del debito pubblico, a partire dalla Grecia nel 2010.
Leggi tutto
Domenico Moro: La natura delle contraddizioni in seno al governo
La natura delle contraddizioni in seno al governo
di Domenico Moro
 Come era
facile aspettarsi, dopo le elezioni europee le contraddizioni
all’interno
del governo si stanno divaricando. Infatti, il ribaltamento
dei rapporti di forza tra i due partner, M5S e Lega, sta dando
luogo a un confronto senza
esclusione di colpi su molte tematiche centrali. Ma va
precisato che le forze in campo sono tre, perché, oltre a M5s
e Lega, gioca un ruolo di
rilevo anche l’altra componente del governo, quella che, sotto
la supervisione del Presidente Mattarella, comprende il
ministro degli esteri
Moavero e soprattutto quello decisivo dell’economia e delle
finanze, Giovanni Tria.
Come era
facile aspettarsi, dopo le elezioni europee le contraddizioni
all’interno
del governo si stanno divaricando. Infatti, il ribaltamento
dei rapporti di forza tra i due partner, M5S e Lega, sta dando
luogo a un confronto senza
esclusione di colpi su molte tematiche centrali. Ma va
precisato che le forze in campo sono tre, perché, oltre a M5s
e Lega, gioca un ruolo di
rilevo anche l’altra componente del governo, quella che, sotto
la supervisione del Presidente Mattarella, comprende il
ministro degli esteri
Moavero e soprattutto quello decisivo dell’economia e delle
finanze, Giovanni Tria.
Rispetto alle elezioni politiche, i Cinque stelle hanno quasi dimezzando la loro quota percentuale, mentre la Lega l’ha raddoppiata, passando da terzo a primo partito nazionale. Quindi, è naturale che il leader del M5s, Luigi Di Maio, cerchi di riprendersi l’iniziativa politica che gli era stata sottratta da Salvini su due temi, l’Europa e soprattutto l’immigrazione. Dall’altro lato, Salvini si trova nella situazione di chi ha accumulato un enorme vantaggio e si chiede come e quando capitalizzarlo. Del resto, l’elemento dominante nella fase politica attuale è la mobilità dei consensi con milioni di voti che si spostano con grande facilità. La situazione è ingarbugliata, perché, se i Cinque stelle devono andare all’attacco per recuperare le loro posizioni, tirare troppo la corda può condurre alle elezioni, che molto probabilmente sancirebbero il loro arretramento, anche se non bisogna dimenticare che le elezioni politiche sono competizioni elettorali diverse da quelle europee. La Lega potrebbe volere nuove elezioni, ma per far cadere il governo deve trovare la motivazione giusta agli occhi degli elettori, senza contare che, svanita ogni possibilità di coalizione con il M5s, si porrebbe il problema di come e con chi formare una nuova coalizione, con il possibile rientro in gioco di Berlusconi. Inoltre, a complicare la situazione c’è la perdurante debolezza del Pd che non sarebbe ancora in grado di costituire una alternativa né all’attuale governo né al centro-destra.
Leggi tutto
Alessandro Pascale: La "Questione nazionale" nel XXI secolo
La "Questione nazionale" nel XXI secolo
di Alessandro Pascale
 «L'emancipazione della classe operaia deve
essere l'opera della classe operaia stessa» (Karl Marx)
[1]
«L'emancipazione della classe operaia deve
essere l'opera della classe operaia stessa» (Karl Marx)
[1]
Da quando esiste il socialismo scientifico i comunisti sanno che l'obiettivo primo della loro azione pratica deve essere la conquista del potere politico. Per giungere a tale obiettivo tutti gli autori fondamentali (da Marx a Gramsci, da Lenin a Mao, ecc.) concordano sul fatto che il partito comunista debba saper coniugare patriottismo ed internazionalismo.
Anche se è più nota l'affermazione che «gli operai non hanno patria», Marx ed Engels precisano nel Manifesto del Partito Comunista:
«ma poiché il proletariato deve conquistarsi prima il dominio politico, elevarsi a classe nazionale [nell'edizione inglese del 1888 si precisa “classe dirigente della nazione”, nota di Luciano Gruppi], costituirsi prima il dominio politico, elevarsi a classe nazionale, costituirsi in nazione, è anch'esso nazionale, benché certo non nel senso della borghesia». [2]
Inoltre «sebbene non sia tale per il contenuto, la lotta del proletariato contro la borghesia è però all'inizio, per la sua forma, una lotta nazionale. Il proletariato di ogni paese deve naturalmente farla finita prima con la sua propria borghesia». [3]
Non è un caso infatti, come sottolinea Domenico Losurdo nel suo monumentale La lotta di classe [4], che tutte le rivoluzioni socialiste siano nate dalla capacità di coniugare la salvezza della nazione in rovina con un programma radicale di trasformazioni sociali. E che già Marx ed Engels perseguissero «non solo la liberazione/emancipazione della classe oppressa (il proletariato), ma anche la liberazione/emancipazione delle nazioni oppresse» [5], ricordando l'appoggio che diedero alle oppressioni subite dai polacchi e dagli irlandesi. Il sostegno ai movimenti nazionali locali viene dato nonostante vi partecipino anche esponenti della nobiltà. Ciò perché «se il proletariato è il protagonista del processo di liberazione/emancipazione che spezza le catene del dominio capitalista, più largo è lo schieramento chiamato a infrangere le catene dell'oppressione nazionale» [6]; nel caso irlandese, Marx fa coincidere la “questione sociale” con la “questione nazionale” [7].
Leggi tutto
Pagmetisse: Migranti: la dignità è un’altra cosa!
Migranti: la dignità è un’altra cosa!
di Pagmetisse
In questi giorni abbiamo assistito ad una delle diatribe più assurde sulla questione dei migranti degli ultimi decenni. Da una parte, gli eroi salvatori di vite umane, dall’altra, i carnefici senza pietà. E mi chiedo come sia possibile ridurre una questione così complessa e articolata, che tocca la vita di migliaia di persone, coinvolge paesi da una sponda all’altra del Mediterraneo e implica le responsabilità di entità politiche sovranazionali di due continenti (Unione Europea e Unione Africana), ad una rappresentazione che sembra una partita di ping pong, in cui ogni colpo rappresenta un’offesa, una provocazione e uno slogan rinviati all’avversario, mentre le due fazioni di tifosi, diametralmente opposte, fanno la ola ad ogni punto conquistato e i migranti, come una pallina, sbattono in un campo e nell’altro.
Sia chiaro, la vita umana va SEMPRE rispettata e tutelata ed è giusto che si accolga con plauso il coraggio e l’intraprendenza della capitana Carola o di chiunque altro si dedichi a soccorrere e a portare in salvo le persone abbandonate in mare, ma il punto non è questo.
Il vero problema è l’immagine svilente e distorta, incollata addosso a queste persone e alle loro esistenze, che emerge da questa lotta mediatico-politica e intellettuale, fondata su due visioni semplicistiche, quanto falsate: per la sinistra sono “esseri umani in cerca di dignità”, per la destra “invasori parassiti che rubano il nostro benessere”.
Leggi tutto
Alessandro Di Battista: 'The Sea Watch Show'
'The Sea Watch Show'
di Alessandro Di Battista*
“The Sea Watch Show” si è da poco concluso ma statene certi, usciranno presto nuove stagioni. In fondo è stato un successo per tanti e va replicato. A quanto pare stanno già girando il primo spin-off. Si chiamerà “Carola l'eroina” e ai soliti “giornaloni” foraggiati per anni dai Benetton non pare vero. Sanno già che intere pagine estive saranno dedicate alla raccolta firme per la temeraria Capitana per evitare che a qualcuno venisse in mente di raccogliere firme per far tornare la gestione delle autostrade allo Stato.
“The Sea Watch Show” è stato un successo. Vi hanno recitato politici di destra e di sinistra e hanno trovato finalmente la parte giusta. D'altro canto se avessero recitato in film sul lavoro, sui diritti sociali, sulla questione morale, sulle grandi opere inutili, sugli sprechi della politica, sulla politica estera, sul TAV, sui Benetton, sulle intercettazioni beh avrebbero lottato tutti quanti per avere la stessa parte: quella degli schiavi del sistema. Ma “The Sea Watch Show” gli ha dato la più grande opportunità: quella di differenziarsi, finalmente. In fondo a questo serve l'immigrazione, a dare la possibilità a politici da 30 anni uguali in tutto e per tutto di poter gridare “noi siamo diversi, popoluccio, dividetevi tra destra e sinistra”. Per questo i politici di professione non cercheranno mai di affrontare le cause dei flussi migratori. Non sia mai che l'unico tema che li distingue dovesse scomparire.
Leggi tutto
Michael Roberts: Fare i conti con "Libra"
Fare i conti con "Libra"
di Michael Roberts
Libra è il nome con cui Facebook, l'impresa globale di social networking, ha chiamato quella che sta pianificando come la sua valuta digitale internazionale. Quale scopo si prefigge, Facebook, con questa nuova valuta? Secondo Facebook, Libra è «una semplice valuta globale ed un'infrastruttura finanziaria che darà potere a miliardi di persone». Nel suo comunicato, la compagnia afferma che: «Il mondo ha veramente bisogno di una valuta digitale affidabile e di un'infrastruttura , che insieme possano garantire e mantenere la promessa della "Internet del denaro". Garantire le vostre risorse finanziarie sul vostro dispositivo mobile dovrebbe essere semplice ed intuitivo. Spostare denaro dappertutto nel mondo dovrebbe essere altrettanto facile e a basso costo - ed altrettanto sicuro - dell'inviare un messaggio di testo o condividere una foto, a prescindere da dove si vive, che cosa si faccia o quanto si guadagni. L'innovazione dovuta a nuovi prodotti e l'ingresso di nuovi operatori nell'ecosistema consentirà di ridurre le barriere all'accesso ed il costo del capitale per ciascuno e faciliterà pagamenti senza attrito per più persone».
Quindi, l'obiettivo dichiarato è quello di fornire una valuta per ciascuno che utilizzi Internet per comprare e vendere beni e servizi fra di loro in tutto il mondo, in maniera trasparente e ad un costo di transazione che si avvicini allo zero.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: Accordo Cina-Usa. Risparmio cinese, piazze finanziarie e spazi per l’Italia
Accordo Cina-Usa. Risparmio cinese, piazze finanziarie e spazi per l’Italia
di Pasquale Cicalese
Si è concluso il summit Trump Xi Jinping al G20 di Osaka.
Trump ha definito i colloqui “eccellenti” e “aprono la strada ad uno storico accordo commerciale”. L’agenzia Xinhua, alle 6, dettava la notizia che riprenderanno i negoziati commerciali.
Xi aveva posto come condizione dell’accordo e del prosieguo dei negoziati la fine del bando alle società tecnologiche cinesi e la conferma del quantum di import cinese di prodotti americani deciso a dicembre, vale a dire 1.300 miliardi di dollari.
Ma il vertice era stato preceduto dalle dichiarazioni di Xi al G20 di ieri, in cui affermava davanti agli astanti che la Cina apriva i mercati agricoli, minerari, manifatturieri e dei servizi, compresi quelli finanziari.
Inoltre, di propria spontanea iniziativa, al fine di rianimare il commercio mondiale, aumentava l’ammontare di import dal resto del mondo abbattendo i dazi.
Circa i servizi finanziari, nei prossimi anni la battaglia sarà tra New York e Londra per accaparrarsi il risparmio cinese, che ammonta ora a 42 mila miliardi e che continua ad aumentare, avendo la Cina un tasso di risparmio pari al 50% del pil.
Probabile che New York verrà scelta come hub di equity mondiale e come passaporto per entrare nel mercato americano, ma il profilo globale cinese è più a favore della piazza londinese, visto che essa raccoglie capitali e li smista in investimenti in tutto il mondo. Sarebbe il braccio finanziario della Via della Seta.
Leggi tutto
Gabriella Baptist: Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace
Francesco Pecoraro, La vita in tempo di pace
di Gabriella Baptist
Nell’ultimo giorno cosciente della sua vita, Ivo Brandani – «perseguitato dal senso della catastrofe», per come è presentato fin dalla prima riga (p. 9), e da quel mal di testa che gli sarà fatale –, mentre si muove in stato di sospensione tra sale d’aspetto ed aerei nei non luoghi della postmodernità, mentre si abbandona al desiderio di andarsene dove che sia, come peraltro ha sempre fatto nella sua vita, lascia che i ricordi affiorino imperiosamente, con le nostalgie e i rimpianti, le rabbie, i risentimenti, gli improperi. Così nel bel romanzo di Francesco Pecoraro – «storia di un mondo che sta per finire», come è aggiunto sulla copertina – ai capitoli che monitorano l’attesa angosciata, computando il tempo che resta, misurando con impazienza il ritardo e la resa, si alternano capitoli che sono in realtà consuntivi di frustrazioni passate e di felicità forse mai davvero possedute e comunque perdute, ricomposizioni a ritroso di aspettative confuse, speranze e disillusioni. Alla fine il bilancio non può che essere fallimentare, come sempre sono i bilanci al cospetto dello sfacelo ultimo, che qui non è solo quello di una vicenda personale, ma di un intero in decomposizione.
Con un significativo capovolgimento di prospettiva, il Prologo inizia la narrazione evocando la decadenza irremissibile e anzi la devastazione della fine di un impero, quel mondo bizantino precedente all’inizio della modernità, quell’oriente prossimo da cui sembra non venire più luce; l’Epilogo conclude invece con il vero inizio della storia, con la città appena liberata, il padre che torna dalla guerra e ritrova la moglie e la figlia salve, con quella promessa di vita rinnovata di cui Ivo Brandani è il figlio.
Leggi tutto
Eros Barone: Immigrazione, gingoismo ed “esercito industriale di riserva”

Immigrazione, gingoismo ed “esercito industriale di riserva”
di Eros Barone
 Generalmente,
il caos è il disordine esistente tra l’ultimo ordine di
cui si è a conoscenza e l’ordine futuro ancora da
realizzarsi.
E’ una fase pericolosa e incerta, nella quale ogni
elemento di solidità sembra sgretolarsi…Sebbene il caos
sia in genere una fase
difficile e faticosa, è anche dinamica, una fase di grande
creatività e sviluppo.
Generalmente,
il caos è il disordine esistente tra l’ultimo ordine di
cui si è a conoscenza e l’ordine futuro ancora da
realizzarsi.
E’ una fase pericolosa e incerta, nella quale ogni
elemento di solidità sembra sgretolarsi…Sebbene il caos
sia in genere una fase
difficile e faticosa, è anche dinamica, una fase di grande
creatività e sviluppo.
Sun Tzu, L’arte della guerra.
-
Immigrazione: dati reali e percezione
Com’è possibile che l’immigrazione, a dispetto della sua modesta consistenza e relativa incidenza se paragonata ad altri paesi europei come la Francia, l’Inghilterra e la Spagna, abbia assunto un rilievo così sproporzionato nell’agenda politica del governo, dei ‘mass media’ e, a partire da qui, nella percezione e nella sensibilità della maggioranza della popolazione italiana?
Il primo dato da considerare è l’entità del fenomeno: tra regolari e irregolari, gli immigrati presenti nel Bel Paese sono (dati ISTAT), all’incirca, 6 milioni, ossia il 10% sul totale della popolazione, quindi una percentuale e un dato assoluto che, in un paese moderno che è la sesta o settima potenza mondiale, non dovrebbe giustificare la sindrome da ‘invasione’ paventata e/o indotta ad opera di determinate forze politiche e sociali.
Sennonché, stando ai sondaggi demoscopici che sono stati effettuati, 1 l’Italia è il paese europeo dove lo scarto tra i dati reali poc’anzi citati e la percezione soggettiva espressa dagli intervistati è in assoluto il più ampio. Basti pensare che i cittadini intervistati percepiscono l’esistenza di una percentuale di immigrati che assomma a più del doppio (esattamente il 25%) di quelli risultanti dai dati reali. Orbene, di fronte alle dimensioni (sia reali che immaginarie) di questo fenomeno sono possibili e concretamente osservabili due tipi di reazione: la prima è quella di chi, attenendosi al dato numerico della consistenza e incidenza tutto sommato modeste del fenomeno, arriva tranquillamente a negare che tale fenomeno costituisca un problema; il secondo tipo di reazione è quello di chi, riflettendo sullo scarto tra i dati e la percezione, ritiene corretto supporre che il problema relativo all’immigrazione sia molto più ampio e profondo di quanto appaia dalle sue dimensioni statistiche.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Discussioni sull’Italia: lotta nazionale e/o lotta di classe?
Discussioni sull’Italia: lotta nazionale e/o lotta di classe?
di Alessandro Visalli
 Moreno
Pasquinelli ha deciso di replicare al mio pezzo sulla politica
della
Lega nel contesto dell’attuale crisi europea, ovvero a “Giochi di specchi ed equivoci: il
caso della
Lega”. Lo ha fatto con un articolo sul blog di P101, “L’Italia non può farcela (da
sola)”.
Moreno
Pasquinelli ha deciso di replicare al mio pezzo sulla politica
della
Lega nel contesto dell’attuale crisi europea, ovvero a “Giochi di specchi ed equivoci: il
caso della
Lega”. Lo ha fatto con un articolo sul blog di P101, “L’Italia non può farcela (da
sola)”.
Potremmo anche chiudere la discussione basandoci sul titolo: certo che l’Italia non può farcela (da sola). Ma non è così semplice, perché la vera domanda è: a fare cosa? E questa domanda si muove su molteplici piani di una discussione necessaria e dirimente, che quindi merita di essere fatta.
Quindi partiamo dai due articoli, bisognerà riassumerli brevemente:
1- Il mio tentava una valutazione della situazione politica con particolare riferimento alle contraddizioni entro l'attuale governo ed alla posizione della Lega rispetto all'Europa. L’idea fondamentale era di provare a partire dalla focalizzazione delle contraddizioni per inquadrare le forze, poco visibili, che si muovono nel campo e le tensioni che manifestano. Infatti anche per pensare in termini di ‘amico e nemico’[1], e/o di ‘nemico principale’ e ‘secondario’[2], bisogna capire che ogni tensione attraversa diagonalmente tutti i campi. Altrimenti dimentichiamo le nostre radici, ed il livello di analisi che comportano, e rischiamo di riprodurre anche inconsapevolmente schemi nazionalisti. Parlare di “Italia”, in ogni contesto politico è una probabilmente necessaria abbreviazione, ma occorre sempre avere cura di pensare nella sua concretezza lo scarto delle forze che si connettono e lottano attraverso i confini politici. La mia analisi partiva quindi dal risultato del 4 marzo, nello schema interpretativo della lotta centro/periferia divenuta prevalente su quella destra/sinistra (anche se questa resta come chiave subordinata, come si vede). Quindi dallo spiazzamento delle sinistre, tutte, nel contesto dello smottamento sociale del secondo decennio.
Questo smottamento ha separato qualcosa di profondo nel paese, e la sinistra non ha trovato di meglio che reagire al suo riflesso elitista condannando i toni popolari come ‘razzisti’ e ‘nuovo fascismo’.
Leggi tutto
Igor Giussani: Sea Watch & Sea Reality
Sea Watch & Sea Reality
di Igor Giussani
 Ci sono due tipi di sbarchi: gli sbarchi
fantasma di cui nessuno parla,
poi arrivano le ONG e si scatena il finimondo, si accendono i
riflettori e tutti parlano di 43 persone non vedendo che nei
giorni scorsi sono sbarcate
200 persone… se sbarcano altri non capisco perché non debbano
sbarcare questi
Ci sono due tipi di sbarchi: gli sbarchi
fantasma di cui nessuno parla,
poi arrivano le ONG e si scatena il finimondo, si accendono i
riflettori e tutti parlano di 43 persone non vedendo che nei
giorni scorsi sono sbarcate
200 persone… se sbarcano altri non capisco perché non debbano
sbarcare questi
Nel loro ingenuo candore, le parole del sindaco di Lampedusa Totò Martello risultano molto illuminanti, se si è capaci di andare al di là della vicenda della Sea Watch 3 e del solito tritacarne mediatico dove si mescolano rabbiose minacce proferite da Salvini, interviste soporifere a Saviano, esternazioni omicide di Giorgia Meloni, reazioni sdegnate delle opposizioni, inviti della Chiesa all’accoglienza, tweet impazziti di VIP, tempeste di indignazione pro-contro ONG sui social network ecc.
In estrema sintesi, infatti, esse forniscono due informazioni preziose:
- in barba alla narrazione dei migranti ‘deboli, sradicati e post-identitari’ in balia del mare su barchini improvvisati e/o vittime di loschi trafficanti di uomini, molti di essi dimostrano capacità e intraprendenza non inferiore a quella dei giovani europei che, depressi dalla crisi economica, cercano miglior sorte in nuovi lidi. Persone quindi che non necessitano di ONG o particolari tutori, per i quali la cosiddetta ‘macchina dell’accoglienza’ probabilmente risulta solo un’inutile palla al piede;
- alla faccia dei proclami governativi inneggianti alla drastica riduzione degli sbarchi, il fenomeno prosegue senza interruzioni nel silenzio generale.
Una forma mentis complottista in tale contesto intravederebbe sicuramente una gigantesca pantomima per portare acqua ai diversi mulini coinvolti: le ONG intercettano le tipologie di migranti confacenti alla loro mission, offrendole sul piatto d’argento della retorica sovranista della Destra e di quella umanitaria della Sinistra, in uno scambio di accuse incrociato tra le parti che ne consolida il prestigio presso i rispettivi seguaci. Così, mentre la gente eleva a icone Carola Rackete o Matteo Salvini a seconda dei gusti personali, i migranti restano anonimi sullo sfondo, avvolti in quel mix di integrazione ed esclusione perfetto per lo sfruttamento economico capitalistico (ci pagano le pensioni, svolgono lavori sottopagati, sono ottime armi di distrazione di massa, per giunta assicurano un consistente pacchetto di voti a Destra e Sinistra mossi da odio o simpatia – cosa desiderare di più?).
Leggi tutto
Stefano Fassina: L’umiliante naufragio della politica
L’umiliante naufragio della politica
di Stefano Fassina
Qual è l’aspetto più grave del lungo e drammatico braccio di ferro avvenuto sulla pelle di oltre 40 persone a Lampedusa? Nessun passo avanti verso un quadro regolativo e impegni delle istituzioni europee e nazionali per la gestione razionale dei flussi dei profughi. Anzi, si conferma, quindi si aggrava, l’abbandono del terreno politico da chi, per mestiere, non dovrebbe fare né il cacciatore con la bava alla bocca di ong, ma lo sceglie, né l’ong, ma ne è costretto. Ancora una volta, la politica, intesa come razionale attività per la risoluzione dei conflitti, per la composizione degli interessi diversi e contrapposti, per la definizione e l’attuazione di soluzioni a problemi complessi e strutturali, è rimasta ai margini.
È sequestrata dallo spettacolo, anzi è spettacolo, abilmente organizzato dal Ministro dell’Interno. Sul piano umanitario, la soluzione alla fine è arrivata. Sul piano politico, è una umiliante sconfitta generale, in Italia e nell’Unione europea, per la Commissione e i governi nazionali, direttamente o indirettamente coinvolti. Non è una novità. È l’ennesimo episodio di una lunga serie. Un’interminabile serie: un altro paio di SeaWatch3 sono in arrivo nei prossimi giorni. Il Ministro social Salvini è già ripartito per Lampedusa su Twitter. Una serie di successo, per chi dalla vantaggiosa posizione di governo fonda il suo consenso sulle apparenti risposte d’ordine per alimentare il disordine, in un circuito vizioso soffocante per la democrazia.
Leggi tutto
Piccole Note: Il G-20 di Osaka. Un nuovo ordine mondiale è alle porte
Il G-20 di Osaka. Un nuovo ordine mondiale è alle porte
di Piccole Note
Aperto il G-20 di Osaka. Summit nel quale succedono cose, al contrario di vertici pregressi che producevano proclami altisonanti vacui quanti poi non rispettati, photo opportunity, sorrisi melliflui e inutili strette di mano.
Quello di Osaka ha prodotto un incontro Trump-Putin, che rompe il muro costruito attorno ai due presidenti. Vertice a porte chiuse, durato venti minuti più di quanto concordato (totale un’ora e venti).
Non si sa cosa si siano detti, ma è ovvio che la priorità è la crisi iraniana, che il presidente russo deve aiutare a sbrogliare per permettere al suo omologo americano a uscirne illeso (se attacca Teheran o va male qualcosa rischia di giocarsi la rielezione).
Ma, ovviamente, avranno parlato anche di altro, come il rilancio del processo di pace con la Corea del Nord, pallino di Trump, e di come trasformare il ritiro delle due potenze dal trattato sulle armi nucleari in opportunità per un nuovo dialogo globale.
Il presidente russo ha invitato il suo interlocutore in Russia per le celebrazioni della vittoria sul nazismo che si terranno nel maggio 2020. Appuntamento simbolico, date tante circostanze attuali. Vedremo se Trump riuscirà ad accettare: forse è troppo vicino alle presidenziali Usa e un’eventuale visita potrebbe essere usata dai suoi tanti nemici.
Leggi tutto
Marco Della Luna: Eurolager: dov'è l'uscita?
Eurolager: dov'è l'uscita?
di Marco Della Luna
Il Governo Conte fa bene a piegarsi alle richieste di Bruxelles e ad evitare la procedura di infrazione (che comporterebbe un esproprio delle funzioni politico-economiche in favore degli eurocrati). E’ il male minore. Oggi.
L’Euro ha un effetto tecnico inevitabile: deindustrializzare l’Italia trasferendone le risorse e gli assets migliori a paesi più efficienti e dominanti entro la UE; lo scopo fondativo dell’UE è esattamente questo (non solo nei confronti dell’Italia).
Se l’Italia resta nell’Euro e nell’UE è destinata a una fine certa e miseranda, ma non a un tracollo immediato, perché, mentre è in corso il suo svuotamento, viene mantenuta in vita finanziariamente. La gente non si ribella perché la gente ha paura dei tracolli e dei sacrifici immediati e non pensa al lungo termine (ed è per questo che la si può portare dove si vuole, quindi le si concede la “democrazia”).
Rompere la gabbia dell’Euro e dell’UE sarebbe pertanto un obiettivo da perseguire anche a costo di sacrifici, ma può farlo soltanto un governo unito, guidato da grandi economisti, sostenuto dal consenso popolare. Un governo capace di resistere alle pressioni, ai ricatti e alle ritorsioni dell’UE e al contempo di rimpiazzare l’Euro e di ricollegare l’economia nazionale ai fornitori e clienti esteri di cui necessita, essendo la nostra un’economia di trasformazione molto dipendente dagli scambi internazionali.
Leggi tutto
Luca Grecchi: Un mondo migliore è possibile. Ma per immaginarlo ci vuole filosofia

Un mondo migliore è possibile. Ma per immaginarlo ci vuole filosofia
di Luca Grecchi
Capita spesso, a chi si occupa di filosofia, di dovere difendere la propria disciplina dalle critiche di chi la ritiene inutile. Mi è capitato anche, durante le consuete domande finali che seguono gli incontri pubblici, di dovere rispondere a genitori preoccupati del fatto che il figlio si fosse iscritto alla facoltà di Filosofia, a causa della probabile disoccupazione futura che ne sarebbe derivata. Premesso che insegno, da una posizione accademica peraltro molto marginale, in una università pubblica, e che non ho dunque interessi privati da difendere, mi sono sentito in quelle occasioni di rassicurare questi genitori con il seguente argomento.
Se è vero – alcune università private forniscono statistiche differenti – che i laureati in Filosofia hanno scarse possibilità occupazionali, è altrettanto vero che questi ragazzi hanno la possibilità di acquisire una educazione alla vita (alla buona vita) non riscontrabile in alcuna altra facoltà universitaria. Ciò, purtroppo, non è vero sempre, in quanto dipende molto dai docenti che si incontrano, dalle letture che consigliano, dalla cura che manifestano per i propri studenti. Tuttavia, un giovane appassionato al pensiero che si iscrive a Filosofia, troverà sicuramente sulla propria strada quanto meno gli antichi filosofi greci, e da loro imparerà molto, anche ciò che serve a lenire le preoccupazioni economiche, comprensibili in un modo di produzione sociale conflittuale ed escludente.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: L’Europa nella strategia nucleare del Pentagono
L’Europa nella strategia nucleare del Pentagono
di Manlio Dinucci
Gli Usa si preparano a schierare nel vecchio continente missili nucleari a gittata intermedia con base a terra, analoghi a quelli degli anni Ottanta che furono eliminati dal Trattato firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e Reagan
I ministri della Difesa della Nato (per l’Italia Elisabetta Trenta, M5S) sono stati convocati a Bruxelles domani per approvare le nuove misure di «deterrenza» contro la Russia, accusata senza alcuna prova di aver violato il Trattato Inf. In sostanza si accoderanno agli Stati uniti che, ritirandosi definitivamente dal Trattato il 2 agosto, si preparano a schierare in Europa missili nucleari a gittata intermedia (tra 500 e 5500 km) con base a terra, analoghi a quelli degli anni Ottanta (i Pershing 2 e i Cruise) che furono eliminati (insieme agli SS-20 sovietici) dal Trattato firmato nel 1987 dai presidenti Gorbaciov e Reagan.
Le maggiori potenze europee, sempre più divise all’interno dell’Unione europea, si ricompattano nella Nato sotto comando Usa per sostenere i loro comuni interessi strategici. La stessa Unione europea – di cui 21 dei 27 membri fanno parte della Nato (come ne fa parte la Gran Bretagna in uscita dalla Ue) – ha bocciato alle Nazioni Unite la proposta russa di mantenere il Trattato Inf. Su una questione di tale importanza l’opinione pubblica europea è lasciata volutamente all’oscuro dai governi e dai grandi media.
Non si avverte così il crescente pericolo che ci sovrasta: aumenta la possibilità che si arrivi un giorno all’uso di armi nucleari. Lo conferma l’ultimo documento strategico delle Forze armate Usa, «Nuclear Operations» (11 giugno), redatto sotto la direzione del Presidente degli Stati maggiori riuniti.
Leggi tutto
Hits 3944
Hits 2974
Hits 2682
Hits 2103
Hits 1979
Hits 1914
Hits 1893
Hits 1872
tonino

Salvatore Bravo: Rosa Luxemburg e la sinistra

Rosa Luxemburg e la sinistra
di Salvatore Bravo
 Destra e Sinistra
Destra e Sinistra
La differenza tra destra e sinistra di governo si assottiglia fino a renderle perfettamente speculare, per cui la sinistra annaspa e si lascia strumentalizzare dalla destra in una pericolosa e complice relazione biunivoca. Porre il problema della differenza significa rendere palese la paralisi programmatica e politica, ed il congelamento nella storia attuale. La sinistra è flatus vocis, siamo in pieno nominalismo, la sinistra di governo risponde alla funzione del capitale, anzi lo blandisce, non è solo dimentica di sé, si lascia colonizzare, diviene parte attivo del dispositivo anonimo del capitalismo assoluto.
La presenza puramente formale della sinistra, nella storia occidentale attuale, ha la sua causa “principale-immediata” nella caduta del muro di Berlino (1989), dopo la caduta dei paesi a socialismo reale non vi è stato che un lungo frammentarsi per adattarsi al capitale, per rendersi visibile e spendibile sul mercato del voto. La sconfitta storica ha palesato un’altra verità: il progressivo emergere del nichilismo economicistico delle sinistre. La sconfitta è l’effetto della verità profonda della sinistra, ovvero il progressivo svuotarsi di un progetto, dell’umanesimo per un accomodarsi curvato sull’economia della sola quantità, per cui l’avanzamento della cultura liberista ha trovato un mondo simbolico già disposto all’economicismo, al verticismo del potere, all’antiumanesimo. Il capitalismo di stato dei paesi a socialismo reale non è stato antitetico, ma competitivo al capitalismo liberista, le destre del capitale sono avanzate su un terreno già arato, pronto a prediligere la quantità sulla qualità, la propaganda all’attività soggettiva consapevole.
Non tutta l’esperienza è stata nefasta, ma il “tradimento culturale” rispetto ai grandi propositi teoretici ed ideologici ha indotto gli elettori a scegliere l’autentico (capitalismo liberista) rispetto all’imitazione (capitalismo di stato).
Per poter riaffermare la differenza tra destra e sinistra mediata dalla condizione storica attuale, non è sufficiente affermare che destra e sinistra sono categorie vetuste, dovrebbero essere riformulate con nuovi contenuti, è necessario l’esodo dagli steccati ideologici. Ricostruire le posizioni ideologiche è operazione lenta e faticosa nella quale lo strato teoretico incontra la prassi.
Leggi tutto
Norberto Natali: Vorrei poter chiedere a Pasolini
Vorrei poter chiedere a Pasolini
di Norberto Natali
 La mancanza di Pasolini mi pesa
sempre di più quando sento, per esempio, parlare Saviano. Due
figure
opposte.
La mancanza di Pasolini mi pesa
sempre di più quando sento, per esempio, parlare Saviano. Due
figure
opposte.
Il grande poeta friulano sapeva farci misurare con i nostri punti di vista con l’abilità -direi da grande artista- di ricorrere alla provocazione graffiante, mai banale né fuorviante, con un sapiente uso del paradosso e dell’iperbole. Riusciva sempre a non lasciarci assopire sugli stereotipi accomodanti verso cui voleva indirizzarci il moderno potere borghese, riusciva a farci domandare cosa ci fosse veramente dietro le apparenze superficiali (e che futuro preparassero).
Come dimenticare l’imprevedibile difesa dei poliziotti figli dei contadini meridionali (quindi della disoccupazione e della povertà provocate dal fascismo e non risolte dalla DC) o certi discorsi “corsari” i quali, apparentemente, sembravano snobbare l’antifascismo ma in realtà servivano ad evitare che questo divenisse un comodo alibi per il potere.
Soprattutto non posso dimenticare la lezione di “Petrolio” e quando diceva (dovremmo ricordarcene tutti, oggi) di sapere che i criminali fossero al potere pur senza averne le prove.
Ovviamente, bisogna utilizzare questa sua eredità sapendo che si tratta degli interventi rapidi ed “educativi” di colui che era, in primo luogo, un grande poeta e come tale ci parlava della realtà. Sarebbe un errore interpretare alla lettera quelle sue incursioni morali, come fossero una posizione o, peggio, un programma politico: è evidente che egli fosse contro la repressione e la sua violenza, così come era un antifascista degno fratello di un partigiano ed un sostenitore convinto e fermo -lo è sempre stato- del PCI.
Lui scrisse una toccante cronaca -da par suo- dei funerali di Di Vittorio che era, in realtà, un tributo alla grande folla di lavoratori, di poveri ed emarginati che si erano radunati per l’ultimo saluto al “capo” della CGIL, in un certo senso un loro eroe.
Chissà se Pasolini confermerebbe (come vuole oggi parte importante della stampa e degli intellettuali, anche della politica) che la “capitana” tedesca protagonista delle cronache di queste settimane, là nella terra di Pio La Torre e Rosario Di Salvo, può essere considerata una specie di eroina della causa dei poveri e degli oppressi, della lotta contro la prepotenza e la corruzione degli sfruttatori.
Leggi tutto
Miguel Martinez: Ragioni e migrazioni
Ragioni e migrazioni
di Miguel Martinez
 La polarizzazione
comporta il rifiuto di immaginarsi che l’altro possa avere delle
ragioni.
La polarizzazione
comporta il rifiuto di immaginarsi che l’altro possa avere delle
ragioni.
Eppure a volte mi sembra che abbiano tutti delle ragioni; o comunque accettare questa possibilità è l’unico modo possibile per iniziare una riflessione su cosa fare: io sono convinto che stiamo vivendo il momento più importante della storia dall’estinzione dei dinosauri, e perdere tempo a litigare è suicida e criminale, insieme.
Quando dico tutti, intendo innanzitutto i migranti stessi, cui di solito nessuno pensa; poi quelli che tifano per il Capitano Salvini che ci salva dagli immigrati e quelli che invece tifano per la Capitana Rackete che salva gli immigrati.
Cito un episodio di cronaca di cui nessuno si ricorderà tra qualche mese, ma che ha diviso gli italiani in due schieramenti urlanti e totalmente incapaci di ascoltarsi a vicenda (i migranti non li ascolta nessuno per principio).
Partiamo dalle ragioni dei migranti.
Quello che una volta chiamavano “Terzo Mondo” è un po’ a chiazze: in Nigeria c’è chi ordina la pizza in aereo da Londra.
Ma per non rendere troppo lungo il discorso, chiamerò Terzo Mondo quella parte del mondo da cui la gente tende a emigrare di corsa, se solo può.
E perché tende a farlo?
Dodici anni fa (mi sento un po’ Cassandra, pensando a cosa è successo poi nel 2011) scrissi qui:
Quando il sole arde forte sull’Egitto e fa salire verso il cielo l’odore onnipresente dei rifiuti, i giovani – ragazzi spesso di una straordinaria ma sprecata autodisciplina, curiosità e intelligenza – si trovano a milioni nei caffè, con un’unica certezza: ma fish mustaqbal, “non c’è futuro“. E hanno, ovviamente, ragione.
Esiste però una magra consolazione: tutti sanno che c’è un Egitto degli egiziani, un posto ancora più caldo, devastato, afflitto dalla miseria e ancora più privo di qualunque speranza.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Da Marte, da Venere o da Atena?
Da Marte, da Venere o da Atena?
di Pierluigi Fagan
Il ruvido politologo neocon americano Robert Kagan, figlio di nobile stirpe politologica e marito della non meno schietta Victoria Nuland (incaricata diplomatica americana a trattare la crisi ucraina che in una conversazione intercettata, all’obiezione di quanto l’Europa si sarebbe sentita scavalcata dalle decisioni americane rispose “fuck the EU”), scrisse nel 2003 un piccolo pamphlet dal titolo “Of Paradise and Power: America and Europe in the New World Order”, qui in colonia, edito da Mondadori.
La tesi era che l’Europa compassionevole (Venere) che sogna la kantiana pace perpetua lo fa perché sotto l’ombrello dell’America hobbesiana e pragmatica (Marte). Da cui la tesi che gli americani vengono da Marte e gli europei da Venere, ma anche che questi secondi uscivano meglio dalla narrazione mitologica perché i primi si fecevan carico delle più spinose ed inevase responsabilità dei secondi. Famiglia occidentale ovvero papà americano mantiene madre europea un po' farfallina.
Così se Captain America è un soldato reso invincibile e primo movente di ogni schiera di giustizieri e liberatori, Captain Europa è una cooperante equa e solidale che sfida marosi e ministri razzisti-egoisti per portare solidarietà, accoglienza, empatia. Ancora meglio se Captain Europe-Venere è tedesca, visto che il restauro d’immagine dei tedeschi è una fabbrica di San Pietro che non si sa mai bene quando terminerà i suoi lavori visto che ha molto da restaurare. Anche se adesso avrà anche miss Ursula van der Leyen, mamma premurosa e ministro della difesa attenta alla parità di genere in quel delle forze armate dell’ex, famigerata, Wehrmacht .
Leggi tutto
Geraldina Colotti: Michelle Bachelet, diritti umani modello Gringolandia
Michelle Bachelet, diritti umani modello Gringolandia
di Geraldina Colotti
Chi è rimasto vigile rispetto al funzionamento di questo sistema-mondo, prevalentemente governato dai meccanismi del profitto e dagli interessi delle grandi multinazionali, sa che la retorica sui diritti umani viene usata spesso come schermo proprio da chi i diritti umani li nega dalle fondamenta: rendendo cioè un privilegio il diritto all'alimentazione, alla salute, all'educazione, ossia a una vita degna di essere vissuta. Chi ha ben presente l'asimmetria che regola la geopolitica attuale, sa che la funzione delle grandi istituzioni internazionali è governata o indirizzata dal gendarme nordamericano, senza il quale nessuna nomina dirigenziale potrebbe passare. Chi considera l'azione politica come scontro di interessi, ossia come risultato di una lotta di classe, inquadra in questi termini le figure dei dirigenti. E in questa prospettiva leggerà anche il vergognoso rapporto ONU di Michelle Bachelet sui “diritti umani in Venezuela”.
Un'informativa a senso unico che sembra più riferirsi alla “Gringolandia” da cui è dipesa la nomina di Bachelet come Alta Commissaria per i Diritti umani, che alla Repubblica Bolivariana del Venezuela. Un documento che sembra più una fotografia della “democradura” esistente nel Cile della signora Bachelet che della democrazia partecipata del Venezuela. Una relazione sdraiata sulla filosofia di quei partiti del “centro-sinistra” modello europeo che a forza di non volersi schierare né da una parte né dall'altra della barricata, hanno finito prima per essere loro stessi la barricata, e poi per saltare decisamente nel campo degli oppressori.
Leggi tutto
Domenico Moro: Lagarde e Von Der Leyen, prevalenza dei governi e dell'asse franco-tedesco
Lagarde e Von Der Leyen, prevalenza dei governi e dell'asse franco-tedesco
di Domenico Moro
Il Consiglio europeo ha deciso di nominare alla presidenza della Commissione europea la tedesca Ursula von der Leyen e alla presidenza della Bce la francese Christine Lagarde.
La nomina delle due donne politiche evidenzia quattro importanti dati di fatto:
1. La ulteriore dimostrazione che la Ue è un organismo intergovernativo e per nulla democratico, neanche in modo formale. Infatti, nella formazione delle decisioni della Ue prevalgono i governi nazionali: la nomina di von der Leyen e Lagarde è stata decisa dal Consiglio europeo, composto dai capi di governo e di Stato dei Paesi Ue. Il Consiglio europeo è l’organismo di gran lunga più importante della Ue, avendo compiti legislativi, di indirizzo politico complessivo, e di nomina dei membri della Commissione e della Bce. Le due nomine, fra l’altro, sono state fatte prima che il Parlamento europeo eleggesse il suo presidente e ormai il Parlamento può intervenire solo per ratificarle.
2. L’attribuzione delle due cariche più importanti a una tedesca e a una francese avviene con un evidente accordo di scambio tra i due Paesi più importanti della Ue e dell’area euro, la Germania e La Francia. Del resto, è stato Macron a proporre Ursula von der Leyen. Si tratta del primo banco di prova veramente importante del nuovo asse franco-tedesco, dopo la firma del trattato di Aquisgrana, che sancisce i nuovi termini dell’alleanza tra Francia e Germania per garantirsi l’egemonia continentale.
Leggi tutto
Davide Malacaria: Putin, la fine del neoliberismo e la visita in Italia
Putin, la fine del neoliberismo e la visita in Italia
di Davide Malacaria
“Il liberismo è superato”. Così Vladimir Putin al Financial Times, in un’intervista importante anche per la scelta dei tempi. La sua pubblicazione sull’autorevole quotidiano della City poco prima del G-20 di Osaka sta infatti a indicare che il presidente russo è tornato al centro della politica internazionale.
Come ha dimostrato il summit giapponese, nel quale Putin si è mosso con un’autorevolezza nuova. È fallito, dunque, il tentativo di relegarlo ai margini della geopolitica globale, sogno infranto di tanti suoi nemici.
Un’avversione nata non tanto dalla sua gestione del potere in Russia, in contrasto con i principi liberali (su questo si poteva sorvolare, come accade in altri contesti: vedi ad esempio l’Arabia Saudita).
Putin e il contenimento della globalizzazione
Il punto di opposizione, da cui la guerra contro Putin, era altro e irriducibile: la sua determinazione a difendere gli interessi della Russia era in contrasto con i dettati della globalizzazione, fondata sulla fine degli Stati nazionali.
Opposizione inaccettabile, giunta al parossismo quando la Russia pretese di riprendere il suo posto nel mondo (es. intervento in Siria), erodendo ancora di più i margini di manovra delle forze della globalizzazione.
Leggi tutto
Paolo Cacciari: Città, ricchezza collettiva
Città, ricchezza collettiva
di Paolo Cacciari
L’obiettivo più profondo del saccheggio in corso del territorio non è “fare cassa”, ma è distruggere gli spazi pubblici di condivisione, realizzare il progetto della signora Thatcher, “la società non esiste, esistono solo gli individui”. Come è possibile contrastare questi fenomeni così aggressivi, a cominciare dalla turisticizzazione della città (208 milioni di turisti stranieri in Italia nel 2018)? «La mia tesi – scrive Paolo Cacciari – è che non sia sufficiente pensare a una loro “regolamentazione” per via amministrativa… Sarebbe necessario un vero “salto di paradigma”…». I riferimenti per un passaggio di questo tipo sono molti: i commons, gli antichi usi civici consuetudinari delle proprietà collettive delle terre, esperienze come i Gas, le Comunità di sostegno all’agricoltura, co-housing, co-working, riuso, riciclo, bioedilizia, energie rinnovabili, commercio ed artigianato di prossimità, scambi non monetari… «Non è poi così difficile immaginare che gli abitanti riescano a riappropriarsi di pezzi e funzioni della città…»
Sappiamo di chi sono le nuove mani che si sono impadronite delle città. Le corporation globali degli investitori finanziari. Vorrei segnalare (per riuscire a replicare ovunque) una bella inchiesta del collettivo “Per un’altra città” di Firenze sulla proprietà immobiliare a Firenze.
Sappiamo anche come è avvenuta l’espropriazione del diritto degli abitanti a decidere sulle scelte d’uso delle loro città. Sono noti i processi globali di urbanizzazione selvaggia che hanno portato a livello mondiale il 50% della popolazione ad abitare nel 3% della superficie terrestre.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Partito e classe dopo la fine della sinistra
Partito e classe dopo la fine della sinistra
di Alessandro Visalli
 Questa, relazione, firmata da
Carlo Formenti e Alessandro Visalli, è stata presentata
all’Assemblea: “Oltre la sinistra. Lavoro, sovranità,
autodeterminazione”, tenutasi a Roma il 15 giugno
presso il
Circolo dei Socialisti alla Garbatella.
Questa, relazione, firmata da
Carlo Formenti e Alessandro Visalli, è stata presentata
all’Assemblea: “Oltre la sinistra. Lavoro, sovranità,
autodeterminazione”, tenutasi a Roma il 15 giugno
presso il
Circolo dei Socialisti alla Garbatella.
Il testo di lancio dell’Assemblea recitava:
Dopo il lancio, a marzo, del Manifesto per la Sovranità Costituzionale il campo in formazione del neo-socialismo patriottico ha subito le tensioni della fase in corso. La frattura tra coloro che sono connessi al sistema-mondo capitalista (mondo finanziario, reti industriali transanzionali, segmenti superiori dell’economia della conoscenza), e coloro che restano ai suoi margini, respinti nelle tante periferie del nostro paese, è stata rimossa da alcuni in favore di un’immaginaria frattura tutta morale tra destra e sinistra. Per altri la ricerca del consenso, e la fretta di intercettarlo, ha prodotto un’interpretazione del ‘populismo di sinistra’ come mera tecnica, priva di un’analisi all’altezza della durezza dello scontro in essere.
Noi crediamo che il conflitto sia tra i ‘centri integrati’ nel mercato mondiale, organizzati gerarchicamente, e le ‘periferie’ che sono nella posizione di essere sfruttate da questi. E crediamo che questo conflitto apra una frattura insanabile che attraversa diagonalmente l’intero campo del capitalismo. Esso crea fenomeni interconnessi come l’estendersi della precarietà, l’erosione della capacità di sostenere una vita decente, il degrado fisico delle nostre città, periferie e campagne, l’abbandono dell’ambiente e il saccheggio indiscriminato, di risorse e uomini del mondo.
Noi crediamo che non si possa assumere una posizione politica all’altezza del presente guardando ai fenomeni separatamente. Vanno visti come una configurazione unitaria fenomeni come il violento ordine europeo, lo svuotamento sistematico delle capacità dello Stato di proteggere i cittadini, la gara per attrarre - spesso in posizione subalterna – capitali privati, attività e lavoratori nelle aree forti, la tragedia dell’emigrazione ed immigrazione che squilibra sistematicamente le nostre società.
Noi crediamo che assumendo una lettura moralista e solo culturale di ciascun singolo fenomeno, nascondendone il carattere sistemico, le soluzioni vengano allontanate.
Per questo crediamo che sia venuto il momento di abbandonare le stantie abitudini di quella sinistra che, uscita sconfitta alla chiusa del XX secolo, abbandonata dal suo popolo (dopo avergli voltato le spalle), si è rifugiata dal nemico, o si è rinchiusa in una critica di tipo moralistico o libertario (perdendo la dimensione di emancipazione collettiva e retrocedendo su vaghe istanze di liberazione individuale). Questo atteggiamento è parte importante della sconfitta del 26 maggio.
Leggi tutto
Piotr: Carola e Matteo: il teatro sul mare

Carola e Matteo: il teatro sul mare
di Piotr
 Una nave della ONG Sea Watch recupera
al largo della
Libia poche decine di immigrati. Rifiuta l'invito della
guardia costiera libica (quella del traballante - e pure
fantoccio - Governo di Unità
Nazionale di al-Sarraj) a dirigersi verso il porto di Tripoli.
E' il più vicino, ma va da sé che non è il più sicuro
(almeno da un punto di vista politico-militare). E qui
iniziano le interpretazioni. Già, perché che cosa significa
“più
sicuro”?
Una nave della ONG Sea Watch recupera
al largo della
Libia poche decine di immigrati. Rifiuta l'invito della
guardia costiera libica (quella del traballante - e pure
fantoccio - Governo di Unità
Nazionale di al-Sarraj) a dirigersi verso il porto di Tripoli.
E' il più vicino, ma va da sé che non è il più sicuro
(almeno da un punto di vista politico-militare). E qui
iniziano le interpretazioni. Già, perché che cosa significa
“più
sicuro”?
Non so se vi ricordate, ma il governo spagnolo affermò ai tempi del caso Aquarius che “la Spagna non è il porto più sicuro, perché non è il più vicino, come dovrebbe essere secondo la legge internazionale”. Quindi la qualifica “sicuro” in quel caso era interpretata come un corollario di “più vicino”.
Il capitano tedesco della Sea Watch 3, Carola Rackete, non accetta per via della sua (ovvia e condivisibile) interpretazione del termine “più sicuro”, ma non va nemmeno verso il porto “più vicino” di Tunisi. Punta invece dritta a Lampedusa.
La Sea Watch, come la Sea Eye e poche altre ONG hanno navi che vanno su e giù davanti alla costa libica e sembra che tengano aggiornata la loro posizione su Facebook (non sono riuscito a verificare), che così sarebbe conosciuta dai trafficanti d'uomini che là inviano le loro carrette negriere. Fatto sta che la Sea Watch 3 non ha raccolto “naufraghi”, ma persone che dall'Africa “vogliono” venire in Europa. Non necessariamente in Italia. Ci faremo raccontare da un africano cosa bisogna intendere con quel “vogliono”.
La reazione dell'Europa, in base ai vecchi accordi, è che questi immigrati li deve gestire il porto di prima accoglienza. Ovvero: l'Italia quelli che arrivano via mare (a causa del “più vicino-più sicuro”) e la Grecia per quelli che arrivano via terra. Sì, proprio quella Grecia martoriata dalla Troika a maggior beneficio delle banche tedesche e francesi, che mentre vede il tasso di bambini indigenti salire inesorabilmente deve anche accollarsi masse di immigrati che nessun altro in Europa vuole.
Leggi tutto
Manolo Monereo: Podemos torni a fare opposizione
Podemos torni a fare opposizione
Eoghan Gilmartin e Tommy Greene intervistano Manolo Monereo
 Nelle elezioni generali di aprile, Unidos
Podemos era andata sopra le
aspettative, pur avendo perso circa un terzo dei
parlamentari rispetto alla tornata elettorale precedente.
Ma alle
europee ha riportato sconfitte significative su tutti i
fronti. Nelle «Città senza paura», ad eccezione di Cadice e
con
difficoltà Barcellona, la sinistra spagnola ha subito un
ulteriore colpo, non è riuscita riconquistare città come
Madrid,
Santiago de Compostela e Saragozza.
Nelle elezioni generali di aprile, Unidos
Podemos era andata sopra le
aspettative, pur avendo perso circa un terzo dei
parlamentari rispetto alla tornata elettorale precedente.
Ma alle
europee ha riportato sconfitte significative su tutti i
fronti. Nelle «Città senza paura», ad eccezione di Cadice e
con
difficoltà Barcellona, la sinistra spagnola ha subito un
ulteriore colpo, non è riuscita riconquistare città come
Madrid,
Santiago de Compostela e Saragozza.
* * * *
Nel 2015 abbiamo assistito alla vittoria di una serie di coalizioni locali radicali in diversi municipi in tutto il paese, mentre a livello nazionale Podemos minacciava di soffiare l’egemonia a sinistra al Psoe. Dopo la perdita di consensi di Podemos nelle elezioni politiche, la sconfitta di maggio subita dalle coalizioni radicali in molti municipi è sembrata una conferma della fine del momento post-Indignados nella politica spagnola. Come spiegheresti la fase di risacca di questo movimento?
Per spiegarlo dobbiamo considerare gli sviluppi di due movimenti differenti. Il primo copre un ciclo più lungo, ed è legato alla reazione democratica della società spagnola alla rottura del contratto sociale dopo la crisi del 2008. Il movimento degli Indignados aveva richieste simili a quelle di Occupy Wall Street, ma [a differenza del movimento americano] riuscì a mobilitare milioni di persone, dando vita a un vero e proprio movimento di massa fondato sull’alleanza tra una gioventù precaria e una generazione più vecchia, politicizzatasi durante il passaggio alla democrazia negli anni Settanta. La generazione di mezzo fu meno attiva.
Grazie soprattutto all’intelligenza e all’audacia di Pablo Iglesias, così come a quella di Ada Colau, questa indignazione è riuscita a esprimersi in maniera politicamente organizzata. Nel 2014, l’ingresso di Podemos nella vita politica ha portato, a sua volta, all’apertura di un secondo ciclo, più piccolo, nel quale le élite hanno provato a neutralizzare la minaccia al regime esistente.
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: Il "giallo" del 5G
Il "giallo" del 5G
di Elisabetta Teghil
La tecnologia non è neutrale, la scienza nemmeno. Non solo l’uso che viene fatto delle innovazioni e delle scoperte tecnologiche risponde alle esigenze e ai desiderata di chi detiene il potere, ma anche gli input alla ricerca e il tipo di ricerca e le sue modalità sono il frutto dei voleri e dell’impostazione del modello socio economico. Allo stesso tempo è impossibile fermare questo tipo di percorso. E’ sempre stato impossibile. Dall’aratro al cavallo di ferro, come chiamavano il treno i nativi d’America, dall’arco con le frecce alla polvere da sparo. Certo da un po’ di decenni a questa parte lo sviluppo tecnologico si sta dimostrando così vertiginoso che lo stesso essere umano che lo produce ha difficoltà a tenerne il passo. Il modello economico capitalista incentrato sul profitto ha fatto sì che il binomio ricerca/profitto desse degli esiti disastrosamente superiori ad ogni aspettativa.
E adesso è la volta del 5G, il nuovo sistema di comunicazione ultra veloce, di quinta generazione appunto.
Che cos’è il 5G?
Il 5G non è solo una rete per la telefonia mobile, dove transitano voce e dati. Il 5G sarà fino a 20 volte più veloce della attuale rete 4G. Tutta questa potenza, permetterà di trasformare l’infrastruttura in un «hub», ossia un «centro», tramite il quale si potranno comandare moltissimi oggetti «smart».
Leggi tutto
Chiara Zoccarato: La cultura d'impresa vs la cultura del potere
La cultura d'impresa vs la cultura del potere
di Chiara Zoccarato
Sul Sole24Ore è stato pubblicato un articolo dal titolo "L'Ilva, le sue dieci sorelle e la cultura anti-industriale" che denuncia le azioni contro l'industria produttiva e finanziaria del governo. Ma cosa vorrebbe, dunque, Confindustria? Che tipo di cultura pro-industria vorrebbe? Lo Stato dovrebbe attrarre multinazionali e capitali esteri, dovrebbe favorire l'industria, perchè qualsiasi industria è meglio di niente, anche se inquina, dovrebbe abbassare il debito pubblico. Ma funzionerebbe? Per qualcuno si, per tutti gli altri no.
Lo Stato che ha veramente a cuore il suo tessuto imprenditoriale è quello
- che spende di tasca propria per ricerca e sviluppo, perchè il progresso è maggiore e la ricaduta tecnologica è a suo vantaggio
- che possiede le industrie strategiche del paese e il controllo delle risorse primarie, e contribuisce così ad alimentare un indotto e una filiera nel settore privato florida e sicura, oltre a poter aprire nuovi mercati rispetto a quelli esistenti in cui possono prosperare
- che detiene, sviluppa e assicura la manutenzione delle infrastutture vitali del paese
- che garantisce la piena occupazione e quindi un livello di domanda aggregata funzionale alla stabilità macroeconomica e dei prezzi, oltre a fornire un bacino di potenziali acquirenti domestici certi, cosa difficile da ottenere con quelli esteri
Leggi tutto
David Insaidi: Iran, sale la tensione. Petrolio, salgono i prezzi
Iran, sale la tensione. Petrolio, salgono i prezzi
di David Insaidi
Le vicende accadute le scorse settimane (bombardamento delle navi petroliere, abbattimento del drone USA da parte dell’Iran, attacco a questo, deciso e poi sospeso all’ultimo da parte di Trump) segnano una preoccupante escalation nel possibile conflitto militare USA-Iran.
Stiamo parlando di una guerra, quella tra Teheran e gli Stati Uniti, che, se dovesse mai scoppiare per davvero, avrebbe conseguenze difficilmente prevedibili.
Infatti un conflitto del genere coinvolgerebbe inevitabilmente paesi come Israele e Arabia Saudita. E non solo perché sono alleati stretti di Washington, ma anche e soprattutto perché entrambe vedono Teheran come il fumo negli occhi, e per diversi motivi. Motivi politico-militari e geo-strategici, nel caso di Israele, ai quali si aggiungono motivi economico-commerciali, nonché religiosi, per quanto riguarda l’Arabia Saudita.
L’Iran, infatti, ha strettissimi rapporti con tutto il mondo sciita, presente a macchia di leopardo un po’ in tutto il Medio Oriente. E quando si parla di sciiti, si parla di formazioni del calibro di Hezbollah in Libano, capaci di tenere testa ad una potenza militare come Israele, oppure come quelle che in Siria hanno dato un contributo fondamentale nella sconfitta del terrorismo islamico (Isis in primo), o come quelle presenti massicciamente in Iraq, nonché quelle che nello Yemen stanno facendo vedere i sorci verdi all’Arabia Saudita.
Leggi tutto
Dante Barontini: Fine della Storia? No, della democrazia…
Fine della Storia? No, della democrazia…
di Dante Barontini
Quando il caos ci sommerge, l’unica possibilità di salvare il funzionamento del cervello è sollevarsi al di sopra del chiacchiericcio e guardare le cose dall’alto per individuare almeno le correnti più importanti. La loro direzione di marcia.
Se qualcuno crede davvero che un tal Matteo Salvini sia il “capo” o la “mente” dell’ondata reazionaria che sta sommergendo l’Italia probabilmente ha bisogno di dare una ripassata alla Storia, o almeno di ricordare che i processi storici selezionano – determinandoli – gli uomini e le donne incaricati di rappresentarli. Non viceversa.
Un ministro degli interni, vice-premier e segretario di partito che trova il tempo di fare un lunghissimo sproloquio, in video, contro la magistratura “rea” di aver liberato la “capitana Carola”, non ha evidentemente molto altro da fare, oltre a “comunicare” h24.
Qui Salvini: https://youtu.be/xAx3Jaoq-v4
A gestire gli affari correnti – del Viminale, della Lega e del governo – ci pensa sicuramente qualcun altro.
Si chiama “personalizzazione della politica”, ossia riduzione dei problemi complessi a soluzioni semplici, al livello delle discussioni tra ubriachi all’osteria. Un attore occupa tutta la scena, mentre dietro le quinte si governa, si media, si compravende, si decide.
Leggi tutto
di Gianpasquale Santomassimo
Ci troviamo all’interno di un sommovimento, in atto da tempo, che riguarda tutto l’Occidente e che in Europa assume i contorni più esplosivi. Chi si lamenta ogni giorno per avere Salvini al governo non può immaginare cosa significhi essere governati da Trump negli Usa, da Bolsonaro in Brasile, ma anche da Orbàn in Ungheria e in Polonia dal clericalismo reazionario. Per non parlare, fatte le debite distinzioni, di Erdogan o Putin.
Usare termini vaghi e impressionistici come “onda nera” rende bene l’idea di una incapacità della cultura della sinistra di tentare di tematizzare razionalmente il fenomeno in atto, dimenticando, fra l’altro, che di questa “onda” sono parte milioni di persone che spesso votavano a sinistra fino a ieri o all’altro ieri.
In estrema sintesi, potremmo dire che si è sgretolata e si sta inabissando tutta la visione del mondo della cultura liberal che è stata lungamente egemonica dopo l’Ottantanove, che ha interpretato la globalizzazione come un fenomeno naturale che non andava governato ma assecondato e accelerato, dando per acquisita l’estinzione in atto degli Stati nazionali e senza porsi troppi pensieri sugli sconfitti e i perdenti, cui si rivolgeva l’invito, benevolo ma pressante, ad adeguarsi.
Una visione del mondo che è stata acquisita in pieno da ciò che si è autoproclamata “sinistra” nel trentennio alle nostre spalle, tanto nella versione “moderata” che in quella “radicale”, distinte a ben vedere soprattutto dall’intensità della rivendicazione dello stesso orizzonte.
Hits 3950
Hits 2978
Hits 2686
Hits 2403
Hits 2261
Hits 2109
Hits 1995
Hits 1899
Hits 1877
tonino

Renato Caputo: La balcanizzazione dell’Italia
La balcanizzazione dell’Italia
di Renato Caputo
Il pensiero unico neoliberista mira a indebolire la sovranità popolare e a tal fine, per dare il colpo definitivo alla Costituzione italiana “troppo democratica”, favorisce la balcanizzazione del paese
 La netta vittoria nelle ultime elezioni
politiche del
qualunquista – programmaticamente né di
destra, né di sinistra – Movimento 5
stelle rischiava di mettere in discussione un
elemento chiave della Seconda repubblica,
ovvero della restaurazione liberista,
il bipolarismo fra due diverse fazioni dello stesso partito: i
liberali progressisti e i liberali
conservatori.
La netta vittoria nelle ultime elezioni
politiche del
qualunquista – programmaticamente né di
destra, né di sinistra – Movimento 5
stelle rischiava di mettere in discussione un
elemento chiave della Seconda repubblica,
ovvero della restaurazione liberista,
il bipolarismo fra due diverse fazioni dello stesso partito: i
liberali progressisti e i liberali
conservatori.
Tale bipolarismo faceva particolarmente comodo ai dirigenti del centro-destra e del centro-sinistra che potevano godere di una notevole rendita di posizione assicurata dal voto utile. Era anche la soluzione più confacente al pensiero unico neoliberista che voleva togliere la possibilità alle classi non possidenti di ottenere una parziale redistribuzione a loro favore di rendite e profitti mediante il suffragio universale. Non potendo eliminare quest’ultimo, se non mettendo a serio rischio la loro capacità di egemonia sui subalterni, il modo migliore per renderlo inoffensivo era svuotarlo dall’interno, riproducendo il modello dello Stato liberale italiano dalla nascita alla Prima guerra mondiale dove appunto si confrontavano due diverse tendenze dello stesso partito e, a scanso di equivoci, dominava permanentemente il trasformismo, visto che non essendoci differenze essenziali e contendendo essenzialmente per la conquista del centro i politicanti erano pronti a tutto pur di mantenere le loro poltrone nelle istituzioni.
Bisogna anche riconoscere che fra i principali responsabili della politica politicante della messa in discussione di tale modello troviamo il Pd, con i governi Letta, Renzi e Gentiloni che si sono spostati talmente a destra da far perdere qualsiasi significato al termine centro-sinistra. In particolare Renzi ha fatto di tutto per coinvolgere nel proprio governo il centro-destra e mirava apertamente alla costruzione di un Partito della nazione, in grado di ricomprendere nel proprio trasformismo centrista tanto il centro-sinistra che il centro-destra. Tale politica non poteva che mettere in allarme i sacerdoti del pensiero unico neoliberista, in quanto veniva meno la finzione del bipolarismo e il ricatto del voto utile e questo finiva per lasciare spazio al risorgere della sinistra.
Leggi tutto
Geraldina Colotti: Venezuela, a proposito di tortura e dintorni
Venezuela, a proposito di tortura e dintorni
di Geraldina Colotti
 Verso le ore 11 del 28
gennaio 1982, le
forze speciali di polizia fanno irruzione in un appartamento
di via Pindemonte, 2 a Padova dov'è tenuto prigioniero il
generale USA James L.
Dozier. Il generale è stato sequestrato qualche tempo prima a
Verona dalla guerriglia marxista delle Brigate Rosse, attiva
in Italia dagli anni
'70. Dozier viene liberato e i cinque brigatisti arrestati
vengono ferocemente torturati per giorni con modalità tante
volte descritte nelle
testimonianze dei sopravvissuti alle dittature del Cono Sur.
Due anni dopo, un prudentissimo rapporto di Amnesty
International registra un
“allarmante aumento di denunce di maltrattamenti” da parte di
arrestati nei primi tre mesi dell'82. Le denunce – scrive
l'organizzazione – si riferiscono ai casi di tortura o
maltrattamenti che sono avvenuti nell'intervallo tra l'arresto
e il trasferimento in
carcere, in commissariati di polizia, caserme di polizia e in
altri posti che presumibilmente non possono venire
identificati perché i fermati
erano incappucciati o bendati.
Verso le ore 11 del 28
gennaio 1982, le
forze speciali di polizia fanno irruzione in un appartamento
di via Pindemonte, 2 a Padova dov'è tenuto prigioniero il
generale USA James L.
Dozier. Il generale è stato sequestrato qualche tempo prima a
Verona dalla guerriglia marxista delle Brigate Rosse, attiva
in Italia dagli anni
'70. Dozier viene liberato e i cinque brigatisti arrestati
vengono ferocemente torturati per giorni con modalità tante
volte descritte nelle
testimonianze dei sopravvissuti alle dittature del Cono Sur.
Due anni dopo, un prudentissimo rapporto di Amnesty
International registra un
“allarmante aumento di denunce di maltrattamenti” da parte di
arrestati nei primi tre mesi dell'82. Le denunce – scrive
l'organizzazione – si riferiscono ai casi di tortura o
maltrattamenti che sono avvenuti nell'intervallo tra l'arresto
e il trasferimento in
carcere, in commissariati di polizia, caserme di polizia e in
altri posti che presumibilmente non possono venire
identificati perché i fermati
erano incappucciati o bendati.
I metodi di tortura riferiti ad Amnesty includono “percosse prolungate e il costringere gli arrestati a bere grande quantità di acqua salata. Sono state denunciate anche bruciature con mozziconi di sigaretta, getti di acqua ghiacciata, torcimento dei piedi e dei capezzoli, strappo dei capelli, strizzatura dei genitali e l'impiego di scariche elettriche”. Altre testimonianze con altrettanti riscontri medici, parlano di torture di natura sessuale subite da alcune guerrigliere. E si denunciano finte esecuzioni, dentro e fuori le carceri speciali, dove pestaggi, maltrattamenti e deprivazioni psico-sensoriali sono all'ordine del giorno, soprattutto in quell'anno.
Nel luglio dell'83, quattro ufficiali di polizia che erano stati oggetto di queste denunce, vengono riconosciuti colpevoli di “abuso di autorità” commesso durante gli interrogatori. Saranno condannati a pene da un anno a 14 mesi, con la condizionale. Un quinto viene prosciolto perché nelle elezioni politiche di giugno era stato eletto deputato, beneficiando così dell'immunità parlamentare. In Italia, a tutt'oggi non esiste il reato di tortura e quei poliziotti verranno poi prosciolti in appello. Il brigatista Cesare di Leonardo che, nonostante le torture non si è pentito, sta ancora scontando una condanna all'ergastolo in un carcere speciale, uno di quelli istituiti, con un semplice decreto ministeriale, a maggio del 1977.
Leggi tutto
Roberto Ciccarelli: Il diritto al futuro contro il capitalismo della sorveglianza
![]()
Il diritto al futuro contro il capitalismo della sorveglianza
di Roberto Ciccarelli
Il plusvalore estratto dalla forza lavoro nel capitalismo delle piattaforme ha meccanismi che arrivano a condizionare l’identità personale. Analisi critica del libro, ancora non tradotto, di Shoshana Zuboff: “The Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future at the new frontier of power”.
 Shoshana Zuboff ha scritto un
libro importante di filosofia
politica e critica dell’economia politica digitale: The
Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future
at the new frontier of
power (Profile Books. pp. 691; L’epoca del
capitalismo di sorveglianza: la lotta per un futuro umano
sulla nuova frontiera del
potere). È un libro necessario che racconta la storia
terribile e urgente di cui siamo protagonisti e offre
strumenti contro il nuovo
potere. Considerato il fatto che non è stato ancora tradotto
in italiano, propongo una guida al libro e una lettura critica
delle cinque tesi
principali.
Shoshana Zuboff ha scritto un
libro importante di filosofia
politica e critica dell’economia politica digitale: The
Age of Surveillance Capitalism. The fight for a human future
at the new frontier of
power (Profile Books. pp. 691; L’epoca del
capitalismo di sorveglianza: la lotta per un futuro umano
sulla nuova frontiera del
potere). È un libro necessario che racconta la storia
terribile e urgente di cui siamo protagonisti e offre
strumenti contro il nuovo
potere. Considerato il fatto che non è stato ancora tradotto
in italiano, propongo una guida al libro e una lettura critica
delle cinque tesi
principali.
0. Che cos’è il capitalismo della sorveglianza
1. Un nuovo ordine economico che configura l’esperienza umana come una materia prima gratuita per pratiche commerciali nascoste di estrazione, predizione e vendita;
2. una logica economica parassita nella quale la produzione delle merci e dei servizi è subordinata a una nuova architettura globale della trasformazione comportamentale degli individui e delle masse;
3. una minaccia significativa alla natura umana nel XXI secolo così come il capitalismo industriale è stato per il mondo naturale nel XIX e XX secolo;
4. una violenta mutazione del capitalismo caratterizzata da una concentrazione della ricchezza, conoscenza e potere senza precedenti nella storia umana; (…);
5. l’origine di un nuovo potere strumentale che afferma il dominio sulla società e presenta una sfida impegnativa alla democrazia di mercato (corsivo mio); (…)”. (p.1).
1. Il capitalismo della sorveglianza è un nuovo ordine economico che configura l’esperienza umana come una materia prima gratuita per pratiche commerciali nascoste di estrazione, predizione e vendita.
Il capitalismo di sorveglianza trasforma l’esperienza in “materiale grezzo gratuito”. Tale materiale è estratto da un corpo, descritto come una “carcassa”, è raffinato, reso intelligente e trasformato in dati comportamentali.
Leggi tutto
Militant: ZingAter. Fenomenologia di una presa per il culo
ZingAter. Fenomenologia di una presa per il culo
di Militant
Non sono poi così lontani i tempi in cui il segretario del PD elargiva promesse tra le mani degli abitanti di Casal Bruciato, accorsi incuriositi dall’apertura in zona della sezione di un partito di cui prima lì si era solo sentito parlare attraverso i media o i racconti di coloro che si erano spinti oltre il confine della periferia romana. Praticamente una creatura mitologica. Quel giorno, il neoeletto Zingaretti, in un momento di pathos estremo, giurava che mai, mai più il Partito Democratico avrebbe abbandonato quelle strade e quella gente, e che da allora si sarebbe per loro battuto come mai prima del pessimo risultato elettorale; pochi giorni prima, uno sfrontato Orfini si presentava, venendo prontamente contestato dalla piazza tanto da necessitare della tutela di un ingente cordone di agenti delle Forze dell’Ordine, all’appuntamento indetto dalle realtà di zona per contrastare lo sciacallaggio mediatico che Casapound stava ponendo in atto, proprio in quel quartiere, sulla pelle dell’ormai nota famiglia rom e di quanti (fortunatamente non molti), esasperati dalle condizioni sociali e di vita sempre più precarie e disagevoli, su di essi avevano intenzione di sfogar la propria rabbia. Nessuno voleva lasciar sole le periferie e tutti volevano lottare al fianco delle classi più emarginate della società, per condizioni abitative più pronte ed adeguate.
A fronte di ciò apparirà dunque inverosimile che oggi non ci si troverà dinanzi ad alcuna levata di scudi contro l’operazione che Ater e Regione Lazio (a guida, ormai da due mandati, dell’illibato e genuino Zingaretti) stanno mettendo in essere per svendere a buon mercato il patrimonio immobiliare di proprietà della prima di queste. Ma facciamo un passo indietro.
Leggi tutto
Salvatore Prinzi: Cosa ci insegnano le elezioni greche?
Cosa ci insegnano le elezioni greche?
di Salvatore Prinzi
Le cose sono complesse, maledettamente complesse.
Soprattutto se non vuoi semplicemente amministrare quello che c'è (che già è un'arte), ma trasformarlo alla radice.
Le elezioni greche, se ci disponiamo a leggere la realtà senza paraocchi, ci consentono di fare molte riflessioni. Ne propongo qualcuna, consapevole dei limiti di questo spazio.
1. La più generale, banale ma bene ripeterselo, perché vale per tanti paesi. E' democrazia questa? Sono "democratiche" elezioni in cui
a) vota poco più di un cittadino su 2;
b) ci sono sbarramenti al 3% (o al 4% etc), che impediscono che sia rappresentato chi vota partiti piccoli (a sto giro in Grecia l'8% dei votanti ha visto "sfumare" il proprio voto);
c) ci sono premi di maggioranza enormi (per cui Syriza che fa il 31% prende 86 seggi, e Nea Demokratia che fa il 39% ne prende 158, quasi il doppio)?
Questi sistemi mediatici ed elettorali, in nome della "governabilità" voluta dal neoliberismo, stanno producendo parlamenti poverissimi e l'esclusione delle persone, soprattutto delle fasce più popolari, dalla partecipazione.
Leggi tutto
Alfonso Gianni: Le radici del progetto secessionista
Le radici del progetto secessionista
di Alfonso Gianni
Intorno alla metà degli anni novanta in Germania prende forma il famoso piano presentato da due deputati della Cdu/Csu, Wolfgang Schauble e Karl Lamers, il primo destinato alla luminosa carriera che sappiamo. Si predica la necessità di una Kernel Europa, cioè di un nucleo duro attorno al quale gli altri dovrebbero ruotare come satelliti in funzione servente. Il progetto troverà lungo il tempo varie declinazioni attorno al tema dell’Europa a due velocità baricentrata sull’asse franco-tedesco
Ora che l’ansia da procedura d’infrazione è venuta meno, al prezzo di una manovra correttiva intorno agli 8 miliardi mascherata da assestamento di bilancio, la maggioranza pentaleghista vuole concentrare tutti i suoi sforzi sull’autonomia regionale differenziata. Per la verità Salvini ha promesso che si farà anche la flat tax, ma questa appare meno probabile ed imminente, visto che il governo si è legato le mani a Bruxelles fino al 2020.
Per l’autonomia regionale invece la «strada è tutta in discesa» ha dichiarato il capo della Lega, mentre tra i più scalpitanti si segnala il presidente dell’Emilia Romagna, il piddino Stefano Bonaccini. La posta in gioco è alta e decisiva. Ne va della coesione politica, civile e sociale del nostro paese. E purtroppo non è un’idea balzana dell’ultimo momento, ma un progetto lungamente covato a livello internazionale e dotato di basi economiche. Se ne comincia a parlare con insistenza negli anni novanta. Il punto di riferimento teorico viene fornito da un fortunato studio di Kenichi Ohmae, un Senior Partner della McKinsey & Company, la più autorevole multinazionale di consulenza strategica.
Leggi tutto
Michele G. Basso: Davvero l'autodeterminazione dei popoli di Lenin è da mettere in soffitta?
Davvero l'autodeterminazione dei popoli di Lenin è da mettere in soffitta? [abbozzo]
di Michele G. Basso
Marx scriveva ad Engels(10 dicembre 1869): " ...è interesse assoluto e diretto della classe operaia inglese liberarsi del suo attuale vincolo con l'Irlanda... Per lungo tempo ho creduto che fosse possibile abbattere il regime irlandese mediante l'ascendancy della English working class. Ho sempre sostenuto questo parere nel New York Tribune. Uno studio più approfondito mi ha convinto ora del contario. La working class inglese non farà mai nulla, prima che si sia liberata dall'Irlanda. Dall'Irlanda si deve far leva. Per questo motivo la questione irlandese è così importante per il movimento sociale in genere".
"Accelerare la rivoluzione sociale in Inghilterra rappresenta...l'obiettivo più importante dell' Associazione internazionale dei lavoratori. L'unico modo per accelerarla è rendere l'Irlanda indipendente"(Marx a Sigfried Meyer e August Vogt, 9 aprile 1870)
"L' atteggiamento dell'Internazionale nei confronti del problema irlandese è molto chiaro. Essa deve innanzitutto promuovere la rivoluzione sociale in Inghilterra. A questo scopo, un forte colpo deve venire inferto in Irlanda". (Comunicazione confidenziale)
L'Inghilterra era allora la metropoli del capitale e l'unico paese in cui fossero presenti pienamente le condizioni materiali per il socialismo, questo spiega il concentrarsi dell'attenzione di Marx su questo paese e sull'Irlanda..
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: I migranti, il senso comune e la politica
I migranti, il senso comune e la politica
di Tommaso Nencioni
Si dice che chi si oppone al governo sul terreno dei diritti dei migranti “fa il gioco di Salvini”. Le cose sono un po’ più complicate di così. Il giudice che scarcera la Capitana della nave Sea Watch appartenente ad una ONG non fa il gioco di Salvini, applica la legge dopo averla interpretata (può non piacere la legge, e addirittura può non piacere la maniera in cui un giudice l’ha interpretata, ma è legge). La ONG che fa sbarcare i migranti raccolti in mare non fa il gioco di Salvini, risponde alla propria ragione sociale (che può piacere o meno; rimane il fatto che una organizzazione che ha come unico scopo raccogliere naufraghi non è tenuta a prendere in considerazione altre variabili, a parte il rispetto della legge).
Chi però dovrebbe fare opposizione al governo e lo fa caratterizzandosi attraverso battaglie totalmente aliene al senso comune non è che fa il gioco di Salvini, ma sicuramente non ne scalfisce il potere. Se c’è un senso comune favorevole al blocco di potere oggi al governo, questo va cambiato, ma non può essere cambiato astraendosi totalmente dalle ragioni che sono alla base di questo senso comune. In ballo c’è la costruzione di un blocco sociale potenzialmente maggioritario in grado di cambiare le relazioni di forza nella società, anche (soprattutto? decidete voi) a vantaggio dei migranti, ma che non può avere il tema dei migranti come chiave di volta.
Leggi tutto
Stefano G. Azzarà: Il populismo socialsciovinista bianco, l’Europa e la ricolonizzazione del mondo

Il populismo socialsciovinista bianco, l’Europa e la ricolonizzazione del mondo
L’emergere di una democrazia bonapartista postmoderna e plebiscitaria e la rivolta “sovranista” contro la Grande Convergenza
di Stefano G. Azzarà (Università di Urbino)
Presento qui la postfazione a un’antologia di testi di Domenico Losurdo dal titolo Imperialismo e questione europea, curata da Emiliano Alessandroni e in uscita presso La scuola di Pitagora. Ringrazio “Dialettica e Filosofia” per avermi consentito di anticiparlo e diffonderlo in Open Access
 Abstract
Abstract
Il mito transpolitico di un superamento epocale delle categorie di destra e sinistra copre in realtà l’esito ultimo di un gigantesco processo decennale di concentrazione del potere che ha determinato la fine della democrazia moderna e l’avvio di una fase di sperimentazioni di forme postmoderne di democrazia. Analogamente, la rivolta populista dei ceti medi e della piccola borghesia, che risponde a una crisi di legittimazione delle “caste” politiche, economiche e culturali europee, è in primo luogo la copertura di una furibonda guerra interna alle classi tra élites stabilite liberoscambiste e élites outsider protezioniste, le quali ultime contestano il consensus universalista e liberaldemocratico imponendo un nuovo consensus particolarista e riconducendo il liberalismo alle proprie origini conservatrici. Questa rivolta è però anche la reazione alla Grande Convergenza del mondo ex coloniale e a quel catastrofico management della crisi (l’Austerity per i poveri) attraverso il quale il capitalismo in Occidente ha scaricato sulle classi subalterne i costi della redistribuzione globale del potere e della ricchezza, scatenando risposte xenofobe indotte e un socialsciovinismo di massa che sta finendo per erodere quanto rimaneva della sinistra novecentesca.
* * * *
1. Una gigantesca concentrazione di potere neoliberale nel solco del bonapartismo postmoderno
È stato notato come l’Italia abbia spesso svolto il ruolo di un laboratorio capace di anticipare tendenze che si sarebbero manifestate in seguito anche in altri paesi, segnando a volte un’intera epoca storica.
Lo è stata e forse lo è ancora sul piano intellettuale, come ha rivendicato Roberto Esposito già negli anni Ottanta e di nuovo più di recente, rinviando ai nomi di Machiavelli e Vico e a una costante spinta di mondanizzazione resasi infine esplicita nel concetto di biopolitica1. Ma possiamo dire che lo sia stata e lo sia anche sul piano politico in senso stretto e cioè su quello delle forme della governance e, ancor prima, delle forme del conflitto.
Leggi tutto
Michele Castaldo: Immigrazione: una navigazione tra bassa criminalità, calcolato cinismo, falsità e ipocrisia
Immigrazione: una navigazione tra bassa criminalità, calcolato cinismo, falsità e ipocrisia
di Michele Castaldo
 Un nuovo
fatto di ordinaria
criminalità compiuto nei confronti degli immigrati, quello di
utilizzare l’episodio della “forzatura del blocco navale” da
parte di Carole Rachete con la Sea Watch 3, per attaccare gli
immigrati con una violenza pari alle forze politiche di
destra, che Salvini ben
sintetizza.
Un nuovo
fatto di ordinaria
criminalità compiuto nei confronti degli immigrati, quello di
utilizzare l’episodio della “forzatura del blocco navale” da
parte di Carole Rachete con la Sea Watch 3, per attaccare gli
immigrati con una violenza pari alle forze politiche di
destra, che Salvini ben
sintetizza.
Nessuna meraviglia, ci mancherebbe, se una Meloni invoca l’affondamento della nave incriminata; quando si dice che l’animo femminile è più sensibile, più umano, perché materno, ovvero la quota rosa della carognata. Non che ci voglia molto per provare disprezzo per Salvini, Meloni et similia. Qualche domanda andrebbe posta anche al M5S, ma è tempo perso, sono troppo stretti nella morsa che il potere, quello vero, dell’economia del paese, gli ha stretta al collo.
È perfettamente inutile disquisire sulle leggi dei mari e dei porti, sui diritti territoriali o umani, non è mestiere di chi è di parte, da entrambe le parti: tra chi difende comunque il diritto dei più deboli contro chi si affanna a sputare su di essi, a vivere della loro miseria, del loro sfruttamento, del loro lavoro.
Trafficanti di esseri umani?
Si. Ha ragione Salvini: c’è un traffico di esseri umani. Cui prodest? A chi giova l’immigrazione, non certamente agli operai, che si ritrovano un concorrente in casa; non giova ai disoccupati per la stessa ragione. Giova al capitalismo nel suo insieme e ai capitalisti italiani di tutta la scala piramidale: piccoli, medi e grandi di tutti i settori in modo particolare di quelli in crisi. Questa semplice verità non viene mai messa in luce perché è troppo complicato spiegare che molti paesi africani sono stati invasi per decenni e rapinati delle loro risorse e oggi si cerca di scaricare la crisi, che l’Occidente sta attraversando, ancora su di essi alimentando, come in Libia, guerre fratricide con lo scopo di continuare, da un lato, a rapinare il petrolio e, dall’altro lato, favorire l’emigrazione in massa verso i lidi europei in cerca di fortuna. Lungo il cammino di loro vita, per raggiungere il sospirato Occidente, l’Europa o gli Usa, incrociano quelli che si prestano al lavoro sporco di caricarli su barconi di fortuna e arrivare sulle coste più vicine all’”Eldorado” e una parte di essi trova la morte senza mai raggiungere una riva.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Genocidio, una parola che si declina al plurale
Genocidio, una parola che si declina al plurale
di Carlo Formenti
Il termine genocidio è stato inventato dal giurista polacco di origine ebraica Raphael Lemkin negli anni della Seconda Guerra mondiale. Lemkin coniò il concetto per denotare la distruzione di una nazione o di un gruppo etnico, ma ne diede una definizione più articolata che non si riferiva esclusivamente all’annientamento fisico delle comunità vittime del crimine di genocidio, ma comprendeva una serie di condotte, quali: la soppressione delle istituzioni di autogoverno, la distruzione della struttura sociale e della classe intellettuale, il divieto di usare la propria lingua, la privazione dei mezzi di sussistenza, il divieto di matrimoni interraziali, il divieto di praticare un determinato culto religioso e la distruzione dei suoi luoghi, l’umiliazione e la degradazione morale. In base a tale definizione, lo storico Leonardo Pegoraro (ricercatore presso la Monash University) mette in discussione la tesi “unicista” che vede nella Shoah il solo evento storico realmente suscettibile di essere definito genocidio, in un libro che analizza alcuni dei più efferati casi di sterminio dei popoli indigeni (“I dannati senza terra. I genocidi dei popoli indigeni in Nord America e in Australasia”, con una Prefazione di Franco Cardini, Meltemi editore).
Pegoraro esordisce mettendo a confronto il punto di vista di chi (come Foucault) ritiene che il genocidio sia un fenomeno eminentemente moderno, se non addirittura novecentesco, e quello di chi (come Sartre) è viceversa convinto che si tratti di una invariante antropologica che si è presentata più volte nel corso della storia della specie. La parola è nuova (il che – aggiungo io – è probabilmente ciò che ispira la posizione di Foucault, dettata da un approccio nominalista-genealogico) ma il fatto è antico, sentenzia Pegoraro schierandosi con Sartre.
Leggi tutto
Stefano Porcari: Le multinazionali straniere in Italia si stanno prendendo – o chiudendo – tutto
Le multinazionali straniere in Italia si stanno prendendo – o chiudendo – tutto
di Stefano Porcari
“Occorre trovare un nuovo compratore”; c’è una “azienda straniera interessata a rilevare l’impianto”; “alcuni reparti possono salvarsi”. Sono queste le parole che ormai sentiamo ripetere sistematicamente e falsamente sia davanti ai cancelli delle fabbriche in crisi sia nei tavoli al Ministero dello Sviluppo Economico. E’ una perversione che i dati dimostrano non essere praticabile né indicare una soluzione adeguata alle esigenze di lavoratrici, lavoratori e della stessa economia del nostro paese.
Nel 2005 le imprese italiane partecipate o controllate da società straniere erano 2.551 e occupavano 520mila dipendenti. Nel 2018 sono salite a 3.519 (+38%) e gli occupati sono diventati 568mila (+10%). Il fatturato di queste aziende passate in mano o partecipate da società estere, nello stesso periodo, è salito da 470 e 507 miliardi di euro.
Analizzando i settori manifatturieri in cui è cresciuto il controllo da parte di multinazionali estere, possiamo vedere come nella metallurgia gli occupati sono passati dai 130mila del 2015 ai 160mila del 2018. Più che raddoppiati invece i dipendenti di aziende estere in un settore come tessile, abbigliamento, calzature che sono passati dai 12mila del 2015 ai 27mila del 2018.
Ma chi sono i cosiddetti investitori stranieri ai quali da anni si sta consegnando una parte consistente del sistema industriale nel nostro paese? Secondo il Sole 24 Ore sono fondi diprivate equity, grandi gruppi globali e più di recente anche piccole imprese multinazionali, che oggi controllano in Italia più di 3.500 aziende e più di mezzo milione di lavoratori e lavoratrici.
Leggi tutto
Simone Garilli: Abbiamo fatto austerità? Una pietra tombale sul dibattito
Abbiamo fatto austerità? Una pietra tombale sul dibattito
di Simone Garilli (FSI Mantova)
Carlo Cottarelli è un economista neoliberale, e in quanto tale è un nemico, ma è una persona caratterialmente sincera e quindi utile da leggere per chi voglia capire come sono andate per davvero le cose negli ultimi dieci anni.
Carlo Cottarelli, Alessandro De Nicola: I dieci comandamenti dell'economia italiana, Rubbettino, 2019
Quello citato sopra è l’ultimo libro da lui curato. Già dal titolo si nota la postura religiosa del dibattito economico in Italia, postura che non accenna a moderarsi a undici anni dalla cosiddetta crisi.
A dimostrazione del fatto che non sarà la divulgazione apolitica e non saranno i moderatismi (magari travestiti da sovranismi) a cambiare i rapporti di forza, nemmeno nella sfera sovrastrutturale. Nel primo capitolo del libro, scritto dallo stesso Cottarelli, il tema è il solito: come ridurre e migliorare la spesa pubblica italiana. Cottarelli mette subito in chiaro le cose, sinceramente: la spesa pubblica italiana negli ultimi undici anni è scesa, molto.
Giustamente distingue tra spesa nominale e spesa reale, essendo la prima il livello di spesa espresso in euro correnti mentre la seconda il livello in euro reali, ottenuto depurando la dinamica di spesa dall’aumento dei prezzi accumulato nel frattempo. Per misurare se e quanta austerità abbiamo fatto è logico prendere a riferimento il secondo parametro, per la semplice ragione che l’austerità consiste nella riduzione della quantità di beni e servizi acquistati dalle pubbliche amministrazioni.
Leggi tutto
Openpolis: La mancanza di dibattito nelle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
La mancanza di dibattito nelle leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
di Openpolis
Molte delle leggi approvate contengono autorizzazioni alla ratifica dei trattati internazionali. La scarsa partecipazione delle camere nell’elaborazione di tali testi può comportare problemi in fase di attuazione, come avvenuto per il Tap e per la Tav
Nelle ultime legislature vengono approvate, in proporzione, numerose leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali.
Il parlamento non interviene nella fase di negoziazione dei trattati e il suo ruolo nell’autorizzazione alla ratifica è limitato. La mancanza di dibattito può comportare problemi in fase di attuazione. È questo il caso della Tav e del Tap, due grandi opere la cui realizzazione è ostacolata da parte del governo stesso.
Vengono approvate molte leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati
Dall’inizio della legislatura abbiamo più volte evidenziato che vengono approvate meno leggi rispetto al passato.
In poco più di un anno le leggi approvate sono state infatti 49, meno di 4 al mese. Il dato è il più basso degli ultimi governi, quando in media venivano approvate oltre 6 leggi al mese (a partire dal governo Berlusconi IV).
Tuttavia, è necessario porsi un’ulteriore domanda: che tipo di leggi vengono votate?
Se infatti andiamo ad osservare la tipologia leggi approvate, vediamo che, su 49, 12 sono ratifiche di trattati internazionali.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Grand Hotel Niger

Grand Hotel Niger
di Mauro Armanino
Niamey, giugno 2019. E’ stato inaugurato in settimana assieme all’aeroporto internazionale di Niamey. Il Grand Hotel Presidenziale 5 stelle, realizzato in 11 mesi e finanziato dalla compagnia turca Summa, è stato battezzato ‘Radisson Blu’. Il costo dell’hotel di lusso ruota attorno ai 46 milioni di euro, circa 30 miliardi di franchi cfa, moneta corrente dell’Africa Occidentale francofona. E’ lo stesso presidente del Niger, Issoufou Mahamadou, che ha presieduto alla cerimonia dell’apertura dell’hotel. Riconosciuto ed apprezzato dalle cancellerie occidentali anche per il fattivo impegno a fermare le migrazioni ad Agadez, il presidente ha invitato i giovani ‘ a prendre ispirazione dalla ditta turca che ha realizzato l’opera in appena undici mesi’. Non si capisce bene perchè dovrebbero essere proprio i giovani a ispirarsi ad un’opera che mai li vedrà ospiti di un hotel di lusso pensato per i capi di stato e consimili all’occasione dell’Assemblea dell’Unione Africana. Confortato per ora da 5 stelle, 17 piani, 150 camere standart e 32 con suite, l’hotel in questione include una sala di conferenze con una capacità di 800 posti. Il Grand Hotel Niger è pronto all’uso come il nuovo aeroporto.
Grand Hotel Niger è aperto a tutti i Paesi desiderosi di fare business nel paese di sabbia. Tra questi alcuni hanno capito che i militari sono costitutivi dell’offerta e hanno installato nel Paese le loro basi.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: Rosa Luxemburg e la sinistra

Rosa Luxemburg e la sinistra
di Salvatore Bravo
 Destra e Sinistra
Destra e Sinistra
La differenza tra destra e sinistra di governo si assottiglia fino a renderle perfettamente speculare, per cui la sinistra annaspa e si lascia strumentalizzare dalla destra in una pericolosa e complice relazione biunivoca. Porre il problema della differenza significa rendere palese la paralisi programmatica e politica, ed il congelamento nella storia attuale. La sinistra è flatus vocis, siamo in pieno nominalismo, la sinistra di governo risponde alla funzione del capitale, anzi lo blandisce, non è solo dimentica di sé, si lascia colonizzare, diviene parte attivo del dispositivo anonimo del capitalismo assoluto.
La presenza puramente formale della sinistra, nella storia occidentale attuale, ha la sua causa “principale-immediata” nella caduta del muro di Berlino (1989), dopo la caduta dei paesi a socialismo reale non vi è stato che un lungo frammentarsi per adattarsi al capitale, per rendersi visibile e spendibile sul mercato del voto. La sconfitta storica ha palesato un’altra verità: il progressivo emergere del nichilismo economicistico delle sinistre. La sconfitta è l’effetto della verità profonda della sinistra, ovvero il progressivo svuotarsi di un progetto, dell’umanesimo per un accomodarsi curvato sull’economia della sola quantità, per cui l’avanzamento della cultura liberista ha trovato un mondo simbolico già disposto all’economicismo, al verticismo del potere, all’antiumanesimo. Il capitalismo di stato dei paesi a socialismo reale non è stato antitetico, ma competitivo al capitalismo liberista, le destre del capitale sono avanzate su un terreno già arato, pronto a prediligere la quantità sulla qualità, la propaganda all’attività soggettiva consapevole.
Non tutta l’esperienza è stata nefasta, ma il “tradimento culturale” rispetto ai grandi propositi teoretici ed ideologici ha indotto gli elettori a scegliere l’autentico (capitalismo liberista) rispetto all’imitazione (capitalismo di stato).
Per poter riaffermare la differenza tra destra e sinistra mediata dalla condizione storica attuale, non è sufficiente affermare che destra e sinistra sono categorie vetuste, dovrebbero essere riformulate con nuovi contenuti, è necessario l’esodo dagli steccati ideologici. Ricostruire le posizioni ideologiche è operazione lenta e faticosa nella quale lo strato teoretico incontra la prassi.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 3971
Hits 2695
Hits 2422
Hits 2275
Hits 2120
Hits 1926
Hits 1906
tonino

Antonio Floridia: Valentino Gerratana: il filosofo militante che ci ha ridato Gramsci
Valentino Gerratana: il filosofo militante che ci ha ridato Gramsci
di Antonio Floridia
 “L’uomo che ci ha ridato Gramsci”,
così Guido Liguori, presidente della International
Gramsci Society, nell’intervento conclusivo del
convegno che ha ricordato, nel centenario della nascita, la
figura di Valentino
Gerratana, e che si è tenuto a Modica, città di origine dello
studioso, il 15 e il 16 giugno.
“L’uomo che ci ha ridato Gramsci”,
così Guido Liguori, presidente della International
Gramsci Society, nell’intervento conclusivo del
convegno che ha ricordato, nel centenario della nascita, la
figura di Valentino
Gerratana, e che si è tenuto a Modica, città di origine dello
studioso, il 15 e il 16 giugno.
Il convegno modicano, organizzato da una “scuola di formazione politica” intitolata alla memoria di Virgilio Failla (storico leader e a lungo deputato del Pci nel ragusano, in quella che a lungo è stata la “provincia rossa” della Sicilia), in collaborazione con l’Istituto Gramsci siciliano e quello nazionale, nonché con la Gramsci International Society, ha avuto il merito di collocare la figura di Gerratana nel contesto della sue radici (a partire dalla relazione di Giancarlo Poidomani, storico dell’università di Catania, su “la costruzione del Partito nuovo nella provincia iblea”) e di illuminare passaggi della biografia di Gerratana che sono rimasti a lungo poco conosciuti, quasi oscurati dall’imponente lavoro per l’edizione critica dei Quaderni di Gramsci, a cui il nome di Gerratana rimarrà indubbiamente legato.
Un momento culminante, e anche molto toccante, del convegno si è avuto con una lunga video-intervista di Emanuele Macaluso. Lo storico leader del PCI ha ricordato i suoi rapporti con Valentino Gerratana, conosciuto in Sicilia nei primi anni del Dopoguerra, quando Macaluso era segretario della Cgil siciliana e Valentino – inviato in Sicilia dal partito per affiancare Calogero Li Causi – era il direttore, di fatto, de “La voce della Sicilia”, il quotidiano voluto dal Pci per sostenere la battaglia politica durissima di quegli anni per la democrazia e la “terra ai contadini”. La testimonianza di Macaluso ha sottolineato, tra l’altro, la grande stima che Togliatti aveva maturato nei confronti del giovane intellettuale siciliano.
L’amicizia con Giaime Pintor
La relazione generale introduttiva del sen. Concetto Scivoletto ha ricostruito l’intero percorso biografico di Gerratana.
Leggi tutto
Carlo Lozito: Carola Rackete, migranti, spoliazione e l'illusione dei muri
Carola Rackete, migranti, spoliazione e l'illusione dei muri
di Carlo Lozito
 Quella capitalistica è la società
dell'apparenza in cui la
realtà si presenta sempre trasfigurata. Per la questione dei
migranti, non si tratta del capovolgimento mistificante dei
rapporti tra gli
uomini trasformati in rapporti tra cose, insito nei rapporti
di produzione borghesi, ma di un atto ideologico col quale
dissimulare la realtà,
fatto di affermazioni, azioni e leggi che violano addirittura
le stesse norme nazionali e internazionali borghesi. Il
ministro dell'interno Salvini ha
inaugurato, e quotidianamente rafforza, la stagione della
calunnia, della piegatura dei fatti al mero scopo
propagandistico, dell'uso della forza
pubblica a proprio uso, dell'uso spregiudicato dei media per
il proprio interesse.
Quella capitalistica è la società
dell'apparenza in cui la
realtà si presenta sempre trasfigurata. Per la questione dei
migranti, non si tratta del capovolgimento mistificante dei
rapporti tra gli
uomini trasformati in rapporti tra cose, insito nei rapporti
di produzione borghesi, ma di un atto ideologico col quale
dissimulare la realtà,
fatto di affermazioni, azioni e leggi che violano addirittura
le stesse norme nazionali e internazionali borghesi. Il
ministro dell'interno Salvini ha
inaugurato, e quotidianamente rafforza, la stagione della
calunnia, della piegatura dei fatti al mero scopo
propagandistico, dell'uso della forza
pubblica a proprio uso, dell'uso spregiudicato dei media per
il proprio interesse.
Poco importa che tanto spiegamento di forze vada a colpire solo i deboli, quelli che nulla o poco possono fare per difendersi e lascino indisturbati i criminali veri, quelli dai poteri forti, quelli che scorrazzano quotidianamente nelle città e campagne italiane liberi di commettere qualsiasi illecito, difesi da mille cavilli giuridici spesi ad arte da un esercito di avvocati quando non totalmente impuniti. Così, Carola Rackete, comandante della nave impiegata nel soccorso ai migranti in mare, è stata arrestata, accusata dai più alti rappresentanti del governo italiano, ma non solo, di essere una criminale.
Una piega di vita, quella in corso, che riduce la politica a beceri insulti e volgari argomentazioni estranee a qualsiasi obiettività che mirano a solleticare e a far presa sugli istinti più beceri dell'essere umano, istinti mai sopiti e pronti a rigurgitare, rinvigoriti dall'incancrenirsi di una situazione economica che produce insicurezza e incertezza, precarietà, rabbia, risentimento che, per la mancanza di idee altre e più proprie alla necessità di liberazione e solidarietà umane, possono essere facilmente depistati contro il diverso e il debole, il migrante appunto. La volgarità e l'ipocrisia in questo regnano sovrani: si brandisce il manganello con una mano, appunto contro gli indifesi, mentre con l'altra si agita il crocefisso per dire che lo si fa in nome della santità.
Leggi tutto
Bazaar: Agostiniani e Paolini
Agostiniani e Paolini
di Bazaar
La sovranità costituzionale, la dissonanza cognitiva e un concilio di Nicea allo stadio
 «Diffidate di quei cosmopoliti che vanno a cercare
lontano nei loro libri i doveri che trascurano di svolgere
nel loro ambiente. Quel
tale filosofo ama i tartari per non essere costretto ad
amare i suoi vicini.» Jean-Jacques Rousseau, Émile
«Diffidate di quei cosmopoliti che vanno a cercare
lontano nei loro libri i doveri che trascurano di svolgere
nel loro ambiente. Quel
tale filosofo ama i tartari per non essere costretto ad
amare i suoi vicini.» Jean-Jacques Rousseau, Émile
Mentre l’Unione Europea – espressione del capitalismo delle potenze egemoniche occidentali, lentamente, come un boa, stritola l’Italia e gli italiani – fenomeni macroscopici, per le dimensioni dell’impatto sociale o mediatico, dividono, spaccano, l’opinione pubblica in due.
La polarizzazione, nonostante gli sforzi dei media per creare dialettiche falsate, tesi e antitesi solo fintamente contrappositive che lasciano al governo materiale delle forze economiche proseguire la propria agenda politica al di là degli interessi generali e «al riparo del processo elettorale», si articola da un lato in un pubblico più o meno incosciente che però resiste – e che si ritiene, per ironia farsesca della Storia, perlopiù “conservatore” – e un pubblico che, a questa agenda politica, presta invece direttamente o indirettamente sostegno. Quest’ultimo si ritiene perlopiù progressista, e sulla sua “consapevolezza” sarà interessante riflettere.
Entrambe le fazioni portano avanti ideologicamente, di fatto, un pensiero (neo)liberale, nonostante la stragrande maggioranza delle persone, in particolar modo nella fazione resistente e conservatrice, rivendichi politiche e necessità di chiara matrice socialista: intervento dello Stato al fine di aumentare le assunzioni nel pubblico impiego, ripresa della crescita salariale nell’amministrazione pubblica, espansione della servizio sanitario nazionale, diminuzione dell’età pensionabile, supporto dello Stato alla famiglia e altre, sacrosante, battaglie socialiste i cui obiettivi furono perentoriamente iscritti in Costituzione e che questa inderogabilmente prescrive.
Dall’altra parte della barricata c’è quel blocco sociale guidato dalla borghesia che vive nelle zone urbane centrali, tendenzialmente di area liberal e progressista, che ha avuto perlopiù vantaggi dall’agenda politica eurounionista, o che ancora non ha subito le conseguenze di quello che è a tutti gli effetti uno strangolamento finanziario volto alla deindustrializzazione dell’Italia, alla grande espropriazione dei patrimoni dei ceti medi e alla definitiva mezzogiornificazione della penisola. Nota: all’espropriazione economica consegue l’esproprio della sovranità democratica.
Leggi tutto
Guido Salerno Aletta: Europa “Zero tituli”
Europa “Zero tituli”
di Guido Salerno Aletta*
I grandi progetti storici vanno valutati dai risultati, non dalle dichiarazioni date in interviste e cerimonie. E i risultati vanno letti guardando al “film”, non al singolo fotogramma.
Da questo punto di vista il progetto di società che sta creando l’Unione Europea è letteralmente un disastro. I cosiddetti “populismi” originano da questo disastro ogni giorno più evidente per le popolazioni di tutti i paesi del Vecchio Continente, che da 30 anni vanno perdendo livelli salariali, diritti, tutele, welfare, speranze, identità, fiducia nel futuro. Se, notizia di ieri, un terzo dei maturandi italiani non comprende un testo in italiano, siamo già oltre i confini del declino nella riproduzione sociale…
Ma una società disastrata non è il massimo, quando si apre una lunga fase di “competizione” tra macroaree economiche continentali. E che la UE non sia al momento foriera di grandi aspettative lo si vede da molti segnali.
Al vertice G20 di Osaka, per dirne una, i futuri rapporti di forza sono apparsi già abbastanza delineati. La debolezza dell’Unione Europea è del resto, senza sorprese, costruita proprio attraverso le politiche di cui è più fiera: l’austerità. Che sta producendo fenomeni devastanti sotto gli occhi di tutti; a cominciare dall’enorme ritardo tecnologico e dal sempre meno lento calo (e invecchiamento) demografico.
Non è soltanto una nostra maligna osservazione. Su alcuni media specializzati, non a caso in informazione economica, cominciano ad apparire editoriali tranchant nei confronti dei certici della Ue. Come questo, del puntuto Guido Salerno Aletta, pubblicato su TeleBorsa, pesantemente ironico fin dal titolo “mourinhano” [Claudio Conti].
Leggi tutto
Manlio Dinucci: La sceneggiata delle relazioni con la Russia
La sceneggiata delle relazioni con la Russia
di Manlio Dinucci
La Russia, dove operano 500 aziende italiane, è il quinto mercato extra-europeo per il nostro export e fornisce il 35% del fabbisogno italiano di gas naturale. L’interscambio è stato di 27 miliardi di dollari nel 2018, ma nel 2013 ammontava a 54 miliardi. Si è quindi dimezzato a causa di quello che il premier Conte definisce il «deterioramento delle relazioni tra Russia e Unione europea che ha portato alle sanzioni europee» (in realtà decise a Washington)
Lo stato delle relazioni tra Italia e Russia è «eccellente»: lo afferma il premier Conte ricevendo a Roma il presidente Putin. Il messaggio è tranquillizzante, anzi soporifero nei confronti dell’opinione pubblica. Ci si limita, fondamentalmente, allo stato delle relazioni economiche. La Russia, dove operano 500 aziende italiane, è il quinto mercato extra-europeo per il nostro export e fornisce il 35% del fabbisogno italiano di gas naturale. L’interscambio – precisa Putin – è stato di 27 miliardi di dollari nel 2018, ma nel 2013 ammontava a 54 miliardi. Si è quindi dimezzato a causa di quello che Conte definisce il «deterioramento delle relazioni tra Russia e Unione europea che ha portato alle sanzioni europee» (in realtà decise a Washington).
Nonostante ciò vi è tra i due paesi una «intensa relazione a tutti i livelli». Toni rassicuranti che ricalcano quelli della visita di Conte a Mosca nel 2018 e del premier Renzi a San Pietroburgo nel 2016, quando aveva garantito che «la parola guerra fredda è fuori dalla storia e dalla realtà».
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: L’Italia entra nella catena del valore cinese. Firmato maxi-accordo
L’Italia entra nella catena del valore cinese. Firmato maxi-accordo
di Pasquale Cicalese
Ne abbiamo accennato un mese fa, oggi arriva la firma. Oggi pomeriggio, a Milano, alla presenza del ministro Tria e dell’omologo cinese Liu Kun, verranno siglati diversi accordi.
Vediamo i due più importanti. Il primo è quello tra Ivass, il regolatore italiano delle assicurazioni e del risparmio, con l’equivalente ente di Pechino, per aprire il mercato del risparmio cinese alle banche, alle assicurazioni e ai fondi italiani.
Il secondo, e qui la sostanza non è da poco, è l’accordo tra la società pubblica di riassicurazione dei crediti alle esportazioni – Sace – con l’omologa cinese Exim Import Bank, per assicurare le società italiane interessate da accordi di fornitura nel mercato cinese e in paesi terzi lungo la Via della Seta.
Milano Finanza riporta stamane che i colossi industriali cinesi sono interessati da accordi di fornitura con imprese italiane già oggi nel settore petrolchimico, nella infrastrutture e nell’aerospaziale.
Circa le infrastrutture, Cassa depositi e Prestiti sta facendo da regista con Impregilo, che si dovrebbe fondere con Astaldi e altre imprese di costruzione in crisi. E’ il progetto Italia, propedeutico all’infrastrutturazione della via della Seta, come da memorandum italo cinese del marzo scorso.
A quanto si sa, nei prossimi anni l’accordo potrebbe allargarsi alla farmaceutica, all’agroalimentare e alla meccanica.
Leggi tutto
Patrizia Gentilini: Prosecco patrimonio Unesco?
Prosecco patrimonio Unesco?
di Patrizia Gentilini*
Riconosciuto il valore unico delle colline di Conegliano e Valdobbiadene. Brindisi di istituzioni e imprese: “Una vittoria per il Veneto e l’Italia”. Peccato che quelle colline sono ormai diventate il simbolo di una monocoltura vinicola industrializzata che fa un uso smodato di pesticidi, cancella la biodiversità, mette sempre più a rischio la qualità delle acque, del suolo e soprattutto la salute delle comunità locali. L’espansione dei vigneti non risparmia nessuno, neppure le aree in prossimità di scuole e asili
Il riconoscimento delle colline del prosecco Conegliano Valdobbiadene a “patrimonio dell’Umanità” da parte dell’Unesco resta una questione “rovente”. La valutazione della Commissione Unesco lo scorso anno era stata negativa, la valutazione attuale è stata viceversa positiva, sia pure con la presenza di diverse raccomandazioni, anche piuttosto pesanti. La notizia è ovviamente stata accolta con grande favore dal governatore della regione Veneto, dal Consorzio del Prosecco e dalle attività produttive del territorio, ma non altrettanto certo dalle comunità locali, dalle associazioni ambientaliste e dai tanti Comitati che da decenni si battono contro la viticoltura intensiva che caratterizza le colline del Prosecco.
Leggi tutto
Roberto Vivaldelli: Caso Lega-Russia, tutti i dubbi sull’inchiesta di Buzzfeed
Caso Lega-Russia, tutti i dubbi sull’inchiesta di Buzzfeed
di Roberto Vivaldelli
Buzzfeed, il sito americano che ha pubblicato il falso dossier sulla Russiagate redatto dall’ex spia britannica Christopher Steele contro Donald Trump, ha lanciato un nuovo Russiagate, stavolta in Italia. Secondo il sito americano, Gianluca Savoini, presidente dell’Associazione Lombardia Russia, avrebbe incontrato, insieme ad altri due italiani, degli uomini russi per negoziare i termini di un presunto accordo che avrebbe portato alla Lega decine di milioni di dollari. Secondo la ricostruzione del giornalista Alberto Nardelli, si sarebbe parlato dei soldi (65 milioni di euro) da far arrivare alla Lega in vista della campagna elettorale per le Europee.
Come spiega il Corriere della Sera, la riunione sarebbe durata poco più di un’ora: l’obiettivo era la vendita di 3 milioni di tonnellate di petrolio all’Eni da parte di un’importante compagnia petrolifera russa. Il valore della vendita sarebbe stato di circa 1,5 miliardi di dollari. Da questa transazione, secondo Buzzfeed, sarebbe avanzati 65 milioni di dollari, quella che (secondo la ricostruzione) sarebbe stata la contropartita per la Lega. L’incontro sarebbe avvenuto il 18 ottobre scorso all’hotel Metropol di Mosca. Il giorno prima, davanti a una platea russa e italiana, il vicepremier Matteo Salvini fece un intervento al Lotte Plaza Hotel nel centro di Mosca, dove ad ascoltarlo c’erano ambasciatori, diplomatici, imprenditori ma anche politici italiani e russi, riuniti per l’assemblea annuale di Confindustria Russia – oltre ad un ottantina di giornalisti accreditati.
Leggi tutto
Robert Kurz: La storia della terza rivoluzione industriale
La storia della terza rivoluzione industriale
4. L’ultima crociata del liberalismo
di Robert Kurz
Pubblichiamo il quarto capitolo della sezione VIII dello Schwarzbuch Kapitalismus (“Il libro nero del capitalismo”) di Robert Kurz
 La terza
rivoluzione industriale ha definitivamente precluso ogni
possibilità di
soluzione per l’autocontraddizione capitalistica. Esauritasi
la sua dinamica compensatoria, perfino il pace-maker
keynesiano applicato al
decrepito sistema-feticcio non poteva che fallire. Il dogma di
una forma sociale totalitaria, ben decisa a sottomettere
l’umanità con
immutata durezza alla legge della valorizzazione e al giogo
dei mercati del lavoro, doveva allora assumere il carattere di
una crociata contro la
realtà.
La terza
rivoluzione industriale ha definitivamente precluso ogni
possibilità di
soluzione per l’autocontraddizione capitalistica. Esauritasi
la sua dinamica compensatoria, perfino il pace-maker
keynesiano applicato al
decrepito sistema-feticcio non poteva che fallire. Il dogma di
una forma sociale totalitaria, ben decisa a sottomettere
l’umanità con
immutata durezza alla legge della valorizzazione e al giogo
dei mercati del lavoro, doveva allora assumere il carattere di
una crociata contro la
realtà.
Il ritorno ad una prospettiva radicalmente microeconomica equivale ad una politica dello struzzo che infila la testa nella sabbia: si liquida nuovamente il livello di riflessione macroeconomico, conquistato con tanta fatica e solo all’interno delle categorie capitalistiche, per dissolvere integralmente la società nei calcoli individuali degli atomi sociali e, in questo modo, rendere la crisi invisibile. Non c’è più nessuna autocontraddizione oggettiva del capitalismo, né alcun problema sociale, visto che apparentemente non fanno altro che obbedire tutti alla propria volontà autoresponsabile: «La disoccupazione può essere spiegata con una libera opzione per il tempo libero in un calcolo di ottimizzazione individuale»1 – questo almeno secondo la «teoria» dell’economista statunitense Robert Lucas. Per simili trovate oggi si vince il premio Nobel (il turno di Lucas è arrivato nel 1995). Con la sua effettivamente «semplice scoperta» secondo cui i liberi calcoli individuali non si lasciano impressionare e dirigere da misure macroeconomiche (di politica sociale), ma le rendono inefficaci con le loro «aspettative razionali» conformi al mercato – così recita la laudatio universale – egli avrebbe «rivoluzionato il pensiero politico-economico».2
Una riflessione grossolana quale quella della «teoria delle aspettative razionali» ci fa comprendere quale sia la strada che ha deciso di intraprendere la crociata neoliberale contro la realtà: l’«economia dell’offerta» («supply side») di Say deve essere applicata una volta per tutte anche ai mercati del lavoro. Chi è costretto a vendere la sua forza-lavoro deve comportarsi civilmente e in maniera altrettanto «conforme al mercato» di chi vende pomodori, mine anticarro o preservativi – ossia secondo la «legge della domanda e dell’offerta» sui mercati anonimi.
Leggi tutto
Giorgio Nebbia: Grandi opere e devastazione ambientale
Grandi opere e devastazione ambientale
di Giorgio Nebbia
 È morto due giorni fa, all’età
di 93 anni, Giorgio Nebbia, uno dei padri
dell’ambientalismo non solo italiano, coerente e inascoltato
sostenitore della necessità scientifica di porre dei limiti
alla crescita:
non per ragioni ideali ma per la decisiva ragione che il
mondo e la materia non sono infiniti. Portò la sua battaglia
anche in Parlamento, come
indipendente eletto nelle fila del Pci negli anni dal 1983
al 1992. Senza successo, come ebbe a scrivere 25 anni dopo:
«Nel 1992 è finita
una maniera di vivere la politica. Ricordo una delle ultime
iniziative del mio mandato parlamentare, in Puglia. Fui
invitato a parlare in una
discoteca, unica volta in cui vi ho messo piede:
naturalmente nessuno ascoltava. Mi resi conto che un partito
che, per adeguarsi, teneva i comizi in
discoteca rappresentava un mondo finito […]. Era finita
anche per me. Nascevano altre associazioni, altre persone si
affacciavano nel movimento
e ormai ero un “vecchio”, talvolta benignamente definito
ancora come “padre” dell’ambientalismo, ma ingombrante
residuo
di un altro mondo. Nasceva l’ambientalismo scientifico: non
bisogna sempre dire no, bisogna pure fare qualcosa e io come
vecchio contestatore,
un po’ anarchico, non servivo più. L’ambientalismo sembrava,
ai miei occhi, occasione per ottenere assessorati e cariche
pubbliche,
ricerca di sovvenzioni e sponsorizzazioni. Si era passati
dalla critica e dalla contestazione all’omologazione».
È morto due giorni fa, all’età
di 93 anni, Giorgio Nebbia, uno dei padri
dell’ambientalismo non solo italiano, coerente e inascoltato
sostenitore della necessità scientifica di porre dei limiti
alla crescita:
non per ragioni ideali ma per la decisiva ragione che il
mondo e la materia non sono infiniti. Portò la sua battaglia
anche in Parlamento, come
indipendente eletto nelle fila del Pci negli anni dal 1983
al 1992. Senza successo, come ebbe a scrivere 25 anni dopo:
«Nel 1992 è finita
una maniera di vivere la politica. Ricordo una delle ultime
iniziative del mio mandato parlamentare, in Puglia. Fui
invitato a parlare in una
discoteca, unica volta in cui vi ho messo piede:
naturalmente nessuno ascoltava. Mi resi conto che un partito
che, per adeguarsi, teneva i comizi in
discoteca rappresentava un mondo finito […]. Era finita
anche per me. Nascevano altre associazioni, altre persone si
affacciavano nel movimento
e ormai ero un “vecchio”, talvolta benignamente definito
ancora come “padre” dell’ambientalismo, ma ingombrante
residuo
di un altro mondo. Nasceva l’ambientalismo scientifico: non
bisogna sempre dire no, bisogna pure fare qualcosa e io come
vecchio contestatore,
un po’ anarchico, non servivo più. L’ambientalismo sembrava,
ai miei occhi, occasione per ottenere assessorati e cariche
pubbliche,
ricerca di sovvenzioni e sponsorizzazioni. Si era passati
dalla critica e dalla contestazione all’omologazione».
In suo ricordo – e a nostra memoria – riportiamo qui, per gentile concessione dell’editore, uno stralcio di uno dei suoi ultimi scritti, il libro intervista con Valter Giuliano Non superare la soglia. Conversazioni su centocinquant’anni di ecologia (Edizioni Gruppo Abele, 2016).
* * * *
Da qualche tempo ci sono due argomenti che animano il dibattito: la costruzione della galleria di base attraverso le Alpi per la linea ad alta velocità Tav Torino-Lione e la costruzione del Ponte di Messina, che periodicamente ritorna nelle agende dei vari governi.
Alle due opere vengono rivolte varie obiezioni di carattere sociale, ambientale, tecnico eccetera. La galleria del Tav in Valle di Susa potrebbe incontrare molteplici difficoltà tecniche, arrecherebbe alterazioni ambientali nella valle e via seguitando; il ponte sullo Stretto di Messina potrebbe essere difficile da realizzare, passerebbe in territori esposti a sismicità, richiederebbe vie di accesso dalla parte calabrese e siciliana con profonde alterazioni del territorio.
Leggi tutto
Salvatore Bravo: L’umanesimo nell’Occidente è stato sostituito dall’umanismo
L’umanesimo nell’Occidente è stato sostituito dall’umanismo
di Salvatore Bravo
 L’umanesimo nell’Occidente è stato
sostituito
dall’umanismo: quest’ultimo è funzionale ai bisogni
del capitalismo assoluto. L’umanismo recide i legami
con ogni fondazione possibile della verità, con ogni
oggettività formulata attraverso il logos, predilige
l’individuo
astratto rispetto all’essere umano concreto e comunitario.
L’umanesimo nell’Occidente è stato
sostituito
dall’umanismo: quest’ultimo è funzionale ai bisogni
del capitalismo assoluto. L’umanismo recide i legami
con ogni fondazione possibile della verità, con ogni
oggettività formulata attraverso il logos, predilige
l’individuo
astratto rispetto all’essere umano concreto e comunitario.
Marx – nella lettura di Costanzo Preve – non può essere relegato nella nomenclatura degli umanisti, poiché non consegna l’essere umano alla contingenza della storia, non riduce il pensiero a nominalismo, ma si pone nell’ottica dell’universale, dell’umanità intera. Il materialismo storico è il mezzo attraverso il quale denuncia l’umanità offesa. Ricostruisce attraverso i modi di produzione l’alienazione (Entfremdung), i processi di negazione della natura umana, la sua riduzione ad appendice del sistema produttivo. Nel conflitto sociale che muove la storia, nelle sue contraddizioni, la condizione umana concreta si dispone al suo interno secondo prospettive e responsabilità differenti: la responsabilità di un magnate è differente rispetto alla responsabilità di un lavoratore salariato. La grandezza di Marx è aver sistematizzato le condizioni che provocano l’alienazione. Ma, nello stesso tempo, non si è limitato a costruire una narrazione ideologica, e dunque parziale: ma la sua opera è finalizzata all’emancipazione dell’umanità, perché il sistema produttivo borghese, il capitalismo, offende e nega la natura umana.
Nell’operaio legato alla catena della macchina e del plusvalore si rende lapalissiana la miseria umana nella fase del capitalismo. L’operaio è negato nella sua natura individuale e comunitaria, è il portatore sano di relazioni sociali errate; la controparte, il capitalista, vive una condizione materiale privilegiata dietro cui agiscono processi di alienazione che nell’immediato non appaiono. In realtà, dietro la maschera del benessere materiale, si scopre il soggetto alienato nella sua natura. Per Preve quindi, Marx è un iperumanista, poiché la sua teoretica è finalizzata a superare le scissioni che impediscono di concettualizzare la natura umana e di valutare attraverso di essa la condizione umana.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: La Grecia torna al massacro originale
La Grecia torna al massacro originale
di ilsimplicissimus
Come era ampiamente prevedibile e previsto Tsipras ha perso le elezioni in Grecia perché la misura degli inganni, dei tradimenti e dei cedimenti alla troika era davvero colma. Ma non si può certo dire che le ragioni del popolo siano state vendicate, perché la liberazione dallo svenditore di ogni cosa, compresa la dignità, ha significato votare proprio per il partito della troika, ovvero per Nea Demokratia di Kyriakos Mitsotakis, ex banchiere, formatosi in Usa, rampollo di una delle più longeve dinastie politiche del Paese con il quale Renzi si è immediatamente complimentato. Dunque il massacro sociale torna all’originale dopo averne assaggiato la fotocopia e viene da ridere quando i giornali strillano che la Grecia ha cambiato pagina: niente affatto si è sempre dentro lo stesso incubo, solo che cambiano gli interpreti. D’altronde non c’erano alternative perché in questi anni di sofferenza nel mondo politico ellenico non si è creata alcuna reale forza alternativa, di certo non rappresentabile da Varoufakis, liberista e globalista integrale dietro le poco convincenti contorsioni a margine dei conti mentre la rassegnazione domina su ogni cosa: esattamente come accade in tutta l’Europa mediterranea dove chi può scappada una gabbia all’altra perché non ha mai sentito parlare di destini collettivi e ha occhi solo per quelli individuali e chi rimane accetta un destino subalterno. L’elezione di Mitsotakis corrisponde alla speranza che arrendendosi, votando “uno di loro”, Bruxelles si rabbonisca e conceda qualche briciola. Cosa che a breve accadrà probabilmente anche in Italia.
Leggi tutto
Giuseppe Masala: La politica economica dal 1992 al 2011 è stata completamente sbagliata
La politica economica dal 1992 al 2011 è stata completamente sbagliata
Il grafico storico delle partite correnti lo dimostra
di Giuseppe Masala
Un grafico emblematico quello storico delle Partite Correnti. Nel 2011 avevamo un saldo pari al -3,7% del Pil e oggi ce l'abbiamo a +2,5% del Pil. Se notate bene siamo ritornati ai livello di quando avevamo la Lira. Con una differenza: allora per tenerci a galla avevamo la valvola di sfogo delle svalutazioni oggi abbiamo questi risultati con la sola svalutazione del lavoro e con l'introduzione di dosi massicce di austerità e dunque a costi sociali enormi. Detto questo abbiamo imparato a stare nell'Euro come la Germania (solo con almeno dieci anni di ritardo).
Rimangono i fatti storici: la politica economica dal 1992 al 2011 è stata completamente sbagliata. Prima hanno distrutto il nostro tessuto industriale pubblico per accontentare i paesi del Nord e farci entrare nell'Euro, poi una volta dentro hanno fatto l'errore madornale di non controllare il saldo delle Partite Correnti accumulando una posizione finanziaria netta passiva di oltre 400 miliardi di euro. Una pazzia che abbiamo pagato a carissimo prezzo, ora che abbiamo sostanzialmente saldato i conti possiamo dirlo.
Di chi l'errore? Di chi la colpa? Mi spiace dirlo ma la colpa è totalmente ascrivibile al duo Prodi-Padoa Schioppa. Berlusconi pur con tutti i suoi limiti ha tentato di tenere sù le Partite Correnti firmando accordi commerciali vantaggiosissimi con Libia e Russia. E per fermarlo hanno anche dovuto usare i cacciabombardieri (bombardando la Libia ma anche il nostro export).
Leggi tutto
Marina Forti: Guerriglieri maoisti in India. Tra gli adivasi del Jharkhand
Guerriglieri maoisti in India. Tra gli adivasi del Jharkhand
di Marina Forti
Di giorno le colonne di veicoli blindati si muovono tra i villaggi, minacciose. Ma dopo il tramonto, terminato il loro diurno sfoggio di potere, tornano alla base: “Quanto alle notti, da sempre appartengono ai maoisti”, spiega il giovane dal grande sorriso. La marcia nella foresta dunque comincia nell'oscurità: una ventina di giovani uomini, in divisa verde olivo e moschetto a tracolla, e una donna. Siamo nel cuore dell'India e i giovani armati sono un plotone naxalita, il movimento rivoluzionario di ispirazione maoista sorto negli anni '60, più volte dato per finito e sempre risorto. La donna invece, unica disarmata, è un'antropologa che cerca risposte: perché una rivolta armata per una società comunista, cioè una battaglia che potrebbe sembrare anacronistica per il resto del mondo, sopravvive proprio in India – in quella che si descrive come la più grande democrazia al mondo, una economia emergente tra le potenze del globo? Soprattutto: perché tra le file di questo movimento guerrigliero ci sono tanti giovani adivasi, o “abitanti originari”, i nativi dell'Asia meridionale? E perché il movimento naxalita, una delle insurrezioni più ignorate del mondo, si è reincarnato proprio in queste foreste?
Alpa Shah ci porta così in un'India remota, in senso geografico e forse ancor più culturale e politico, anche se la storia che racconta ha risvolti modernissimi. La sua marcia con il plotone naxalita dura sette notti, duecentocinquanta chilometri a piedi attraverso foreste impervie tra il Jharkhand e il Bihar, nell'India nord-orientale.
Leggi tutto
Il Pedante: E la fiducia si impenna!
E la fiducia si impenna!
di Il Pedante
Sono trascorsi poco più di due anni dall’entrata in vigore del decreto Lorenzin sull’obbligo vaccinale per l’infanzia. Mentre le forze del governo gialloblù annunciano di volerlo sostituire con una nuova legge dai contorni ancora incerti, alcuni (pochi, in verità) cercano di tirare un bilancio del provvedimento e delle sue conseguenze, non solo normative. Con la più che duplicazione delle vaccinazioni obbligatorie e l’introduzione di sanzioni economiche e sospensioni scolastiche per i piccoli inadempienti, il decreto ha innescato dibattiti e scatenato conflitti sia tra cittadini e istituzioni (specialmente quelle sanitarie, costrette al ruolo di «gendarmi» della salute) sia all’interno di un’opinione pubblica divisa tra i sostenitori di una omnicomprensiva «scienza» e i cosiddetti «novax» destinatari di anatemi e censure. Le sospensioni scolastiche dalle scuole d’infanzia, in certi casi di dubbia legittimità, hanno prodotto emarginazione e disagio nelle famiglie renitenti, il cui numero sembra essere tutt’altro che marginale. Proiettando i dati diffusi da alcune regioni, i minori tra zero e sedici anni non in regola con il calendario vaccinale potrebbero infatti ammontare a 1,2 milioni di unità: il 13% delle coorti interessate. Diventa perciò urgente capire se ne sia valsa la pena e riflettere su quanto sia opportuno insistere nella direzione tracciata.
La premessa d’obbligo è che l’obiettivo della legge, di aumentare l’adesione a dieci – non dodici o sette, né quindici – vaccinazioni per l’infanzia, è un obiettivo di politica sanitaria, esprime cioè una delle tante possibili visioni della salute pubblica e degli strumenti per promuoverla.
Leggi tutto
Gian Marco Martignoni: Su «Tempi (retro) moderni»
Su «Tempi (retro) moderni»
di Gian Marco Martignoni
«Oggi tendiamo a temere il futuro, avendo perso la nostra capacità collettiva di temperarne gli eccessi, rendendolo meno spaventoso e orribile» ha scritto Zygmunt Bauman in «Retropia». Non casualmente si ispira al testamento spirituale del sociologo polacco la bella conversazione tra Francesca Re David e il sociologo Lelio Demichelis – uno studioso attento ai nuovi fenomeni dell’alienazione contemporanea – contenuta nell’agile libro «Tempi (retro) moderni» (pag 94, euro 15, Jaca Book ) che senza remore ripercorre le vicende sindacali dell’ultimo quarantennio, anche in relazione alla nuove configurazioni dell’impresa-rete.
Per via della crisi economica esplosa nel 2008 è stato un decennio travagliato per il sindacato in generale, ma soprattutto per una categoria tradizionalmente combattiva come la Fiom, che ha dovuto gestire una serie impressionante di processi di “razionalizzazione” dell’apparato produttivo del nostro Paese. Giustamente Francesca Re David sottolinea come nonostante tutti gli attacchi a cui il sindacato è stato sottoposto in questi anni – a partire dalla sconfitta alla Fiat del 1980 sino all’autoritarismo esplicitato della dottrina Marchionne a Pomigliuano d’Arco – esso rimane una delle poche organizzazioni di massa che resiste alle suggestioni della narrazione neoliberale, esercitando a tutti i livelli il suo ruolo di agente contrattuale.
Leggi tutto
Hits 3983
Hits 2702
Hits 2435
Hits 2280
Hits 2128
Hits 1942
Hits 1911
Hits 1894
Hits 1873
Hits 1793
tonino

Alessandro Somma: Quando la Socialdemocrazia tedesca tradì se stessa
Quando la Socialdemocrazia tedesca tradì se stessa
Bad Godesberg e il ripudio della democrazia economica
di Alessandro Somma
 Nel 2019 ricorrono due
importanti anniversari tondi che i tedeschi stanno celebrando
con una certa
enfasi: cento anni fa veniva promulgata la Costituzione di
Weimar, la prima in Europa a parlare di diritti sociali e di
democrazia economica, mentre
settant’anni fa vedeva la luce la Costituzione di Bonn,
l’unica nata dalla sconfitta del fascismo a non menzionare i
diritti sociali e la
democrazia economica.
Nel 2019 ricorrono due
importanti anniversari tondi che i tedeschi stanno celebrando
con una certa
enfasi: cento anni fa veniva promulgata la Costituzione di
Weimar, la prima in Europa a parlare di diritti sociali e di
democrazia economica, mentre
settant’anni fa vedeva la luce la Costituzione di Bonn,
l’unica nata dalla sconfitta del fascismo a non menzionare i
diritti sociali e la
democrazia economica.
Un altro anniversario tondo è stato invece tenuto un poco in sordina. Sessant’anni or sono il Partito socialdemocratico tedesco (Spd) varava il Programma di Bad Godesberg che formalizzava l’accettazione dell’economia di mercato e con ciò il ripudio della democrazia economica come suo orizzonte programmatico.
Democrazia economica
La democrazia economica è stata a lungo un cavallo di battaglia dei Socialdemocratici tedeschi, che coniarono l’espressione ai tempi della Repubblica di Weimar nell’ambito del movimento sindacale[1], per indicare una forma di risocializzazione dell’economia non ridotta alla mera richiesta di un primato della politica. Quel primato era per molti aspetti una realtà: all’epoca i Paesi capitalisti avevano in massima parte riconosciuto la pianificazione come ineludibile[2], motivo per cui occorreva impegnarsi per renderla un’attività frutto di decisioni partecipate. Di qui il primo fondamento della democrazia economica: l’individuazione attraverso il circuito democratico delle scelte produttive complessive e di lungo periodo (Gesamtwirtschaftsplan)[3].
Non si trattava di superare il capitalismo. La pianificazione comportava il coinvolgimento del Parlamento nelle scelte complessive circa il «cosa produrre», per realizzare l’interazione tra meccanismo concorrenziale e meccanismo democratico. Il «come produrre» restava invece ancorato ai fondamenti che contraddistinguono il capitalismo: esso «può e deve essere affidato all’economia di mercato, che presumibilmente si muoverà in modo sensato e proficuo fondandosi sulla libera concorrenza»[4].
Leggi tutto
Domenico Moro: A cento anni dal biennio rosso
A cento anni dal biennio rosso
I moti per il caro-viveri
di Domenico Moro
 Lo studio della storia del
movimento operaio e rivoluzionario è importante non solo per
ricordare le
proprie radici e affermare la propria identità ma anche e
soprattutto come ammaestramento per le scelte politiche
tattiche e strategiche per
l’oggi e per il futuro.
Lo studio della storia del
movimento operaio e rivoluzionario è importante non solo per
ricordare le
proprie radici e affermare la propria identità ma anche e
soprattutto come ammaestramento per le scelte politiche
tattiche e strategiche per
l’oggi e per il futuro.
Proprio in questo inizio di estate 2019 cade il centenario dell’inizio del biennio rosso (1919-1920), che rappresenta uno dei momenti di più alta tensione rivoluzionaria delle classi subalterne italiane degli ultimi cento anni, sia per la profondità sia per la diffusione delle lotte sul territorio nazionale. Per certi aspetti, molto probabilmente il biennio rosso rimane superiore anche rispetto agli altri due altri grandi movimenti delle classi subalterne, sia quello sviluppatosi durante la Resistenza, che fu limitato al Centro-Nord e con caratteristiche anche di lotta di liberazione nazionale oltre che di lotta di classe, sia quello che ebbe luogo tra il 1969 e il 1977-80, cioè tra l’Autunno caldo e l’occupazione della Fiat.
Il biennio rosso si articola in una serie di eventi, che hanno inizio nel giugno-luglio 1919 con i moti per il caro-viveri e proseguono con la lotta per la terra, con l’ammutinamento dell’Esercito e culminano con l’occupazione delle fabbriche nel 1920. Dedichiamo questo primo articolo ai moti per il caro-viveri, ma prima è necessario chiarire i precedenti e il contesto in cui nasce il biennio rosso.
Il contesto generale e la Prima guerra mondiale
Così come in Russia la rivoluzione del 1917 fu preceduta dalla sua “prova generale” del 1905, anche in Italia i sommovimenti del biennio rosso furono preceduti, prima dello scoppio della Prima guerra mondiale, da un importante moto insurrezionale, la cosiddetta settimana rossa (1914). La stessa entrata in guerra dell’Italia fu contrassegnata da una importante opposizione da parte popolare, in cui la lotta alla guerra si unì alla lotta per il pane. Di particolare importanza furono gli avvenimenti accaduti durante la guerra, nel 1917.
Leggi tutto
Marco Gatto: Dopo il disastro
Dopo il disastro
Note su A Sinistra di Giorgio Cesarale
di Marco Gatto
 I.
I.
Al lettore italiano mancava una sintesi puntuale delle traiettorie teoriche in campo a sinistra. Non mi riferisco a semplici mappe da fruire per uno sterile aggiornamento disciplinare, ma a un tentativo molto complesso di restituzione di un universo filosofico e critico assai vario, la cui multiformità è essa stessa un problema su cui interrogarsi. Giorgio Cesarale, nel suo A Sinistra. Il pensiero critico dopo il 1989 (Roma-Bari, Laterza, 2019), lo fa con grande acume e propone una chiave di lettura assai netta, suggerendoci in che modo interpretare i percorsi della riflessione radicale più recente.
Prima di illustrare la prospettiva messa in campo dall’autore, mi permetto di indugiare sullo stato dell’arte. Più di un decennio fa, uno studioso brillante come Göran Therborn, in un libro dilemmatico dal titolo From Marxism to Post-Marxism?,1 aggiornava le tesi storiografiche di Perry Anderson (il cui noto resoconto de Il dibattito nel marxismo occidentale, datato 1977, rappresentava un tentativo di analizzare il grande turning point che avrebbe condotto alla crisi politica del marxismo) e constatava che il pensiero critico di matrice materialistica stava approssimandosi a una fase di mutazione molto consistente, nel corso della quale avrebbe interrogato la sua effettiva validità interpretativa. In Therborn poteva leggersi, fra le righe, la convinzione che il post-marxismo (ormai divenuto l’involucro del pensiero antagonistico tout court) si fosse ormai arreso all’evidenza di una postmodernità che ne aveva trasformato le modalità analitiche, relegandolo a una delle infinite possibili ermeneutiche del contemporaneo. E, in effetti, se il marxismo tradizionale è divenuto una sorta di “bene culturale” da conservare nei manuali di filosofia, la tradizione novecentesca – chiamiamola pure del marxismo occidentale – ha impresso una spinta a questa sterilizzazione politica, conducendo spesso il discorso politico verso ambiti assai ristretti, a volte solo e soltanto culturali.
Leggi tutto
Alberto Negri: Iran e Libia, l’irresistibile leggerezza dei media
Iran e Libia, l’irresistibile leggerezza dei media
di Alberto Negri*
Iran e Libia... Ecco chi ci minaccia davvero: le bufale dell’informazione manipolata. Se ne sono accorti anche i maggiori giornali americani, non i nostri. Oggi paghiamo pesantemente il prezzo dei nostri errori: ma i nostri media fanno finta di ignorarli
Alla fine la gente ci crede pure che sia l’Iran ad avere violato l’accordo sul nucleare del 2015. Come ripetono ogni giorno tv e giornali in un bombardamento mediatico pari a quello che investe la tragedia libica dei migranti con affermazioni tendenziose.
Teheran ha violato ora l’intesa in maniera quasi simbolica dopo anni in cui 15 rapporti dell’Aiea ne hanno confermato la piena adesione per lanciare un avvertimento all’Europa che lascia colpevolmente nelle mani di Trump le chiavi della pace e della guerra.
L’insostenibile leggerezza dei media è inaccettabile. L’Iran minaccia di uscire dell’accordo sul nucleare: questo è il ritornello. È stato Donald Trump non solo a rendere carta straccia l’accordo ma anche ad applicare sanzioni all’Europa e a tutti coloro che commerciano con Teheran.
All’Iran hanno fatto la guerra nel 1980 (un milione di morti) e quando nel 2014 è comparso l’Isis a combattere i jihadisti in Siria e Iraq c’erano gli iraniani (e i curdi) non gli americani e gli europei che con le monarchie del Golfo usavano gli estremisti contro Assad. Chi ha fatto gli attentati in Europa?
Leggi tutto
Simone Fana: Europa e Italia al bivio
Europa e Italia al bivio
di Simone Fana
Le elezioni europee hanno segnalato la crisi dello stato, nei contesti nazionali e nell’assetto europeo, che si traduce nell’incapacità di produrre stabilità. Per la destra questa crisi devono pagarla le classi subalterne
Un nodo di problemi emerge nella lettura del voto delle recenti elezioni europee. Due sono le grandi questioni da affrontare: la prima si pone nel rapporto tra politica e società e la seconda è quella tra livelli istituzionali e rapporti sociali di produzione. Da un lato i nessi che collegano i soggetti politici con la società, quindi il livello di autonomia o interdipendenza tra le forme di organizzazione della società e l’iniziativa politica; dall’altro il rapporto tra lo Stato e le classi sociali, tra la struttura istituzionale e lo sviluppo dei rapporti di forza nella società. In opera vediamo quindi il livello soggettivo che si muove nel breve periodo sulla spinta dell’iniziativa politica e il livello oggettivo delle strutture, che ha una sua durata e resistenza.
Due ordini di problemi, distinti, ma che si incontrano, anzi si scontrano, determinando gli equilibri di potere, il loro sviluppo e la loro crisi.
La politica come contingenza nella crisi della società
La dominanza del politico sul sociale mi pare un tratto evidente che si dà con forza nella manovra politica sulla crisi economica del biennio 2007/2008.
Leggi tutto
Roberto Vivaldelli: Germania, è muro contro Von der Leyen: trema la linea Merkel?
Germania, è muro contro Von der Leyen: trema la linea Merkel?
di Roberto Vivaldelli
Che motivo aveva Angela Merkel di supportare e sponsorizzare la candidatura del socialista Frans Timmermans alla guida della Commissione europea? Innanzitutto un calcolo politico che riguardava la grande coalizione tedesca da lei guidata costituita da Unione Cristiano Democratica (Cdu)/Unione Cristiano-Sociale in Baviera (Csu) e Partito Socialdemocratico Tedesco (Spd). Con Timmermans, infatti, Merkel avrebbe consolidato la tenuta del governo Merkel IV e fatto un favore agli alleati socialdemocratici, oltre a piazzare il compagno di partito Manfred Weber alla presidenza dell’Europarlamento.
Affossato lo “schema Osaka”, il disegno della Cancelliera tedesca è naufragato. La nomina del Ministro della Difesa Ursula von der Leyen alla Commissione Ue supportata dai Paesi di Visegrád con il tacito benestare di Washington, ha generato, infatti, un certo scompiglio e malumori all’interno della compagine governativa tedesca. Come scrive IlSole24Ore, quella che poteva essere salutata come una “vittoria” tedesca a Bruxelles è stata contaminata dalle tossine nell’aria. Ursula von der Leyen è stata letteralmente demolita dall’opinione pubblica tedesca per via dei suoi fallimenti come ministro. In un recente sondaggio, il 56% degli tedeschi ha spiegato di essere contrario al ministro “che lascia il viale del tramonto in Germania per una strada lastricata di gloria a Bruxelles”.
Leggi tutto
Business Insider Italia: Ecco l’agenda per battere nazionalisti di destra e neoliberali di sinistra
Ecco l’agenda per battere nazionalisti di destra e neoliberali di sinistra
Stiglitz detta la linea ai ‘capitalisti progressisti’
di Business Insider Italia
Joe Stiglitz è forse il più istrionico (per non dire iconico) tra gli economisti insigniti di un premio Nobel ma anche quello più incline a smuovere le acque nel paludato mondo accademico anglosassone. Allievo di Modigliani, ha contrassegnato la sua carriera collocandosi tra i più aspri critici alla dottrina prevalente dagli anni ’70 a oggi, quella neoliberista. Nel farlo ha sempre basato le sue argomentazioni non tanto su ipotesi teoriche ma piuttosto su un’analisi che si potrebbe definire “sul campo”, avendo Stiglitz trascorso diversi anni ai vertici delle principali istituzioni politiche e finanziarie mondiali, prima come capo dei consiglieri economici dell’amministrazione Cilnton, poi al vertice della Banca Mondiale.
L’idea ricorrente di Stiglitz è che la ricetta neoliberista, nata negli anni ’70 alla cosiddetta scuola di Chicago il cui principale esponente era il suo collega Milton Friedman, ha fallito miseramente. Un’affermazione forte che trova le sue ragioni nel fatto che dopo quarant’anni di applicazione agli Stati Uniti e alle economie mondiali più avanzate di un mix di politiche formato da: meno tasse per i ricchi, deregolamentazione del mercato del lavoro e dei prodotti, finanziarizzazione e globalizzazione, il risultato oggi sotto gli occhi di tutti sia una crescita dell’economia inferiore a quella registrata nei venticinque anni successivi alla seconda guerra mondiale e una diseguaglianza impressionante tra ricchi e poveri, con la forbice che si allarga sempre di più.
Leggi tutto
Matteo Bortolon: Quello greco è un crollo annunciato
Quello greco è un crollo annunciato
di Matteo Bortolon
Nuova Finanza Pubblica . Sebbene Syriza abbia tenuto sopra il 30% - anche in forza di un sistema fortemente bipolare, che non presenta significativi concorrenti dopo l’inabissamento del Pasok - la possibilità di una alternativa di governo nell’ambito dell’eurosistema crolla definitivamente
Torna la destra in Grecia. Un esito previsto ampiamente dai sondaggi, incluso il margine di dieci punti che separa Tsipras dai vincitori. Si tratta di un crollo.
Sebbene Syriza abbia tenuto sopra il 30% – anche in forza di un sistema fortemente bipolare, che non presenta significativi concorrenti dopo l’inabissamento del Pasok – la possibilità di una alternativa di governo nell’ambito dell’eurosistema crolla definitivamente.
Syriza sopravvive ed avrà un ruolo significativo, ma come fantasma di se stessa, ridotta al ruolo di ala progressista del bipolarismo locale, con poche chance di tornare a minacciare il sistema. Al di là del dato politico, conviene approfondire il panorama economico e finanziario per avere un contesto di comprensione dell’esito elettorale. Su questa rubrica abbiamo spiegato molte volte i termini della questione. Lo squilibrio fra paesi più ricchi e più poveri della Ue ha favorito un flusso di capitali dalle banche del centro a quelle della periferia, creando così creditori e debitori; quando lo scoppiare della crisi fra 2009-10 ha reso la restituzione difficile, le istituzioni della Ue e la Troika hanno obbligato gli stati debitori a salvare le proprie banche, ingigantendo il loro debito pubblico.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Sviluppi della “teoria della dipendenza”
Sviluppi della “teoria della dipendenza”
di Alessandro Visalli
 Nell’arco
di quasi quattro anni sul blog sono state prodotte molte
letture in qualche
modo riconducibili allo sviluppo storico della “teoria della
dipendenza”, una complessa tradizione che matura tra gli anni
cinquanta e
sessanta e si concentra sulle relazioni tra i paesi in
sviluppo (o “sottosviluppati”) e quelli dominanti (o
“imperialisti”),
la forma sociale capitalista è letta in tutto il suo sviluppo
in chiave di interconnessione mondiale, ma con una
significativa evoluzione nel
tempo.
Nell’arco
di quasi quattro anni sul blog sono state prodotte molte
letture in qualche
modo riconducibili allo sviluppo storico della “teoria della
dipendenza”, una complessa tradizione che matura tra gli anni
cinquanta e
sessanta e si concentra sulle relazioni tra i paesi in
sviluppo (o “sottosviluppati”) e quelli dominanti (o
“imperialisti”),
la forma sociale capitalista è letta in tutto il suo sviluppo
in chiave di interconnessione mondiale, ma con una
significativa evoluzione nel
tempo.
Gli autori centrali che abbiamo letto sono stati chiamati a volte “la banda dei quattro”, per la forte comunione di intenti che li caratterizzava, pur entro significative differenze. Della “banda” non è presente Immanuel Wallerstein (ma rimedieremo) e c’è l’inserimento di un autore meno centrale come Hosea Jaffe, ma, soprattutto di un libro decisivo nella costruzione di almeno parte delle radici intellettuali, quello di Baran.
Chiaramente si tratta di un lavoro in itinere, del tutto incompleto e parziale, che richiederà almeno il completamento di altre letture di Jaffe, della linea interpretativa di critica del ‘capitalismo monopolistico’ (scuola marxista americana), con altri testi di Baran, ma anche di Sweezy e O’Connor, e di qualche altro libro secondario di Samir Amin e dello stesso Giovanni Arrighi, ma anche Leo Huberman, Gunnar Myrdal e Terence Hopkins.
In ordine cronologico bisognerebbe partire dalla lettura del saggio di Paul Baran, “Il surplus economico”, del 1957, che si inserisce a pieno titolo in una linea genealogica di autori e saggi marxisti sull’imperialismo che vede superare ed inglobare l’analisi marxiana del colonialismo (che pure anticipa molti temi) con le analisi di Lenin, “L’imperialismo, fase suprema del capitalismo”, del 1916, anticipate da John Hobson, “Imperialism, a study”, del 1902, Rudolf Hilferding, “Il capitale finanziario”, del 1910, e Rosa Luxemburg, “L’accumulazione del capitale”, del 1913. Si può ricordare anche il libro di Henryk Grossmann “Il crollo del capitalismo”, 1929, che tra le controtendenze equilibranti indica il mercato mondiale, ovvero la “ricostruzione della redditività con il dominio del mercato mondiale”, e quindi la “funzione economica dell’imperialismo”.
Leggi tutto
Alessandro Mantovani: Marx "populista''
![]()
Marx "populista''
Costruzione di un giallo fantapolitico
di Alessandro Mantovani
 Nel
fantapolitico di Diego Gabutti Un'avventura di Amadeo
Bordiga (Milano,
Longanesi, 1982), ambientato nel primo dopoguerra, il
rinvenimento di una lettera comprovante mercanteggiamenti tra
Marx e Bismarck getta
sbalordimento e scompiglio nell'ambiente dell'appena nata
Internazionale Comunista: la lettera deve rimanere segreta,
altrimenti tutta la narrazione
su cui i comunisti fondano la loro costruzione crollerebbe
come un castello di carte. La satira di Gabutti sbeffeggia
così, d'un sol colpo,
tanto il vezzo dei marxologi per gli inediti che
ribalterebbero, di tempo in tempo, l'interpretazione di Marx,
quanto il filisteismo dell'
''ortodossia marxista'', alla quale, come noto, lo stesso
Marx, di fronte alle dilettantistiche semplificazioni con cui
alcuni suoi zelanti discepoli
avevano schematizzato il suo pensiero, si era sempre
ironicamente sottratto, giungendo sarcasticamente ad
affermare: «io non sono
marxista».
Nel
fantapolitico di Diego Gabutti Un'avventura di Amadeo
Bordiga (Milano,
Longanesi, 1982), ambientato nel primo dopoguerra, il
rinvenimento di una lettera comprovante mercanteggiamenti tra
Marx e Bismarck getta
sbalordimento e scompiglio nell'ambiente dell'appena nata
Internazionale Comunista: la lettera deve rimanere segreta,
altrimenti tutta la narrazione
su cui i comunisti fondano la loro costruzione crollerebbe
come un castello di carte. La satira di Gabutti sbeffeggia
così, d'un sol colpo,
tanto il vezzo dei marxologi per gli inediti che
ribalterebbero, di tempo in tempo, l'interpretazione di Marx,
quanto il filisteismo dell'
''ortodossia marxista'', alla quale, come noto, lo stesso
Marx, di fronte alle dilettantistiche semplificazioni con cui
alcuni suoi zelanti discepoli
avevano schematizzato il suo pensiero, si era sempre
ironicamente sottratto, giungendo sarcasticamente ad
affermare: «io non sono
marxista».
Ho il sospetto che per immaginare la sua esilarante storia, Gabutti si sia ispirato, oltre che al ritrovamento, dopo la rivoluzione russa, della famosa Confessione di Bakunin allo zar, anche alla scoperta, nel 1923, di una lettera di Marx a Vera Zasulič sul destino della comune rurale russa. Il giallo consisterebbe, in questo caso, nel fatto che la missiva sarebbe stata niente po' po' di meno che occultata dai cosiddetti fondatori del marxismo russo, Georgi Plechanov, Vera Zasulič e Pavel Axelrod, per i motivi che vedremo appresso.
La storia è già nota da tempo1, ma ogni tanto alcuni marxologi la ripropongono, secondo la sequenza: Marx distante dal ''marxismo'', Engels dogmatizzatore dello stesso, Plechanov discepolo di Engels e maestro di Lenin, Lenin allievo di Plechanov e padre di Stalin; ed ogni volta che succede, qualche sprovveduto critico del bolscevismo, ignaro fino a quel momento, si mette a far grancassa2.
La questione, come si vedrà, non è meramente storiografica, anzi, ha un preciso valore politico. Ma torniamo alla storia della lettera scomparsa. Per narrarla, dobbiamo fare un passo indietro.
Leggi tutto
Paolo Di Remigio: Le scienze umane a Bibbiano
Le scienze umane a Bibbiano
di Paolo Di Remigio
(Pubblichiamo volentieri questa riflessione dell'amico Paolo Di Remigio, che parte dai fatti di Bibbiano per discutere su ciò che sono oggi le scienze umane. M.B.)
 1.
1.
A Bibbiano, ma in precedenza al ‘Forteto’ vicino Firenze e poi in provincia di Modena, i bambini sono stati strappati ai loro genitori tramite accuse infamanti in particolare nei confronti dei padri e, dopo un lavaggio del cervello perché si rassegnassero al trauma, ma anche senza che si rassegnassero, affidati a nuovi nuclei familiari o a istituti prezzolati. Psicologi, assistenti sociali, giudici hanno calunniato adulti e rubato bambini, per realizzarne le peggiori angosce, per sacrificare le vite di tutti sull'altare del denaro e degli appetiti perversi. L’ampiezza delle reti di complicità, di reticenza e di disattenzione che permette queste spaventose vicende e vi stende il velo dell’omertà dimostra l’esistenza di potenti forze destabilizzanti, animate da un’ideologia che razionalizza l’odio nei confronti dell’istituzione familiare e il cui terreno di coltura è in certi settori delle ‘scienze umane’ – le scienze delle intenzioni: psicologia, sociologia, antropologia.
Poiché rappresentano un costo sociale, le scienze devono giustificare la loro esistenza. Esse dimostrano di meritare i finanziamenti allargando il campo della conoscenza con scoperte utili. Mentre le scienze della natura fanno scoperte utili e non meno utili si mostrano gli strumenti che le hanno consentite, le scienze dell’uomo sono in una situazione molto più difficile. All'uomo l’uomo è molto più trasparente della natura ed è molto difficile aggiungere qualcosa di nuovo e insieme intelligente dopo l’etica di Platone e Aristotele. La ricerca del nuovo si è diretta innanzitutto verso popoli sconosciuti; ma questo campo è essenzialmente esaurito già nel rinascimento; in seguito saranno disponibili soltanto società sempre più piccole, sempre più semplici, e ormai non ce ne sono più da scoprire[1]. La possibilità di scoperta resta invece intatta nell'ambito dell’eccezione, dell’anormalità, della malattia; qui si apre un campo effettivamente sconfinato per la ricerca, perché nel campo dell’umano si danno infinite eccezioni. Le scienze umane più gravide di conseguenze hanno uno stretto legame con le terapie.
Ne deriva una situazione ambigua. La scienza è conoscenza universale: concerne, secondo la determinazione di Aristotele, ciò che accade sempre o per lo più.
Leggi tutto
Giovanni Iozzoli: Siamo tutti Carola! Va bene, però dopo che si fa?
Siamo tutti Carola! Va bene, però dopo che si fa?
di Giovanni Iozzoli
[Questo scritto è uscito su Napoli Monitor il 04/07/19. Nonostante Carmilla non riproponga testi già pubblicati in altri contesti, in questo caso viene fatta un’eccezione ritenendo il pezzo utile al dibattito]
Lo Zelig di quel che resta della sinistra, ogni tanto assume identità fittizie – il più delle volte un personaggio mediatico o globale – e prova disperatamente ad aggrapparsi alla scia della personalità o dell’evento, cercando un qualche contenuto, un valore, un orientamento. Siamo tutti Assange, siamo tutti Me too, siamo tutti Greta: aver buttato nel cesso la storia rivoluzionaria del Novecento, l’assenza di memoria teorizzata come valore, l’introiezione acritica dell’agenda liberista scambiata per modernità e diritti civili, tutto ciò ha reso l’ectoplasma della sinistra bisognoso di unirsi a “qualcos’altro” – generalmente qualcosa di evanescente e assai provvisorio – per riuscire a dare una effimera definizione di sé.
A me la faccenda della Carola non entusiasma. A parte la solidarietà umana per una ragazza coraggiosa (oggettivamente simpatica, anche per l’iperbolico reato di cui è accusata: “resistenza a nave da guerra”, fattispecie penale più adatta a Godzilla), questa pseudo contesa tra Capitana e Capitano, mi sembra porti acqua solo al mulino di Salvini. Non riesco proprio ad aderire alla prevalente cultura del “like”: mi piace o non mi piace – questa storia che siamo sempre pubblico di uno spettacolino in cui al massimo ci è consentito schierarci a favore o contro qualcosa.
Leggi tutto
Roberto Vivaldelli: Perché l’arresto di Jeffrey Epstein è un terremoto politico
Perché l’arresto di Jeffrey Epstein è un terremoto politico
di Roberto Vivaldelli
È uno scandalo che coinvolge il mondo politico americano quello che ha travolto Jeffrey Epstein, il finanziere di 66 anni arrestato sabato con nuove accuse di reati sessuali ed estorsione, per aver sfruttato tra il 2002 e il 2005 decine di minorenni: dava soldi, secondo fonti del tribunale di Manhattan, in cambio di “massaggi” ma avrebbe compiuto anche molestie e abusi.
I fatti, coperti da segreto istruttorio, sarebbero accaduti tanto a New York, nella sua lussuosa residenza nell’Upper East Side, che nella villa di Palm Beach, in Florida, e sono coinvolte ragazzine che avevano anche solo 14 anni. Epstein, 66 anni, ha una rete di contatti ad altissimo livello, da Donald Trump, Bill Clinton, a cui ha spesso prestato il suo aereo privato, al principe Andrea, è stato fermato sabato all’aeroporto di Tererboro, nel New Jersey, appena sbarcato negli Stati Uniti da un volo su jet privato proveniente da Parigi. Già nel passato il finanziere era rimasto coinvolto in accuse simili da cui era riuscito a uscire grazie a un accordo con la procura che fece molto discutere.
Trump lo cacciò da Mar-a-Lago
Come nota Bloomberg, il finanziere era un membro del club di Trump, a Palm Beach, Mar-a-Lago. The Donald volò sull’aereo di Epstein almeno una volta. “Conosco Jeff da quindici anni. Ragazzo fantastico” dichiarò Trump al New York magazine nel 2002.” È molto divertente stare con lui. Si dice anche che gli piacciono le belle donne tanto quanto me, e molte di loro sono più giovani”.
Leggi tutto
Brendan Chilton: Il Labour come l’abbiamo conosciuto non esiste più
Il Labour come l’abbiamo conosciuto non esiste più
di Brendan Chilton
Dalla rivista online Spiked un amaro e accorato epitaffio posto sul Labour di Corbyn, che con il suo voltafaccia sulla Brexit manda a pezzi la sua linea politica, tradisce i suoi elettori del ceto popolare, si inginocchia davanti ai potenti e rischia di estinguersi
Con un’inversione di rotta straordinaria e senza precedenti, il Partito Laburista ha annunciato oggi che sosterrà la campagna per il Remain in un futuro referendum sull’UE. E questo nonostante la promessa messa nero su bianco nel manifesto del 2017 di accettare l’esito del referendum originale del 2016. Questa è la conseguenza di tre anni di campagne da parte di chi all’interno del movimento laburista ha rifiutato di accettare il risultato del referendum. Hanno accumulato un’enorme pressione su Jeremy Corbyn, per convincerlo a cambiare la posizione del partito laburista. Oggi Corbyn ha ceduto alle stesse persone che alcuni anni fa lo avevano sfidato per la leadership nel partito.
Oggi è un giorno tragico nella storia del partito laburista e un giorno fatale per la democrazia britannica. È, potenzialmente, l’inizio della fine del partito laburista così come lo conosciamo. Il Labour è in continuo calo nei sondaggi d’opinione, nonostante il valoroso recente impegno dei parlamentari laburisti del Nord e delle Midlands, regioni che hanno votato sì alla Brexit, per la difesa della democrazia e per la salvaguardia del Labour come partito dei lavoratori e delle donne. I loro sforzi potrebbero essere arrivati troppo tardi per salvare i laburisti da una possibile sconfitta catastrofica alle prossime elezioni.
Leggi tutto
Mario Lettieri e Paolo Raimondi: Il boomerang cinese di Trump: nasce un sistema monetario parallelo in yuan?
Il boomerang cinese di Trump: nasce un sistema monetario parallelo in yuan?
di Mario Lettieri* e Paolo Raimondi**
A ogni azione di solito corrisponde una reazione che, a volte, sorprende chi ha iniziato il contenzioso. E’ il caso della politica dei dazi e delle sanzioni di Trump: stanno determinando le condizioni per la nascita di un sistema monetario parallelo basato sullo yuan cinese utilizzabile sia per gli scambi commerciali sia come riserva monetaria. Soprattutto in Asia. Anche le sanzioni americane nei confronti di chi importa petrolio dall’Iran, di fatto, spigono in tale direzione. La Cina è il principale importatore di energia dall’Iran e continuerà a farlo. Il problema, di conseguenza, sorgerà al momento del pagamento in dollari.
Ogni anno la Cina importa dal resto del mondo petrolio per 250 miliardi di dollari e altri 150 miliardi di merci, quali l‘acciaio, il rame, il carbone e la soia. Tutte queste commodity finora sono valutate e commerciate in campo internazionale in dollari. Perciò anche la Cina li deve pagare con la valuta americana. Ciò dà alle autorità Usa un ampio margine di “manovra” su cosa la Cina compra e da chi. In verità, negli anni passati gli Usa non hanno mai nascosto l’intenzione e la capacità di usare questa leva per condizionare certi sviluppi in un’ottica geopolitica e geoeconomica.
Ad esempio, hanno imposto delle forti sanzioni pecuniarie contro alcune banche non americane, come la Standard Chartered inglese e la BNP Parisbas francese, per aver fatto in passato delle operazioni finanziarie in dollari con le controparti iraniane, anche se le suddette banche non avevano violato alcuna regola dei Paesi in cui gli accordi erano stati stipulati.
Leggi tutto
Matteo Masi: L’attualità di piano A/piano B
L’attualità di piano A/piano B
di Matteo Masi
Come mai è così difficile tenere insieme l’ipotesi Piano A – Piano B nel dibattito pubblico italiano? La tattica in due passi è quella proposta, ormai da anni, da Melenchon e dalla France Insoumise. In italia viene spesso discussa e anche appoggiata, ma quando si vanno ad affrontare nei singoli aspetti le politiche da inserire nell’uno o nell’altro piano si finisce sempre per lanciare accuse incrociate di altreuropeismo o, viceversa, di settarismo no-euro.
Tuttavia, nel momento in cui si sposa la tattica del Piano A – Piano B entrambi i piani devono essere pienamente accettati e discussi per costruire effettivamente un’ipotesi concreta che possa diventare piano di governo. Salvo che questo non voglia essere un mero strumento retorico e che, quindi, uno dei due piani venga utilizzato come “specchietto per le allodole”, da una parte o dall’altra.
Certo, dopo la Grecia e il tradimento di Syriza è difficile pensare che possa essere possibile nell’UE proporre effettivamente un piano A che possa venire accettato dal centro Tedesco, ma allo stesso modo è necessario capire che il popolo non è ancora in maggioranza pronto a una rottura unilaterale con la struttura sovranazionale neoliberista chiamata Unione Europea. Proprio per questo è necessario porsi il problema di costruire un piano A che, in caso venga accettato, rappresenti effettivamente le istanze delle classi subalterne.
Leggi tutto
Hits 4000
Hits 2709
Hits 2450
Hits 2288
Hits 2146
Hits 1921
Hits 1904
Hits 1901
tonino

Rosaria Rita Canale: Bilancia dei pagamenti e squilibri nell’eurozona: cosa occorrerebbe fare
Bilancia dei pagamenti e squilibri nell’eurozona: cosa occorrerebbe fare
di Rosaria Rita Canale
Abstract: In this article the divergences within the euro area are examined in the light of balance-of-payments imbalances recorded in the TARGET2 balances of the individual countries. It emerges that countries with positive values of the target balances (surpluses) have lower interest rates than the Euro area average and countries with negative values (deficits) have higher than average rates. Furthermore, an inverse relationship also emerges between balance of payments balances and poverty. The centralized measures of monetary policy and quantitative easing, together with fiscal restrictions for countries in deficit seem not to have resolved these differences and a new strategy is proposed to reduce divergences. This strategy, inspired by the post-war Keynes plan, should include expansionary measures for the creditor countries, such as: 1) fiscal expansion; 2) increase in money wages and 3) direct foreign investment in countries in difficulty.
 Dalla crisi
economica ad oggi si sono registrati all’interno della zona
Euro squilibri
preoccupanti fra i paesi che sembrano non poter essere colmati
dalle straordinarie misure espansive di politica monetaria
condotta a livello
centralizzato dalla BCE. Come è noto poi la
politica fiscale – che è affidata ai singoli stati -non può
essere usata come strumento di stabilizzazione, se non da quei
paesi che rispettano le regole fiscali imposte dai trattati e
che quindi non ne hanno
un gran bisogno.
Dalla crisi
economica ad oggi si sono registrati all’interno della zona
Euro squilibri
preoccupanti fra i paesi che sembrano non poter essere colmati
dalle straordinarie misure espansive di politica monetaria
condotta a livello
centralizzato dalla BCE. Come è noto poi la
politica fiscale – che è affidata ai singoli stati -non può
essere usata come strumento di stabilizzazione, se non da quei
paesi che rispettano le regole fiscali imposte dai trattati e
che quindi non ne hanno
un gran bisogno.
Queste differenze fra i singoli paesi sono evidenti negli squilibri della bilancia dei pagamenti. La zona Euro è assimilabile ad un insieme di paesi legati fra loro da un tasso di cambio irrevocabilmente fisso. Tuttavia, dal momento che esiste solo una moneta, in alternativa all’acquisto e alla vendita di riserve in valuta estera è stato concepito un meccanismo di compensazione di nome TARGET[1] – evolutosi nel novembre 2007 in TARGET2 (T2). Con T2 i paesi con un surplus della bilancia dei pagamenti ricevono, attraverso la banca centrale nazionale, il credito netto derivante dal deficit della bilancia dei pagamenti degli altri paesi. Il costo del debito dei paesi in deficit è rappresentato dal tasso di rifinanziamento sulle operazioni principali fissato attualmente dalla BCE allo 0,25%. Perciò questo meccanismo di compensazione agisce come una sorta di linea di credito concessa ai paesi che stanno vivendo una crisi della bilancia dei pagamenti che rende l’Eurozona più resiliente come unione valutaria rispetto al gold standard o ai più tradizionali sistemi di ancoraggio al dollaro (Klein 2017).
Leggi tutto
Andrea Cerutti: Strappare nuovamente il possibile all’oblio
Strappare nuovamente il possibile all’oblio
di Andrea Cerutti
Recensione a L’operaismo politico italiano di Gigi Roggero (DeriveApprodi)
 L’operaismo politico italiano,
appena uscito per la collana Input di DeriveApprodi, è
composto
dalla trascrizione di sei lezioni sull’operaismo dalle origini
sino alle diramazioni più recenti – una, interamente dedicata
alla
figura di Romano Alquati, tenuta da Guido Borio, le altre da
Gigi Roggero – e termina con un’utile intervista riepilogativa
dell’autore curata da Davide Gallo Lassere.
L’operaismo politico italiano,
appena uscito per la collana Input di DeriveApprodi, è
composto
dalla trascrizione di sei lezioni sull’operaismo dalle origini
sino alle diramazioni più recenti – una, interamente dedicata
alla
figura di Romano Alquati, tenuta da Guido Borio, le altre da
Gigi Roggero – e termina con un’utile intervista riepilogativa
dell’autore curata da Davide Gallo Lassere.
Le lezioni sono rivolte a giovani militanti politici. Lo stile è quindi diretto senza fronzoli, fedele allo “stile operaista” e, sin dalle prime pagine, traspare l’intento – in linea con l’indicazione di Walter Benjamin – “di strappare nuovamente la trasmissione del passato al conformismo che è sul punto di soggiogarla”; il conformismo dei vincitori che vogliono relegare il passato dei vinti all’eterno oblio o alla neutralizzazione accademica affinché smetta di disturbare il racconto delle magnifiche sorti e progressive.
Questo passato è l’operaismo, ovvero l’ultimo ed estremo tentativo di cui si ha notizia di usare il pensiero di Marx secondo una prospettiva pratico-rivoluzionaria e non come sistema teorico atto ad interpretare il funzionamento del sistema capitalistico.
Si parte opportunamente dalle genealogie dell’operaismo: Danilo Montaldi, Galvano Della Volpe, il gruppo francese di «Socialisme ou barbarie». Con una giusta avvertenza: «quello che … ci interessa evidenziare è il carattere di transizione degli anni Cinquanta. Attenzione, però: solo ex post possiamo attribuire un carattere storicistico e teleologico al termine transizione. Ex ante, nel vivo di quella fase, con lenti normali avremmo visto smarrimento, caoticità, rassegnazione … la transizione non ci viene consegnata dalla Storia; la transizione viene conquistata da un agire contro la Storia» (pp. 19-20). Roggero vuole dirci che lo stesso smarrimento, la medesima rassegnazione in cui siamo immersi può essere ribaltata, «è proprio nelle fasi in cui sembra non accadere nulla che va agita la capacità di anticipazione e giocata la scommessa rivoluzionaria.
Leggi tutto
Dante Barontini: La mina dei “soldi russi” sotto i piedi di Salvini
La mina dei “soldi russi” sotto i piedi di Salvini
di Dante Barontini
Per esaminare la vicenda dei “soldi russi per Salvini” è necessario indossare maschera e guanti. Perché la materia puzza in modo feroce e appare immersa in quella fogna di liquami in cui faccendieri, servizi segreti, mediatori, affaristi e politici di mezza tacca sguazzano finché non vengono travolti.
Non si può dunque “parteggiare” senza automaticamente mettersi al servizio di uno o l’altro dei protagonisti. Siano essi il gruppo di “tecnici delle transazioni” riuniti nella hall dell’Hotel Metropole di Mosca, i giornalisti de L’Espresso che hanno ricevuto un mare di informazioni sull’incontro, i “fornitori” di quelle informazioni (intercettare una conversazione del genere, in territorio russo, senza farsi scoprire, non è proprio un giochetto che può fare chiunque…), i gruppi interessati a che quell’accordo andasse in porto e quelli ovviamente al lavoro per farlo fallire, nonché quelli interessati a stroncare “i sovranisti della Lega” e dunque anche la carriera politica del fascioleghista “di successo”.
Ma essere “obbiettivi” in una vicenda così puzzolente è anche abbastanza difficile, perché tutte le informazioni rilevanti sono messe a disposizione da chi è interessato a farlo. Oppure non raggiungibili. Dunque sono sempre parziali, manchevoli, depistanti proprio quando sembrano indirizzarti verso una conclusione “certa”.
Leggi tutto
Fabio Nobile: La strada sbagliata. Dalla Sea Watch all'antifascismo
La strada sbagliata. Dalla Sea Watch all'antifascismo
di Fabio Nobile
In Italia il dibattito politico è sospeso in un limbo su cui vale la pena spendere alcuni ragionamenti.
La dialettica vera, sulle questioni che riguardano i nodi reali da sciogliere, è ferma a quella tra le due formazioni di governo, nonché la componente più direttamente emanazione della UE rappresentata da Tria e Moavero, mentre le opposizioni di “sinistra” ritrovano nell’antifascismo uno spontaneo e strumentale collante.
Le virgolette alla definizione sinistra sono quanto mai appropriate inserendo il PD dentro tale opposizione. Ma nella percezione di massa, ancor di più in assenza di una forza credibile di classe, il PD è gran parte della sinistra. Nelle nostre riflessioni spesso questo “dettaglio” viene omesso o rimosso.
E la parola d’ordine dell’antifascismo è quella attorno a cui proprio il PD sta cercando di riaggregare forze. Non ci vuole molto per capirlo visto che la guida politica di tale strategia si è espressa sulle pagine di Repubblica. Dopo il Caimano, c’è il Capitano da combattere, ma la sostanza non cambia.
I fatti ci dicono che da quando questa campagna è partita il partito di Salvini è passato dal 17 al 35% dei consensi, la sinistra radicale non è avanzata di un centimetro e il PD ha riacquisito, seppure ancora molto a stento e tra mille contraddizioni, la patente del Partito che credibilmente si può candidare a guida di un’alternativa.
Leggi tutto
Bruno Steri: Rivoluzione africana e lacrime compassionevoli: il diritto di non emigrare
Rivoluzione africana e lacrime compassionevoli: il diritto di non emigrare
di Bruno Steri
Lo schiavo che non organizza la propria ribellione non merita compassione per la sua sorte
In una fase di confuse e, per certi versi, paradossali discussioni su salvataggi in mare e flussi migratori - una volta ribadito l’elementare principio che i naufraghi, tutti i naufraghi, vanno salvati e posti in sicurezza - non è comunque inutile tornare all’istruttiva lezione di Thomas Sankara, il “Che Guevara africano”, Presidente del Burkina Faso (letteralmente: patria degli uomini integri) per una breve quanto esaltante stagione. Di lui dicevano: non piace agli americani, parla di nazionalizzazioni; è troppo “sinistrorso”, insomma è un socialista.
In effetti, tra le altre cose, egli dichiarava: “Lo schiavo che non organizza la propria ribellione non merita compassione per la sua sorte” e “L'aiuto di cui abbiamo bisogno è quello che ci aiuti a fare a meno degli aiuti”.
Temi delicatissimi e quanto mai pericolosi, perché nominano senza metafore la rapina attuata da un pugno di finanzieri ai danni di interi popoli. Il paradosso è eclatante. La Costa d’Avorio, ad esempio, è primo esportatore mondiale di cacao, ma per i suoi abitanti la cioccolata è un miraggio confezionato a prezzi per essi irraggiungibili. Allo stesso modo, il Burkina Faso è il secondo esportatore mondiale di cotone, ma i suoi abitanti non godono di un’industria manifatturiera del vestiario all’altezza di un tale primato.
Leggi tutto
Carlo Clericetti: Bce, Macron presidente-ombra
Bce, Macron presidente-ombra
di Carlo Clericetti
L’istituzione più potente dall’Ue è teoricamente a guida collegiale, ma l’esperienza suggerisce che a contare è la linea del presidente. La designata Christine Lagarde non ha la statura tecnica di Draghi e non ha dimostrato di sapersi imporre quando la situazione lo richiede. Si profila così una banca centrale guidata di fatto dal presidente francese
Chi comanda alla Bce? Teoricamente l’istituzione più potente dell’Unione europea è indipendente dai governi ed è guidata da un Comitato esecutivo di sei membri fissi, a cui si aggiungono, nelle riunioni del Consiglio direttivo, i governatori delle banche centrali nazionali. Ma il suo funzionamento degli ultimi vent’anni ha mostrato che la realtà è piuttosto diversa dalla teoria.
Innanzitutto, il Comitato e il Consiglio sicuramente discutono e contribuiscono all’elaborazione della linea di politica monetaria, ma di fatto chi comanda è il presidente. Il segnale più lampante in questo senso non è stato il whatever it takes o le altre mosse di Draghi, ma il demenziale doppio rialzo dei tassi deciso dal suo predecessore Jean-Claude Trichet nel 2011, con l’economia alle corde e il rischio di deflazione che già allora si poteva intuire. Se davvero le decisioni fossero collegiali, quella mossa non sarebbe stata fatta, perché è davvero difficile immaginare che tutti i governatori potessero prendere un tale abbaglio.
Il presidente, dunque, non è un primus inter pares, ma è un vero e proprio dominus. Sempre se si vuole stare ai dati di fatto, la Bce è un organismo monocratico.
Leggi tutto
Mauro Armanino: Il genocidio dei sogni e il processo dell’Occidente

Il genocidio dei sogni e il processo dell’Occidente
di Mauro Armanino
Niamey, luglio 019. Ci processarono tutti in contumacia. Il genocidio era stato perpetrato sotto i nostri occhi e non avevamo fatto nulla per impedirlo. Le Nazioni Unite avevano definito un genocidio come ‘l’atto che mira a distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso’. La distruzione dei portatori di sogni, non menzionati nella citata definizione, fu particolarmente grave perchè rivelava il punto di non ritorno per il futuro della società. Non può essere considerato casuale che i sogni, per anni, siano stati detenuti, schiavizzati, bombardati, affondati nel mare o perduti nel tentativo di attraversare il deserto ormai militarizzato. Ci si era abituati alle guerre perchè lontane e ai morti perchè invisibili. Si viveva la vita e la storia come una semplice successione di avvenimenti slegati dalle scelte operate dalla politica di quei tempi. Buona parte della gente consumava il tempo senza accorgersi che questo bene prezioso non avrebbe dovuto essere messo in vendita. Non si sapeva esattamente chi e quando si decise che i sogni avrebbero costituito un pericolo per le generazioni future. La società era stata organizzata in modo da mantenere sotto controllo ogni velleità di cambiamento al di fuori delle norme stabilite dal potere. Leggi, decreti, ordinanze, precetti, comandamenti e codici videro crescere il loro peso nella vita quotidiana.
Leggi tutto
Sergio Bologna: Il “declino” in Italia
Il “declino” in Italia
di Sergio Bologna
Relazione presentata a Torino il 1.12.2018 in occasione della presentazione del numero speciale di “Primo Maggio” (cfr. Altronovecento n.36).
 Quando inizia la letteratura sul “declino” in
Italia?
Quando inizia la letteratura sul “declino” in
Italia?
Sarebbe interessante fare una ricerca ad hoc, perché – se non ricordo male – non è stata una qualche corrente “riformista” ad iniziare questo percorso, sono stati ambienti culturali contigui a Confindustria. Un percorso che poi si è incamminato su un terreno dove il tema del “declino” è diventato quasimainstream al punto da condizionare lo sguardo all’indietro (come dimostra l’Annale Feltrinelli dello scorso anno intitolato l’Approdo mancato). Senza riuscire a temperare tuttavia lo slancio cieco dell’onda mediatica che esaltava le magnifiche sorti e progressive del modello neoliberale e pretendeva piena, incondizionata fiducia in esse.
La classe capitalistica, la cui inettitudine viene continuamente messa in luce dalla letteratura sul “declino”, persevera nella sua autoreferenziale esaltazione della propria missione di classe dirigente, scaricando tutte la responsabilità del “declino” sulla politica.
Ma né gli uni né gli altri, né gli storici o gli analisti del “declino” né il padronato nel suo complesso s’interrogano se sia o meno il caso di rivedere il giudizio dato sui comportamenti antagonistici di classe degli Anni 70, anni di emancipazione e di produzione d’intelligenza operaia.Suquel ciclo di lotte continua invece a pendere il giudizio di condanna come un momento di follìa collettiva, d’insensatezza. Io credo che la lettura di quegli anni dovrebbe rivalutare come chiave interpretativa quella battuta di Mario Tronti, che tanto fece sorridere allora quando fu pronunciata, e cioé che “la lotta operaia impone lo sviluppo capitalistico”. La vicenda Fiat dal 1980 al 2002 è la controprova della giustezza di quella affermazione: là dove la lotta operaia tace, là dove il suo silenzio si fa prolungato, il capitalismo s’infogna in una crisi mortale. Sconfitti gli operai nell’ottobre 1980 e dopo ventidue anni di pace sociale, la Fiat e con essa l’industria italiana dell’auto, erano a terra.
Leggi tutto
Demostenes Floros: I retroscena delle grandi manovre geopolitiche ed economiche nello scacchiere internazionale
I retroscena delle grandi manovre geopolitiche ed economiche nello scacchiere internazionale
intervista a Demostenes Floros
 Mysterion si arricchisce di un
nuovo spazio di approfondimento che affronta le più
importanti questioni
geopolitiche ed economiche odierne. L’intervista che segue è
stata rilasciata qualche settimana fa (prima delle elezioni
europee) ad un
giornale tedesco, il “Deutsche-wirtschafts-nachrichten”,
dall’esperto di geopolitica Demostenes Floros, il quale l’ha
gentilmente concessa al nostro blog. In Italia soltanto la
nostra rubrica e la pagina Facebook di Pandoratv.it di
Giulietto Chiesa pubblicano questa
preziosa intervista (l’originale in tedesco si può trovare
attraverso il seguente link: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2019/06/12/peking-wird-sich-dem-druck-des-weissen-hauses-nicht-beugen/).
Senza rivelare i particolari dell’articolo mi permetto di
fare una breve e personale considerazione sul tema qui sotto
discusso in rapporto alle
grandi manovre storiche che si stanno sviluppando, e delle
quali questo contributo può offrire una chiara, lucida e
importante chiave
interpretativa dei rapporti di forza all’interno dello
scacchiere internazionale, e inoltre anche un utile spunto
di riflessione.
L’oggetto di questa intervista, a mio avviso, va inserito in
un contesto più ampio che tenga conto dell’importantissimo
mutamento
tecnologico a cui sta andando incontro il Pianeta e in
particolare l’Occidente, e va legato ad uno scenario più
strettamente militare
molto pericoloso che ha fatto rinascere una nuova corsa agli
armamenti nucleari. Per farla breve, stiamo attraversando
una crisi gravissima e senza
precedenti e alcuni delle riflessioni e dei fatti riportati
sotto possono aiutarci a capire in che direzione e verso
stiamo andando. Buona
lettura.
Mysterion si arricchisce di un
nuovo spazio di approfondimento che affronta le più
importanti questioni
geopolitiche ed economiche odierne. L’intervista che segue è
stata rilasciata qualche settimana fa (prima delle elezioni
europee) ad un
giornale tedesco, il “Deutsche-wirtschafts-nachrichten”,
dall’esperto di geopolitica Demostenes Floros, il quale l’ha
gentilmente concessa al nostro blog. In Italia soltanto la
nostra rubrica e la pagina Facebook di Pandoratv.it di
Giulietto Chiesa pubblicano questa
preziosa intervista (l’originale in tedesco si può trovare
attraverso il seguente link: https://deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/2019/06/12/peking-wird-sich-dem-druck-des-weissen-hauses-nicht-beugen/).
Senza rivelare i particolari dell’articolo mi permetto di
fare una breve e personale considerazione sul tema qui sotto
discusso in rapporto alle
grandi manovre storiche che si stanno sviluppando, e delle
quali questo contributo può offrire una chiara, lucida e
importante chiave
interpretativa dei rapporti di forza all’interno dello
scacchiere internazionale, e inoltre anche un utile spunto
di riflessione.
L’oggetto di questa intervista, a mio avviso, va inserito in
un contesto più ampio che tenga conto dell’importantissimo
mutamento
tecnologico a cui sta andando incontro il Pianeta e in
particolare l’Occidente, e va legato ad uno scenario più
strettamente militare
molto pericoloso che ha fatto rinascere una nuova corsa agli
armamenti nucleari. Per farla breve, stiamo attraversando
una crisi gravissima e senza
precedenti e alcuni delle riflessioni e dei fatti riportati
sotto possono aiutarci a capire in che direzione e verso
stiamo andando. Buona
lettura.
* * * *
Gli Stati Uniti d’America hanno vietato a tutti gli altri paesi di acquistare petrolio iraniano. Quale leva hanno gli USA per far rispettare tale divieto?
In primo luogo, è opportuno precisare che le sanzioni comminate all’export di greggio iraniano a partire dal 5 novembre 2018 sono misure imposte unilateralmente dagli Stati Uniti e non dall’ONU quindi, non rispecchiano le norme del diritto internazionale.
Leggi tutto
Roberto Paura: Che cos'è la verità? Questione d'immaginazione
Che cos'è la verità? Questione d'immaginazione
di Roberto Paura
 Nel Vangelo
di Giovanni, durante l’interrogatorio di Ponzio Pilato, Gesù
dichiara di essere venuto al mondo “per rendere testimonianza
alla verità”, specificando che chiunque lo ascolti è dalla
parte della verità. La risposta non sembra colpire il
governatore romano, che si limita a rispondere con una domanda
retorica: “Che
cos’è la verità?”. A quella domanda Gesù non risponde, almeno
secondo l’evangelista, né Pilato sembra
attendersi una risposta. Probabilmente l’ha rivolta a sé
stesso, lui che dev’essere stato educato allo scetticismo di
Pirrone, al
relativismo di Protagora, al nichilismo di Gorgia nelle scuole
filosofiche di Roma: eccolo, quest’uomo presuntuoso che, come
tutti gli ebrei,
pretende di possedere la verità, di poter persino annunciare –
è di nuovo Giovanni a mettergli in bocca queste parole – di
essere via, veritas et vita.
Nel Vangelo
di Giovanni, durante l’interrogatorio di Ponzio Pilato, Gesù
dichiara di essere venuto al mondo “per rendere testimonianza
alla verità”, specificando che chiunque lo ascolti è dalla
parte della verità. La risposta non sembra colpire il
governatore romano, che si limita a rispondere con una domanda
retorica: “Che
cos’è la verità?”. A quella domanda Gesù non risponde, almeno
secondo l’evangelista, né Pilato sembra
attendersi una risposta. Probabilmente l’ha rivolta a sé
stesso, lui che dev’essere stato educato allo scetticismo di
Pirrone, al
relativismo di Protagora, al nichilismo di Gorgia nelle scuole
filosofiche di Roma: eccolo, quest’uomo presuntuoso che, come
tutti gli ebrei,
pretende di possedere la verità, di poter persino annunciare –
è di nuovo Giovanni a mettergli in bocca queste parole – di
essere via, veritas et vita.
Una domanda ancora attuale
Riletto ai giorni nostri, questo passaggio è più attuale che mai: Pilato è lo scettico nichilista postmoderno, che ha imparato nei suoi lunghi studi che la verità è sempre relativa, dipendente dal contesto, dalla cultura, dall’epoca e così via; Gesù il dogmatico metafisico che annuncia ostinato l’esistenza di un’unica, sola verità. Ma se fino a poco tempo fa questi diverbi potevano interessare solo i filosofi o i teologi, oggi il problema della verità è diventato addirittura un “rischio esistenziale”, a voler dar retta alle analisi del World Economic Forum, che inserisce il problema della postverità, neologismo entrato nei dizionari anglosassoni nel 2016, nel suo annuale rapporto sui rischi che corre la nostra civiltà (WEF, 2017).
Addirittura? Sembra un po’ eccessivo. Dopotutto, le bugie di Pinocchio non hanno mai fatto male a nessuno; lo scetticismo di Pilato, certo, ha mandato a morte Gesù, mettendo a rischio il progetto di salvezza di Dio (hai detto niente), ma qui siamo di fronte a un problema più triviale e più attuale, che riguarda questo mondo. Cosa sta succedendo?
Leggi tutto
Guglielmo Forges Davanzati: Le criticità tecniche e politiche dell’autonomia differenziata
Le criticità tecniche e politiche dell’autonomia differenziata*
di Guglielmo Forges Davanzati
Già agli inizi del Novecento, uno dei massimi economisti italiani di quel periodo – Francesco Saverio Nitti – aveva avvertito che l’istituzione delle Regioni avrebbe comportato costi difficilmente sostenibili per le finanze pubbliche italiane senza effetti apprezzabili sulla crescita né delle aree più ricche né delle aree più povere del Paese. A distanza di oltre un secolo, considerando il fatto che la loro istituzione – come documentato da molti studi – ha contribuito all’esplosione del debito pubblico italiano, appare difficile dargli torto. E ciò nonostante le spinte autonomistiche, in Italia, non solo non si sono ridotte, ma hanno subìto una notevole accelerazione negli ultimi anni.
La motivazione è sempre la stessa: maggiore autonomia comporta scelte politiche più efficaci a ragione del fatto che vengono realizzate su una scala più prossima alla collettività di riferimento. In altri termini, si ritiene che il decisore politico locale conosca meglio di quello nazionale i problemi delle aree che governa, ne interpreta meglio le necessità e, per conseguenza, effettua scelte di allocazione di fondi pubblici con maggiori informazioni.
Negli anni più recenti, la convinzione che un assetto federale in Italia sia quello che maggiormente risponda alle esigenze dei territori si è rafforzata, in modo trasversale fra partiti politici, a partire dalla riforma del titolo V della Costituzione realizzata nel 2001.
Leggi tutto
Francesco Maria Toscano: Salvini, ovvero il "filorusso" più "atlantista" del mondo
Salvini, ovvero il "filorusso" più "atlantista" del mondo
di Francesco Maria Toscano
La vicenda dei “rubli di Salvini” sta diventando ridicola, trattandosi chiaramente di una manovra ricattatoria che serve in via preventiva per far addivenire il Capitano in versione “capitone” a più miti consigli su tante questioni che stanno a cuore ai padroni del vapore. La vicenda, da qualunque punto di vista la si guardi, non regge. I nuovi protagonisti di questa macchiettistica “Santa Inquisizione”, con i russi che occupano il posto che nel Medioevo fu delle “streghe”, non hanno il senso del ridicolo né della misura. Se ne avessero, infatti, dovrebbero preliminarmente spiegare perché mai gli uomini di Putin morirebbero dalla voglia di foraggiare un partito come quello di Salvini che fa di continuo il “controcanto” al Cremlino. Qualche esempio? Eccovi serviti. Putin riconosce Maduro quale legittimo presidente del Venezuela, Salvini si schiera invece con i neocon americani e sponsorizza il fantoccio Guaidò; Putin apre alla Via della Seta lanciata dai cinesi, Salvini frena; Putin difende le ragioni dell’Iran mentre Salvini tratta la Persia alla stregua di uno “stato canaglia”; i Paesi di “Visegrad” odiano la Russia ma Salvini, tanto per cambiare, spalleggia Orban e soci. Dulcis in fundo, giusto per non sembrare troppo “accomodante”, Salvini in compagnia del restante gregge europeo ha da poco avallato l’ennesimo insensato rinnovo delle sanzioni economiche applicate proprio in danno dell’ “amico” Putin.
Leggi tutto
Tommaso Nencioni: Putin e la crisi del liberalismo
Putin e la crisi del liberalismo
di Tommaso Nencioni
L’intervista rilasciata dal Presidente della federazione russa Vladimir Putin al Financial Times, e ripresa da numerosi altri media occidentali, circa la crisi del liberalismo occidentale, ha aperto un dibattito di notevole portata nell’intellighenzia conservatrice del nostro Paese. La discussione avviata dalla fondazione Magna Carta pare di assoluto interesse, sia, va da sé, per la portata del tema; sia perché il pensiero conservatore italiano sta in questo torno di tempo raggiungendo un livello di organicità e di influenza che da tempo non si rintracciava nel Paese, e questo dibattito sta offrendo un ulteriore momento di sistematizzazione.
Il liberalismo, secondo Putin, rappresenterebbe una dottrina “obsoleta”, non più in grado di garantire la “stabilità” in società eccessivamente “frammentate”; ne potrebbe derivare un mondo ingovernabile ed una crisi di leadership, cui il modello russo farebbe da argine con il suo ancoraggio ai valori tradizionali e la sua stabilità e organicità.
Sul versante del conservatorismo italiano, Marco Gervasoni fa notare come in realtà nelle osservazioni di Putin si ritrovi l’eco del dibattito avviato da anni dagli intellettuali conservatori statunitensi. Il pensiero del Presidente russo non sarebbe dunque un portato “asiatico”, alieno al nostro modo di pensare, ma in realtà sarebbe ben innestato nel mondo euro-atlantico.
Leggi tutto
Aginform.org: Sovranisti e comunisti
Sovranisti e comunisti
di Aginform.org
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
Nella grande confusione che caratterizza la situazione a 'sinistra' dopo la nascita del governo gialloverde e per evitare di essere coinvolti in valutazioni poco chiare nel loro significato, occorre affrontare da un punto di vista comunista la questione del cosiddetto sovranismo, del suo significato e di come rapportarsi ad esso.
Se andiamo ai dati oggettivi bisogna tener conto che, in Italia come in Europa e poi anche negli Stati Uniti con Trump, in contrapposizione alla tendenza globalista sviluppata in tandem da democratici americani e liberalimperialisti europei sul piano economico come su quello strategico-militare, i settori schiacciati dal rullo compressore della mondializzazione hanno iniziato a reagire con forza crescente.
Ha cominciato la Francia col Front National, poi via via altri paesi europei hanno seguito la stessa strada, dalla Germania, alla Spagna, ai paesi dell'Europa orientale. I settori di cui parliamo sono settori di piccola e media borghesia, ma anche operatori economici che vivono ai margini dell'economia globalizzata e, assieme a questi, ampi strati popolari che subiscono gli effetti della crisi economica che investe parti sempre più rilevanti del sistema produttivo.
Leggi tutto
comidad: Rifondazione Comunista e l'euro
Rifondazione Comunista e l'euro
di comidad
Mesi fa il quotidiano ”Il Foglio” ha annunciato l’arrivo di un definitivo regolamento di conti tra l’attuale governo ed i Centri Sociali. Dopo il caso Alex, i tempi sembrano maturi. Per trovare argomenti contro i Centri Sociali e la “sinistra radicale” in genere, Salvini potrebbe attingere ad un articolo di Roberto Saviano su “l’Espresso” di cinque anni fa.
Saviano non lesinava le rampogne nei confronti dei Centri Sociali napoletani, da lui accusati di vecchiume ideologico, di invidia sociale e persino di connivenza con la camorra. Il motivo di tanta severità era che i Centri Sociali si erano permessi di manifestare contro la Banca Centrale Europea, in quei giorni in consesso a Napoli. Il messaggio di Saviano alla “sinistra radicale” era abbastanza chiaro: scherzate con i fanti (la questione migratoria), ma lasciate in pace i santi (i banchieri eurocrati).
Eppure la “sinistra radicale”, in particolare Rifondazione Comunista, detiene un primato cronologico ed ideologico nella contestazione nei confronti del sistema eurocratico. Il 28 ed il 29 ottobre del 1992, in una Camera spopolata ed afflitta dai timori delle incursioni dei giudici di Mani Pulite, si tenne il dibattito parlamentare per la ratifica del Trattato di Maastricht. Ad onta delle condizioni precarie del mondo politico di allora, il dibattito fu estremamente puntuale, ciò per merito dei due esponenti di Rifondazione che presero la parola.
Leggi tutto
Hits 4017
Hits 2724
Hits 2467
Hits 2298
Hits 2159
Hits 1931
Hits 1926
Hits 1836
tonino

Alessandro Somma: I limiti del Cosmopolitismo
I limiti del Cosmopolitismo
La sovranità nazionale nel conflitto tra democrazia e capitalismo
di Alessandro Somma
Il cosmopolitismo mira a promuovere la pace e dunque a rappresentare un argine al ripetersi dei conflitti che hanno caratterizzato il secolo breve. L’esperienza ha mostrato come il superamento della sovranità nazionale abbia alimentato lo sviluppo di un ordine economico neoliberale, in quanto tale minaccioso per la giustizia sociale e in ultima analisi per la pace. Di qui la necessità di un recupero della dimensione nazionale non certo per affermare identità escludenti, bensì per ripristinare un accettabile equilibrio tra democrazia e capitalismo
 1. Sovranità nazionale, pace ed
emancipazione sociale
1. Sovranità nazionale, pace ed
emancipazione sociale
Il cosmopolitismo inteso come teoria e pratica relativa alla dissoluzione della sovranità nazionale, pur potendo vantare radici affondate in un tempo lontano1, assume la valenza attuale in tempi relativamente recenti: quando si combina con quanto Norberto Bobbio chiamava pacifismo attivo, ovvero con il riconoscimento che la pace non costituisce «un’evoluzione fatale della società umana», bensì «il risultato dello sforzo intelligente e organizzato dell’uomo diretto allo scopo voluto»2. È invero per effetto delle due guerre mondiali che matura la convinzione che lo Stato nazionale rappresenta un ostacolo insormontabile al perseguimento di quello scopo, e anzi costituisce un catalizzatore di insanabili conflitti. Il tutto nell’ambito di riflessioni in cui il cosmopolitismo, che pure è concetto ambiguo e poliedrico3, assume spesso e volentieri le vesti del federalismo europeo, la cui traiettoria intellettuale intreccia continuamente le tematiche pacifiste.
Certo, in ambito cosmopolita si riconosce che lo Stato nazionale era nato per liberare i popoli e che da questo punto di vista, almeno per un certo periodo, si è effettivamente rivelato essere «un potente lievito di progresso». Si aggiunge però che lo Stato ha ben presto cessato di essere strumento per la realizzazione di fini per divenire fine a se stesso, assumendo addirittura i connotati di «un’entità divina, un organismo che deve pensare solo alla propria esistenza ed al proprio sviluppo». Di qui la tendenza invincibile a provocare conflitti bellici e a vivere la pace unicamente come momento preparatorio di quei conflitti, tendenza stigmatizzata con particolare veemenza nel celeberrimo Manifesto di Ventotene:
«Lo Stato, da tutelatore della libertà dei cittadini, si è trasformato in padrone di sudditi tenuti a servizio, con tutte le facoltà per renderne massima l’efficienza bellica.
Leggi tutto
Alessandro Visalli: Antonio Gramsci, “Notarelle sul Machiavelli”
Antonio Gramsci, “Notarelle sul Machiavelli”
di Alessandro Visalli
 Antonio Gramsci,
ottenuto in carcere il permesso di scrivere, all’inizio del
’29,
stende pochi anni dopo le sue “Notarelle” sul “Principe”
di Machiavelli. Gli obiettivi della scrittura sono
molteplici: dal tempo dei suoi studi filologici all’Università
di Torino voleva scrivere del capolavoro del fiorentino ma,
soprattutto,
ora si pone il problema di indagare il rapporto del partito
politico con le classi e lo Stato (Quaderno 4, 1930); cioè, di
pensare “non
il partito come categoria sociologica, ma il partito che vuole
fondare lo Stato”.
Antonio Gramsci,
ottenuto in carcere il permesso di scrivere, all’inizio del
’29,
stende pochi anni dopo le sue “Notarelle” sul “Principe”
di Machiavelli. Gli obiettivi della scrittura sono
molteplici: dal tempo dei suoi studi filologici all’Università
di Torino voleva scrivere del capolavoro del fiorentino ma,
soprattutto,
ora si pone il problema di indagare il rapporto del partito
politico con le classi e lo Stato (Quaderno 4, 1930); cioè, di
pensare “non
il partito come categoria sociologica, ma il partito che vuole
fondare lo Stato”.
È interessante rileggere oggi questa densissima riflessione di Gramsci, anche correndo il rischio della riattualizzazione e dunque del tradimento (ma non si può leggere senza inserire dei fili), perché è, attraverso lo schermo della trattazione del Principe, lo sforzo di confrontarsi con un momento di “crisi organica” e con l’insorgere in questa di momenti ‘cesaristi’ o ‘boulangeristi’[1], facendo leva sul “partito” e la ripresa della politica. Al momento ‘boulangerista’ si risponde con l’azione politica e la “filosofia della praxis”. Al “momento populista”, con il “momento politico” che ne incorpora tuttavia alcuni elementi: è in parte autonomo rispetto all’economico[2] e legato ad una componente emozionale e volontaristica, interamente connesso all’azione (l’obiettivo è sempre la “praxis”, l’azione pratica). Il “partito-principe” è, cioè, il suscitatore, quando se ne danno le condizioni, di una “volontà collettiva nazionale-popolare”, ed al contempo è “l’organizzatore di una riforma intellettuale e morale” e quindi di una “forma superiore di civiltà moderna”.
Il Partito, vero “intellettuale collettivo”, attraverso quella che chiama l’azione della filosofia della prassi, si impegna a trasformare il senso comune[3] di strati sociali ampi, potenzialmente egemonici perché maggioritari, ma al momento disgregati, e, in quanto “filosofia della prassi”, al contempo e necessariamente li muove all’azione collettiva. Questa azione, prendendo in qualche misura una certa distanza dalle forme più ingenue del marxismo, si muove a livello della “soprastruttura” ma non senza “una precedente riforma economica”. Anzi, continua subito, “il programma di riforma economica è il modo concreto in cui si presenta ogni riforma intellettuale e morale”. Le due cose, la riforma morale ed intellettuale, in seguito dirà di conoscenza, si connette internamente, indissolubilmente, all’azione. Questa serve a quella e quella senza questa non è possibile, né utile.
Leggi tutto
Moreno Pasquinelli: Cos'è impolitico? Risposta a Senso Comune
Cos'è impolitico? Risposta a Senso Comune
di Moreno Pasquinelli
 Confesso di essere
restato alquanto sorpreso nel leggere che proprio noi di P101
saremmo "impolitici". La critica ci
è stata rivolta da Matteo Masi sul sito
di Senso Comune in un articolo che perora la necessità
di avere un "credibile Piano A" di riforma dell'Unione europea
e quindi di averne
uno "B" di riserva nel caso l'eurocrazia risponda a pesci in
faccia e si sia costretti ad uscire.
Confesso di essere
restato alquanto sorpreso nel leggere che proprio noi di P101
saremmo "impolitici". La critica ci
è stata rivolta da Matteo Masi sul sito
di Senso Comune in un articolo che perora la necessità
di avere un "credibile Piano A" di riforma dell'Unione europea
e quindi di averne
uno "B" di riserva nel caso l'eurocrazia risponda a pesci in
faccia e si sia costretti ad uscire.
Non è l'accusa di "impoliticità" in sé che stupisce, quanto la ragione che ne starebbe a fondamento.
Ma sentiamo quel che ad un certo punto scrive il Masi:
«Sul versante “no-euro” permangono allo stesso modo criticità speculari. Prendiamo ad esempio proprio l’articolo di sollevazione che criticava quello di Cesaratto, verso la fine leggiamo: “Ma tutto ciò avrebbe senso solo a partire da una valutazione positiva sulla riformabilità dell’Unione europea e dell’euro. Riformabilità che invece non esiste, che è pari a zero. Non lo diciamo noi, lo dicono i fatti da tanti anni ormai". Questo atteggiamento, per quanto giustificato dai fatti, risulta impolitico tanto quanto avere il piano A senza credere nella necessità di un piano B». [sottolineatura nostra]
Per il Masi dunque la nostra linea politica — uscire dalla Ue per riconquistare piena la sovranità nazionale e popolare — per quanto giustificata DAI FATTI sarebbe "impolitica".
Questo asserto contiene una sfrontata contraddizione logica: una affermazione e la sua negazione non possono essere ambedue simultaneamente completamente vere. Non posso dire, ad esempio, Senso Comune è un movimento morto ma è vivo. O è morto o è vivo. Per dirla con Aristotele: «È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo».
Quand'è infatti che una qualsivoglia posizione è da considerarsi "impolitica"? Quando essa non poggia sulla "Analisi concreta della situazione concreta (Lenin). Quando, in estrema sintesi, non è realistica e confonde (ci direbbe Hegel) "l'essere col dover essere".
Leggi tutto
Paolo Bartolini: Le due C del Trauma: spunti per un’alleanza tra psicologia e politica

Le due C del Trauma: spunti per un’alleanza tra psicologia e politica
di Paolo Bartolini
Recentemente1 ho suggerito l’opportunità di indagare le coordinate dell’odierno dominio neoliberista alla luce del concetto di trauma, dunque reclamando la necessità di un’alleanza programmatica tra scienze psicologiche e politica. L’utilità di un approccio simile può essere giustificata storicamente: la riproduzione delle logiche di potere contemporanee si dà influenzando direttamente la sfera psichica della vita individuale e collettiva. La battaglia per uscire dalla narrazione tossica del capitalismo finanziario e predatorio, e per immaginare alternative credibili all’accumulazione quantitativa fine a se stessa, oggi si svolge soprattutto nei campi della psicopolitica, della manipolazione dell’immaginario di massa, della messa a valore di facoltà umane generiche (linguaggio, creatività, gioco…). Gli aspetti economici, istituzionali e geopolitici sono certo importanti, ma la dimensione simbolica e affettiva dell’esistenza umana non può essere trascurata in un passaggio d’epoca che vede trionfare il capitalismo come forza parassitaria, capace di penetrare nel tessuto intimo dei sogni, delle aspettative e dei desideri dei soggetti. Il marketing, la comunicazione dei leader politici attraverso i social network, la creazione del consenso in senso ampio, toccano corde emotive ben precise, stimolando nei cittadini/consumatori reazioni potenti, immediate e prive di filtro.
Con un’espressione altisonante, potremmo dire che il potere nel XXI secolo può conservarsi e prosperare solo conquistando (sedando) le anime delle persone.
Leggi tutto
Jack Orlando: Senza cattivo non c’è Storia
Senza cattivo non c’è Storia
di Jack Orlando
Sedici anni tra curve e movimenti, piazze e barricate, hanno fatto dello Jacob Foggia un’esperienza politica di tutto rispetto. E se non sono ascesi al quel bizzarro pantheon di strutture e collettivi “che contano” e che il movimento ama crearsi, sicuramente si ritagliano un posto di primo piano per stile e capacità di ragionamento.
Adesso lo Jacob tira le somme di sedici anni di attività e critica militanti e lancia, per il sollazzo estivo della compagneria, il suo primo libro, collettivo ed autoprodotto: Attraverso questo mare di cemento. Un testo denso, tagliente, arrogante che non risparmia nessuno.
Abbondano stoccate e affondi, bocconi indigesti per chi è pungolato nella sua marginale comfort zone e, certamente, qualcuno dirà che non è proprio il caso di usare tanta schiettezza e rudezza nei modi, che di questi tempi il movimento non sta bene ed è meglio non stressarlo buttandogli addosso limiti, colpe e responsabilità. Eppure è proprio perché il movimento è oggi nella fase acuta della sua lunga crisi che questo libro fa bene, come uno schiaffo sulla faccia di un amico che, troppo ansioso e ubriaco, ha perso il controllo di sé e seguita nel fare danni.
Dal suo avamposto di provincia Jacob ha messo insieme una serie di intuizioni che, in modo sparso e ancor più frammentato, circolano già oggi tra quelle soggettività di movimento che si sentono soffocare in un vestito vecchio e troppo stretto, insofferenti nel perpetuare meccanismi politici che tutto dimostrano tranne la loro efficacia.
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: Vola l’export, e per fortuna che “non siamo competitivi”!
Vola l’export, e per fortuna che “non siamo competitivi”!
di Pasquale Cicalese
Oggi siamo alla rubrica “strano, ma vero”. L’Italietta, quella del debito pubblico insostenibile e delle riforme strutturali da fare per “essere competitivi”, ha superato come tasso di crescita dell’export la Cina.
Rispettivamente +4% nei primi 5 mesi di quest’anno dell’Italia contro +3.9% della Cina.
Poco fa sono usciti i dati: si stimava un surplus di 2,2 miliardi, il dato reale è 5.3 miliardi; mentrequello dell’Ue, stranamente – visto che abbiamo a che fare con i campioni del mercantilismo, Olanda e Germania – che passa da 0.9 miliardi a 2.2 miliardi.
Nei primi 5 mesi il surplus passa da 13,3 miliardi del 2018 ai 16.4 miliardi del 2019. Il surplus, al netto dell’energia passa da 29 a 33 miliardi.
Ebbene, data la vulgata per cui “non si è competitivi”, la settimana scorsa è uscito un dato dell’Unctad: l’Italia è il quinto paese al mondo per surplus commerciale, con 107 miliardi di dollari.
A quanto pare quest’anno andrà ancora meglio con riflessi sulla bilancia dei pagamenti (il dato di maggio uscirà domani sul sito di Bankitalia), sulla posizione finanziaria estera netta, quasi in pareggio, come abbiamo rilevato qualche giorno fa e con un surplus dei redditi primari e della bilancia turistica ancora in aumento.
Morale: viviamo molto al di sotto delle nostre possibilità.
Leggi tutto
F.S.: Il Rubicone di Matteo Salvini
Il Rubicone di Matteo Salvini
di F.S.
Nessuno meglio di Maurizio Molinari (LA STAMPA 14 luglio 2019: Quei silenzi davanti a Pompeo) coglie il significato eminentemente politico e geopolitico, non spionistico, della vicenda Savoini. Il direttore del quotidiano piemontese paragona infatti l'eventuale premiershipsalviniana a quella di Massimo D'Alema. Francesco Cossiga, politologo di rarissima finezza, ricordava in più interviste come fosse stato proprio lui, intermediario e garante per la protezione degli interessi americani nel Mediterraneo, a farsi portatore dell'affidabilità neo-atlantista dell'ex segretario nazionale della Federazione Giovanile Comunista Italiano. L'intervento italiano in Kosovo mostrava infatti, confermando la previsione cossighiana, l'affidabilità in funzione NATO della vecchia classe dirigente “rossa”, maturatasi appunto nella logica della necessità strategica, per il Mediterraneo, dell'ombrello NATO.
Complottismo e spy stories sono armi di diversione strategica in mano alle elites dominanti dell'alta borghesia supercapitalista della NATO.
Il complottismo di massa, non a caso, per quanto riecheggiato molto spesso dai dominati è lo strumento di dominio politico e ideologico par excellence delle oligarchie neoliberali, superimperialiste, occidentali. Proprio Molinari, con il suo veramente ben ponderato articolo, ce lo fa ben intuire.
Leggi tutto
Carlo Bertani: Castellani, Cagliari, Gardini…Savoini, Salvini…
Castellani, Cagliari, Gardini…Savoini, Salvini…
di Carlo Bertani
Ancora una volta. Come se nessuno sapesse che il mondo del petrolio è il mondo della corruzione per antonomasia: ai tempi di Mattei, si portavano nei Paesi arabi bionde “stangone”, molto gradite agli emiri. Poi, gli emiri capirono che non era il caso di farsi turlupinare con due puttane da strapazzo: nacquero i petroldollari, il resto – guerre comprese – lo conosciamo.
Perché il mondo del petrolio e dell’energia è così differente?
Perché c’è una netta differenziazione fra i Paesi che hanno importanti risorse energetiche e quelli che non le hanno: c’è una sorta di differenza di potenziale energetico fra Paesi come l’Arabia Saudita, la Russia, l’Iran…e la Germania, l’Italia, il Regno Unito…una differenza di potenzialeche, in Fisica, si definisce Tensione. C’è dunque tensione fra i Paesi produttori e quelli consumatori: normale che sia così.
Per cautelarsi dai rischi della tensione, si fa fluire fra i due poli a diverso potenziale una Corrente, che è quella che scorre nel filo oppure, la sfilza di petroliere del Golfo Persico o gli oleodotti: una corrente d’energia, che fluisce per mantenere basso il rischio. L’Iraq e la Libia insegnano.
La corrente, per fluire in sicurezza, ha bisogno di un impianto che ha le sue regole, ed anche il flusso d’energia ha le sue regole – in genere non scritte ma ben conosciute in quel mondo – cosicché, quando Mattei forzò quel sistema, il sistema lo “staccò” dal circuito.
Leggi tutto
Chiara Giorgi: Ripensare la politica al tempo del neoliberismo
Ripensare la politica al tempo del neoliberismo
di Chiara Giorgi
Il destino della democrazia: un volume appena pubblicato da ETS, a cura di Emanuele Profumi e Alfonso M. Iacono, raccoglie interventi di filosofi, sociologi e antropologi che si interrogano su come re-immaginare la politica per ricreare la società di fronte alle macerie del neoliberismo
 Politica, possibile, alterità. Tre
termini che possono guidarci oggi nel ripensare l’alternativa,
nella riformulazione di un progetto politico capace di
proiettare il presente nel tempo aperto del futuro, del possibile-divenire.
Tutti i
contributi ospitati nel volume riescono infatti a tenere
insieme l’analisi del tempo presente e la prefigurazione di un
ordine alternativo
rispetto a quello neoliberista, offrendo materiali preziosi
per sottrarci a ciò che più costituisce la cifra del nostro
vivere: un
imperante presentismo in cui il tempo del neoliberalismo ci
continua a schiacciare, sancendo l’impossibilità della
dimensione
progettuale[1].
Politica, possibile, alterità. Tre
termini che possono guidarci oggi nel ripensare l’alternativa,
nella riformulazione di un progetto politico capace di
proiettare il presente nel tempo aperto del futuro, del possibile-divenire.
Tutti i
contributi ospitati nel volume riescono infatti a tenere
insieme l’analisi del tempo presente e la prefigurazione di un
ordine alternativo
rispetto a quello neoliberista, offrendo materiali preziosi
per sottrarci a ciò che più costituisce la cifra del nostro
vivere: un
imperante presentismo in cui il tempo del neoliberalismo ci
continua a schiacciare, sancendo l’impossibilità della
dimensione
progettuale[1].
Le tre domande dalle quali parte l’introduzione di uno dei curatori – Emanuele Profumi – sono allora: quale società desideriamo, come possiamo cambiare quella che abbiamo ereditato? E da qui, come ripensare la politica, strumento necessario del cambiamento comune, consapevole e possibile? Come riarticolare il nesso tra «la politica e la (ri)creazione della società», tra politica e democrazia?
Per far ciò è innanzitutto necessario porsi due altrettanto basilari interrogativi: a che punto siamo arrivati, in quale stato di malessere ci troviamo e dove vogliamo andare, che cambiamenti immaginiamo e progettiamo?
Rispetto alla prima questione, molti contributi offrono spunti di rilievo per ricordarci, sulla scorta di una letteratura sempre più corposa in tema, le caratteristiche fondamentali del presente. Vale la pena ripercorrere alcune di queste caratteristiche, nella consapevolezza che è proprio questa disamina a rendere possibile un ripensamento della politica, a fronte del suo svuotamento, del suo impoverimento e neutralizzazione, a fronte di una politica ridotta a mezzo fine a se stesso.
Molti saggi (Iacono, Profumi, Fadini, Galanti, Sintomer, Santoro, Pla) ci consentono di fotografare la situazione attuale, la crisi della democrazia, della rappresentanza politica, del costituzionalismo, della mediazione dei grandi soggetti collettivi, degli stessi fondamenti delle costituzioni del Novecento.
Leggi tutto
Roberto Finelli: La dottrina della verità senza la dottrina della città

La dottrina della verità senza la dottrina della città
Per una critica della teoria heideggeriana della tecnica
di Roberto Finelli
 1. La
de/formazione heideggeriana della
«questione della tecnica»
1. La
de/formazione heideggeriana della
«questione della tecnica»
Proporre visioni del mondo e dell’essere umano a partire dalla categoria o dal principio dell’Essere significa, come insegnava quel grande maestro di filosofia antica e di laicismo che è stato Guido Calogero, riproporre questioni improponibili ed arcaiche, che muovevano da metafisiche antiche legate alla transustanziazione ed ipostasi del verbo «essere», ossia di una parola, in un presunto fattore di realtà1.
Non a caso la storia della metafisica dell’Essere e della sua trascendenza si conclude con la filosofia moderna, specificamente con la Critica della ra- gion pura di Kant e la sua riduzione della realtà dell’essere all’esistenza, cioè alla percezione di un alcunché che si dà attraverso il modificarsi dell’apparato sensibile del corpo. Ma appunto, proprio a partire dall’estinzione del problema e della tematica dell’essere nella modernità e dalla sua riduzione a fantasma di antiche metafisiche e religioni, si può assai meglio intendere la poderosità dell’operazione culturale compiuta da Martin Heidegger nella prima metà del Novecento con la riproposizione del principio dell’Essere a principio di senso dell’intera realtà, umana e non umana, e insieme l’intento di far valere tale rinnovata dottrina dell’Essere come la massima espressione egemonica della filosofia dell’intero Novecento.
Com’è ben noto, Heidegger ha potuto compiere la sua gigantesca impresa, non attraverso una mera riproposizione dell’antico, bensì attraverso la sua partecipazione, a livelli assai rigorosi di acquisizione, alla fenomenologia di Husserl da un lato, quale teoresi moderna più avanzata sulla struttura della soggettività, e dall’altro alla tradizione della filosofia scolastica e del suo impianto ontologico, anche qui secondo modalità di studio e di conoscenza di grande estensione e profondità. Né v’è dubbio alcuno che la genialità del pensatore di Messkirch sia consistita proprio nella capacità di mediare queste due aree di competenza filosofiche, così lontane ed eterogenee tra loro, e di concepire in tal modo, prima, una originalissima fenomenologia ontologica della soggettività con Sein e Dasein e, poi, una metafisica della storicità dell’Essere nella seconda fase del suo pensiero.
Leggi tutto
Slavoj Žižek: Una commedia greca dell'assurdo
Una commedia greca dell'assurdo
di Slavoj Žižek
Il triste destino di Syriza è emblematico della nuova situazione della sinistra europea
Nel capitalismo, così come lo conosciamo, quando una grave crisi economica rende impossibile la riproduzione normale del sistema, viene imposto, per circa un decennio fino a che la situazione economica viene rinormalizzata, un qualche tipo di dominio autoritario (generalmente una dittatura militare), quanto basta perché un ritorno alla democrazia possa essere nuovamente tollerato - ricordiamo il caso del Cile, dell'Argentina, della Corea del Sud... Il ruolo unico di Syriza è stato quello che gli è stato concesso di svolgere il ruolo che generalmente viene riservato alla dittatura di destra: ha assunto il potere in un momento di profondo scontento sociale e di crisi, ed ha adempiuto al suo compito di implementare le dure misure di austerità, e così ora lascia il palcoscenico per essere sostituito da un partito chiamato Nuova Democrazia - lo stesso partito che precedentemente aveva portato la Grecia alla crisi. Le azioni di governo attuate da Syriza sono miste: ha fatto delle cose buone (che avrebbero potuto essere state fatte da un razionale governo di centro, come l'accordo con la Macedonia riguarda il cambiamento del nome), ma in generale il risultato è stato quello di una duplice catastrofe. Non solo perché sono state implementate le misure di austerità - esattamente quello a cui si era opposta tutta la sua campagna ed il suo programma di partito.
Leggi tutto
coniarerivolta: Viaggio nel mondo immaginario dei padroni, dove il lavoro abbonda ma i lavoratori si scansano
Viaggio nel mondo immaginario dei padroni, dove il lavoro abbonda ma i lavoratori si scansano
di coniarerivolta
“Il lavoro c’è e ci sarà, ma mancano i lavoratori”. Inizia così l’ennesimo sproloquio che prova a spiegarci come la disoccupazione sia una mera ma ineluttabile colpa dei disoccupati stessi. Dopo Confindustria, De Bortoli e compagnia cantante, è toccato nei giorni scorsi a Giuseppe Bono, Amministratore delegato di Fincantieri, in un suo intervento in un convegno organizzato dalla CISL sul futuro del lavoro. Non è la prima volta che affrontiamo il tema, ma se la retorica padronale continua, opportunisticamente, a diffondere questo veleno, a noi non resta che perseverare. Come abbiamo già sottolineato e continueremo a fare, infatti, i dati ci dicono tutt’altro: i posti vacanti, ovvero le posizioni lavorative aperte occupabili dai disoccupati, sono una goccia nell’oceano della disoccupazione. Il lavoro non c’è, poiché l’economia italiana è sfiancata da anni di austerità. Tutto il resto sono chiacchiere intrise di malafede. Ma andiamo con ordine.
Il discorso di Giuseppe Bono è la solita sequela di lamentele: offriamo lavori pagati più che lautamente ma non troviamo competenze adeguate, il comportamento dei giovani è incomprensibile e segno di un cambiamento culturale avverso all’etica del lavoro. L’azienda è in crescita, cresciamo al 10% annuo e serviranno 6000 lavoratori tra carpentieri saldatori che non riusciamo a trovare e via borbottando.
Leggi tutto
Marta Fana: Voglio il tuo sudore
Voglio il tuo sudore
di Marta Fana
Sedici ore di lavoro in cambio di un paio di pasti e un gadget. È quanto offrono gli organizzatori dell'evento balneare di Jovanotti. Un caso paradigmatico
E' una fotografia azzeccata, quella del volantino del Comune di Cerveteri Marina in cui si cercano volontari per la raccolta differenziata durante il tour dell’estate: il Jova Beach Party. È Jovanotti, travestito da Zio Sam, mentre chiede il nostro aiuto, almeno sedici ore di lavoro, in cambio di un panino, una bibita e un gadget. È l’immagine dell’industria culturale: quella che ogni sera fattura milioni di euro ma non paga i lavoratori, perché ormai chiamati volontari, ragazzi fortunati.
Giorno dopo giorno ci si abitua a non vedere, a non guardare in che modo si produce realmente ciò che abbiamo attorno: che si tratti di barattoli di pomodoro pelato o di mega installazioni su cui si esibiranno le star più o meno del momento. Una rimozione che può avere svariate giustificazioni, ma che prima o poi torna a chiedere il conto, a svegliarci di soprassalto. Così per il prossimo concerto di Lorenzo Jovanotti vengono reclutati volontari per «presidiare i contenitori della raccolta differenziata dislocati sull’area dell’evento e informare le persone su come fare bene la raccolta differenziata». In cambio, niente poco di meno che «accesso all’evento; buono per panino + bibita; maglietta Beach Angels + cappellino; – e dulcis in fundo – assicurazione a copertura di danni personali e a terzi».
Leggi tutto
Commonware: Il salvinismo è una tigre di carta
Il salvinismo è una tigre di carta
di Commonware
Leggendo questo titolo, probabilmente, molti penseranno a un’analisi degli ondivaghi sondaggi che segnalano un calo dei voti per la Lega. Niente affatto. Lasciamo i sondaggi a Repubblica e a Mentana, agli affezionati lettori e spettatori della cronachetta quotidiana. Non solo perché i sondaggi, soprattutto negli ultimi anni, si sono puntualmente rivelati degli strampalati bluff. Il problema sta a monte. Per capire quello che realmente accade nella materialità dei rapporti sociali, dobbiamo distanziare lo sguardo. Lontano dai sondaggi, lontano anche dalle urne elettorali. Fuori dall’opinione pubblica, dentro la composizione sociale, le sue contraddizioni, le sue possibili linee di faglia.
Fin dagli esordi del governo giallo-verde, e poi via via lungo il suo incerto e strambo cammino, abbiamo sostenuto che non vediamo alla base del leghismo dei blocchi sociali e di potere consolidati, quanto piuttosto una combinazione – scrivevamo – tra personalizzazione della leadership, amministrativizzazione del quadro intermedio, liquidità di una base squagliata nel fluttuare delle passioni, fatta di follower e non più di militanti, com’era per il leghismo padano. Anche per questo, e non solo, ogni paragone col fascismo ci sembrava e continua a sembrarci analiticamente inutile, se l’obiettivo è comprendere il nemico per sconfiggerlo, e non semplicemente insultarlo per sfogarsi.
Leggi tutto
Attilio Pasetto:Il bilancio (per ora) è aggiustato, sul futuro ombre e qualche luce
Il bilancio (per ora) è aggiustato, sul futuro ombre e qualche luce
di Attilio Pasetto
E’ stata una vera manovra correttiva, basata quasi tutta sulle entrate (6,2 miliardi su 7,6). Ma il problema si riproporrà tra qualche mese: la nuova manovra dovrà essere di circa 40 miliardi. Un aiuto viene dalla fatturazione elettronica, che avrà effetti positivi anche sulle imposte dirette. Nel quadro generale, rischi dalla congiuntura ma anche qualche possibile fattore positivo
Come già avvenuto alla fine dello scorso anno in sede di presentazione della legge di bilancio 2019, il governo in extremis è riuscito ad evitare per la seconda volta la procedura d’infrazione sul debito, che la Commissione europea si apprestava a formalizzare. L'aggiustamento di bilancio da 7,6 miliardi di euro, appena deliberato, è una vera manovra correttiva che ha riportato il deficit pubblico dal 2,5% al 2,04% del Pil, in conformità con l’obiettivo previsto dalla legge di bilancio 2019. Inoltre la lettera inviata da Conte e Tria alla Commissione contiene rassicurazioni di un “miglioramento strutturale” anche per il 2020.
I 7,6 miliardi di aggiustamento, corrispondenti allo 0,42% del Pil, sono rappresentati per circa 6,2 miliardi da maggior gettito, dovuto a maggiori entrate fiscali per 2,9 miliardi, più contributi per 0,6 miliardi e altre entrate relative a dividenti dalla Banca d'Italia e dalla Cassa Depositi e Prestiti per 2,7 miliardi.
Leggi tutto
Hits 4032
Hits 2733
Hits 2485
Hits 2300
Hits 2166
Hits 1942
Hits 1940
Hits 1779
Carlo Formenti: Su una campagna elettorale a senso unico
Hits 1751
Sergio Bologna: Alle radici di una storiografia militante
Hits 1701
tonino

Redazione ROARS: Dati INVALSI: “fotografia” o strumento di intimidazione matematica?
Dati INVALSI: “fotografia” o strumento di intimidazione matematica?
di Redazione ROARS
 Arriva l’estate e
arriva l’ennesimo rapporto sui test INVALSI. Le metafore dei
test come
“fotografia” della realtà e del “termometro” si sprecano. La
Presidente Ajello ha in una recente intervista radiofonica
usato la metafora degli esami del sangue: i risultati dei test
INVALSI somigliano alle percentuali di colesterolo nel sangue.
Proprio
quest’ultima analogia può essere utile per capire bene cosa
misurano le prove INVALSI. Nel sangue il colesterolo c’è
davvero
e può essere osservato. Le prove INVALSI, oltre alle
famigerate “competenze”, dal 2016 affermano di stimare
statisticamente anche
un’altra grandezza che non è direttamente osservabile: il
“valore aggiunto”. I test servono alle scuole per migliorarsi,
si
dice. Devono essere svolti da tutti: è una questione di
equità, si aggiunge. Ma lo sanno i commentatori che le scuole
non hanno alcun
accesso alle prove svolte dai loro studenti? Che da quanto le
prove sono computer based ciò che viene loro restituito è solo
un file che
associa il punteggio x all’allievo y, senza
nessun’informazione su come quel punteggio sia stato ottenuto?
Cosa non ha saputo lo studente?
Dove e cosa ha sbagliato? L’assenza di questa informazione
essenziale per qualsiasi insegnante, per qualsiasi concreto
miglioramento in classe
svela la sola e vera funzione della prova. All’INVALSI
interessa raccogliere dati relativi a ciascuno studente nel
tempo. I punteggi dei test
certificheranno le competenze di ognuno. E quelle
certificazioni piano piano subentreranno ai titoli di studio
rilasciati dalle scuole pubbliche. Ecco
a cosa servono i test INVALSI ed ecco perché la rilevazione è
censuaria e non, come accade nel resto del mondo, campionaria.
Arriva l’estate e
arriva l’ennesimo rapporto sui test INVALSI. Le metafore dei
test come
“fotografia” della realtà e del “termometro” si sprecano. La
Presidente Ajello ha in una recente intervista radiofonica
usato la metafora degli esami del sangue: i risultati dei test
INVALSI somigliano alle percentuali di colesterolo nel sangue.
Proprio
quest’ultima analogia può essere utile per capire bene cosa
misurano le prove INVALSI. Nel sangue il colesterolo c’è
davvero
e può essere osservato. Le prove INVALSI, oltre alle
famigerate “competenze”, dal 2016 affermano di stimare
statisticamente anche
un’altra grandezza che non è direttamente osservabile: il
“valore aggiunto”. I test servono alle scuole per migliorarsi,
si
dice. Devono essere svolti da tutti: è una questione di
equità, si aggiunge. Ma lo sanno i commentatori che le scuole
non hanno alcun
accesso alle prove svolte dai loro studenti? Che da quanto le
prove sono computer based ciò che viene loro restituito è solo
un file che
associa il punteggio x all’allievo y, senza
nessun’informazione su come quel punteggio sia stato ottenuto?
Cosa non ha saputo lo studente?
Dove e cosa ha sbagliato? L’assenza di questa informazione
essenziale per qualsiasi insegnante, per qualsiasi concreto
miglioramento in classe
svela la sola e vera funzione della prova. All’INVALSI
interessa raccogliere dati relativi a ciascuno studente nel
tempo. I punteggi dei test
certificheranno le competenze di ognuno. E quelle
certificazioni piano piano subentreranno ai titoli di studio
rilasciati dalle scuole pubbliche. Ecco
a cosa servono i test INVALSI ed ecco perché la rilevazione è
censuaria e non, come accade nel resto del mondo, campionaria.
“Una fotografia disarmante”, la definisce Christian Raimo; “due Italie, una che legge e scrive e parla inglese e l’altra no”, scrive Rai news; “un’Italia che non ama il merito e non capisce che la sana competizione è vitale per la crescita”, chiosa il Corriere della Sera; “il 35% degli studenti in terza media non comprende un testo in italiano”, continua Repubblica; “sono la foto di un Paese non democratico” commenta eccentricamente Marco Rossi Doria sul Fatto quotidiano. E tanti altri.
La pubblicazione annuale del rapporto dei dati INVALSI produce ciclicamente, almeno dal 2008 in avanti, anno in cui le prove diventano censuarie – ovvero destinate a tutti gli studenti italiani delle classi testate – paginate di indignazione e sconcerto mediatico.
Leggi tutto
Raffaele Alberto Ventura: La guerra di tutti
La guerra di tutti
Adriano Ercolani intervista Raffaele Alberto Ventura
 Pochi libri aiutano a comprendere il presente
come La
guerra di tutti di Raffaele Alberto
Ventura.
Pochi libri aiutano a comprendere il presente
come La
guerra di tutti di Raffaele Alberto
Ventura.
Forse solo La società della performance di Maura Gancitano e Andrea Colamedici, affrontando la contemporaneità da un’angolazione diversa, offre la stessa mole di spunti e sentieri di riflessione.
Ventura, intellettuale da anni molto apprezzato per le sue riflessioni sul blog Eschaton, ha destato molto clamore col suo libro precedente, Teoria della classe disagiata (premiato anche da un ardito adattamento teatrale), un testo che ha mostrato le già note qualità dell’autore: una notevole erudizione, una spiccata capacità di analisi, una non comune libertà da schieramenti (post) ideologici.
Il primo libro era una fotografia, spietatamente realistica, della condizione paradossale della classe media intellettuale contemporanea, composta da intelligenze brillanti destinate a vivacchiare nell’assoluta negazione di ogni riconoscimento simbolico dei propri talenti e competenze.
Una critica ricorrente tra i numerosi lettori è stata la mancanza di una pars costruens.
Ecco, dunque, La guerra di tutti: già nel titolo la risposta appare beffardamente consapevole. Come il titolo del primo libro faceva il verso al testo ormai classico di Thorstein Veblen, La teoria della classe agiata (di cui rovesciava la prospettiva), nel secondo c’è un riferimento evidente a Thomas Hobbes che indicava lo stato di natura, antecedente a ogni legge, come “Bellum omnium contra omnes”.
Fin dal titolo, l’autore mette in scena la crisi delle istituzioni politiche attuali. Il sottotitolo indica i macrotemi della riflessione: “populismo, terrore e crisi della società liberale”.
Il libro, oltre a essere, come già detto, una miniera di spunti di approfondimento senza troppi riscontri nel panorama attuale, ha il grande pregio di conciliare un alto livello intellettuale con benedette concessioni alla cultura pop: ecco, quindi, Ventura usare intelligentemente Debbie Harry in Videodrome di Cronenberg, come metafora del contagio populista tramite i media,; Captain America e Iron Man per spiegare il dibattito di teoria del diritto tra Carl Schmitt e Hans Kelsen; l’invasione dei Borg in Star Trek come spunto di riflessione sulla Rivoluzione Francese; V for Vendetta sul concetto hobbesiano di Leviatano; Rihanna per comprendere Il pendolo di Foucault di Umberto Eco.
Leggi tutto
Pino Arlacchi: Hong Kong, la storia che non leggerete
Hong Kong, la storia che non leggerete
di Pino Arlacchi*
Non riportare mai la versione dell’altra parte in campo e limitarsi a ripetere la stessa storiella, senza il minimo approfondimento, sono diventati le regole seguite dai media mainstream nel trattare i fatti internazionali. Che si tratti di Cina, Venezuela, guerre, massacri e catastrofi, ogni volta che si deve informare si ricorre a una formuletta preconfezionata. Che coincide regolarmente con gli interessi dei proprietari dei mezzi di comunicazione, dei governi occidentali e dello 0,1% che tenta di governare le cose del mondo.
Per rompere questa corruzione mediatica, che svuota di senso il discorso democratico e ci mette nelle mani di una plutocrazia sempre più ristretta, occorre immergersi nel caos delle fonti alternative di informazione o fondare giornali indipendenti. Oppure essere dei premi Nobel come Paul Krugman. Il quale si può permettere dalle colonne del New York Times di elencare le forme attraverso cui lo 0,1% distorce a proprio vantaggio le priorità pubbliche. E produce, aggiungiamo noi, la comunicazione ipersemplificata, falsa e omissiva di cui siamo vittime.
Ecco la lista di Krugman: 1) Corruzione hard: mazzette di soldi a politici e giornalisti. 2) Corruzione soft. Cioè “porte girevoli” tra governo e business, compensi per giri di conferenze, membershipdi club esclusivi. 3) Contributi elettorali. 4) Definizione dell’agenda politica attraverso la proprietà dei media e dei think tank, in modo da far prevalere priorità che fanno spesso a pugni con la ragionevolezza e il bene comune ( P. Krugman, NYT 22.6.2019).
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Prevedere, pianificare, sviluppare, correggere e reiniziare da capo
Prevedere, pianificare, sviluppare, correggere e reiniziare da capo
di Pierluigi Fagan
Nel 2018 il numero di articoli scientifici scritti da cinesi, che sono stati pubblicati superando le varie peer review, è stato per la prima volta pari a quello degli americani. Nel 1996 erano un decimo di quelli americani, solo negli ultimi dieci anni sono raddoppiati. Praticamente pari anche l’indice di citazione che -all’ingrosso- indicherebbe l’influenza o importanza dei contenuti espressi. Sono appena cinque gli anni stimati nei quali i cinesi supereranno di gran lunga gli americani per investimenti, persone impiegate nello sforzo scientifico, articoli pubblicati e citati. Il milione e mezzo di cinesi impiegato nella Ricerca&Sviluppo (R&D), è già oggi superiore a quello di americani e somma di tutti gli europei. Ma “somma degli europei” è un dato meramente statistico in quanto non esiste una vera unica comunità aggregata di scienziati o tecnici europei in quanto Europa non è un unico stato ed il problema si nota poi a valle in termini di brevetti che rimangono nazionali.
I cinesi poi sono iscritti nel sistema asiatico, in cui anche indiani, coreani e giapponesi ed altri, stanno perseguendo la stessa strada. Le sinergie di sistema quindi accresceranno i relativi impeti di crescita.
Ogni anno, i cinesi sfornano lo stesso numero di ingegneri che oggi vivono in USA e -negli ultimi anni- hanno sistematicamente triplicato rispetto al proprio Pil (che è altino sebbene qui in occidente si continuino a far titoloni sul fatto che crescono “solo di più del 6% annuo” essendo per volume la seconda economia del mondo), i loro investimenti annui in R&D.
Leggi tutto
Mauro Miccolis: La tela del ragno: il secondo impero britannico
La tela del ragno: il secondo impero britannico
di Mauro Miccolis
Le linee guida del progetto sono quelle di dirottare le risorse dall’economia reale alla finanza, per poi drenarle attraverso strumenti ad hoc.
Finché il denaro resta nel circuito dell’economia reale, anche e soprattutto sotto forma di liquidità in nero, rimane a disposizione dell’economia di quel paese (a meno che non venga trasferito fisicamente all’estero).
L’impoverimento delle masse è la necessaria conseguenza del drenaggio di risorse verso la finanza speculativa.
È un processo scientifico, assolutamente voluto.
Il fine di questo processo è il dominio delle potenze imperiali sulle altre grandi e medie potenze, attraverso il monopolio delle regole dei mercati finanziari.
New York e Londra gestiscono due casinò globali, e hanno distribuito i loro croupier nei governi del resto del mondo, per far in modo che imprenditori e risparmiatori buttassero il loro denaro nelle slot machines dei prodotti finanziari, piuttosto che nell’economia del loro paese.
Qualcuno ogni tanto vince qualche spiccio, mentre resto del paese nel suo complesso si impoverisce.
I croupier a fine lavoro se ne tornano a casa con qualche fiche nel taschino.
Leggi tutto
Dante Barontini: Ora tutto traballa, pure Salvini
Ora tutto traballa, pure Salvini
di Dante Barontini
Il governo “prendi tre e paghi uno” si è infilato in una brutta strettoia, tanto da presentarsi chiaramente differenziato nelle tre parti costitutive: Lega, Cinque Stelle, “garanti” verso l’Unione Europea (Conte, Tria, Moavero Milanesi, Trenta, nei ruoli chiave di presidenza del consiglio, economia, esteri e difesa).
A determinare il potenziale sfascio dell’esecutivo concorrono moltissimi fattori, che proviamo sommariamente a riassumere così, tralasciandone altri di importanza minore:
a) il raddoppio dei voti alla Lega, alle ultime europee, ha rovesciato i rapporti di forza del 4 marzo e “convinto” il vertice del Carroccio di poter dettare ormai esplicitamente l’agenda di governo; al punto da convocare direttamente le parti sociali per presentare un “programma” che non è quello del governo nel suo insieme;
b) la dura manovra da preparare per il prossimo anno, sotto il ferreo controllo della Commissione Europea; per la quale esistono risorse straordinarie impreviste (da fatturazione elettronica, crescita delle esportazioni, crollo dello spread e quindi degli interessi da pagare sui titoli di stato, ecc), ma che saranno solo una frazione dell’importo preteso dalla Ue;
c) il RussiaGate che coinvolge direttamente Salvini e i suoi uomini più fidati, e che ovviamente stimola il tentativo di riscossa dei molti soggetti “compressi” dalla sua bulimica presenza (Cinque Stelle, Pd, lo stesso Berlusconi e persino la macchietta di Fratelli d’Italia).
Leggi tutto
coniarerivolta: Salario minimo e cuneo fiscale: la fregatura è servita
Salario minimo e cuneo fiscale: la fregatura è servita
di coniarerivolta
 Tra le più conosciute
scene del cult ‘L’allenatore nel pallone’ vi è una bizzarra
conversazione tra Oronzo Canà, coach della Longobarda, una
matricola della Serie A, e il patron della squadra, il
pittoresco presidente
Borlotti. I due si trovano impelagati nelle trattative
del calciomercato, alle prese con squali e magnati del
settore, e stanno cercando di imbastire una rosa
sufficientemente competitiva per raggiungere una miracolosa
salvezza. Borlotti, che di certo non ha né la stoffa né le
disponibilità delle big del calcio italiano, si trova dunque a
dover ingegnare astruse operazioni per poter portare qualche
giocatore alla
corte di Canà. Appena uscito da un colloquio con l’Avvocato
Agnelli, Borlotti confida entusiasta al suo allenatore: “Ma
lo sa
che noi attraverso le cessioni di Falchetti e Mengoni
riusciamo ad avere la metà di Giordano? Da girare
all’Udinese per un quarto di Zico
e tre quarti di Edinho”. Di fatto, la Longobarda stava
cedendo i suoi due unici giocatori di livello in cambio di
eventuali
comproprietà future. Insomma, una fregatura bella e buona per
il povero Canà.
Tra le più conosciute
scene del cult ‘L’allenatore nel pallone’ vi è una bizzarra
conversazione tra Oronzo Canà, coach della Longobarda, una
matricola della Serie A, e il patron della squadra, il
pittoresco presidente
Borlotti. I due si trovano impelagati nelle trattative
del calciomercato, alle prese con squali e magnati del
settore, e stanno cercando di imbastire una rosa
sufficientemente competitiva per raggiungere una miracolosa
salvezza. Borlotti, che di certo non ha né la stoffa né le
disponibilità delle big del calcio italiano, si trova dunque a
dover ingegnare astruse operazioni per poter portare qualche
giocatore alla
corte di Canà. Appena uscito da un colloquio con l’Avvocato
Agnelli, Borlotti confida entusiasta al suo allenatore: “Ma
lo sa
che noi attraverso le cessioni di Falchetti e Mengoni
riusciamo ad avere la metà di Giordano? Da girare
all’Udinese per un quarto di Zico
e tre quarti di Edinho”. Di fatto, la Longobarda stava
cedendo i suoi due unici giocatori di livello in cambio di
eventuali
comproprietà future. Insomma, una fregatura bella e buona per
il povero Canà.
Una scena simile si sta consumando in questi giorni nei corridoi del Palazzo, dove si discute delle condizioni materiali di vita di milioni di lavoratori italiani, il cui destino sembra somigliare a quello della Longobarda di Canà.
Sappiamo che c’è attualmente sul tavolo una proposta di legge sull’introduzione di un salario minimo che, seppur soggetta ad un futuro iter parlamentare che potrebbe comunque portarla a svuotarsi del suo contenuto più meritevole, rappresenterebbe per molti lavoratori un miglioramento delle condizioni retributive. Tale disegno di legge, a firma della senatrice Nunzia Catalfo (M5S), oltre ad essere stato criticato dai soliti portaborse degli interessi dominanti, è stato, in maniera tutt’altro che sorprendente, oggetto degli strali di Confindustria.
Leggi tutto
Norberto Natali: Giorni che rischiarano decenni
Giorni che rischiarano decenni
Giornalisti, scoop o truppe mediatiche?
di Norberto Natali
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
 L’obiettività
e la neutralità sono due categorie molto diverse.
L’obiettività
e la neutralità sono due categorie molto diverse.
La prima è possibile e necessaria, è la premessa essenziale per un approccio scientifico alla realtà, deve e può essere perseguita anche con una logica di parte: per esempio, si può difendere apertamente l’interesse di una classe ma con obiettività, in primo luogo ammettendo da che parte si sta.
La neutralità, invece, è un’illusione, è già una manipolazione non obiettiva (“ideologica”) del proprio ruolo: specie nella società divisa in classi, è una pura illusione la “neutralità” della stampa ma anche di altre sovrastrutture (la giustizia, la cultura, ecc.), invocarla o attribuirsela è il primo indizio della mancanza di obiettività. La stampa, per esempio, è borghese anche quando espone o denuncia quanto vi è di negativo e sbagliato nella società capitalista, perché si limita all’indicazione di singoli fatti isolati, slegati dal resto e generalmente li presenta come dovuti a disfunzioni casuali o ad occasionali “colpe” di singoli, anch’essi considerati isolatamente.
La stampa borghese evita accuratamente di far comprendere ai lettori che tanti mali della società, in realtà, sono effetto (più o meno indiretto) di una comune causa originaria: per esempio il potere della borghesia, l’assetto capitalistico della società e la decadenza che esso genera. A maggior ragione, è cura della stampa borghese fare in modo che i suoi utenti non prendano coscienza che tanti guai collettivi potrebbero avere una soluzione duratura, ampia e profonda: ad esempio, con la rivoluzione, la sostituzione della classe al potere, il superamento del capitalismo.
Non sorprende che la stampa borghese, quindi, sia proprietà (diretta o indiretta) sul piano internazionale, di un piccolissimo gruppo di monopolisti, e che questi trovino anche il modo di guadagnarci economicamente, da tale proprietà, non solo politicamente ed ideologicamente.
Qui non si lamenta, dunque, la mancata “neutralità” della stampa borghese, né la sua proprietà e neanche l’esagerazione con cui manipola l’orientamento pubblico oltre i limiti fin qui descritti: in Italia in particolare (con il decisivo aiuto della gran parte della sinistra che ha rinunciato, oltretutto, a contrapporre una stampa di classe, proletaria, come ce n’era fino ad alcuni decenni fa) è riuscita a nascondere ogni conflitto ed interesse di classe.
Leggi tutto
Paolo Costa: Democracy and its crises. Le lezioni berlinesi di Charles Taylor
Democracy and its crises. Le lezioni berlinesi di Charles Taylor
di Paolo Costa
[Dal 17 al 19 giugno 2019 Charles Taylor ha tenuto a Berlino la prima edizione delle Benjamin Lectures, istituite dallo Humanities and Social Change Center, diretto da Rahel Jaeggi. Tema delle tre lezioni era la crisi delle democrazie contemporanee. Negli stessi giorni, sempre nella capitale tedesca, l’Istituto Italiano di Cultura ha organizzato una settimana di eventi entro la cornice del progetto DediKa per celebrare Giorgio Agamben]
 Ho l’impressione, a volte, che non si rifletta
a
sufficienza sul peso che il culto delle celebrities ha
anche nella ricerca scientifica – e sulla stranezza di tutto
ciò.
Ho l’impressione, a volte, che non si rifletta
a
sufficienza sul peso che il culto delle celebrities ha
anche nella ricerca scientifica – e sulla stranezza di tutto
ciò.
Lo scambio tra celebrità e sapere è noto e reciprocamente vantaggioso. La celebrity intellettuale porta in dotazione un condensato di reputazione che non è più oggetto di discussione e tale reputazione cristallizzata gratifica di luce riflessa anche l’istituzione che riesce a reclutarla. La celebrity, a sua volta, se non ha scrupoli, può massimizzare l’Effetto San Matteo di cui gode per default e ricevere in cambio denaro, opportunità e, last but not least, vagonate di adulazione. Questo caso da manuale di ingiustizia epistemica ribadisce una delle leggi più affidabili della socialità umana: the rich are bound to get richer and the poor to get poorer: that’s the way it is.
Soprattutto per istituzioni che faticano oggi a legittimarsi, come i centri di ricerca umanistici, la notorietà – un indicatore incontestabile del fatidico “impact factor” – è spesso l’unico surrogato plausibile dell’utilità percepita, ovvero delle remuneratività.
Ma vi siete mai messi nei panni di una celebrity? Si direbbe un esperimento mentale interessante. Se la reputazione scientifica è meritata, questa dovrebbe andare di pari passo con l’umiltà. Il detto socratico “so di non sapere”, non è infatti un tributo alle buone maniere o, peggio ancora, un gesto di falsa modestia. È il riconoscimento prudente della sproporzione tra l’estensione e la profondità delle grandi questioni filosofiche che stanno sullo sfondo di qualsiasi indagine scientifica e la portata reale delle capacità della mente umana, o meglio delle episodiche performance cognitive di una persona in carne e ossa.
Ora, immaginate che un nuovo Centro di ricerca, con sede in una prestigiosa capitale europea, vi inviti a tenere un ciclo di lezioni pubbliche su una questione cruciale della contemporaneità – ad esempio, la crisi della democrazia – voi come vi disporrete psicologicamente all’evento?
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: La Cina controcorrente, grazie ai salari alti
La Cina controcorrente, grazie ai salari alti
di Pasquale Cicalese
Lo avevamo scritto due anni fa. Ieri lo ha certificato addirittura il Fondo Monetario Internazionale.
Il surplus delle partite correnti cinesi in 11 anni si è azzerato, dal 10% allo 0.1%.
Non ha contribuito, precisa il Fmi, Trump e la sua guerra dei dazi, ma al contrario la reflazione salariale cinese (fortissimo aumento dei salari, anno dopo anno), politiche fiscali fortemente espansive e l’apprezzamento dello yuan.
In tal modo la Cina ha sorretto il mercato mondiale non sottraendo risorse, ma anzi aprendo agli esportatori esteri il suo mercato, costituito oggi al 76% dai consumi interni.
Attenzione dunque a seguire la vulgata dei media e degli economisti occidentali. Quella cinese non è affatto un’economia mercantilista (ossia trainata dalle esportazioni e dalla costante riduzione dei salari, sul “modello” della Germania e dunque dell’intera Unione Europea), ma predilige l’equilibrio nello scambio con l’estero.
Al contrario, nota il Fmi, il surplus delle partite correnti tedesche raggiunge il 7,3% del pil, a cui fa da contraltare il deficit delle partite correnti americano pari al 2,3%, con il debito federale cresciuto sotto Trump del 10,1%, raggiungendo il 101% del pil. In totale i debiti americani raggiungono 70 mila miliardi di dollari.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Un’emergenza silente
Un’emergenza silente
di Andrea Zhok
Il principio guida di un’educazione efficace consiste nello sfruttare la capacità umana di ‘compensazione’ dopo uno sforzo superiore al normale. Così, se vuoi educare un muscolo ad essere più forte o reattivo lo sottoponi ad uno sforzo anomalo, che poi verrà compensato dall’organismo, sviluppando le parti coinvolte. La stessa cosa accade per qualunque capacità mentale, dalla memoria alle capacità di codifica e decodifica verbale. Questo significa, molto semplicemente, che qualunque buona educazione richiede di sottoporre il discente (soprattutto in crescita) a sforzi mirati superiori alla propria norma. Se e quando lo fa, la relativa facoltà cresce.
Ora, la specie umana fino a tempi recenti ha vissuto in condizioni in cui gli ‘ostacoli’, le necessità di fare uno sforzo fuori dalla norma, provenivano da sfide ambientali, da circostanze pratiche esterne. Alcune di queste circostanze, soprattutto nell’ambito della maturazione intellettuale, venivano dall’esposizione durante la crescita alla richieste normative, comportamentali, concettuali e linguistiche delle proprie società.
Come rispetto al cibo, i soggetti di norma non avevano la necessità di ‘mettersi a dieta’ con uno sforzo di volontà, perché ci pensavano le sfide ambientali a mantenere in efficienza la propria corporeità, così l’esposizione dei bambini (per lungo tempo concepiti come ‘adulti in miniatura’) al confronto con un mondo di norme, ragionamenti e tenzoni verbali adulte forniva uno stimolo spesso sufficiente ad una buona maturazione intellettuale.
Leggi tutto
comidad: Come hanno delandinizzato Landini?
Come hanno delandinizzato Landini?
di comidad
Un governo di destra ha incontrato un’opposizione che si colloca ancora più a destra. Pochi potevano supporre che i confusi tentativi del ministro dello Sviluppo e del Lavoro, Luigi Di Maio, di conferire una verniciatura sociale all’attuale politica governativa, non trovassero alcuna sponda nel sindacato. Il nuovo segretario della CGIL, Maurizio Landini, si è infatti iscritto alla schiera degli energumeni del liberismo, facendo concorrenza persino al più scalmanato di tutti, Luigi Marattin.
La proposta di Di Maio di istituire anche in Italia un salario minimo per legge, ha ricevuto da Landini una risposta abbastanza paradossale per il leader di una formazione che dovrebbe ispirarsi alla tradizione del riformismo socialista. Landini ha dichiarato infatti che le questioni salariali non riguardano il governoma la contrattazione delle parti sociali.
È lo stesso tipo di obiezione che veniva rivolta da parte confindustriale alla fine degli anni ’60 nei confronti dell’allora ministro del Lavoro, un ex sindacalista CGIL, il socialista Giacomo Brodolini, il quale aveva promosso per legge uno Statuto dei Lavoratori. A Brodolini si contestò appunto che i rapporti di lavoro andavano regolati per via contrattuale e non per legge. Sebbene fosse stato un sindacalista dei più prestigiosi, Brodolini la pensava diversamente, attirandosi tali odi che la sua morte prematura fu salutata con brindisi di gioia negli ambienti padronali.
Leggi tutto
Vox Populi: Da Alitalia per inquadrare il declino industriale italiano
Da Alitalia per inquadrare il declino industriale italiano
di Vox Populi
Risuonano in queste prime settimane di luglio le note di una canzone ascoltata in più occasioni negli ultimi decenni: Alitalia.
Alitalia è in crisi cronica da molto tempo, lo sappiamo tutti, ed in questi giorni il governo sta cercando di salvare l’azienda senza procedere verso la doverosa nazionalizzazione per non violare le deliranti regole europee. Ad oggi esiste il rischio di nuovi esuberi, si parla di 740 lavoratori su 11000 dipendenti nel personale di terra per risparmiare 14 milioni di euro, tagli sul salario del 5% per i piloti e del 5,8% per gli assistenti di volo, diminuzione dei riposi mensili da 10 a 9 e del numero dell’equipaggio su un’unità di Boeing 777.
Di Maio deve gestire una situazione complicata che vede sul piede di guerra i sindacati, specialmente l’USB, e molte incertezza nella ricerca dei soci per mettere insieme un capitale congruo per rilanciare l’azienda.
I due attori da tenere in considerazione sono Ferrovie dello Stato e Delta Airlinesche dettano le condizioni al governo. Ferrovie dello Stato pretende di far entrare nella partita i Benetton, con Atlantia, che come contropartita chiedono al governo di lasciare nelle loro mani le nostre autostrade. A questa richiesta aggiunge la cancellazione dei voli da Roma per Pisa, Firenze e Napoli con lo scopo di favorire il trasporto via treno, mentre Delta Airlines vorrebbe delle concessioni sulle tratte a lungo raggio con l’ovvio risultato di ridimensionare Alitalia, facendola scendere da 117 a 102 aerei.
Leggi tutto
Alessio Di Florio: Olimpiadi, c’è poco da festeggiare
Olimpiadi, c’è poco da festeggiare
di Alessio Di Florio
La Storia ci racconta di come grandi eventi, come Olimpiadi e Mondiali, siano diventati albero della cuccagna per cricche di ogni tipo. E hanno distrutto le finanze pubbliche
Dirette televisive, giubilo a reti e prime pagine unificate, esultanze sfrenate ovunque. Uno straniero distratto davanti a tutto questo penserebbe che lunedì 24 giugno sia accaduto qualcosa di epocale. Tipo l’inizio di una nuova età dell’oro, l’uscita dalla più grande epidemia della storia, la trasformazione di tutti i più poveri in ultraricchi, la cancellazione di ogni ingiustizia e sperequazione sociale, la scoperta che la disoccupazione è stata cancellata e dal giorno dopo ogni cittadino ha un lavoro con orari umani e alte retribuzioni. Nulla, invece, di tutto questo. Molto più banalmente, il Comitato Olimpico Internazionale ha designato l’Italia – o meglio due città in due regioni (su venti!) – come sede dei Giochi Olimpici invernali del 2026. In molte delle dirette e delle esultanze a reti unificate è stato posto l’accento su due aspetti. Il primo: è stata una “vittoria” bipartisan, dalla Lega al PD al CONI tutti uniti appassionatamente per un obiettivo. Il secondo: accanto al governo, alle Regioni Veneto e Lombardia e al sindaco Sala a Losanna hanno perorato la “causa” anche molti imprenditori. Un fronte spesso definito il “partito del pil” e della “crescita”. Ma, in politica e in economia, nulla è neutrale. Perché, molto banalmente, tutto ha uomini e donne che li promuovono e animano.
Leggi tutto
Hits 4065
Hits 2513
Hits 1980
Hits 1824
Hits 1801
Hits 1731
Sergio Farris: Confindustria e Sindacati. L'europeismo come atto di fede
Hits 1678
Eros Barone: Grandezza, limiti e attualità della Resistenza
Hits 1673
tonino

Dante Barontini: “Il partito della secessione” urla, ma è sotto scacco
“Il partito della secessione” urla, ma è sotto scacco
di Dante Barontini
 La crisi
del governo italiano è parte integrante della partita
europea. Chi
guarda alle vicende di questi giorni con gli occhi incollati
ai sondaggi interni, farà sempre più fatica ad interpretare
i messaggi
trasversali, gli sgambetti, gli scontri violenti che
devastano la maggioranza.
La crisi
del governo italiano è parte integrante della partita
europea. Chi
guarda alle vicende di questi giorni con gli occhi incollati
ai sondaggi interni, farà sempre più fatica ad interpretare
i messaggi
trasversali, gli sgambetti, gli scontri violenti che
devastano la maggioranza.
E’ appena il caso di ricordare che in questi ultimi cinque anni abbiamo avuto ben due partiti sopra o vicini al 40% nel voto popolare (non nei sondaggi), e in pochissimi mesi hanno perso tutto. Il Pd democristiano di Renzi e il M5S del neodemocristiano Di Maio sono già storia del passato. Il democristiano di ultradestra, l’”altro Matteo”, può fare la stessa fine alla stessa velocità.
Se fosse una partita solo italiana, questo andamento schizofrenico dell’elettorato richiederebbe l’intervento di uno squadrone di psichiatri di alto livello. Se la si vede intrecciata con la partita europea, invece, emerge una razionalità piuttosto severa.
Il punto essenziale da capire – e che la sedicente sinistra” ha sempre rimosso perché troppo chiaro – è che i governi nazionali dell’Unione a 27 hanno da quasi tre decenni perso la propria “sovranità di politica economica”. Quanto più è debole un paese (per peso economico o per livello del debito pubblico), tanto meno è libero di decidere cosa fare delle proprie risorse e delle entrate fiscali.
Questa limitazione è stata il problema che ha consumato il consenso di tutte le formazioni politiche succedutesi dal 1992 ad oggi, consumando leader (Berlusconi, Prodi, Bersani, Letta, Renzi, Di Maio, ecc) e “partiti”.
Se non puoi decidere la politica economica, le tue promesse elettorali diventano impossibili da rispettare. Quanto meno, quel che riesci a combinare – prendiamo ad esempio “reddito di cittadinanza” e “quota 100” – è solo una pallida imitazione di quel che avevi promesso.
In linea teorica, un governo nazionale – di qualsiasi connotazione ideal-politica – ha la possibilità di “retroagire” a livello europeo, avanzando istanze, chiedendo cambiamenti dei trattati, condivisione delle decisioni.
Leggi tutto
Ennio Abate: Sulla violenza nella storia
Sulla violenza nella storia
di Ennio Abate
 La
questione della violenza nella storia, ora anche in una
dimensione
“gobalizzata” (in passato affrontata su Poliscritture almeno
qui, qui, qui e qui), resta
irrisolta .
Meglio insistere a interrogarsi sul fenomeno. Da tutti i
possibili punti di vista. Senza mai arrendersi
all'”evidente” e finire per
sublimarla o esorcizzarla. Va bene anche partire da
materiale “datato” o “passato” o riflettendo a distanza di
anni da questo
o quell’evento traumatico.All’indomani della discussione
scaturita dal post di Donato Salzarulo sugli anni ’70
(soprattutto nella
sua seconda parte: qui) e
per continuare ad approfondire, pubblico dal mio
“Riordinadiario 2005” le ben meditate e ancora lucidissime e
attuali “Sette tesi
sul terrorismo nel Ventunesimo secolo” di Peppino Ortoleva.
Apparvero il 5 agosto di quell’anno sul sito della LUHMI
(Libera
Università di Milano e del suo hinterland, promossa da
Sergio Bologna) e vale la pena rileggerle e rifletterci.
Aggiungo il mio intervento e le
conclusioni dello stesso Ortoleva (purtroppo non più
accessibili on line a quanto vedo, ma di cui avevo
conservato una copia). Chi volesse
conoscere il resto della discussione lo trova qui (andando in
‘Archivio’ > ‘Sul terrorismo’). Un’ultima precisazione.
Ad Ortoleva, che nella sua replica scriveva: «La
mia posizione sulla violenza politica implica un
corollario, su cui credo Ennio non sia d’accordo. In
materia di violenza politica l’etica
della convinzione (per rifarci al binomio weberiano
rimesso in circolazione da Bobbio) non serve a nulla: se
si agisce sul terreno della storia
è su questo che si deve essere giudicati; se si
coinvolgono altre vite non si può pretendere di essere
giudicati solo sulla propria
coscienza», rispondo sia pur a distanza di anni di
concordare invece in pieno con lui: no, per me pure non è la
coscienza
individuale (o soggettiva) a misurare da sola il valore di
un’azione. Lo può essere (forse) un “io/noi” capace di
proporre e
attuare – fosse solo per poco tempo (nella storia le
rivoluzioni sono lampi) – un progetto razionale e condiviso
evitando sia i deliri
incontrollati dell’”io” sia quelli standardizzati dei “noi”
eterodiretti. [E. A.]
La
questione della violenza nella storia, ora anche in una
dimensione
“gobalizzata” (in passato affrontata su Poliscritture almeno
qui, qui, qui e qui), resta
irrisolta .
Meglio insistere a interrogarsi sul fenomeno. Da tutti i
possibili punti di vista. Senza mai arrendersi
all'”evidente” e finire per
sublimarla o esorcizzarla. Va bene anche partire da
materiale “datato” o “passato” o riflettendo a distanza di
anni da questo
o quell’evento traumatico.All’indomani della discussione
scaturita dal post di Donato Salzarulo sugli anni ’70
(soprattutto nella
sua seconda parte: qui) e
per continuare ad approfondire, pubblico dal mio
“Riordinadiario 2005” le ben meditate e ancora lucidissime e
attuali “Sette tesi
sul terrorismo nel Ventunesimo secolo” di Peppino Ortoleva.
Apparvero il 5 agosto di quell’anno sul sito della LUHMI
(Libera
Università di Milano e del suo hinterland, promossa da
Sergio Bologna) e vale la pena rileggerle e rifletterci.
Aggiungo il mio intervento e le
conclusioni dello stesso Ortoleva (purtroppo non più
accessibili on line a quanto vedo, ma di cui avevo
conservato una copia). Chi volesse
conoscere il resto della discussione lo trova qui (andando in
‘Archivio’ > ‘Sul terrorismo’). Un’ultima precisazione.
Ad Ortoleva, che nella sua replica scriveva: «La
mia posizione sulla violenza politica implica un
corollario, su cui credo Ennio non sia d’accordo. In
materia di violenza politica l’etica
della convinzione (per rifarci al binomio weberiano
rimesso in circolazione da Bobbio) non serve a nulla: se
si agisce sul terreno della storia
è su questo che si deve essere giudicati; se si
coinvolgono altre vite non si può pretendere di essere
giudicati solo sulla propria
coscienza», rispondo sia pur a distanza di anni di
concordare invece in pieno con lui: no, per me pure non è la
coscienza
individuale (o soggettiva) a misurare da sola il valore di
un’azione. Lo può essere (forse) un “io/noi” capace di
proporre e
attuare – fosse solo per poco tempo (nella storia le
rivoluzioni sono lampi) – un progetto razionale e condiviso
evitando sia i deliri
incontrollati dell’”io” sia quelli standardizzati dei “noi”
eterodiretti. [E. A.]
* * * *
Sette tesi sul terrorismo nel Ventunesimo secolo
di Peppino Ortoleva
1. Il terrorismo è un’arma. E’ un’arma peculiare, certo, per il tipo di “combattente” che richiede e che crea, e soprattutto per il carattere indiretto della sua azione, che non mira a infliggere danni alle forze avversarie ma a disorientare l’opinione pubblica.
Leggi tutto
Giovanni Di Fronzo: Sui recenti avvenimenti a Hong Kong
Sui recenti avvenimenti a Hong Kong
di Giovanni Di Fronzo
Nelle ultime settimane la città cinese di Hong Kong è scossa da una seconda fiammata del cosiddetto “movimento degli ombrelli”, di matrice antigovernativa, che già aveva avuto una prima fiammata nel 2014.
Si ricorda che Hong Kong, assieme a Macao e Taiwan, è uno dei territori che la Rivoluzione Cinese del 1949 non è riuscita a riscattare dal dominio straniero. La città, infatti, rimase colonia del Regno Unito, sotto il cui tallone si trovava dalla fine della Prima Guerra dell’Oppio (1842), ad eccezione del breve periodo di occupazione giapponese dal 1941 al 1945.
La decolonizzazione ebbe avvio solo 1997, attraverso una trattativa diplomatica pacifica fra Repubblica Popolare Cinese e Regno Unito. Da allora il potere politico cinese si esercita sull’isola attraverso il sistema definito “Una Cina, due sistemi”, ovvero su Hong Kong si esercita una giurisdizione particolare, sia dal punto di vista del sistema politico/istituzionale in senso stretto, sia dal punto di vista economico, ovvero vi è minor interventismo e regolamentazione dello stato sulle forze capitaliste. Tuttavia è pianificato che tali differenziazioni con il resto della Cina vengano gradualmente meno, fino alla conformazione totale prevista per il 2047.
Ebbene, negli ultimi anni, i più cruciali passaggi politici che segnano la strada verso la conformazione totale dell’ex-colonia britannica alla Cina sono caratterizzati da altrettanti passaggi conflittuali più o meno estesi: nel 2014 era stata una riforma elettorale che segnava un maggior intervento centrale nelle elezioni locali a dare il via al movimento.
Leggi tutto
Gilberto Trombetta: Germanizzazione
Germanizzazione
di Gilberto Trombetta [post di un amico]
Ieri, dopo aver smarcato l'uscita, me ne sono andato in biblioteca di ateneo perché volevo verificare rapidamente un paio di cose su dei testi di Wallerstein.
Naturalmente quello che cercavo non l'ho trovato, riproverò con un po' più di tempo.
Però nel fondo dove vado a pescare libri di mio interesse, frutto di una donazione da parte di uno storico/geografo che insegnava alla Statale, mentre scorrevo i titoli sugli scaffali alla ricerca di quel che avevo in mente mi sono imbattuto in un libro di Rampini, edito da Laterza nel 1996*.
L'ho preso, mi son messo su un banco e gli ho dedicato un'oretta.
Il libro contiene cose che sappiamo, fino allo sfinimento.
Leggerlo oggi può risultare solo noioso, ma ha decisamente un suo interesse nel fatto che sia stato pubblicato nel 1996 e contenga un sacco di citazioni letterali di uomini potenti di quell'epoca (molti rimasti potenti fino ai giorni nostri, altri un po' dimenticati come Hans Tietmeyer).
Rampini, che alcuni ultimamente sembrano voler indicare come un intellettuale rappresentativo di una "sinistra" che abbia ritrovato del buon senso, è in realtà sempre stato un nemico e questo testo lo dimostra limpidamente.
Il suo unico "merito" è quello di non essere un idiota, come molti suoi colleghi. Il che lo rende più pericoloso, semmai.
Leggi tutto
Geraldina Colotti: Venezuela, l'Internazionale dei popoli in lotta
Venezuela, l'Internazionale dei popoli in lotta
di Geraldina Colotti
Questo 25 di luglio, partiti e organizzazioni popolari, provenienti da tutto il mondo, si sono dati appuntamento a Caracas per il Foro di San Paolo. Hanno risposto all'appello alla solidarietà internazionalista per avvolgere in un grande abbraccio la rivoluzione bolivariana, sotto attacco dell'imperialismo e delle sue marionette perché rappresenta un'alternativa concreta di pace con giustizia sociale.
Nessun compagno o compagna può negare quale sforzo gigantesco rappresenti per un paese che si trova nella morsa di un feroce blocco economico-finanziario ospitare un'iniziativa di portata simile. E' dunque compito di ogni internazionalista rispondere in maniera non rituale, ponendosi all'altezza dei compiti richiesti oggi per costruire un'alternativa strutturale nei pasi capitalisti, e confrontandosi sul modo per riuscirsi.
Dieci anni fa, Hugo Chavez, il principale simbolo della rivoluzione bolivariana, propose di costruire una Quinta Internazionale, e così si espresse: “Tocca a noi assumere il ruolo di avanguardia e dobbiamo assumerlo così, compagni e compagne, rendendoci conto, prendendo coscienza della gigantesca responsabilità che grava sulle nostre spalle, su quelle di ognuna di voi, compagne, di ognuno di voi compagni.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Sulla vicenda di Bibbiano
Sulla vicenda di Bibbiano
di Andrea Zhok
Con le ultime passerelle politiche il tasso di strumentalizzazione della vicenda di Bibbiano mi pare stia superando la soglia di guardia. Sotto le apparenze di una tenzone simbolica e di una grande battaglia culturale direi che si stia giocando al solito giochino nazionale del lancio del secchio di letame per uno zero virgola nei sondaggi.
I dati accertati che abbiamo sulla vicenda non sono molti.
Sembra accertato:
- che vi sia stato un utilizzo strumentale e disonesto di tecniche diagnostiche da parte di operatori dei servizi sociali nell'area di Bibbiano;
- che tale utilizzo sia stato volto a sottrarre i figli a famiglie in difficoltà per darli in affidamento;
- che l'onlus di Moncalieri "Hansel e Gretel", cui sono stati affidati gli interventi psicoterapeutici, ci abbia guadagnato in maniera sproporzionata;
- che il sindaco di Bibbiano, del PD, sia accusato di abuso d'ufficio per aver assegnato senza concorso alla onlus l'incarico di prendersi cura dei minori;
- che una dirigente dei servizi sociali e un assistente sociale abbiano brigato illegalmente per affidare i bambini a coppie conosciute personalmente.
Leggi tutto
Matteo Gaddi e Nadia Garbellini: Non c'è tempo da perdere
Non c'è tempo da perdere
Come industria 4.0 cambierà il modo di produrre
di Matteo Gaddi e Nadia Garbellini
 Delocalizzazioni
e Industria 4.0 sono due fenomeni molto dibattuti, ma
raramente presi in
considerazione congiuntamente. Eppure, come vedremo, entrambi
concorrono all’evoluzione della geografia del Capitale,
alimentandosi a
vicenda.
Delocalizzazioni
e Industria 4.0 sono due fenomeni molto dibattuti, ma
raramente presi in
considerazione congiuntamente. Eppure, come vedremo, entrambi
concorrono all’evoluzione della geografia del Capitale,
alimentandosi a
vicenda.
Le imprese delocalizzano, ci viene detto, perché in Italia non trovano un clima favorevole al business. Le ragioni sono le più disparate: instabilità politica, eccessiva rigidità del mercato del lavoro, carenze infrastrutturali, quadro normativo eccessivamente articolato, tassazione troppo elevata, e così via.
La realtà, non è difficile capirlo, si presenta ben diversa: l’UE è una grande area di libero scambio, all’interno della quale si sono aboliti i confini alla circolazione di merci e capitali – e persone, limitatamente ai cittadini dell’area – in presenza di enormi disparità per quanto riguarda normative, standard sociali e ambientali, salari, regimi fiscali.
Ciò genera enormi possibilità di arbitraggio per le grandi imprese, che possono decidere di collocare sede fiscale, casa madre, impianti produttivi e uffici amministrativi in paesi diversi, a seconda della convenienza. Quindi, la strategia ottimale per ciascun paese è quella di specializzarsi in una determinata funzione, offrendo al Capitale tutte le condizioni ottimali per una allocazione geografica efficiente delle fasi produttive.
Naturalmente, gestire queste catene produttive lunghe è molto complesso, poiché implica il coordinamento di una lunga serie di fasi differenti, collocate in aree geografiche distinte – e soggette a normative diverse. L’attività di ricerca è stata pienamente organica a questa strategia, ed è stata indirizzata verso lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di facilitare il processo di centralizzazione senza concentrazione.
“Lo sviluppo della tecnologia avviene interamente all’interno [del] processo capitalistico. [...] Lo sviluppo capitalistico della tecnologia comporta, attraverso le diverse fasi della razionalizzazione e di forme sempre più raffinate di integrazione, un aumento crescente del controllo capitalistico.” (Panzieri, 1961)
Leggi tutto
Sebastiano Isaia: Libra. Ovvero la naturale smisuratezza del denaro
Libra. Ovvero la naturale smisuratezza del denaro
di Sebastiano Isaia
 Dieci anni fa Facebook contava
175 milioni di iscritti, «guadagnando altre due posizioni e
scavalcando [quanto a
popolazione] Pakistan e Bangladesh. “Se Facebook fosse un
Paese – aveva scritto un mese fa il suo fondatore Mark
Zuckerberg –,
sarebbe quello con l’ottava popolazione mondiale, superando
Giappone e Russia». Così scriveva Il Corriere della
Sera il 9 febbraio del 2009. Con oltre 2,4 miliardi
di utenti Facebook è oggi il Paese più popoloso del
pianeta. Mi si
obietterà che stiamo parlando pur sempre di un Paese virtuale,
di un luogo che non esiste nella “concreta realtà”, di
qualcosa che esiste solo in una dimensione algoritmica, tant’è
vero che Facebook non è una Nazione, non ha uno
Stato, non
ha un esercito, non ha («e non deve avere!») una moneta
sovrana. A questa legittima, sebbene un po’ ingenua e poco
“dialettica” obiezione, mi permetto di rispondere con un’altra
domanda: ma credete davvero che per il Capitale ha un senso
porre la
distinzione “ontologica” tra virtuale e reale? Perché dei
rapporti sociali capitalistici, oggi dominanti su scala
mondiale, qui
stiamo parlando, e di nient’altro. E scrivendo rapporti
sociali capitalistici non alludo solo a una dimensione
“classicamente” economica, tutt’altro, tanto più che la stessa
distinzione tra una sfera economica e una sfera esistenziale
è sempre più evanescente, poco significativa, se non
francamente inesistente. Per dirla con Massimo Troisi – e
attraverso la
mediazione di Marx, nella cui barba mi impiglio continuamente
–, credevo fosse economia e invece era la vita. E
viceversa.
Dieci anni fa Facebook contava
175 milioni di iscritti, «guadagnando altre due posizioni e
scavalcando [quanto a
popolazione] Pakistan e Bangladesh. “Se Facebook fosse un
Paese – aveva scritto un mese fa il suo fondatore Mark
Zuckerberg –,
sarebbe quello con l’ottava popolazione mondiale, superando
Giappone e Russia». Così scriveva Il Corriere della
Sera il 9 febbraio del 2009. Con oltre 2,4 miliardi
di utenti Facebook è oggi il Paese più popoloso del
pianeta. Mi si
obietterà che stiamo parlando pur sempre di un Paese virtuale,
di un luogo che non esiste nella “concreta realtà”, di
qualcosa che esiste solo in una dimensione algoritmica, tant’è
vero che Facebook non è una Nazione, non ha uno
Stato, non
ha un esercito, non ha («e non deve avere!») una moneta
sovrana. A questa legittima, sebbene un po’ ingenua e poco
“dialettica” obiezione, mi permetto di rispondere con un’altra
domanda: ma credete davvero che per il Capitale ha un senso
porre la
distinzione “ontologica” tra virtuale e reale? Perché dei
rapporti sociali capitalistici, oggi dominanti su scala
mondiale, qui
stiamo parlando, e di nient’altro. E scrivendo rapporti
sociali capitalistici non alludo solo a una dimensione
“classicamente” economica, tutt’altro, tanto più che la stessa
distinzione tra una sfera economica e una sfera esistenziale
è sempre più evanescente, poco significativa, se non
francamente inesistente. Per dirla con Massimo Troisi – e
attraverso la
mediazione di Marx, nella cui barba mi impiglio continuamente
–, credevo fosse economia e invece era la vita. E
viceversa.
Ciò che mi appare di gran lunga più significativo e degno di analisi (analisi che qui nemmeno tenterò) a proposito di Libra non è tanto l’intenzione che muove lo scabroso progetto (si tratta del vecchio e caro profitto, di cos’altro?) o la sua concreta realizzabilità nel medio o nel lungo periodo, quanto la sua “ontologia sociale”, il suo essere la perfetta espressione di tendenze economiche e sociali che rimontano molto indietro nel tempo e che sono intimamente legate al concetto stesso di capitale, oltre che, ovviamente, alla sua prassi. Dirompente non è l’idea imprenditoriale in sé, che a suo modo è anzi già vecchia (oggi le tecnologie hanno un grado di obsolescenza che tende alla velocità della luce), ma la scala, la dimensione sociale e geoeconomica che essa abbraccia: la globalizzazione capitalistica minaccia un nuovo scatto in avanti, e verso territori finora non esplorati fino in fondo. Di qui le preoccupazioni di diverso segno che hanno accompagnato il lancio mediatico di Libra.
Leggi tutto
Sergio Cesaratto: Così l’Italia può limitare i danni dell’Ue tedesca
Così l’Italia può limitare i danni dell’Ue tedesca
Lorenzo Torrisi intervista Sergio Cesaratto
La nuova Commissione europea nasce debole e a guida tedesca. All’Italia conviene appoggiare la linea francese nell’Ue
Ursula von der Leyen si prepara a mettere a punto la squadra per dare vita alla nuova Commissione europea che entrerà ufficialmente in carica a novembre. Anche all’Italia spetterà indicare il nome di un Commissario, ma gli incarichi spetteranno all’ormai ex ministra della Difesa tedesca. «Mi sembra che questa Commissione nasca piuttosto debole. Quel sospiro di sollievo che ha fatto la von der Leyen quando Sassoli ha dato lettura dei voti a favore ricevuti, solo nove in più dei necessari, la dice lunga. La situazione è però interessante», ci dice Sergio Cesaratto, Professore di Economia politica all’Università di Siena.
* * * *
In che senso?
È una Commissione che non ha una maggioranza solida e che ha davanti sfide importanti. Su Eurointelligence Wolfgang Munchau ha evidenziato ieri gli effetti negativi di alcune regole europee, come quella sull’output gap, cioè la differenza tra il Pil effettivo e quello potenziale, che può giustificare una certa flessibilità sui conti pubblici di un Paese. È però difficilissimo calcolare la crescita potenziale di un’economia, quindi su questa regola occorrerebbe un intervento della Commissione. Non dobbiamo poi dimenticare la Brexit, la politica estera…
Leggi tutto
Andrea Zhok: Sul sequestro della petroliera britannica nel Golfo Persico

Sul sequestro della petroliera britannica nel Golfo Persico
di Andrea Zhok
Oggi la politica estera è piena di allarmate considerazioni sulla tensione tra Regno Unito ed Iran.
L’Iran ha infatti annunciato di aver sequestrato nello Stretto di Hormuz la Stena Impero, una petroliera britannica con 23 persone a bordo.
Giornali e telegiornali traboccano non solo di toni di allarme, ma naturalmente anche di giudizi più o meno espliciti di condanna dell’azione iraniana, e di supporto all’attesa reazione britannica. (Es. Repubblica: “Aumenta la tensione nel Golfo, con l’Iran che lancia una nuova provocazione”.)
E’ invece curiosa la distrazione mediatica per l’antefatto di questo intervento.
La notte tra il 5 e il 6 luglio scorso la petroliera iraniana Grace 1 era stata sequestrata con un assalto di 30 Royal Marines nei pressi di Gibilterra.
Le motivazioni ufficiali del sequestro erano state il sospetto (sic!) che la nave intendesse violare l’embargo dichiarato dall’UE (sic!) per le importazioni di petrolio verso la Siria.
L’Iran ha tentato dapprima le vie legali, ma poco più di 24 ore fa la Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che il sequestro della Grace 1 poteva essere prolugato di un altro mese.
Ora, dal punto di vista della sostanza politica ciò che sta avvenendo è del tutto trasparente: ci sono state pressioni americane per rinforzare il blocco alle esportazioni di petrolio da parte iraniana, in modo da mettere in ginocchio economicamente il paese, e il Regno Unito (non senza qualche mugugno e protesta interna) ha deciso di cedere a tali pressioni dell’alleato.
Leggi tutto
Vincenzo Morvillo: Camilleri, De Crescenzo e il flusso social post mortem
Camilleri, De Crescenzo e il flusso social post mortem
di Vincenzo Morvillo
Sì, ho capito. Erano due uomini brillanti, simpatici e colti. Sebbene con una cultura declinata secondo canoni molto diversi. Ma, con tutto il rispetto, permettetemi di prendere le distanze da questo costante, uniforme, inquietante flusso di pensiero social. Da questo pericoloso conformismo post mortem!
Uno, Camilleri, era il tipico intellettuale “liberal-progressista”, organico ad una sinistra legalista, statolatra, riformista e borghese. Il suo Montalbano, d’altronde, è uno sbirro che ricorda molto da vicino gli eroi in divisa (di quelli che non si incontrano nelle strade e nei commissariati), tanto cari a quel Pci che fu il partito garante e gendarme dell’ordine sociale. Poi, se proprio devo leggere di sbirri per puro piacere letterario, leggo Conan Doyle, Simenon, Chandler.
Il secondo, De Crescenzo, per quanto amabile e divertente, era un sincero reazionario: nostalgico, antimoderno, populista. Tipico esponente di una cultura da supermarket, ridusse la filosofia ad un banale raccontino per turisti del pensiero in vacanza, senza alcuna profondità logica, naturale, scientifica, economica. Cantore di una Napoli francamente intollerabile, per quanto narrata con affetto e indulgenza.
Quell’indulgenza paternalistica che è, però, l’altra faccia della medaglia della paternalistica severità bacchettona. Alla Saviano, per capirci.
Insomma, un comodo cliché, apparecchiato per le classi dominanti e per un popolo che ami crogiolarsi nella sua “idiota” incoscienza.
Leggi tutto
Lorenzo Ferrazzano: Il ruolo politico del Movimento 5 Stelle
Il ruolo politico del Movimento 5 Stelle
di Lorenzo Ferrazzano
«Vivo una crisi di fiducia anche personale, io avevo creduto in questo rapporto, mi sono fidato per mesi e mesi, per questo parlo di fiducia rotta». Sono le parole che ieri pomeriggio, ad Helsinki, in seguito al vertice dei ministri degli interni europei, Matteo Salvini ha rivolto a Luigi Di Maio, dopo che il Movimento 5 Stelle ha fornito un contributo decisivo alla nomina di Ursula von der Leyen come presidente della Commissione Europea.
I toni sono poi scesi ma queste parole rappresentano comunque il segnale evidente – e annunciato – di uno strappo profondo tra Lega e M5S. A poco più di un anno dall’insediamento del governo, abbiamo visto ribaltarsi tutte le carte in tavola. Un rovesciamento dei rapporti di forza tra Salvini e Di Maio, considerati a torto o a ragione le due anime dell’Italia: quella che guardava agli imprenditori del Nord e quella che prometteva il riscatto del Sud.
Si trattava di una scommessa. Bisognava capire se le esigenze radicalmente diverse delle due «Italie» potessero convergere coerentemente in un unico contratto di governo, senza che le une scavalcassero le altre. Sperare che la Lega potesse rimarginare le ferite del Nord e il Movimento rappresentare una speranza per il Sud.
Le contraddizioni strutturali di questa alleanza, del tutto evidenti in due forze politiche così lontane per storia e identità, minavano le basi stesse del governo già dal momento della sua nascita. Durante questa legislatura, Lega e M5S sono stati poi in disaccordo su tutto.
Leggi tutto
Hits 4081
Hits 2524
Hits 1989
Hits 1823
Hits 1741
Hits 1702
Hits 1691
Hits 1681
Hits 1659
Hits 1608
tonino

Giorgio Riolo: Il malsviluppo e la crisi sociale ed ecologica
Il malsviluppo e la crisi sociale ed ecologica
E attenti al 29 luglio, Overshoot Day: la terra (con tutti noi) va in rosso
di Giorgio Riolo
A Giorgio Nebbia, recentemente scomparso. Figura preziosa come presenza umana, intellettuale e politica della sinistra italiana. Ambientalista rigoroso e comunista, la giustizia sociale e la giustizia ambientale come pensiero vissuto. A lui la nostra gratitudine per averci aiutato negli anni decisivi della formazione culturale e politica
 Il
prossimo 29 luglio è il cosiddetto Overshoot Day (*) il
Giorno del
Superamento-Supesfruttamento. Vale a dire, della possibilità
del pianeta terra di rigenerare-ripristinare l’equilibrio
delle risorse a
causa del consumo-emissione di CO2-inquinamento-rifiuti ecc.
su scala mondiale. Questa misura è calcolata ogni anno dalla
benemerita Rete
mondiale dell’Impronta Ecologica (Global Footprint Network).
Nel 1970 il giorno era il 31 dicembre. Il saldo allora era a
somma zero. Oggi per 5
mesi e qualche giorno deprediamo letteralmente la terra. Da
sommare alle depredazioni degli anni precedenti.
L’accumulazione del capitale e
l’accumulazione della violenza ambientale, sul vivente.
Il
prossimo 29 luglio è il cosiddetto Overshoot Day (*) il
Giorno del
Superamento-Supesfruttamento. Vale a dire, della possibilità
del pianeta terra di rigenerare-ripristinare l’equilibrio
delle risorse a
causa del consumo-emissione di CO2-inquinamento-rifiuti ecc.
su scala mondiale. Questa misura è calcolata ogni anno dalla
benemerita Rete
mondiale dell’Impronta Ecologica (Global Footprint Network).
Nel 1970 il giorno era il 31 dicembre. Il saldo allora era a
somma zero. Oggi per 5
mesi e qualche giorno deprediamo letteralmente la terra. Da
sommare alle depredazioni degli anni precedenti.
L’accumulazione del capitale e
l’accumulazione della violenza ambientale, sul vivente.
Naturalmente, con la gerarchia mondiale di questo furto. Gli Usa (328 milioni di abitanti) avrebbero bisogno di 5 pianeti a questo ritmo dell’impronta ecologica dei suoi abitanti. La Cina 2,2 pianeti (ma 1 miliardo e 420 milioni di abitanti) e l’India 0,7 (ma 1 miliardo e 370 milioni di abitanti) e via scalando nella popolazione mondiale delle periferie del mondo. Inoltre è annunciato per il prossimo agosto 2019 il nuovo rapporto dello Ipcc (gruppo di lavoro intergovernativo di scienziati del clima sul cambiamento climatico, legato all’Onu ). Ma basta lo Special Report del 2018 per allarmarci. Siamo già dentro a processi irreversibili.
Per l’occasione, anticipo qui di seguito alcune parti dell’ultimo capitolo di un libro scritto con Massimiliano Lepratti sulla “storia globale dell’umanità”, in attesa di pubblicazione. È una sintesi di circa 350 pagine scritta per un pubblico largo, senza pretese specialistiche, ma con l’intento di contribuire a una battaglia culturale importante, con riferimenti bibliografici minimi. Facendo tesoro della lezione di Samir Amin, della critica radicale dell’eurocentrismo e dell’occidentalocentrismo, secondo l’impostazione del sistema-mondo dello storico francese Fernand Braudel ecc.
Nel capitalismo “tutto si tiene”. Il fine è sempre quello di tenere assieme giustizia sociale (e di genere) e giustizia ambientale. Non sovrapposte, disgiungibili, bensì fuse, contestuali, della stessa sostanza (consustanziali, qualcuno direbbe). Dopo di che, il difficile è quale militanza, quale azione politica e sociale farne scaturire. Tutti i problemi che rimangono entro una sinistra decente (alternativa ecc.) in questa epoca storica.
Leggi tutto
Carlotta Caciagli: Gli Student Hotel e la creatività del capitale
Gli Student Hotel e la creatività del capitale
di Carlotta Caciagli*
Mentre il diritto allo studio viene attaccato trasformandolo in «debito d'onore», in diverse città d'Europa nascono studentati privati di lusso. Sono l'ennesimo tentativo di far diventare qualsiasi esperienza di vita un'esperienza di consumo
 Amsterdam, Dresda, Berlino, Firenze, Parigi. In
alcune città gli Student
Hotel sono già sbarcati, in molte altre arriveranno presto,
come a Lisbona, Barcellona, Tolosa. In Italia si conta di
aprirne almeno altri
cinque nei prossimi due anni. Ma cosa sono gli Student Hotel?
Stando al nome sembrerebbero dei semplici alloggi per
studenti, ma a ben guardare sono
molto altro: luoghi che riproducono un preciso modello di
città e una precisa concezione di istruzione.
Amsterdam, Dresda, Berlino, Firenze, Parigi. In
alcune città gli Student
Hotel sono già sbarcati, in molte altre arriveranno presto,
come a Lisbona, Barcellona, Tolosa. In Italia si conta di
aprirne almeno altri
cinque nei prossimi due anni. Ma cosa sono gli Student Hotel?
Stando al nome sembrerebbero dei semplici alloggi per
studenti, ma a ben guardare sono
molto altro: luoghi che riproducono un preciso modello di
città e una precisa concezione di istruzione.
The Student Hotel (Tsh) è uno studentato e al tempo stesso un hotel di lusso, ci si può stare una notte come un anno intero. Al suo interno è composto di camere e spazi comuni: cucine, salotti, aule studio, aule conferenze, biliardi, terrazze con piscina, in alcuni casi saune e idromassaggi. Un design progettato – quando possibile dalla archistars di casa, poiché la visibilità è garantita – per essere casa, ufficio e luogo di ricreazione al tempo stesso. Uno spazio pensato per rendere accettabile che fra lavoro e tempo libero non ci siano confini. Perché se essere perennemente presi nella morsa del processo produttivo significa una camera vista mare, be’, allora non è poi così male. Salvo per i prezzi, che allo studentato si avvicinano proprio poco dato che una camera può costare anche 100 euro a notte. Viene quasi da chiedersi chi siano le persone che possono permettersi una stanza qua. Ce lo spiega il gruppo possessore: Tsh è per giovani creativi, studenti, intellettuali, professionisti e startuppers. Insomma per tutte quelle figure professionali che lavorano sempre pur sembrando non lavorare mai. In fondo, ci dice sempre il gruppo Tsh, si tratta di un’idea semplice, ovvero riunire imprenditori, studenti e viaggiatori sotto un unico tetto, alle parole d’ordine di mescolanza, multiculturalismo e condivisione.
Parole a cui è difficile contrapporsi, perché rimandano le menti a giovani aperti, che conoscono il mondo, che apprendono lingue nuove, a italiani che imparano a cucinare cous-cous, a inglesi che mangiano pasta e pizza, a film in lingua originale, a serate a tema in cui conoscere i costumi degli altri. La «mission» di Tsh è quella che abbiamo assunto essere dell’Erasmus, ovvero creare un contesto stimolante per tutti, in cui si beneficia del contatto con il diverso.
Leggi tutto
Leonardo Mazzei: Chi ha paura non vada alla guerra
Chi ha paura non vada alla guerra
In risposta a Davide Gionco
di Leonardo Mazzei
«Posto che una fase di emergenza va effettivamente messa nel conto (ma non nei termini ipotizzati dal Gionco), essa non sarebbe comunque troppo lunga. E qui voglio essere brutale ma chiaro: se non siamo nemmeno capaci di immaginare e di affrontare qualche giorno senza il bancomat, è giusto che rimaniamo schiavi. Non si può infatti avere la botte piena (la sovranità) e la moglie ubriaca (il quieto vivere senza scossone alcuno)».
Chi ha paura non vada alla guerra. Ecco un detto che chi si occupa delle cose della politica sempre dovrebbe rammentarsi. E come non farlo, ricordando Sciascia, nel momento in cui gli ominicchi potrebbero lasciare il posto ai quaquaraqua? Ma non è di "grande" politica che vogliamo occuparci oggi, bensì di un problema più circoscritto: quello dei sovranisti alimentati a paura, quelli del "vorrei ma non posso", del "prima bisogna...", eccetera eccetera.
Stavolta ce ne offre lo spunto uno scritto di Davide Gionco, apparso su "Scenari economici". Il ritornello è sempre il solito: uscire dall'euro è difficile, la Bce ci strangolerebbe, il consenso non ci sarebbe (o comunque non reggerebbe), meglio sarebbe stato esserne fuori, ma ormai...
Certo in maniera del tutto involontaria sono proprio questi discorsi il regalo più grande che si possa fare alle oligarchie euriste. Del resto, anche tra i dominanti non manca chi riconosce che l'euro sia stato un errore, aggiungendo però subito dopo che adesso uscirne sarebbe semplicemente catastrofico.
Leggi tutto
Elijah J Magnier: Iran e Trump sull’orlo dell’abisso
Iran e Trump sull’orlo dell’abisso
di Elijah J Magnier
L’Iran sta spingendo il presidente degli Stati Uniti Donald Trump sull’orlo dell’abisso, elevando il livello delle tensioni in Medio Oriente a nuove vette. Dopo il sabotaggio [in inglese] di quattro petroliere ad al-Fujairah, l’attacco al gasdotto [in inglese] Aramco un mese fa, e l’attacco [in inglese] della scorsa settimana a due petroliere nel Golfo di Oman, il Corpo della Guardia Rivoluzionaria Iraniana (IRGC – ora classificato dagli USA come gruppo terrorista) ieri ha abbattuto un drone [in inglese] della US Navy, inviando due messaggi chiari. Il primo messaggio è che l’Iran è pronto per una guerra totale, indipendentemente dalle conseguenze. Il secondo messaggio è che l’Iran è consapevole che il Presidente degli Stati Uniti si è messo nell’angolo da solo; l’imbarazzante attacco è arrivato una settimana dopo che Trump aveva dato il via alla sua campagna elettorale.
Secondo fonti ben informate, l’Iran ha respinto [in inglese] una proposta dell’intelligence americana – fatta da una terza parte – che Trump potesse bombardare uno, due o tre obiettivi chiari, scelti dall’Iran, in modo che entrambi i paesi potessero apparire come i vincitori e Trump potesse salvare la faccia. L’Iran ha categoricamente respinto l’offerta, e ha inviato la sua risposta: persino un attacco contro una spiaggia vuota in Iran avrebbe innescato un lancio di missili contro gli obiettivi statunitensi nel Golfo.
Leggi tutto
Dino Erba: Camilleri, De Crescenzo: perché tanto rumore?
Camilleri, De Crescenzo: perché tanto rumore?
di Dino Erba
Spero che questo testo abbia ampia circolazione nella nostra intossicata società spettacolare di massa. Personalmente lo sottoscrivo parola per parola. Nel leggerlo mi ha impressionato anche la coincidenza di reazione alla lettura di Camilleri: anch’io una volta presi in mano un suo libro, così, solo per sapere di cosa si trattasse. Lo gettai via quasi subito. Per me era una storia banale, avvolta in una scrittura banale e trovavo ignobile la «sicilianizzazione» della lingua italiana: perché o si scrive in siciliano o si scrive in italiano o si intreccia (si alterna) il dialetto con la lingua: ma la fusione, cioè la creazione di una terza lingua bastarda, proprio no. Ripugnante in termini letterari.
Non mi sfuggiva poi che tutta la serie televisiva di Montalbano, Piovre ecc. riabilitava sfacciatamente le «nostre» forze dell’ordine che con i poteri mafiosi hanno imparato a convivere, salvo «incidenti» minori di tanto in tanto.
Per De Crescenzo - un esempio di scadimento nella volgarità culturale da parte di un membro tra i più «spettacolosi» dell’élite intellettuale italiana - si dovrebbe anche aggiungere la versione poco dignitosa da lui propagata dello spirito partenopeo. Ma questo non spetta dirlo a un romano come me, ma spetterebbe a chi, tra il popolo napoletano più autentico, si sia sentito umiliato dalla ridicolizzazione decrescenzana, trita e ritrita, del presunto napoletanismo. (r.m.).
La morte degli illustri vegliardi ha destato sperticati encomi, a destra e a manca. A bocce ferme, tali encomi potrebbero apparire eccessivi (se non servi…).
Personalmente, di Camilleri tentai di leggere un romanzo, lo trovai tedioso, stilisticamente manieristico (un Gadda siculo?). Della sua illustre creatura, il macchiettistico Commissario, vidi qualche vicenda televisiva, sull’onda della galoppante infatuazione.
Leggi tutto
Jeff Hoffman: Il “pacco” dei diritti umani e il contropaccotto delle multinazionali
Il “pacco” dei diritti umani e il contropaccotto delle multinazionali
di Jeff Hoffman
IDLO sta per International Develpment Law Organization. Il direttore generale è stata anche segretaria generale di Amnesty International. Idlo è l’unica organizzazione intergovernativa che si dedica esclusivamente a studiare e a promuovere le leggi. Le leggi che studia, progetta e promuove sono quelle che rendono legale l’arbitrio delle multinazionali nel mondo, e quelle che permettono di promuovere o addirittura rendere obbligatorio l’acquisto dei loro prodotti. Cervelli sopraffini, maligni, che riescono a trasformare una coltura intensiva di olio di palma in una “riforestazione”, o che promuovono l’uso del cloro per disinfettare le acque. Sono quelli che festeggiano quando c’è un terremoto o una guerra o una tragedia qualsiasi.
IDLO lavora in tandem con la Banca Mondiale e una delle sue iniziative è di eliminare i farmaci dannosi. Che bello. Eliminano i farmaci negativi di BigPharma? No, certo che no. Si occupano di eliminare piccole aziende farmaceutiche nei paesi del terzo mondo.
In quale cornice si muovono? E’ possibile trovare centinaia di esempi di leggi che ci costringono a comprare cose dannose per la nostra salute. Il direttore generale di Idlo è Irene Khan, che ha costruito la sua carriera e riempito lautamente il suo conto corrente occupandosi di DIRITTI UMANI e scrivendo libri.
La cornice è quella dei diritti umani e “degli aiuti allo sviluppo”. Il secolo scorso ha partorito questa cosa delle ong dei diritti umani.
Leggi tutto
Giovanna Cracco: Per chi sta realmente lavorando questa economia?
Per chi sta realmente lavorando questa economia?
di Giovanna Cracco
 Il 3 luglio scorso la
Commissione europea ha ritirato la proposta di aprire una
procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia (1), dichiarando che
terrà il Paese sotto stretta osservazione e se ne riparlerà in
autunno, in fase di manovra finanziaria 2020. L’ha fatto
perché l’Italia ha messo sul piatto 7,6 miliardi, modificando
le proprie
politiche economiche così come la Commissione aveva richiesto.
Problema risolto? No. E per comprendere quanto sia irrisolto,
occorre fare un
passo indietro e tornare sul Rapporto con cui il 5 giugno la
Commissione Ue aveva proposto l’apertura della procedura
d’infrazione.
Il 3 luglio scorso la
Commissione europea ha ritirato la proposta di aprire una
procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia (1), dichiarando che
terrà il Paese sotto stretta osservazione e se ne riparlerà in
autunno, in fase di manovra finanziaria 2020. L’ha fatto
perché l’Italia ha messo sul piatto 7,6 miliardi, modificando
le proprie
politiche economiche così come la Commissione aveva richiesto.
Problema risolto? No. E per comprendere quanto sia irrisolto,
occorre fare un
passo indietro e tornare sul Rapporto con cui il 5 giugno la
Commissione Ue aveva proposto l’apertura della procedura
d’infrazione.
Per leggerlo (2), la sola volontà non è sufficiente; occorre saltare lo steccato ed entrare nel territorio dell’ostinazione, per poi accettare di muoversi nello spazio dell’incredulità. Dapprima è la fatica a dominare, per la sequela di cifre e percentuali che in modo ossessivo si ripetono, dopodiché arriva la sensazione di essere finiti in un mondo parallelo, nel quale le coordinate con cui dovremmo misurare il reale, non esistono.
Da parte sua, con titoli di scatola in prima pagina, editoriali, analisi e aperture di telegiornali che rappresentano come legittima la posizione della Commissione Ue, nemmeno l’informazione mainstream ha aiutato a giugno e non aiuta tuttora a restare aggrappati alla realtà, anzi contribuisce a eliminare dal discorso pubblico ogni riflessione che entri nel merito. La narrazione sulla bontà dei ‘vincoli di bilancio’ introdotti da Maastricht è pensiero dominante da quasi tre decenni, dunque non stupisce l’acritico recepimento del ‘torto’ e della ‘ragione’; eppure la capacità di ragionamento, per quanto atrofizzata, avrebbe dovuto avere un sussulto davanti alla lettura del Rapporto, e la realtà, per quanto negata, si presenta oggi agli occhi in modo talmente drammatico e prepotente che dovrebbe essere impossibile evitare di guardarla.
Se l’applicazione di una teoria economica allarga la forbice della diseguaglianza sociale e aumenta la povertà, deve essere messa in discussione. Alla radice, nella sua impostazione di base, non in superficie, cercando compromessi che non ne modificano l’impianto. “Per chi sta realmente lavorando questa economia?” ha affermato a fine giugno Elizabeth Warren, senatrice democratica in corsa alle primarie del partito, al primo dibattito televisivo della campagna elettorale:
Leggi tutto
coniarerivolta: Boeri e le gabbie salariali: l’incubo che ritorna
Boeri e le gabbie salariali: l’incubo che ritorna
di coniarerivolta
 In un articolo
pubblicato su Repubblica, Tito Boeri, ex presidente
dell’INPS, propone una delle sue tante ricette, rigorosamente
in salsa neoliberista, per
far tornare a crescere l’economia italiana e ridurre la
disoccupazione: la reintroduzione delle cosiddette “gabbie
salariali”, cioè differenziali tra le retribuzioni
dei lavoratori in base al luogo di residenza, ipocritamente
giustificati
sulla base di differenze nel costo della vita nelle varie
regioni d’Italia. Prima di addentrarci nei dettagli della
proposta, vediamo da cosa
scaturisce questa nuova (nuova si fa per dire, i neoliberisti
sono persone molto banali) idea del Prof. Boeri.
In un articolo
pubblicato su Repubblica, Tito Boeri, ex presidente
dell’INPS, propone una delle sue tante ricette, rigorosamente
in salsa neoliberista, per
far tornare a crescere l’economia italiana e ridurre la
disoccupazione: la reintroduzione delle cosiddette “gabbie
salariali”, cioè differenziali tra le retribuzioni
dei lavoratori in base al luogo di residenza, ipocritamente
giustificati
sulla base di differenze nel costo della vita nelle varie
regioni d’Italia. Prima di addentrarci nei dettagli della
proposta, vediamo da cosa
scaturisce questa nuova (nuova si fa per dire, i neoliberisti
sono persone molto banali) idea del Prof. Boeri.
Il predecessore di Tridico ci informa, preoccupato, che il Nord del Paese si sente tradito dalla Lega, che avrebbe lasciato troppo spazio alle ricette economiche del Movimento 5 Stelle e avrebbe rinunciato, in tutto o in parte, alle proprie. “L’agenda di Governo” – scrive Boeri – “ha del tutto ignorato le istanze del blocco sociale settentrionale”. Immediatamente, Boeri mette le cose in chiaro sulla sua visione del Paese, riferendosi a un Nord di lavoratori e pensionati che speravano nelle promesse della Lega – quota 100 e la flat tax, ad esempio – e a un Sud di disoccupati che avevano votato in massa Movimento 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza. Solo questi ultimi sarebbero stati davvero accontentati. Il produttivo Nord sarebbe stato fregato dalla Lega attraverso una quota 100 molto limitata, nella sua portata, rispetto alle aspettative dei lavoratori settentrionali prossimi alla pensione e una flat tax che, fino ad ora, non si è vista (se non attraverso una ben misera “flataxina”).
Secondo Boeri, un partito interessato ad affrontare i veri problemi del Paese dovrebbe partire dalla questione settentrionale, prendendo di petto quella che secondo lui è la vera grande ingiustizia territoriale: i salari reali (ovvero il rapporto tra i salari in termini monetari e i prezzi, che ci dice, in pratica, quante cose un lavoratore può comprare con il proprio stipendio) sono più alti al Sud che al Nord, a causa di prezzi molto più bassi nelle regioni meridionali rispetto a quelli nelle regioni del Settentrione.
Leggi tutto
Carlo Formenti: Podemos e M5S vittime dell'effetto Zelig
Podemos e M5S vittime dell'effetto Zelig
di Carlo Formenti
Nei miei ultimi libri ho analizzato la mutazione genetica che ha fatto sì che le sinistre (tanto le socialdemocratiche che le radicali) siano trasmigrate nel campo liberale (sia pure con diverse sfumature), abbandonando la rappresentanza delle classi subalterne per rivolgere la propria attenzione ai ceti medi riflessivi. Ho anche tentato di indicare tanto le cause “esterne” (le trasformazioni del sistema capitalistico e il loro impatto sulla stratificazione di classe), quanto quelle “interne” (il mancato svecchiamento dell’apparato ideologico ereditato dal passato) del fenomeno. Si tratta di temi troppo impegnativi da affrontare nello spazio di un post, per cui mi limito qui a evidenziare quello che è forse il sintomo più clamoroso della mutazione, vale a dire l’impulso suicida che accomuna tutte le forze politiche che tuttora si definiscono di sinistra. In particolare, vorrei sottolineare che, a essere afflitti dal sintomo in questione, sono anche quei populismi “di sinistra” che pure sembravano avviati ad occupare il vuoto politico lasciato dalle “vecchie” sinistre, tanto da alimentare il sospetto che basti collocarsi in quell’area per condannarsi all’autodistruzione.
I casi di Podemos e dell’M5S sono particolarmente significativi. Si tratta di due forze che presentano differenze tutt’altro che marginali: l’M5S ha sempre affermato di non essere di destra né di sinistra, mentre Podemos, dopo esitazioni iniziali, ha rivendicato l’appartenenza al campo delle sinistre radicali; i programmi politici del primo appaiono studiati per rivolgersi a una base sociale trasversale, mentre quelli del secondo sono più orientati verso gli interessi degli strati sociali inferiori.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: American Psyco contro Huawei
American Psyco contro Huawei
di ilsimplicissimus
La mail di un ricercatore austriaco conosciuto moltissimi anni fa durante i giorni in cui infuriava l’illusione della fusione fredda, mi ha aperto una nuova prospettiva sulla questione Huawei, ribaltandola completamente e mostrandomi quali sono le vere preoccupazioni Usa riguardo alla leadership cinese nella banda larga mobile 5G: niente a che vedere con la pretestuosa minaccia di intercettazioni di Pechino che è nel migliore dei casi solo un processo alle intenzioni, ma piuttosto con la probabilità che le intercettazioni elettroniche diventino quasi impossibili, grazie alla crittografia quantistica, altro campo nella quale la Cina è in testa, quantomeno nella realizzazione concreta. Era il 29 settembre 2017 quando a Pechino il fisico Jian-Wei Pan ha posato la mano su un globo cerimoniale di vetro, parte simbolica e decorativa della prima rete sperimentale di comunicazione quantistica criptata a lunga distanza comunicando con Shanghai su una distanza di oltre 1800 chilometri. Lo stesso giorno a Vienna, il professor Anton Zeilinger, direttore dell’Istituto di ottica e informazione quantistica ha ricevuto una video chiamata dai suoi colleghi in Cina: la prima intercontinentale con crittografia quantistica, resa possibile dal satellite di comunicazione quantica cinese noto come Micius nome latino del filosofo e scienziato Mozi vissuto al tempo degli stati combattenti. Questa sperimentazioni ci dicono che l’applicazione alla rete non dovrebbe essere poi molto lontana.
Leggi tutto
Francesco Raparelli: L’intelletto o ciò che sta fuori
L’intelletto o ciò che sta fuori
di Francesco Raparelli
In un bel saggio, “Averroè l’inquietante. L’Europa e il pensiero arabo”, appena pubblicato in Italia da Carocci, Jean-Baptiste Brenet rilegge le tesi maledette del Commentator attraverso Freud e la sua nozione di ‘perturbante’. Un esperimento teorico avvincente e fecondo
Un fatto e un’immagine. Cominciamo dal primo: condannate dal vescovo di Parigi le sue posizioni filosofiche (1270; 1277), Sigieri di Brabante avrà vita difficile. Pur lasciando l’insegnamento, e Parigi, una coltellata lo finisce a Orvieto. La colpa? Aver rilanciato, nel centro dell’Europa cristiana, l’aristotelismo dell’arabo Averroè – di Cordova, europeo e straniero nello stesso tempo. L’immagine. Firenze, Basilica di Santa Maria Novella: nell’affresco di Andrea di Bonaiuto, Tommaso con i piedi schiaccia gli eretici sconfitti; tra questi, Averroè. La cristianità lo vuole sconfitto, pensando al De unitate intellectus – dal domenicano redatto nel 1270. Eppure è un rimosso, familiare quanto estraneo, che non smette di riprendersi la scena.
Averroè l’inquietante: così il titolo di un saggio, breve ma folgorante, di Jean-Baptiste Brenet, appena edito in Italia (Carocci, 12 euro). Al pari di un reagente chimico, il noto scritto di Freud del 1919, Il perturbante, sostiene Brenet nella rinnovata conquista dell’aristotelismo più indigesto della storia del pensiero europeo: quello del Commentator.
Leggi tutto
Andrea Zhok: Breve aggiunta al post su Bibbiano
Breve aggiunta al post su Bibbiano
di Andrea Zhok
Con poche eccezioni, la discussione seguita al post precedente è stata molto interessante e personalmente istruttiva.
Alla luce di alcune informazioni che ignoravo, che mi sono state gentilmente segnalate, e di cui riporto gli estremi più sotto, credo sia opportuno aggiungere questa considerazione.
Anche dopo tali informazioni, il senso del post rimane quello che intendeva essere e ne rivendico integralmente i contenuti, e precisamente:
1) non credo affatto che ci sia una 'congiura ideologica del PD' dietro ai fatti di Bibbiano;
2) credo che la strumentalizzazione politica e l'eco mediatica non sarebbero state le stesse senza il coinvolgimento di politici del PD;
3) credo che la questione di gran lunga più importante da affontare in questo paese sia l'aiuto alle famiglie nel loro complesso, aiuti che implicano una riflessione su come vogliamo che crescano i nostri figli, che domani non saranno solo 'figli delle loro famiglie', ma 'figli di tutti', concittadini.
Detto questo, da quanto è emerso, credo si debba aggiungere, su un piano differente, quanto segue:
Il caso di Bibbiano, se usato non per fare polemica politica spicciola, ma per focalizzare su un macroscopico problema relativo agli affidi forzosi, può essere utile. E' importante però uscire dalla logica della 'congiura di indole politica', che finisce solo per offuscare il problema, creando i soliti blocchi contrapposti che lasciano tutto come prima.
Leggi tutto
Hits 4100
Hits 2546
Hits 2001
Hits 1845
Hits 1773
Hits 1727
Hits 1725
Hits 1688
Hits 1664
Hits 1616
tonino

Fernanda Mazzoli: Autonomia differenziata e dissoluzione dell’unità nazionale: ce lo chiede l’Europa?
Autonomia differenziata e dissoluzione dell’unità nazionale: ce lo chiede l’Europa?
di Fernanda Mazzoli
 Dietro le apparenze,
l’autonomia differenziata sembra essere parte di un più
generale
processo di costruzione di una Europa (e di un’Italia) “a due
velocità”. Le regioni italiane con il Pil più elevato
vogliono competere alla pari con le regioni più ricche e
produttive d’Europa, senza quei lacci e lacciuoli che un
ordinamento unitario
potrebbe far valere (contratti collettivi di lavoro, tutela
paesaggistica, valore legale del titolo di studio, per citarne
alcuni), disponendo,
inoltre, di risorse più elevate, grazie al trattenimento in
loco di una parte consistente del gettito fiscale. In Francia,
una recente riforma
ha ridotto il numero delle regioni da 22 a 13. Le regioni
troppo piccole o poco popolate avevano bisogno di raggungere
“una dimensione adeguata
alle sfide economiche e di mobilità”, tale da consentire “di
competere con le collettività simili in Europa“. Fra tali
collettività regionali si citano la Catalogna, la Baviera e,
guarda caso, la Lombardia. Al di là delle indubbie e anche
notevoli
differenze, riforma regionale francese ed autonomia
differenziata compongono un quadro sostanzialmente unitario.
Chi legga con attenzione le bozze di
intesa dell’autonomia differenziata trova ben pochi
riferimenti di tipo identitario e molta governance, efficienza
amministrativa, crescita
economica, sinergia con le imprese, promozione
dell’innovazione. Il dibattito sull’impatto potenzialmente
devastante di una
regionalizzazione di sanità, scuola e ricerca ha posto in
secondo piano questo punto, il quale ci offre, in realtà, la
chiave di volta
di tutto l’edificio. A ben vedere, anche la gestione
dell’istruzione e della ricerca risponde alla necessità di
formare manodopera
per le aziende del territorio. In questa corsa spietata,
l’Italia è percepita dalle regioni ricche come un carrozzone
troppo lento ed
ammaccato, per riuscire a tenere il passo con i bolidi del
Nord Europa, loro naturale punto di riferimento. Il resto è
folklore, una caramella
dal gusto vagamente dolciastro ad uso e consumo (anche
elettorale) dei nostalgici dei dialetti e dei sapori perduti.
Dietro le apparenze,
l’autonomia differenziata sembra essere parte di un più
generale
processo di costruzione di una Europa (e di un’Italia) “a due
velocità”. Le regioni italiane con il Pil più elevato
vogliono competere alla pari con le regioni più ricche e
produttive d’Europa, senza quei lacci e lacciuoli che un
ordinamento unitario
potrebbe far valere (contratti collettivi di lavoro, tutela
paesaggistica, valore legale del titolo di studio, per citarne
alcuni), disponendo,
inoltre, di risorse più elevate, grazie al trattenimento in
loco di una parte consistente del gettito fiscale. In Francia,
una recente riforma
ha ridotto il numero delle regioni da 22 a 13. Le regioni
troppo piccole o poco popolate avevano bisogno di raggungere
“una dimensione adeguata
alle sfide economiche e di mobilità”, tale da consentire “di
competere con le collettività simili in Europa“. Fra tali
collettività regionali si citano la Catalogna, la Baviera e,
guarda caso, la Lombardia. Al di là delle indubbie e anche
notevoli
differenze, riforma regionale francese ed autonomia
differenziata compongono un quadro sostanzialmente unitario.
Chi legga con attenzione le bozze di
intesa dell’autonomia differenziata trova ben pochi
riferimenti di tipo identitario e molta governance, efficienza
amministrativa, crescita
economica, sinergia con le imprese, promozione
dell’innovazione. Il dibattito sull’impatto potenzialmente
devastante di una
regionalizzazione di sanità, scuola e ricerca ha posto in
secondo piano questo punto, il quale ci offre, in realtà, la
chiave di volta
di tutto l’edificio. A ben vedere, anche la gestione
dell’istruzione e della ricerca risponde alla necessità di
formare manodopera
per le aziende del territorio. In questa corsa spietata,
l’Italia è percepita dalle regioni ricche come un carrozzone
troppo lento ed
ammaccato, per riuscire a tenere il passo con i bolidi del
Nord Europa, loro naturale punto di riferimento. Il resto è
folklore, una caramella
dal gusto vagamente dolciastro ad uso e consumo (anche
elettorale) dei nostalgici dei dialetti e dei sapori perduti.
Per comprendere in tutta la loro complessità – ragioni di fondo e razionalità generale che le ispira- le dinamiche sottese all’autonomia differenziata e gli effetti che potrebbero derivare da una sua realizzazione, è necessario allontanarsi dai confini nazionali ed aprirsi su uno scenario europeo.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Democrazia sostanziale e formale
![]()
Democrazia sostanziale e formale
di Pierluigi Fagan
Questo post sarebbe riservato ad un dialogo di approfondimento con due miei contatti ( Vincenzo Cucinottae Gabriele Pastrello col quale mi scuso per il carattere minuscolo) ma poiché contiene opinioni di valore più generale, da commento diventa post. Se non siete interessati alla teorizzazione politica, evitatelo è molto lungo e molto palloso
 In una precedente
discussione, ci si imbatteva nella differenza tra formale e
sostanziale a proposito della democrazia, ma
la distinzione non era chiara, vedrò quindi di chiarirla.
Innanzitutto per intenderci reciprocamente, debbo ancorare
il punto di vista di
partenza o quantomeno chiarirlo. Chi scrive aderisce ad una
ideologia democratica. L’ideologia democratica sembra molto
popolare ma
c’è un profondo disguido sulla questione, non è
probabilmente quella che pensate di conoscere voi.
In una precedente
discussione, ci si imbatteva nella differenza tra formale e
sostanziale a proposito della democrazia, ma
la distinzione non era chiara, vedrò quindi di chiarirla.
Innanzitutto per intenderci reciprocamente, debbo ancorare
il punto di vista di
partenza o quantomeno chiarirlo. Chi scrive aderisce ad una
ideologia democratica. L’ideologia democratica sembra molto
popolare ma
c’è un profondo disguido sulla questione, non è
probabilmente quella che pensate di conoscere voi.
Ideologia democratica ha ben poca teorizzazione di base. Compare inizialmente nelle Storie di Erodoto, se ne dà qualche specifica in Politica di Aristotele, se ne dà versione critica negativa nella Costituzione degli Ateniesi (versione c.d. Anonimo Oligarca o Pseudo Senofonte), viene sistematicamente massacrata da Platone, teorico massimo di ogni forma piramidale gerarchica, dalla metafisica in giù. Scompare dai radar della teoria politica lungo tutto il periodo romano e medioevale. Nel primo moderno ci sarebbero i diggers ed i levellers della Guerra Civile inglese di metà XVII secolo ma non scrivevano le loro idee. Per altro vennero tutti fisicamente massacrati da Cromwell delle cui truppe facevano parte. Ricompare sostanzialmente con J.J.Rousseau, seguito da qualche fazione dei moti pre e durante la Rivoluzione francese (giacobini-montagnardi, socialisti detti da Marx “utopisti”, anarchici della Comune del 1871). Ha qualche ripresa più recente ma non possiamo qui entrare nel merito.
Nel periodo moderno sostanzialmente scompare, sostituita da una forma giustificata teoricamente da B. Constant nel 1819 che titola: “La libertà degli antichi comparata alla libertà dei moderni”, corroborato poi da J. Stuart Mill (liberale, inglese). Constant era un liberale franco-svizzero e la sua comparazione muove dai principi teorici di Rousseau, dicendo però che -ovviamente- negli stati moderni composti da milioni di persone, non si poteva certo fare la “democrazia diretta” tipo Atene o Ginevra, bisognava passare a quella rappresentativa entro ovviamente lo stato moderno liberale à la Montesquieu con tripartizione dei poteri etc. etc. Constant chiama “libertà” la democrazia, facendo il verso a Rousseau che ironizzava sulla forma rappresentativa liberale che presupponeva di dare libertà di partecipazione al processo politico ai cittadini, “una volta ogni quattro anni” (riferendosi a gli inglesi).
Leggi tutto
Pasquale Cicalese: Gli effetti della deflazione salariale tedesca sull’Eurozona. Il caso della Francia
Gli effetti della deflazione salariale tedesca sull’Eurozona. Il caso della Francia
di Pasquale Cicalese
Come i lettori sanno, la posizione finanziaria estera netta italiana, vale a dire differenza tra attivi e passivi finanziari, della bilancia commerciale, di investimenti di portafoglio e investimenti esteri fisici, in Italia è passata dal 2013 ad aggi da -410 mliardi del 2013 a -45 miliardi del primo trimestre del 2019, il 2,6% del pil, grazie ai notevoli surplus commerciali e delle partite correnti di questi anni, a costi sociali altissimi.
Sapete pure che la Spagna ha un passivo della posizione finanziaria estera netta pari all’81% del pil. In pratica quel paese cresce grazie ai fondi esteri ed è totalmente dipendente, avendo perso qualsiasi sovranità, come tutti i Pigs, monetaria ma anche, e qui sta la differenza, economica; tant’è che è una filiazione diretta tedesca.
Veniamo all’altro paese cardine dell’asse franco-tedesco, la Francia. Ebbene, visto che detta legge, come sta messo questo paese? Partiamo dal 2005. Perché? Guarda caso in quell’anno si hanno i primi effetti deflazionistici delle leggi Hartz Iv, la riforma del mercato del lavoro tedesca che inaugurò l’epoca dei minijob, a tal punto che oggi coprono una platea di 8 milioni di persone.
In quell’anno la Francia aveva una posizione finanziaria estera netta pari a -34 miliardi di euro, un niente sul pil. Tra il 2000 e il 2017 il passivo commerciale della Francia rispetto alla Germania, cumulato, ha raggiunto la strabiliante cifra di 521 miliardi di euro, il doppio del passivo italiano dello stesso periodo, 228, con la differenza che negli ultimi anni il passivo italiano nei confronti dei tedeschi sta diminuendo, quella francese aumenta (fonte: Guido Salerno Aletta, L’abbraccio del boa, Teleborsa).
Leggi tutto
Elisabetta Teghil: Quando manca l’analisi politica
Quando manca l’analisi politica
Dall’‘affido condiviso’ al Ddl Pillon
di Elisabetta Teghil
Il disegno di legge Pillon è solo l’ultimo atto di un lungo percorso iniziato una decina di anni fa che ha mirato passo dopo passo a far completamente perdere la comprensione di cosa sia il patriarcato, di quali siano le modalità di oppressione della donna in questa società, di quale sia la struttura dell’oppressione di genere.
Negli anni ’70, sotto la spinta dei movimenti, del movimento femminista in particolare ma non solo perché l’analisi di quali siano i meccanismi di asservimento del genere femminile è un’analisi che non può assolutamente prescindere dalla comprensione di come funzioni la società nel suo complesso, era stato riconosciuto che le donne erano sì socialmente e giuridicamente soggetto svantaggiato in tutti i sensi, ma che questo era dovuto ad una precisa scelta strutturale che le voleva in una condizione subalterna a tutto campo. Qualunque problema si affrontasse, quindi, non si poteva prescindere da questa valutazione di fondo. Era stata varata, così, una legislazione di tutela sia nelle separazioni che nell’affidamento dei figli. Tutela che non era dovuta alla sensibilità delle istituzioni bensì ai rapporti di forza modificati dalle lotte. Questo tipo di impostazione man mano è mutata sotto la spinta del cambiamento in senso neoliberista della società. Il rapporto di forza si era di nuovo modificato con uno sbilanciamento molto pesante in favore delle classi dominanti.
Leggi tutto
No Muos: Crisi e tendenza alla guerra
Crisi e tendenza alla guerra
di No Muos
Condividiamo questo testo scritto dai compagni No Muos
La guerra negli ultimi anni sta diventando una realtà concreta. Una guerra che rischia di svilupparsi su scala globale, come alcuni osservatori stanno notando, e che potrebbe coinvolgere diversi attori della scena internazionale. Molti fattori ci indicano come la tendenza a una guerra globale si stia facendo sempre più marcata e ormai, con cadenza quasi mensile, si verificano incidenti diplomatico-militari che rischiano di diventare dei casus belli da cui fare partire il tutto. Tra questi indicatori il più evidente è l’incremento della spesa militare a livello mondiale. Se, come è sempre stato storicamente, le guerre si preparano e non scoppiano all’improvviso, allora è conseguenziale pensare che gli attori globali si stiano preparando a questa eventualità, rendendosi responsabili di attentati all’ambiente, delle attuali e future emigrazioni forzate e, infine, dell’arricchimento dei signori internazionali della guerra, vere e proprie mafie globali.
La rincorsa agli armamenti ha conosciuto delle notevoli trasformazioni dall’89 in poi. Non siamo più di fronte a un mondo bipolare che usa lo strumento della militarizzazione anche come forma di deterrenza reciproca. Gli attori in competizione sono aumentati, è venuta meno quella configurazione geopolitica mondiale che ha caratterizzato la seconda metà del ‘900, e la competizione globale conosciuta prima come “globalizzazione”, con una forte guida USA, adesso si sta trasformando in una nuova competizione tra potenze imperialiste e subimperialiste o aspiranti tali.
Leggi tutto
Carlo Bertani: Lasciateli governare...
Lasciateli governare...
di Carlo Bertani
Mi pare chiaro che la vicenda TAV sarà la fine di questo governo, perché una cosa del genere è la fine del M5S, ma va bene così. Non si poteva fare molto per l’Italsider e per la TAP, ma per la TAV sì, ed hanno calato le braghe. Salvini esulta, e mi chiedo il perché: non ha capito che questo atto è il de profundis del Governo?
La votazione in Parlamento sarà all’insegna di fischi, frizzi, motteggi e male parole, da una parte e dall’altra – perché anche i media devono magnare – ma l’esito è scontato, perché i “Sì” TAV sono l’accozzaglia dei dipendenti degli (im)prenditori italioti, che si solluccherano all’idea della pioggia di miliardi: PD, FI, Lega e FdI uniti nella lotta per le poltrone che contano, che rendono. Come ha detto Arata, intercettato dalla Guardia di Finanza, “I politici li devi pagare”.
Il bello verrà dopo.
Fatto salvo che un ritorno alle urne non è possibile fino alla prossima Primavera (fate, da bravi, due conticini con la legge elettorale, ed aggiungeteci pure cosa pensa Mattarella sull’andare a votare sotto Finanziaria), la soluzione sarà nel veleggiare in bonaccia, la cosiddetta “normale amministrazione”, che in Belgio è andata avanti per anni, poiché valloni e fiamminghi non ne volevano sapere.
Salvini andrà avanti ritenendo, oramai, d’esser lui il Presidente del Consiglio, mentre Conte diverrà una silfide dai passaggi un po’ retorici, un poco futuristi, per niente convincenti: perché, quando un premier accetta un mandato che viene dall’estero – e se lo fa andar bene – deve dimenticare d’essere un sovranista. Come Salvini, che oggi invece lo è: un sovranista europeo e francese.
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: 5 stelle nel buco nero
5 stelle nel buco nero
di Fulvio Grimaldi
La Storia in farsa: Di Maio, l’Occhetto del MoVimento, Conte, il suo Napolitano
 Quos vult Iupiter perdere,
dementat prius (A coloro che vuole
rovinare, Giove toglie prima la ragione)
Quos vult Iupiter perdere,
dementat prius (A coloro che vuole
rovinare, Giove toglie prima la ragione)
“Come può un movimento proseguire nella sua azione di cambiamento della Cosa Pubblica? Necessariamente attraverso un continuo attacco al pericolo numero uno della collettività: il pensiero dominante, la forma di fascismo più pericolosa del XXI secolo”. (Alessandro Di Battista, “Politicamente Scorretto”, edizioni Paper First)
Prima del diluvio
Si stava al fresco, iniziando, con l’aiuto di Speck, succhi di mela, automobilisti rispettosi, gerani ai balconi, gente senza cellulari sui sentieri, abeti rossi e praterie di trifoglio, l’adattamento al salto dai consuetudinari 380 metri ai quasi 2000. Arrivavano, dalla bottega alimentare che mi consegnava la mazzetta dei giornali, le solite notizie appassionanti confezionate dalle eccellenze del giornalismo nostrano traendone i materiali da territori tra il deserto, la palude e i letamai. Grazie alle ottime condizioni ambientali, spirito e corpo riuscivano a tenergli testa.
Statunitensi, ammattiti per gli scacchi di Venezuela e Siria, che sbattevano furiose sciabole su tonitruanti scudi in mezzo al Golfo; Elisabetta Due che, in ansia competitiva con l’omonima numero Uno, rilanciava pirati alla Drake contro petroliere da razziare; eletti europei che, in cambio di guiderdoni, cavolini di Bruxelles e foie gras di Strasburgo (da oche inchiodate quanto loro al patibolo della libertà), si prestavano a formare un “parlamento” che era tale come Salvini è Bismarck; l’inestinguibile flusso di zozzerie, volgarità, malandrinate e imbecillità Lega e PD che continuava a scorrere ai piedi degli italiani fermi e impassibili sulla sponda del fiume (mai un cadavere); i tg nazionali che al confronto di quelli tedeschi, francesi, russi, nigeriani (pure disponibili nel maso) parevano Sfera Ebbasta contro Aretha Franklin, tanto che ci si riprendeva solo alla vista del canale provinciale con i suoi jodel e i suoi caduti dalla bicicletta.
Leggi tutto
Mauro Pasquinelli: Per una critica del populismo
Per una critica del populismo
di Mauro Pasquinelli
Non sono poche le occasioni in cui SOLLEVAZIONE ha ospitato riflessioni sulla questione del "populismo". Anni addietro, non solo noi, promuovemmo sul tema convegni di studio. Una categoria politica, quella del "populismo", polisemica e insidiosa quant'altre mai. Il terremoto elettorale del 4 marzo 2018, l'avvento al potere di due formazioni considerate populiste, il fatto dunque che l'Italia diventa il principale laboratorio politico europeo, obbliga a tornare sul punto ed a riaprire la discussione. Iniziamo con questo contributo. Inutile ricordare che pubblicare un contributo non significa che la redazione lo condivida. Il dibattito proseguirà
 Populismi senza
popolo, popoli senza socialismo
Populismi senza
popolo, popoli senza socialismo
Ai tempi di Marx l’opposizione destra-sinistra non esisteva ma si presentava nelle vesti di alternativa tra Monarchia o Repubblica democratico-borghese. Non diverso era ai tempi di Lenin, dove destra significava fascismo, bonapartismo, reazione, militarismo e sinistra socialdemocrazia, democrazia, riformismo, pacifismo. Mai, tuttavia, abbiamo visto dirigenti o teorici del socialismo, tranne quelli di matrice riformista, posizionarsi nel secondo campo delle opzioni della classe dominante. Dal terzo campo rivoluzionario, si poteva al massimo fornire un appoggio tattico al secondo campo per porre un argine o battere l’ipotesi del primo, quella più autoritaria.
Al dualismo storico destra sinistra nel campo delle opzioni borghesi, che data dall’affare Dreyfus (1894) oggi si aggiunge, o forse si sostituisce, quello tra popolo ed élite, per la precisione tra populismo e globalismo, sovranismo e cosmopolitismo.
Cercherò di dimostrare perché il populismo non è un alternativa vera al cosmopolitismo, come la sinistra non lo è mai stata alla destra.
Queste riflessioni vogliono essere un invito alla discussione sul tema del populismo all’interno dellasinistra patriottica, per una ridefinizione del suo posizionamento tattico e strategico, che tutt’ora, ahimè, staziona all’interno del secondo campo populista, presidiato in Occidente da forze politiche per lo più xenofobe e rozzo-brune.
Lancio subito una provocazione concettuale che sarà più chiara dopo aver letto questo breve saggio, e che a me serve per renderlo più appetitoso: il populismo agisce in nome del popolo. Il socialista agisce per il popolo e con il popolo. Questione di preposizioni? No questioni di sostanza e lo vedremo alla fine.
“L’emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi” scriveva Marx in esergo al proclama di fondazione della Prima internazionale. Ed aveva ragione: il socialismo è la prima forma sociale, nella storia dell’umanità che per essere realizzata richiede il protagonismo e la partecipazione attiva e permanente della comunità degli uomini.
Leggi tutto
Stefano Laffi: La cultura come oppio del popolo
La cultura come oppio del popolo
Storia di una resa secondo Goffredo Fofi
di Stefano Laffi
Quando Karl Marx formula quella famosa definizione della religione non vuol fare l’anticristo, intende piuttosto denunciare una condizione di oppressione del popolo di cui la religione sarebbe il farmaco, inventato dall’uomo per lenire il proprio stato di infelicità: il grido di Marx contro la religione è per riportare la lotta in vista di quella felicità nel mondo reale, non nell’Aldilà.
Da allora però il mondo è cambiato parecchio, il capitale ha certamente vinto e ha incorporato l’illusione di felicità nel qui ed ora, cioè nel consumo, nell’abbondanza di merci che regalano a chi ha i mezzi la fantasia del Paradiso in Terra. E, per dirla con Luciano Gallino citato nel testo di Fofi, oggi gli unici rimasti a fare la lotta di classe sono i ricchi, contro i poveri.
Goffredo Fofi, nato nel ’37 e cresciuto fra i contadini umbri, da instancabile critico culturale, giornalista, direttore di riviste, agitatore di gruppi resistenti sparsi per l’Italia ha assistito alla grande mutazione di questo Paese: ha visto una civiltà agraria diventare prima industriale e poi terziaria, fino a illudere oggi i suoi giovani che si possa tutti vivere di arte; ha partecipato a lotte e movimenti delle minoranze oppresse, poi sconfitte o “recuperate” dal potere nelle loro istanze più vitali; ha visto gli intellettuali passare da guide spirituali a personaggi televisivi; ha conosciuto una scuola e una cultura capaci di riscattare un’intera popolazione prima di cadere nel declino attuale.
Leggi tutto
Manlio Dinucci: In Ucraina vivaio Nato di neonazisti
In Ucraina vivaio Nato di neonazisti
di Manlio Dinucci
Proseguono le indagini sui moderni arsenali scoperti in Piemonte, Lombardia e Toscana, di chiara matrice neonazista come dimostrano le croci uncinate e le citazioni di Hitler trovate insieme alle armi. Resta però senza risposta la domanda: si tratta di qualche nostalgico del nazismo, collezionista di armi, oppure siamo di fronte a qualcosa di ben più pericoloso? Gli inquirenti – riferisce il Corriere della Sera – hanno indagato su «estremisti di destra vicini al battaglione Azov», ma non hanno scoperto «nulla di utile». Eppure vi sono da anni ampie e documentate prove sul ruolo di questa e altre formazioni armate ucraine, composte da neonazisti addestrati e impiegati nel putsch di piazza Maidan nel 2014 sotto regia Usa/Nato e nell’attacco ai russi di Ucraina nel Donbass.
Va chiarito anzitutto che l’Azov non è più un battaglione (come lo definisce il Corriere) di tipo paramilitare, ma è stato tasformato in reggimento, ossia in unità militare regolare di livello superiore.
Il battaglione Azov venne fondato nel maggio 2014 da Andriy Biletsky, noto come il «Führer bianco» in quanto sostenitore della «purezza razziale della nazione ucraina, impedendo che i suoi geni si mischino con quelli di razze inferiori», svolgendo così «la sua missione storica di guida della Razza Bianca globale nella sua crociata finale per la sopravvivenza».
Per il battaglione Azov Biletsky reclutò militanti neonazisti già sotto il suo comando quale capo delle operazioni speciali di Pravy Sektor. L’Azov si distinse subito per la sua ferocia negli attacchi alle popolazioni russe di Ucraina, in particolare a Mariupol.
Leggi tutto
Notav: La stessa cricca
La stessa cricca
di Notav
Quanto accade intorno alla Tav in Val Susa conferma che i due Matteo, Salvini e Renzi, sono della stessa pasta, “amici del partito del tondino e del cemento – come scrivono i No Tav – foriero di voti e sostegno politico nelle loro scalate ai vertici del potere…”. Ma mostra anche ciò che per i media mainstream resta un mistero: malgrado mistificazioni e tentativi di indebolirli, i No Tav sono ancora lì, con un movimento intergenerazionale e in forte risonanza con molti altri movimenti territoriali. Il 25 luglio comincia il Festival ad Alta Felicità: saranno decine di migliaia le persone ad arrivare, dal nord al sud Italia
Sono della stessa pasta, appartengono alla stessa cricca, quella degli amici del partito del tondino e del cemento foriero di voti e sostegno politico nelle loro scalate ai vertici del potere. Questi due tweet recenti e ravvicinati di Matteo Salvini e Matteo Renzi (qualche riga qui sotto) ci restituiscono la sintesi degli ultimi decenni in salsa Si Tav, slogan e dichiarazioni di appartenenza alla classe dei potenti e ai loro interessi.
Da alcuni giorni i media mainstream rimbalzano notizie di denunce e provvedimenti, politicanti in cerca di visibilità e in perenne campagna elettorale auspicano arresti e punizioni esemplari per tutelare e premiare la polizia, la stessa che 18 anni fa uccise Carlo Giuliani e colorò di sangue Genova attraversata da una generazione ricca di speranze e promesse per il futuro.
Leggi tutto
Sergio Farris: 25 luglio 1943: il crepuscolo del Duce
25 luglio 1943: il crepuscolo del Duce
di Sergio Farris
Nella notte fra il 24 e il 25 luglio 1943, il Gran Consiglio del Fascismo votò a maggioranza assoluta un ordine del giorno che imponeva a Benito Mussolini di rimettere i suoi poteri al Re e rinunciare al comando supremo delle forze armate, con la finalità di ripristinare – sotto qualche aspetto – lo Statuto Albertino.
L’avventura bellica dell’Italia, alla quale il Duce aveva opportunisticamente voluto dare inizio nel giugno del 1940, quando le armate dell’alleato tedesco si trovavano ormai alle porte di Parigi, si stava via via rivelando una disfatta. (‘Ho bisogno soltanto di qualche migliaio di morti per potermi sedere da ex-belligerante al tavolo delle trattative‘, aveva detto il 26 maggio 1940).
A El Alamein, il 23 ottobre 1942 era stata definitivamente persa la guerra d’Africa. La ritirata dalla Russia – nel gennaio 1943 – era stata un’ecatombe. Le forze armate degli Alleati angloamericani erano sbarcate in Sicilia il 10 luglio e i bombardamenti delle città andavano crescendo di intensità.
Fra la popolazione, sempre più stremata dalla guerra e dalle ristrettezze economiche, crescevano il malcontento – manifestato anche con scioperi nelle fabbriche di Milano e Torino – ed il distacco nei confronti del Regime. Nonostante il tentativo operato da Mussolini di offrire un mutamento di immagine del Regime con un rinnovamento della compagine di governo, l’insoddisfazione nel paese veniva ormai colta persino nelle gerarchie interne all’apparato fascista. Lo stesso Re, Vittorio Emanuele III, cominciava a divisare piani per tentare di modificare il corso degli eventi.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Hits 2022
Hits 1870
Hits 1785
Hits 1768
Hits 1749
Hits 1679
Hits 1633
Stefano G. Azzarà: Je suis Huawei, il Manifesto è Trump
Hits 1633
Thomas Fazi: Euro: una questione di classe
Hits 1621
tonino

Enrico Grazzini: La Libra di Facebook, il monopolio bancario sulla moneta e le controproposte di riforma
La Libra di Facebook, il monopolio bancario sulla moneta e le controproposte di riforma
di Enrico Grazzini
 Facebook,
il social network con 2,5 miliardi di persone connesse, ha
recentemente annunciato
di volere emettere nel 2020 una nuova moneta
privata globale, la Libra.[1] Si
tratta di un ulteriore e forse decisivo passo in avanti verso
una moneta completamente privatizzata, denazionalizzata,
liberalizzata in mano a
Facebook o ad un altro dei colossi digitali, come Amazon,
Apple, Google e Microsoft.
Facebook,
il social network con 2,5 miliardi di persone connesse, ha
recentemente annunciato
di volere emettere nel 2020 una nuova moneta
privata globale, la Libra.[1] Si
tratta di un ulteriore e forse decisivo passo in avanti verso
una moneta completamente privatizzata, denazionalizzata,
liberalizzata in mano a
Facebook o ad un altro dei colossi digitali, come Amazon,
Apple, Google e Microsoft.
Ovviamente il sistema attuale difende tenacemente le sue prerogative e i suoi privilegi. Da Donald Trump, passando per il governatore della Banca d’Inghilterra Mark Carney fino alla Banca Centrale Europea c'è stata una levata di scudi. "È fuori discussione permettere loro di svilupparsi nel vuoto normativo, perché è semplicemente troppo pericoloso “ha affermato Benoit Coeure dell'Executive Board della BCE” Progetti come quello di Facebook sono però un utile campanello d'allarme per i regolatori e le autorità pubbliche. Dobbiamo muoverci più rapidamente di quanto abbiamo fatto finora". Anche il ministro francese delle finanze Bruno Le Maire ha precedentemente affermato che "è fuori questione" che la Libra sia autorizzata "a diventare una moneta sovrana. Non può e non deve accadere".
In effetti le monete globali potrebbero diffondersi molto più velocemente di quanto a prima vista uno si aspetterebbe. Basti pensare che Facebook si è quotata in borsa solo nel maggio 2012 e oggi raggiunge già 2 miliardi e mezzo di persone. Il dilemma è se il sistema monetario attualmente dominante tenterà di fronteggiare gli sviluppi della moneta digitale arroccandosi in difesa dei suoi privilegi, o se invece l'assetto monetario attuale – che provoca costantemente crisi e che dà alle banche commerciali il privilegio esclusivo di stampare moneta – sarà capace di riformarsi come bene pubblico a favore della società, della democrazia e dell'eguaglianza sociale.
Per ora comunque Mario Draghi, presidente della Banca Centrale Europea, ha già respinto una proposta di riforma della BCE stessa con l'introduzione della moneta digitale. Il Parlamentare europeo Jonás Fernández (del gruppo dell'Alleanza Progressista di Socialisti e Democratici, S&D) ha infatti chiesto se la BCE ritiene valido di introdurre la moneta digitale aprendo ai privati la possibilità di avere dei conti correnti direttamente presso la BCE stessa.
Leggi tutto
Adriano Giannola: Asimmetria e autonomia
Asimmetria e autonomia
Nord-Sud nella proposta di governo, un pericolo per l’Italia
di Adriano Giannola
Adriano Giannola (Università di Napoli “Federico II”, presidente Svimez) analizza il tema delle “intese” sulla Autonomia differenziata tra Governo e regioni a statuto ordinario e svela i meccanismi fiscali sottostanti che mettono in crisi lo stereotipo, cavalcato dalla Lega, che la secessione Nord/Sud gioverebbe alle regioni del Nord
 1. Premessa
1. Premessa
L’attenzione a tematiche urgenti come la “questione Tav” fonte di serie tensioni all’interno della compagine governativa hanno lasciato finora sullo sfondo il tema delle “intese” sulla Autonomia differenziata tra Governo e regioni a statuto ordinario. Il che desta una certa sorpresa se si considera che proprio questo è il solo punto definito “assolutamente prioritario” nel Contratto. Anche l’attenzione della stampa per l’argomento è stato a lungo tiepido e intermittente, spiazzata ogni giorno dalla strategia cara al ministro degli interni di utilizzare armi di distrazione di massa. Proprio per la cura posta a non parlarne fidando, di poter agire con rapidità e senza trovare soverchie resistenze, la questione si è fatta particolarmente preoccupante e va attentamente monitorata. Perciò è utile qualche riflessione sull’ impatto che questoprogetto lombardo-veneto potrà avere per il paese tutto e non solo per la popolazione del Mezzogiorno.
Le diverse bozze di intesa scaturite finora da una trattativa accuratamente riservata che nelle intenzioni doveva restare segreta hanno il tratto comune, ossessivamente reiterato, di fare cassa imponendo il principio che il finanziamento standard delle nuove funzioni non sia correlato al loro costo bensì al gettito (“capacità fiscale”) della regione. Si insiste con una disinvoltura che pretenderebbe di essere sofisticata e che al contrario è progressivamente esercizio di artificiose acrobazie logiche basate sul curioso principio-privilegio in base al quale a identici servizi erogati corrispondono fabbisogni standard tanto più elevati quanto maggiore è la capacità fiscale di un territorio. In sostanza le regioni che producono più reddito e pagano più tasse dovrebbero ricevere a copertura di identici servizi maggiori risorse delle regioni più povere. Si tratta di un insulto alla logica ancor prima che al dettato della Costituzione che con chiarezza stabilisce che ogni cittadino debba pagare le tasse in base al reddito e ricevere i servizi indipendentemente dal dove risiede.
E’ comprensibile che la Lega confermi, al di là delle apparenze, la sua vera natura di partito del Nord, sorprende invece l’acritico sostegno fornito fino ad ora -anche se con qualche distinguo ed imbarazzo- dal Movimento 5 stelle.
Leggi tutto
Michael Hudson: La dedollarizzazione dell’impero finanziario americano
La dedollarizzazione dell’impero finanziario americano
Bonnie Faulkner intervista Michael Hudson
Abbiamo tradotto per voi questa interessantissima intervista all’economista americano Michael Hudson. Nonostante la lunghezza, ne consigliamo la lettura, in quanto ci aiuta a comprendere in modo molto chiaro come l’uso del dollaro e dei bond americani nel mondo sia determinante per la politica internazionale attuale e dei prossimi decenni. Buona lettura
 L’imperialismo è il
conseguimento di qualcosa in cambio di niente. E’ una
strategia per
ottenere il surplus di altri paesi senza svolgere attività
produttive, ma creando un sistema di rendita estrattivo. Un
potere imperialista
obbliga altri paesi a pagare un tributo. Ovvio, l’America
non dice apertamente agli altri paesi “dovete pagarci un
tributo”, come
facevano gli imperatori Romani con le province che
governavano.
L’imperialismo è il
conseguimento di qualcosa in cambio di niente. E’ una
strategia per
ottenere il surplus di altri paesi senza svolgere attività
produttive, ma creando un sistema di rendita estrattivo. Un
potere imperialista
obbliga altri paesi a pagare un tributo. Ovvio, l’America
non dice apertamente agli altri paesi “dovete pagarci un
tributo”, come
facevano gli imperatori Romani con le province che
governavano.
I diplomatici statunitensi insistono semplicemente sul fatto che altri paesi investano gli utili della loro bilancia dei pagamenti e le riserve ufficiali della loro banca centrale in dollari americani, in particolare in titoli del Tesoro americano. Questo sistema di utilizzo dei buoni del tesoro americani trasforma il sistema monetario e finanziario globale in un sistema tributario in favore degli USA. E’ questo che consente agli USA di pagare i costi delle spese militari, incluse le 800 basi militari dislocate in tutto il mondo.
Il tema di oggi è la dedollarizzazione dell’impero finanziario americano.
Il dottor Hudson è un economista finanziario e anche uno storico. E’ presidente dell’Institute for the Study of Long-Term Economic Trend [Studio delle tendenze economiche a lungo termine], è analista finanziario a Wall Street e distinto professore di economia presso l’Università del Missouri, a Kansas City. Fra i suoi libri più recenti troviamo: And Forgive Them Their Debts…Lending [E perdona I loro debiti.., prestando], Foreclosure and Redemption from Bronze Age Finance and Jubilee Year [Preclusione e riscatto dalla finanza dall’età del bronzo al Giubileo], Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Destroy the Global Economy [Uccidere l’ospite, come i parassiti della finanza e il debito distruggono l’economia globale]; e J is for Junk Economics: A Guide to Reality in an Age of Deception [J come “junk economy” (economia spazzatura), una guida alla realtà in un’era dell’inganno].
Torniamo oggi su una discussione dell’importante libro del 1972 del dottor Hudson, Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire [Super imperialismo: la strategia economica dell’impero americano], una critica del modo in cui gli Stati Uniti sfruttano le economie straniere attraverso il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale.
Leggi tutto
Giovanna Baer: Fra Stato e Mercato. L'ossimoro cinese
Fra Stato e Mercato. L'ossimoro cinese
di Giovanna Baer
 Fondata nel
1949 come Paese socialista, la Repubblica Popolare Cinese ha
adottato in
seguito, a partire dalle riforme economiche del 1978, un
approccio ‘capitalista’ sui generis, che l’ha trasformata
nella seconda
economia mondiale e che le permetterà con ogni probabilità di
strappare la leadership agli Stati Uniti entro la fine del
secolo.
Qualunque mutamento della politica economica cinese ha ormai
implicazioni globali. Il progetto denominato “Made in China
2025”, un
ambizioso programma elaborato e gestito da Pechino per
trasformare la Cina nel principale leader tecnologico
mondiale, costituisce di fatto non solo
una sfida globale per le economie di mercato, ma soprattutto
il primo tentativo di esportazione del sistema economico
cinese. Da qui le tensioni fra
la Cina e il suo partner commerciale più importante, ma anche
il suo principale concorrente: gli Stati Uniti d’America.
Fondata nel
1949 come Paese socialista, la Repubblica Popolare Cinese ha
adottato in
seguito, a partire dalle riforme economiche del 1978, un
approccio ‘capitalista’ sui generis, che l’ha trasformata
nella seconda
economia mondiale e che le permetterà con ogni probabilità di
strappare la leadership agli Stati Uniti entro la fine del
secolo.
Qualunque mutamento della politica economica cinese ha ormai
implicazioni globali. Il progetto denominato “Made in China
2025”, un
ambizioso programma elaborato e gestito da Pechino per
trasformare la Cina nel principale leader tecnologico
mondiale, costituisce di fatto non solo
una sfida globale per le economie di mercato, ma soprattutto
il primo tentativo di esportazione del sistema economico
cinese. Da qui le tensioni fra
la Cina e il suo partner commerciale più importante, ma anche
il suo principale concorrente: gli Stati Uniti d’America.
L’ultima volta che due sistemi economici incompatibili e in competizione fra loro si sono fronteggiati – erano i tempi della guerra fredda – ogni lato ha eretto dei muri. Ma, oltre alla vendita occasionale di alcuni articoli di consumo (è il caso della Pepsi in Russia), c’erano pochissimi scambi o investimenti tra le nazioni basate sul libero mercato e le nazioni comuniste. Al contrario, l’adesione della Cina alla WTO (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) nel 2001 è stata caldamente sostenuta dagli Stati capitalisti, nella speranza che l’appartenenza a un’organizzazione con regole comuni e condivise di matrice occidentale conducesse Pechino a compiere i passi necessari affinché la Repubblica Popolare diventasse una vera e propria economia di mercato. Secondo l’allora presidente della WTO, Supachai Panitchpakdi, la richiesta testimoniava “la volontà della Cina di giocare secondo le regole del commercio internazionale e di portare il suo apparato governativo spesso opaco e ingombrante in armonia con un ordine mondiale che richiede chiarezza ed equità”. Ciò non è accaduto, e fra gli impegni cinesi in seno alla WTO e le sue effettive pratiche commerciali ed economiche il divario è rimasto eclatante (1), con il risultato che in un’economia globale profondamente integrata, oggi coesistono – per ora pacificamente – due sistemi molto diversi.
Leggi tutto
Thomas Fazi: Sulle origini fasciste dell'UE
Sulle origini fasciste dell'UE
di Thomas Fazi
 Oggi, in seguito alla nomina di Boris Johnson a
nuovo primo ministro britannico,
molti stanno riprendendo una sua celebre intervista del 2016
in cui affermò che l'Unione europea sta perseguendo un
obiettivo simile a quello
di Hitler nella creazione di un sovrastato europeo.
Oggi, in seguito alla nomina di Boris Johnson a
nuovo primo ministro britannico,
molti stanno riprendendo una sua celebre intervista del 2016
in cui affermò che l'Unione europea sta perseguendo un
obiettivo simile a quello
di Hitler nella creazione di un sovrastato europeo.
Detta così, può sembrare un'assurdità.
In verità, come spiego in Sovranità o barbarie, l'affermazione di Johnson non è così lontana dalla realtà.
È opinione comune che il moderno pensiero federalista nasca dalle ceneri della seconda guerra mondiale. Ma le teorie federaliste risalgono a ben prima del conflitto mondiale e persino lo stesso federalismo “antifascista” di Spinelli presenta inquietanti elementi di contiguità con le teorie che ispirarono quel conflitto e in antitesi alle quali, secondo la vulgata, si sarebbe sviluppato il pensiero federalista.
L’ideologia europeista, antisovranista e sovranazionalista – e il sogno dell’unificazione economico-politica del continente – erano infatti aspetti centrali della stessa filosofia nazifascista, nelle sue molteplici varianti, nonché della propaganda hitleriana.
Come scrive lo storico inglese John Laughland, autore di un corposo volume sul tema, “non solo i nazisti, ma anche i fascisti e i loro collaboratori in giro per l’Europa, hanno fatto ampio uso dell’ideologia federalista ed europeista per giustificare le loro aggressioni”. Ciò potrebbe meravigliare. È opinione comune, infatti, che i nazifascisti, in quanto ultrasciovinisti e imperialisti, esaltassero lo Stato-nazione e la sovranità nazionale; in verità, osserva Laughland, “essi nutrivano una profonda avversione per la sovranità nazionale; non solo, come può sembrare ovvio, per quella delle altre nazioni, ma per il concetto stesso”.
Il rifiuto della sovranità nazionale è molto esplicito nel pensiero nazifascista; fatto ancor più interessante, tale rifiuto si fondava sulle stesse argomentazioni dei federalisti odierni. Uno dei principali punti in comune dell’europeismo nazifascista tanto con l’europeismo spinelliano quanto con quello odierno era l’idea secondo cui gli Stati-nazione conducono inevitabilmente alla guerra e che dunque la presenza di una moltitudine di “piccole patrie” sul continente europeo fosse un elemento foriero di instabilità.
Leggi tutto
Sabato Danzilli: Non è lavoro, è sfruttamento: il lavoro all’epoca della gig economy
![]()
Non è lavoro, è sfruttamento: il lavoro all’epoca della gig economy
di Sabato Danzilli
 Il libro di Marta Fana
Non è lavoro, è sfruttamento unisce il rigore
dell’analisi
all’efficacia polemica, ed è uno strumento molto utile sia per
un ragionamento sul mondo del lavoro attuale sia per la
militanza
politica. Fana ricostruisce in maniera rigorosa la storia
impietosa dell’attacco ai diritti sociali, avvenuto con
violenza sempre maggiore negli
ultimi decenni. Nel testo si prende in esame il vasto mondo
del precariato perché, come dimostrato con notevole forza nel
testo, studiare
quanto avvenuto al lavoro precario significa studiare
l’“avanguardia” dello sfruttamento. La cronologia dei colpi
sferrati negli
ultimi decenni ai diritti sociali duramente conquistati è,
infatti, la piena dimostrazione di una tendenza graduale verso
la degradazione
sostanziale del lavoro. Studiare il lavoro precario significa
quindi studiare quello che rischia di diventare il mondo del
lavoro nel suo
complesso.
Il libro di Marta Fana
Non è lavoro, è sfruttamento unisce il rigore
dell’analisi
all’efficacia polemica, ed è uno strumento molto utile sia per
un ragionamento sul mondo del lavoro attuale sia per la
militanza
politica. Fana ricostruisce in maniera rigorosa la storia
impietosa dell’attacco ai diritti sociali, avvenuto con
violenza sempre maggiore negli
ultimi decenni. Nel testo si prende in esame il vasto mondo
del precariato perché, come dimostrato con notevole forza nel
testo, studiare
quanto avvenuto al lavoro precario significa studiare
l’“avanguardia” dello sfruttamento. La cronologia dei colpi
sferrati negli
ultimi decenni ai diritti sociali duramente conquistati è,
infatti, la piena dimostrazione di una tendenza graduale verso
la degradazione
sostanziale del lavoro. Studiare il lavoro precario significa
quindi studiare quello che rischia di diventare il mondo del
lavoro nel suo
complesso.
Spesso persino nella sinistra “radicale” il tema assume, invece, un’impostazione caricaturale, differente solo nella fraseologia da quella “pietistica” che si può trovare nei liberal, se mai si occupano del problema. Per quest’ultimi basta infatti limitarsi a denunce di carattere moralistico quando avvengono tragedie sui luoghi di lavoro.
Se ci soffermiamo solo sul lavoro a chiamata e sui voucher rileviamo che essi hanno origine con la riforma Biagi- Maroni del 2003, approvata con la giustificazione di dover regolare prestazioni lavorative di carattere discontinuo o intermittente. In pochi anni i requisiti di disoccupazione o mobilità e i pochi limiti e obblighi per i datori di lavoro al loro utilizzo vengono meno e il lavoro a chiamata viene esteso come possibilità per tutti i lavoratori. Gli ultimi anni hanno visto l’esplosione dei voucher, liberalizzati completamente dal governo Monti nel 2012. Il Jobs Act ha poi ulteriormente aumentato il tetto massimo di reddito annuo percepibile in questo modo. Ricordiamo la grande campagna referendaria della CGIL nel 2017 per l’abolizione dello strumento e come essa fu bloccata con un decreto d’urgenza, che eliminava i voucher per far annullare i referendum, ma poi li reintroduceva dopo un mese, attraverso un mero cambio di denominazione.
Leggi tutto
Fernanda Mazzoli: Autonomia differenziata e dissoluzione dell’unità nazionale: ce lo chiede l’Europa?
Autonomia differenziata e dissoluzione dell’unità nazionale: ce lo chiede l’Europa?
di Fernanda Mazzoli
 Dietro le apparenze,
l’autonomia differenziata sembra essere parte di un più
generale
processo di costruzione di una Europa (e di un’Italia) “a due
velocità”. Le regioni italiane con il Pil più elevato
vogliono competere alla pari con le regioni più ricche e
produttive d’Europa, senza quei lacci e lacciuoli che un
ordinamento unitario
potrebbe far valere (contratti collettivi di lavoro, tutela
paesaggistica, valore legale del titolo di studio, per citarne
alcuni), disponendo,
inoltre, di risorse più elevate, grazie al trattenimento in
loco di una parte consistente del gettito fiscale. In Francia,
una recente riforma
ha ridotto il numero delle regioni da 22 a 13. Le regioni
troppo piccole o poco popolate avevano bisogno di raggungere
“una dimensione adeguata
alle sfide economiche e di mobilità”, tale da consentire “di
competere con le collettività simili in Europa“. Fra tali
collettività regionali si citano la Catalogna, la Baviera e,
guarda caso, la Lombardia. Al di là delle indubbie e anche
notevoli
differenze, riforma regionale francese ed autonomia
differenziata compongono un quadro sostanzialmente unitario.
Chi legga con attenzione le bozze di
intesa dell’autonomia differenziata trova ben pochi
riferimenti di tipo identitario e molta governance, efficienza
amministrativa, crescita
economica, sinergia con le imprese, promozione
dell’innovazione. Il dibattito sull’impatto potenzialmente
devastante di una
regionalizzazione di sanità, scuola e ricerca ha posto in
secondo piano questo punto, il quale ci offre, in realtà, la
chiave di volta
di tutto l’edificio. A ben vedere, anche la gestione
dell’istruzione e della ricerca risponde alla necessità di
formare manodopera
per le aziende del territorio. In questa corsa spietata,
l’Italia è percepita dalle regioni ricche come un carrozzone
troppo lento ed
ammaccato, per riuscire a tenere il passo con i bolidi del
Nord Europa, loro naturale punto di riferimento. Il resto è
folklore, una caramella
dal gusto vagamente dolciastro ad uso e consumo (anche
elettorale) dei nostalgici dei dialetti e dei sapori perduti.
Dietro le apparenze,
l’autonomia differenziata sembra essere parte di un più
generale
processo di costruzione di una Europa (e di un’Italia) “a due
velocità”. Le regioni italiane con il Pil più elevato
vogliono competere alla pari con le regioni più ricche e
produttive d’Europa, senza quei lacci e lacciuoli che un
ordinamento unitario
potrebbe far valere (contratti collettivi di lavoro, tutela
paesaggistica, valore legale del titolo di studio, per citarne
alcuni), disponendo,
inoltre, di risorse più elevate, grazie al trattenimento in
loco di una parte consistente del gettito fiscale. In Francia,
una recente riforma
ha ridotto il numero delle regioni da 22 a 13. Le regioni
troppo piccole o poco popolate avevano bisogno di raggungere
“una dimensione adeguata
alle sfide economiche e di mobilità”, tale da consentire “di
competere con le collettività simili in Europa“. Fra tali
collettività regionali si citano la Catalogna, la Baviera e,
guarda caso, la Lombardia. Al di là delle indubbie e anche
notevoli
differenze, riforma regionale francese ed autonomia
differenziata compongono un quadro sostanzialmente unitario.
Chi legga con attenzione le bozze di
intesa dell’autonomia differenziata trova ben pochi
riferimenti di tipo identitario e molta governance, efficienza
amministrativa, crescita
economica, sinergia con le imprese, promozione
dell’innovazione. Il dibattito sull’impatto potenzialmente
devastante di una
regionalizzazione di sanità, scuola e ricerca ha posto in
secondo piano questo punto, il quale ci offre, in realtà, la
chiave di volta
di tutto l’edificio. A ben vedere, anche la gestione
dell’istruzione e della ricerca risponde alla necessità di
formare manodopera
per le aziende del territorio. In questa corsa spietata,
l’Italia è percepita dalle regioni ricche come un carrozzone
troppo lento ed
ammaccato, per riuscire a tenere il passo con i bolidi del
Nord Europa, loro naturale punto di riferimento. Il resto è
folklore, una caramella
dal gusto vagamente dolciastro ad uso e consumo (anche
elettorale) dei nostalgici dei dialetti e dei sapori perduti.
Per comprendere in tutta la loro complessità – ragioni di fondo e razionalità generale che le ispira- le dinamiche sottese all’autonomia differenziata e gli effetti che potrebbero derivare da una sua realizzazione, è necessario allontanarsi dai confini nazionali ed aprirsi su uno scenario europeo.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Democrazia sostanziale e formale
![]()
Democrazia sostanziale e formale
di Pierluigi Fagan
Questo post sarebbe riservato ad un dialogo di approfondimento con due miei contatti ( Vincenzo Cucinottae Gabriele Pastrello col quale mi scuso per il carattere minuscolo) ma poiché contiene opinioni di valore più generale, da commento diventa post. Se non siete interessati alla teorizzazione politica, evitatelo è molto lungo e molto palloso
 In una precedente
discussione, ci si imbatteva nella differenza tra formale e
sostanziale a proposito della democrazia, ma
la distinzione non era chiara, vedrò quindi di chiarirla.
Innanzitutto per intenderci reciprocamente, debbo ancorare
il punto di vista di
partenza o quantomeno chiarirlo. Chi scrive aderisce ad una
ideologia democratica. L’ideologia democratica sembra molto
popolare ma
c’è un profondo disguido sulla questione, non è
probabilmente quella che pensate di conoscere voi.
In una precedente
discussione, ci si imbatteva nella differenza tra formale e
sostanziale a proposito della democrazia, ma
la distinzione non era chiara, vedrò quindi di chiarirla.
Innanzitutto per intenderci reciprocamente, debbo ancorare
il punto di vista di
partenza o quantomeno chiarirlo. Chi scrive aderisce ad una
ideologia democratica. L’ideologia democratica sembra molto
popolare ma
c’è un profondo disguido sulla questione, non è
probabilmente quella che pensate di conoscere voi.
Ideologia democratica ha ben poca teorizzazione di base. Compare inizialmente nelle Storie di Erodoto, se ne dà qualche specifica in Politica di Aristotele, se ne dà versione critica negativa nella Costituzione degli Ateniesi (versione c.d. Anonimo Oligarca o Pseudo Senofonte), viene sistematicamente massacrata da Platone, teorico massimo di ogni forma piramidale gerarchica, dalla metafisica in giù. Scompare dai radar della teoria politica lungo tutto il periodo romano e medioevale. Nel primo moderno ci sarebbero i diggers ed i levellers della Guerra Civile inglese di metà XVII secolo ma non scrivevano le loro idee. Per altro vennero tutti fisicamente massacrati da Cromwell delle cui truppe facevano parte. Ricompare sostanzialmente con J.J.Rousseau, seguito da qualche fazione dei moti pre e durante la Rivoluzione francese (giacobini-montagnardi, socialisti detti da Marx “utopisti”, anarchici della Comune del 1871). Ha qualche ripresa più recente ma non possiamo qui entrare nel merito.
Nel periodo moderno sostanzialmente scompare, sostituita da una forma giustificata teoricamente da B. Constant nel 1819 che titola: “La libertà degli antichi comparata alla libertà dei moderni”, corroborato poi da J. Stuart Mill (liberale, inglese). Constant era un liberale franco-svizzero e la sua comparazione muove dai principi teorici di Rousseau, dicendo però che -ovviamente- negli stati moderni composti da milioni di persone, non si poteva certo fare la “democrazia diretta” tipo Atene o Ginevra, bisognava passare a quella rappresentativa entro ovviamente lo stato moderno liberale à la Montesquieu con tripartizione dei poteri etc. etc. Constant chiama “libertà” la democrazia, facendo il verso a Rousseau che ironizzava sulla forma rappresentativa liberale che presupponeva di dare libertà di partecipazione al processo politico ai cittadini, “una volta ogni quattro anni” (riferendosi a gli inglesi).
Leggi tutto
Fulvio Grimaldi: 5 stelle nel buco nero
5 stelle nel buco nero
di Fulvio Grimaldi
La Storia in farsa: Di Maio, l’Occhetto del MoVimento, Conte, il suo Napolitano
 Quos vult Iupiter perdere,
dementat prius (A coloro che vuole
rovinare, Giove toglie prima la ragione)
Quos vult Iupiter perdere,
dementat prius (A coloro che vuole
rovinare, Giove toglie prima la ragione)
“Come può un movimento proseguire nella sua azione di cambiamento della Cosa Pubblica? Necessariamente attraverso un continuo attacco al pericolo numero uno della collettività: il pensiero dominante, la forma di fascismo più pericolosa del XXI secolo”. (Alessandro Di Battista, “Politicamente Scorretto”, edizioni Paper First)
Prima del diluvio
Si stava al fresco, iniziando, con l’aiuto di Speck, succhi di mela, automobilisti rispettosi, gerani ai balconi, gente senza cellulari sui sentieri, abeti rossi e praterie di trifoglio, l’adattamento al salto dai consuetudinari 380 metri ai quasi 2000. Arrivavano, dalla bottega alimentare che mi consegnava la mazzetta dei giornali, le solite notizie appassionanti confezionate dalle eccellenze del giornalismo nostrano traendone i materiali da territori tra il deserto, la palude e i letamai. Grazie alle ottime condizioni ambientali, spirito e corpo riuscivano a tenergli testa.
Statunitensi, ammattiti per gli scacchi di Venezuela e Siria, che sbattevano furiose sciabole su tonitruanti scudi in mezzo al Golfo; Elisabetta Due che, in ansia competitiva con l’omonima numero Uno, rilanciava pirati alla Drake contro petroliere da razziare; eletti europei che, in cambio di guiderdoni, cavolini di Bruxelles e foie gras di Strasburgo (da oche inchiodate quanto loro al patibolo della libertà), si prestavano a formare un “parlamento” che era tale come Salvini è Bismarck; l’inestinguibile flusso di zozzerie, volgarità, malandrinate e imbecillità Lega e PD che continuava a scorrere ai piedi degli italiani fermi e impassibili sulla sponda del fiume (mai un cadavere); i tg nazionali che al confronto di quelli tedeschi, francesi, russi, nigeriani (pure disponibili nel maso) parevano Sfera Ebbasta contro Aretha Franklin, tanto che ci si riprendeva solo alla vista del canale provinciale con i suoi jodel e i suoi caduti dalla bicicletta.
Leggi tutto
Mauro Pasquinelli: Per una critica del populismo
Per una critica del populismo
di Mauro Pasquinelli
Non sono poche le occasioni in cui SOLLEVAZIONE ha ospitato riflessioni sulla questione del "populismo". Anni addietro, non solo noi, promuovemmo sul tema convegni di studio. Una categoria politica, quella del "populismo", polisemica e insidiosa quant'altre mai. Il terremoto elettorale del 4 marzo 2018, l'avvento al potere di due formazioni considerate populiste, il fatto dunque che l'Italia diventa il principale laboratorio politico europeo, obbliga a tornare sul punto ed a riaprire la discussione. Iniziamo con questo contributo. Inutile ricordare che pubblicare un contributo non significa che la redazione lo condivida. Il dibattito proseguirà
 Populismi senza
popolo, popoli senza socialismo
Populismi senza
popolo, popoli senza socialismo
Ai tempi di Marx l’opposizione destra-sinistra non esisteva ma si presentava nelle vesti di alternativa tra Monarchia o Repubblica democratico-borghese. Non diverso era ai tempi di Lenin, dove destra significava fascismo, bonapartismo, reazione, militarismo e sinistra socialdemocrazia, democrazia, riformismo, pacifismo. Mai, tuttavia, abbiamo visto dirigenti o teorici del socialismo, tranne quelli di matrice riformista, posizionarsi nel secondo campo delle opzioni della classe dominante. Dal terzo campo rivoluzionario, si poteva al massimo fornire un appoggio tattico al secondo campo per porre un argine o battere l’ipotesi del primo, quella più autoritaria.
Al dualismo storico destra sinistra nel campo delle opzioni borghesi, che data dall’affare Dreyfus (1894) oggi si aggiunge, o forse si sostituisce, quello tra popolo ed élite, per la precisione tra populismo e globalismo, sovranismo e cosmopolitismo.
Cercherò di dimostrare perché il populismo non è un alternativa vera al cosmopolitismo, come la sinistra non lo è mai stata alla destra.
Queste riflessioni vogliono essere un invito alla discussione sul tema del populismo all’interno dellasinistra patriottica, per una ridefinizione del suo posizionamento tattico e strategico, che tutt’ora, ahimè, staziona all’interno del secondo campo populista, presidiato in Occidente da forze politiche per lo più xenofobe e rozzo-brune.
Lancio subito una provocazione concettuale che sarà più chiara dopo aver letto questo breve saggio, e che a me serve per renderlo più appetitoso: il populismo agisce in nome del popolo. Il socialista agisce per il popolo e con il popolo. Questione di preposizioni? No questioni di sostanza e lo vedremo alla fine.
“L’emancipazione dei lavoratori sarà opera dei lavoratori stessi” scriveva Marx in esergo al proclama di fondazione della Prima internazionale. Ed aveva ragione: il socialismo è la prima forma sociale, nella storia dell’umanità che per essere realizzata richiede il protagonismo e la partecipazione attiva e permanente della comunità degli uomini.
Leggi tutto
Giorgio Riolo: Il malsviluppo e la crisi sociale ed ecologica
Il malsviluppo e la crisi sociale ed ecologica
E attenti al 29 luglio, Overshoot Day: la terra (con tutti noi) va in rosso
di Giorgio Riolo
A Giorgio Nebbia, recentemente scomparso. Figura preziosa come presenza umana, intellettuale e politica della sinistra italiana. Ambientalista rigoroso e comunista, la giustizia sociale e la giustizia ambientale come pensiero vissuto. A lui la nostra gratitudine per averci aiutato negli anni decisivi della formazione culturale e politica
 Il prossimo 29 luglio è il
cosiddetto Overshoot Day (*) il Giorno del
Superamento-Supesfruttamento. Vale a dire, della
possibilità del pianeta terra di rigenerare-ripristinare
l’equilibrio delle risorse a
causa del consumo-emissione di CO2-inquinamento-rifiuti
ecc. su scala mondiale. Questa misura è calcolata ogni
anno dalla benemerita Rete
mondiale dell’Impronta Ecologica (Global Footprint
Network). Nel 1970 il giorno era il 31 dicembre. Il saldo
allora era a somma zero. Oggi per 5
mesi e qualche giorno deprediamo letteralmente la terra.
Da sommare alle depredazioni degli anni precedenti.
L’accumulazione del capitale e
l’accumulazione della violenza ambientale, sul vivente.
Il prossimo 29 luglio è il
cosiddetto Overshoot Day (*) il Giorno del
Superamento-Supesfruttamento. Vale a dire, della
possibilità del pianeta terra di rigenerare-ripristinare
l’equilibrio delle risorse a
causa del consumo-emissione di CO2-inquinamento-rifiuti
ecc. su scala mondiale. Questa misura è calcolata ogni
anno dalla benemerita Rete
mondiale dell’Impronta Ecologica (Global Footprint
Network). Nel 1970 il giorno era il 31 dicembre. Il saldo
allora era a somma zero. Oggi per 5
mesi e qualche giorno deprediamo letteralmente la terra.
Da sommare alle depredazioni degli anni precedenti.
L’accumulazione del capitale e
l’accumulazione della violenza ambientale, sul vivente.
Naturalmente, con la gerarchia mondiale di questo furto. Gli Usa (328 milioni di abitanti) avrebbero bisogno di 5 pianeti a questo ritmo dell’impronta ecologica dei suoi abitanti. La Cina 2,2 pianeti (ma 1 miliardo e 420 milioni di abitanti) e l’India 0,7 (ma 1 miliardo e 370 milioni di abitanti) e via scalando nella popolazione mondiale delle periferie del mondo. Inoltre è annunciato per il prossimo agosto 2019 il nuovo rapporto dello Ipcc (gruppo di lavoro intergovernativo di scienziati del clima sul cambiamento climatico, legato all’Onu ). Ma basta lo Special Report del 2018 per allarmarci. Siamo già dentro a processi irreversibili.
Per l’occasione, anticipo qui di seguito alcune parti dell’ultimo capitolo di un libro scritto con Massimiliano Lepratti sulla “storia globale dell’umanità”, in attesa di pubblicazione. È una sintesi di circa 350 pagine scritta per un pubblico largo, senza pretese specialistiche, ma con l’intento di contribuire a una battaglia culturale importante, con riferimenti bibliografici minimi. Facendo tesoro della lezione di Samir Amin, della critica radicale dell’eurocentrismo e dell’occidentalocentrismo, secondo l’impostazione del sistema-mondo dello storico francese Fernand Braudel ecc.
Nel capitalismo “tutto si tiene”. Il fine è sempre quello di tenere assieme giustizia sociale (e di genere) e giustizia ambientale. Non sovrapposte, disgiungibili, bensì fuse, contestuali, della stessa sostanza (consustanziali, qualcuno direbbe). Dopo di che, il difficile è quale militanza, quale azione politica e sociale farne scaturire. Tutti i problemi che rimangono entro una sinistra decente (alternativa ecc.) in questa epoca storica.
Leggi tutto
Carlotta Caciagli: Gli Student Hotel e la creatività del capitale
Gli Student Hotel e la creatività del capitale
di Carlotta Caciagli*
Mentre il diritto allo studio viene attaccato trasformandolo in «debito d'onore», in diverse città d'Europa nascono studentati privati di lusso. Sono l'ennesimo tentativo di far diventare qualsiasi esperienza di vita un'esperienza di consumo
 Amsterdam, Dresda, Berlino, Firenze, Parigi.
In alcune città gli Student
Hotel sono già sbarcati, in molte altre arriveranno presto,
come a Lisbona, Barcellona, Tolosa. In Italia si conta di
aprirne almeno altri
cinque nei prossimi due anni. Ma cosa sono gli Student
Hotel? Stando al nome sembrerebbero dei semplici alloggi per
studenti, ma a ben guardare sono
molto altro: luoghi che riproducono un preciso modello di
città e una precisa concezione di istruzione.
Amsterdam, Dresda, Berlino, Firenze, Parigi.
In alcune città gli Student
Hotel sono già sbarcati, in molte altre arriveranno presto,
come a Lisbona, Barcellona, Tolosa. In Italia si conta di
aprirne almeno altri
cinque nei prossimi due anni. Ma cosa sono gli Student
Hotel? Stando al nome sembrerebbero dei semplici alloggi per
studenti, ma a ben guardare sono
molto altro: luoghi che riproducono un preciso modello di
città e una precisa concezione di istruzione.
The Student Hotel (Tsh) è uno studentato e al tempo stesso un hotel di lusso, ci si può stare una notte come un anno intero. Al suo interno è composto di camere e spazi comuni: cucine, salotti, aule studio, aule conferenze, biliardi, terrazze con piscina, in alcuni casi saune e idromassaggi. Un design progettato – quando possibile dalla archistars di casa, poiché la visibilità è garantita – per essere casa, ufficio e luogo di ricreazione al tempo stesso. Uno spazio pensato per rendere accettabile che fra lavoro e tempo libero non ci siano confini. Perché se essere perennemente presi nella morsa del processo produttivo significa una camera vista mare, be’, allora non è poi così male. Salvo per i prezzi, che allo studentato si avvicinano proprio poco dato che una camera può costare anche 100 euro a notte. Viene quasi da chiedersi chi siano le persone che possono permettersi una stanza qua. Ce lo spiega il gruppo possessore: Tsh è per giovani creativi, studenti, intellettuali, professionisti e startuppers. Insomma per tutte quelle figure professionali che lavorano sempre pur sembrando non lavorare mai. In fondo, ci dice sempre il gruppo Tsh, si tratta di un’idea semplice, ovvero riunire imprenditori, studenti e viaggiatori sotto un unico tetto, alle parole d’ordine di mescolanza, multiculturalismo e condivisione.
Parole a cui è difficile contrapporsi, perché rimandano le menti a giovani aperti, che conoscono il mondo, che apprendono lingue nuove, a italiani che imparano a cucinare cous-cous, a inglesi che mangiano pasta e pizza, a film in lingua originale, a serate a tema in cui conoscere i costumi degli altri. La «mission» di Tsh è quella che abbiamo assunto essere dell’Erasmus, ovvero creare un contesto stimolante per tutti, in cui si beneficia del contatto con il diverso.
Leggi tutto
Giovanna Cracco: Per chi sta realmente lavorando questa economia?
Per chi sta realmente lavorando questa economia?
di Giovanna Cracco
 Il 3 luglio scorso la
Commissione europea ha ritirato la proposta di aprire una
procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia (1), dichiarando che
terrà il Paese sotto stretta osservazione e se ne riparlerà
in
autunno, in fase di manovra finanziaria 2020. L’ha fatto
perché l’Italia ha messo sul piatto 7,6 miliardi,
modificando le proprie
politiche economiche così come la Commissione aveva
richiesto. Problema risolto? No. E per comprendere quanto
sia irrisolto, occorre fare un
passo indietro e tornare sul Rapporto con cui il 5 giugno la
Commissione Ue aveva proposto l’apertura della procedura
d’infrazione.
Il 3 luglio scorso la
Commissione europea ha ritirato la proposta di aprire una
procedura
d’infrazione nei confronti dell’Italia (1), dichiarando che
terrà il Paese sotto stretta osservazione e se ne riparlerà
in
autunno, in fase di manovra finanziaria 2020. L’ha fatto
perché l’Italia ha messo sul piatto 7,6 miliardi,
modificando le proprie
politiche economiche così come la Commissione aveva
richiesto. Problema risolto? No. E per comprendere quanto
sia irrisolto, occorre fare un
passo indietro e tornare sul Rapporto con cui il 5 giugno la
Commissione Ue aveva proposto l’apertura della procedura
d’infrazione.
Per leggerlo (2), la sola volontà non è sufficiente; occorre saltare lo steccato ed entrare nel territorio dell’ostinazione, per poi accettare di muoversi nello spazio dell’incredulità. Dapprima è la fatica a dominare, per la sequela di cifre e percentuali che in modo ossessivo si ripetono, dopodiché arriva la sensazione di essere finiti in un mondo parallelo, nel quale le coordinate con cui dovremmo misurare il reale, non esistono.
Da parte sua, con titoli di scatola in prima pagina, editoriali, analisi e aperture di telegiornali che rappresentano come legittima la posizione della Commissione Ue, nemmeno l’informazione mainstream ha aiutato a giugno e non aiuta tuttora a restare aggrappati alla realtà, anzi contribuisce a eliminare dal discorso pubblico ogni riflessione che entri nel merito. La narrazione sulla bontà dei ‘vincoli di bilancio’ introdotti da Maastricht è pensiero dominante da quasi tre decenni, dunque non stupisce l’acritico recepimento del ‘torto’ e della ‘ragione’; eppure la capacità di ragionamento, per quanto atrofizzata, avrebbe dovuto avere un sussulto davanti alla lettura del Rapporto, e la realtà, per quanto negata, si presenta oggi agli occhi in modo talmente drammatico e prepotente che dovrebbe essere impossibile evitare di guardarla.
Se l’applicazione di una teoria economica allarga la forbice della diseguaglianza sociale e aumenta la povertà, deve essere messa in discussione. Alla radice, nella sua impostazione di base, non in superficie, cercando compromessi che non ne modificano l’impianto. “Per chi sta realmente lavorando questa economia?” ha affermato a fine giugno Elizabeth Warren, senatrice democratica in corsa alle primarie del partito, al primo dibattito televisivo della campagna elettorale:
Leggi tutto
coniarerivolta: Boeri e le gabbie salariali: l’incubo che ritorna
Boeri e le gabbie salariali: l’incubo che ritorna
di coniarerivolta
 In un articolo
pubblicato su Repubblica, Tito Boeri, ex presidente
dell’INPS, propone una delle sue tante ricette,
rigorosamente in salsa neoliberista, per
far tornare a crescere l’economia italiana e ridurre la
disoccupazione: la reintroduzione delle cosiddette “gabbie
salariali”, cioè differenziali tra le
retribuzioni dei lavoratori in base al luogo di residenza,
ipocritamente giustificati
sulla base di differenze nel costo della vita nelle varie
regioni d’Italia. Prima di addentrarci nei dettagli della
proposta, vediamo da cosa
scaturisce questa nuova (nuova si fa per dire, i
neoliberisti sono persone molto banali) idea del Prof.
Boeri.
In un articolo
pubblicato su Repubblica, Tito Boeri, ex presidente
dell’INPS, propone una delle sue tante ricette,
rigorosamente in salsa neoliberista, per
far tornare a crescere l’economia italiana e ridurre la
disoccupazione: la reintroduzione delle cosiddette “gabbie
salariali”, cioè differenziali tra le
retribuzioni dei lavoratori in base al luogo di residenza,
ipocritamente giustificati
sulla base di differenze nel costo della vita nelle varie
regioni d’Italia. Prima di addentrarci nei dettagli della
proposta, vediamo da cosa
scaturisce questa nuova (nuova si fa per dire, i
neoliberisti sono persone molto banali) idea del Prof.
Boeri.
Il predecessore di Tridico ci informa, preoccupato, che il Nord del Paese si sente tradito dalla Lega, che avrebbe lasciato troppo spazio alle ricette economiche del Movimento 5 Stelle e avrebbe rinunciato, in tutto o in parte, alle proprie. “L’agenda di Governo” – scrive Boeri – “ha del tutto ignorato le istanze del blocco sociale settentrionale”. Immediatamente, Boeri mette le cose in chiaro sulla sua visione del Paese, riferendosi a un Nord di lavoratori e pensionati che speravano nelle promesse della Lega – quota 100 e la flat tax, ad esempio – e a un Sud di disoccupati che avevano votato in massa Movimento 5 Stelle per ricevere il reddito di cittadinanza. Solo questi ultimi sarebbero stati davvero accontentati. Il produttivo Nord sarebbe stato fregato dalla Lega attraverso una quota 100 molto limitata, nella sua portata, rispetto alle aspettative dei lavoratori settentrionali prossimi alla pensione e una flat tax che, fino ad ora, non si è vista (se non attraverso una ben misera “flataxina”).
Secondo Boeri, un partito interessato ad affrontare i veri problemi del Paese dovrebbe partire dalla questione settentrionale, prendendo di petto quella che secondo lui è la vera grande ingiustizia territoriale: i salari reali (ovvero il rapporto tra i salari in termini monetari e i prezzi, che ci dice, in pratica, quante cose un lavoratore può comprare con il proprio stipendio) sono più alti al Sud che al Nord, a causa di prezzi molto più bassi nelle regioni meridionali rispetto a quelli nelle regioni del Settentrione.
I più letti degli ultimi tre mesi
Giorgio Galli - Roberto Sidoli: Una discussione sulla teoria dell’effetto di sdoppiamento
Hits 2626
Hits 1908
Hits 1822
Hits 1815
Hits 1774
Hits 1705
Hits 1696
Hits 1652
tonino

Marino Badiale, Fausto Di Biase, Paolo Di Remigio, Lorella Pistocchi: Settis, Serianni e la catastrofe della scuola
Settis, Serianni e la catastrofe della scuola
di Marino Badiale, Università di Torino; Fausto Di Biase, Università di Chieti-Pescara; Paolo Di Remigio, Liceo Classico di Teramo; Lorella Pistocchi, Scuola Media di Villa Vomano
Riceviamo e volentieri pubblichiamo
 L’eliminazione della tradizionale
traccia di storia dalla prima prova dell’esame di Stato ha
sollecitato alcuni intellettuali a pubblicare sul quotidiano
‘Repubblica’ un appello preoccupato per la decadenza della
cultura storica in
Italia[1]. Ne è
seguita un’audizione alla Commissione Istruzione Pubblica –
Beni Culturali del Senato[2], nella quale
il prof.
Settis, sulla base dell’etica implicita nella Costituzione, ha
pronunciato un’appassionata apologia degli studi storici come
pilastri
della sovranità della nazione e della libertà del cittadino, e
il prof. Serianni, responsabile dell’ultima versione della
prima
prova dell’esame di Stato e quindi chiamato direttamente in
causa dall’appello, ha smentito che la nuova formula
dell’esame
emarginasse la storia, sostenendo, al contrario, che ‘la
storia è e resta fondamentale come dimensione culturale e
anche come elemento di
verifica di competenze e conoscenze degli studenti arrivati
alla fine’, che ‘la storia, proprio come dimensione che
innerva tutti gli
altri saperi, è largamente presente’, anzi è addirittura
‘privilegiata’.
L’eliminazione della tradizionale
traccia di storia dalla prima prova dell’esame di Stato ha
sollecitato alcuni intellettuali a pubblicare sul quotidiano
‘Repubblica’ un appello preoccupato per la decadenza della
cultura storica in
Italia[1]. Ne è
seguita un’audizione alla Commissione Istruzione Pubblica –
Beni Culturali del Senato[2], nella quale
il prof.
Settis, sulla base dell’etica implicita nella Costituzione, ha
pronunciato un’appassionata apologia degli studi storici come
pilastri
della sovranità della nazione e della libertà del cittadino, e
il prof. Serianni, responsabile dell’ultima versione della
prima
prova dell’esame di Stato e quindi chiamato direttamente in
causa dall’appello, ha smentito che la nuova formula
dell’esame
emarginasse la storia, sostenendo, al contrario, che ‘la
storia è e resta fondamentale come dimensione culturale e
anche come elemento di
verifica di competenze e conoscenze degli studenti arrivati
alla fine’, che ‘la storia, proprio come dimensione che
innerva tutti gli
altri saperi, è largamente presente’, anzi è addirittura
‘privilegiata’.
Il prof. Serianni, preoccupato soprattutto di difendere il nuovo esame di Stato e di assumere un atteggiamento complessivamente rassicurante, è molto lontano dal rilevare che il cambiamento subito dalla scuola italiana negli ultimi venti anni vi ha posto la cultura storica, come pure la cultura in generale, in una posizione di estrema precarietà; non evita però di menzionare due ‘criticità’: la prima che nel biennio degli istituti professionali l’insegnamento della storia è ridotto a un’ora alla settimana, la seconda che in futuro esso potrebbe essere ridotto in tutte le scuole affinché vi abbia spazio la nuova disciplina ‘Cittadinanza e Costituzione’, che il Parlamento non potrà non approvare(non si capisce se per deliberazione dello stesso prof. Serianni)[3]. Non emerge dal suo intervento, e invero neanche dagli altri, che queste ‘criticità’ sono gli ultimi episodi di una lunga vicenda di ostilità, i cui precedenti risalgono alla riforma Moratti del 2003 e alla riforma Gelmini del 2010. Mettendo fine alla tradizione che alle elementari affidava una prima esposizione di tutta la storia e alle medie una sua più approfondita riesposizione, la prima riformatrice destinò a quelle la storia dalle origini fino alla tarda antichità e a queste la storia dalla tarda antichità fino al presente, eliminò cioè la sua ripetizione, come se i bambini memorizzassero le conoscenze con un facile clic sul comando ‘Salva’; distribuì inoltre gli argomenti in modo che il tempo concesso alla terza elementare fosse dilapidato a favoleggiare dei dinosauri.
Leggi tutto
Carlo Lozito: Crisi ambientale e sociale: le due facce della catastrofe capitalistica
Crisi ambientale e sociale: le due facce della catastrofe capitalistica
di Carlo Lozito
L'ampio dibattito sull'ambiente, dopo le manifestazioni studentesche seguite all'appello di Greta Thunberg, tratta un'infinità di aspetti salvo quello fondamentale: il disastro ambientale è causato dal modo di produzione capitalistico. Così alla questione sociale, autentica emergenza contemporanea, si aggiunge quella ambientale mostrando l'insostenibilità del capitalismo e la necessità di metterlo in discussione per liberare l'uomo e la natura dal suo dominio
 Il
capitale contro la Terra
Il
capitale contro la Terra
Per dare un'idea della velocità dei cambiamenti avvenuti negli ultimi due secoli è sufficiente considerare i grafici dell'aumento della popolazione mondiale e della crescita della produzione negli ultimi millenni. Essi, praticamente piatti negli fino a due secoli fa, indicano come la crescita demografica e della produzione si concentrino sostanzialmente a partire dalla rivoluzione industriale quando si sviluppa il capitalismo moderno fondato sulla grande industria. Tenuto conto che la crescita demografica è legata alla produzione e disponibilità di cibo, è nei meccanismi di funzionamento del capitalismo che dobbiamo cercare la causa di queste crescite senza precedenti in tutta la storia umana.
Marx con la formula d-m-d' descrive l'essenza del ciclo di accumulazione del capitale: denaro investito dal capitalista (d) che si trasforma in mezzi di produzione e salari che servono per la realizzazione delle merci (m) le quali, una volta vendute sul mercato, si trasformano nuovamente in denaro ma in quantità accresciuta (d'). L'accrescimento è dovuto al plusvalore estorto all'operaio e non pagato dal capitalista, plusvalore incorporato nelle merci prodotte che una volta vendute si trasforma in profitto. Questo processo, che è specifico del modo di produzione capitalistico, permette teoricamente un accrescimento illimitato del capitale. Più il capitalista investe, più merci fa produrre agli operai, più allarga il mercato in cui venderle, più la sua tasca si gonfia di nuovo capitale. Nel ciclo successivo, per ripetere il processo e tenuto conto del saggio medio del profitto quale obiettivo da perseguire, il capitale di partenza ha una dimensione maggiore e per questo costringe il capitalista a una dimensione aumentata della produzione. E così via per i cicli successivi. Naturalmente qui abbiamo volutamente semplificato la descrizione del processo. Ciò che importa sottolineare è che il perseguimento del profitto induce la spinta alla produzione su scala sempre più allargata, la quale a sua volta genera la spinta al consumo di quanto prodotto. Poco importa che si tratti del capitalista dell'Ottocento oppure delle attuali imprese monopolistiche guidate da un consiglio d'amministrazione, la legge fondamentale operante nel capitalismo è sempre questa.
Leggi tutto
Pierluigi Fagan: Notizie da un altro pianeta
Notizie da un altro pianeta
di Pierluigi Fagan
La NASA ha pubblicato su Nature uno studio incredibile. Tramite osservazione satellitare, si sono accorti che il pianeta Terra è più verde di venti anni fa. Se ne sono accorti dopo un po’ dall’inizio del monitoraggio appunto venti anni fa, ed avevano pensato che questa ripresa del verde planetario fosse un prodotto inaspettato dell’esubero di CO2, una sorta di effetto benefico collaterale all’effetto ritenuto malefico dell’eccesso di emissioni, una applicazione della logica Zichichi, un maitre à penser che ultimamente ha molto seguito qui da noi.
Col tempo però, comparando le rilevazioni su mappe, hanno scoperto che tutto il rinverdimento planetario era concentrato in due zone di questo strano altro pianeta, le zone dette “Cina” ed “India”. Caramba, che sorpresa! Hanno poi scoperto che gli abitanti di questo strano altro mondo, i cinesi, usano quello che chiamano “Esercito Popolare” per piantare alberi che contrastino l’avanzata dei deserti interni ed anzi, pare che questi strani esseri si siano messi in testa di rubare spazio al deserto stesso, piantando alberi a ripetizione. Un esercito di vangatori, che buffa idea, no? Mettete dei fiori nei vostri cannoni, diceva una antica canzone … . Si sono anche detti sorpresi del fatto che, alla stessa NASA, avevano letto i giornali che mostravano quanto pazzi fossero questi cinesi che si auto-soffocavano con l’emissione di CO2 a causa della dissennata idea di far avanzare il loro sviluppo.
Leggi tutto
Tomaso Montanari: TAV e Movimento 5Stelle. Il momento è ora
TAV e Movimento 5Stelle. Il momento è ora
di Tomaso Montanari
Il momento è ora. Se il Movimento 5 Stelle vuole sperare di avere – nonostante il disastro continuo in cui si è risolta la sua esperienza di governo – un qualsiasi futuro, deve uscire dall’esecutivo sul tradimento di Giuseppe Conte sul TAV. Ora. Senza nemmeno provare a nascondersi dietro l’ipocrita dito di uno scontatissimo voto parlamentare.
Il presidente del Consiglio non è riuscito a produrre una sola ragione tecnica che ribalterebbe la famosa analisi costi-benefici. Ha invocato vaghe decisioni dell’Europa (prima ancora che la nuova Commissione decida), ha prospettato «costi» del recesso non precisati e non dimostrati: ha fatto sua la solita fumisteria da chiamparini & madamine, senza uno straccio di fatto nuovo.
È dunque evidente Conte ha fatto una scelta politica: arrivati allo stallo e alla vigilia della resa dei conti, il garante del patto di governo ha scelto uno dei due contraenti, buttando a mare l’altro. Non ha tutelato quello che l’ha portato a Palazzo Chigi: ha abbracciato il più forte. E per farlo ha voluto usare l’arma-fine-di-mondo: perché sa perfettamente che restare in un Governo che fa il TAV significa, per i 5 Stelle, il suicidio. Ma c’è un’altra faccia della medaglia: presentarsi non più come l’avvocato difensore dei cittadini, ma come l’avvocato d’affari del TAV significa schierarsi non solo con la Lega, ma accreditarsi definitivamente con il sistema. Con il Pd, con gli imprenditori e (ahimè) con i sindacati: con il presidente della Repubblica e con tutti gli alti garanti dello stato delle cose.
Leggi tutto
Piccole Note: Il Russiagate è finito: si rilancia l'asse anglosassone
Il Russiagate è finito: si rilancia l'asse anglosassone
di Piccole Note
Il Russiagate è finito, non con una deflagrazione, ma in un balbettio. L’audizione al Congresso del procuratore speciale Mueller, che nell’idea dei democratici doveva riaprire un capitolo chiuso, non ha prodotto novità di rilievo.
Donald Trump può quindi derubricare l’inchiesta a incidente di percorso. Per i democratici è il momento di tornare alla politica, dopo anni di sospensione suicida a questa vicenda.
Il fatto che il Russiagate sia un prodotto della premiata ditta neocon può offrire il destro per un paragone con la guerra irachena, di eguale matrice.
Tornare alla politica
Dopo la vittoria di Trump, contro la Casa Bianca è stata lanciata l’arma di distruzione di massa del Russiagate che, distruggendo il tycoon che aveva impudentemente sfidato un ordine globale dato per irreversibile, avrebbe dovuto riconsegnare gli Stati Uniti alla follia neocon.
La bomba anti-Trump si è dimostrata simile alle armi di distruzioni di massa di Saddam, affannosamente cercate e mai trovate.
Tra i tanti commenti all’audizione di Mueller spicca un titolo del Washington Post: “I democratici hanno un’opzione per porre fine alla presidenza Trump: vincere le elezioni del 2020”.
Leggi tutto
Gianmarco Oro, Giorgio Gattei: Classi Sociali e Geometria del Governo Giallo-Verde
Classi Sociali e Geometria del Governo Giallo-Verde
di Gianmarco Oro, Giorgio Gattei
 1. Le classi sociali nell’emiciclo
parlamentare.
1. Le classi sociali nell’emiciclo
parlamentare.
La doppia ipotesi che muove questa indagine è che i partiti politici non sono altro che i “veicoli” con cui le classi sociali si contendono il potere politico nelle competizioni elettorali e che queste classi sono riconducibili, grossolanamente, alle denominazioni classiche di “borghesia”, “proletariato” e “ceti medi”. Naturalmente queste denominazioni andrebbero adattate al giorno d’oggi, così da distinguere la borghesia in industriale, agraria e finanziaria; il proletariato da chiamarsi meglio “salariato” o “classe operaia” (ma non certamente “classe subalterna”!); mentre i ceti medi risultano come un coacervo di strati sociali difformi in cui sono indistintamente compresi i “padroncini” (di fabbrica e di campagna), i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, e liberi professionisti) e gli impiegati sia privati che pubblici. E qui va ricordato lo sconcerto che ci prese quando, appena pochi anni dopo l’insorgenza operaia dell’autunno caldo, Paolo Sylos Labini osò documentare, statistiche alla mano, che l’Italia era un paese a maggioranza della “quasi classe” dei ceti medi invece che del proletariato: nel 1971 il 49,6% contro il 47,8% che nel 1983 era già passato al 54% contro il 42,7%[i].
Ora c’è anche una teoria, ignorata dai più, secondo la quale la classe borghese si è storicamente espressa sotto la forma di due partiti politici: in Gran Bretagna i liberali e i conservatori e negli Stati Uniti i democratici e i repubblicani, data la doppia specie del suo reddito: il profitto industriale oppure la rendita (agraria e finanziaria)[ii]. In Europa anche il proletariato ha preso politicamente forma doppia: il partito socialista dapprima e il partito comunista poi, riformista il primo, rivoluzionario il secondo. E i ceti medi? Data l’anomalia della loro ambigua composizione sociale, hanno solitamente mancato di presentarsi con una propria forma-partito, affidando la difesa dei propri interessi di classe al partito “dei padroni” oppure a quello “di parte operaia” che sentivano al momento più vicino. Ma valeva comunque l’ammonimento marxiano per cui «i ceti medi, il piccolo industriale, il piccolo negoziante, l’artigiano, il contadino [mancavano al tempo i liberi professionisti e gli impiegati], tutti costoro combattono la borghesia per salvare dalla rovina l’esistenza loro di ceti medi.
Leggi tutto
Eros Barone: Da Stalin a Churchill: marxismo, linguistica e glottofagia
![]()
Da Stalin a Churchill: marxismo, linguistica e glottofagia
di Eros Barone
 Non
imiterò che me
stesso, Pasolini. Più morta di un inno sacro / la sublime
lingua borghese è la mia lingua. / Non conoscerò che me
stesso / ma
tutti in me stesso. La mia prigione / vede più della tua
libertà.
Non
imiterò che me
stesso, Pasolini. Più morta di un inno sacro / la sublime
lingua borghese è la mia lingua. / Non conoscerò che me
stesso / ma
tutti in me stesso. La mia prigione / vede più della tua
libertà.
Franco Fortini, da Composita solvantur, 1994.
- Il contributo di Stalin sul rapporto fra la teoria linguistica e il marxismo
È comunemente ammesso che nessuna scienza può svilupparsi senza una lotta di opinioni, senza libertà di critica.*
Gli scritti di Stalin sulla linguistica sono costituiti da una serie di risposte che Stalin dètte ad alcuni giovani comunisti sui problemi riguardanti il rapporto tra la linguistica e il marxismo, risposte che furono pubblicate sulla «Pravda», il principale quotidiano sovietico, tra il giugno e l’agosto del 1950. Le domande rivolte a Stalin concernevano soprattutto il problema dei rapporti tra la lingua e la struttura economica della società, e si possono così riassumere: la lingua è una sovrastruttura determinata dalla base economica? la lingua è il prodotto di una determinata classe sociale? quali sono gli elementi che definiscono una lingua nell’àmbito della vita sociale?
Rispondendo a queste domande, Stalin ebbe l’opportunità di intervenire nel dibattito che si era aperto sulle colonne della «Pravda» per confutare la teoria, dominante da circa un ventennio, del linguista Nikolaj Jakovlevič Marr, il quale sosteneva l’esistenza di un diretto rapporto di determinazione tra la base economica di una società e la sua lingua. Partito da studi specialistici di filologia armena e georgiana e di lingue caucasiche, Marr era noto soprattutto per la sua teoria ‘jafetica’ secondo cui esisterebbe un’affinità genealogica tra le lingue del gruppo caucasico e quelle semitiche, affinità che, in via di ipotesi, sarebbe estensibile non solo a tutte le lingue preindoeuropee del bacino del Mediterraneo, ma perfino a tutte le lingue del mondo in cui, dall’Asia all’Africa e all’America, il linguista russo cercò di individuare le tracce della famiglia jafetica. 1
In séguito alla rivoluzione d’ottobre e alla lettura di Marx, Engels e Lenin, Marr si propose di dare un nuovo fondamento filosofico marxista alla teoria generale del linguaggio, cui era approdato applicando meccanicamente lo schema materialistico secondo il quale le sovrastrutture di una società sono determinate dalla struttura economica ed estendendo la nozione di sovrastruttura sino ad includervi la lingua, la quale, essendo determinata dalla base economica, recherebbe il marchio della classe che l’ha prodotta.
Leggi tutto
Emanuele De Luca: Altro che Autonomia. Va salvata la scuola pubblica
Altro che Autonomia. Va salvata la scuola pubblica
di Emanuele De Luca
Mentre continua l'offensiva leghista sull'autonomia differenziata, il prossimo anno gli insegnanti precari diventeranno un quinto del totale. È il momento di sottrarsi ai continui ricatti per riprendere in mano il futuro dell'istruzione pubblica
Come riportano i dati Inps, da inizio settembre più di 40.000 insegnanti andranno in pensione grazie a “quota 100”. Bene, potrebbe commentare qualcuno, tutti contenti per il traguardo raggiunto e posti liberi per giovani docenti. Peccato, però, che nemmeno un euro sia stato stanziato per sostituirli. Nelle dichiarazioni entusiastiche del Ministro Bussetti sullo stato di avanzamento delle richieste di pensionamento, non vi è alcun accenno a chi e come dovrà prenderne il posto. Già, perché nella scuola pubblica, per quanto profondi siano i tagli e drastici gli accorpamenti, le classi si devono formare lo stesso e una riforma che destina fondi per prepensionare ha la necessità di investire per coprire quei ruoli vacanti con nuovi posti di ruolo.
Qui, però, interviene la collaudata “magia”: nessuna assunzione di ruolo – il settore evidentemente non è considerato strategico per il paese – ma si ricorrerà a docenti precari che, secondo i calcoli dei sindacati, il prossimo anno scolastico potrebbero arrivare a 170.000, un quinto del totale. Si tratta di contratti che incidono molto meno sul bilancio della stato ma che ingolfano un settore già allo stremo, con graduatorie di terza fascia esaurite da tempo e non ancora rinnovate, da sommare a concorsi promessi che, però, non servono a nulla se non si stabilizzano gli (oramai) storici vincitori.
Leggi tutto
Guido Viale: Il partito del Pil
Il partito del Pil
di Guido Viale
In Italia c’è un regime: il cosiddetto “Partito del Pil” (si è auto-denominato così lui stesso) che unisce quasi tutti i partiti, da Lega e Fratelli d’Italia a Pd e Forza Italia, con una consistente presenza di esponenti dei 5Stelle – l’ala governativa – più tutta Confindustria, gran parte dei vertici sindacali, un bel po’ di gerarchie cattoliche, tutti i media (stampa e TV al completo). Regimi e partiti “fratelli” del Partito del Pil italiano esistono in tutto il mondo, anche se non si sono dati il nome ridicolo che ha in Italia, ma in nessun paese dove esiste la possibilità di esprimere o di coltivare liberamente la propria opinione si incontra una coalizione così ferrea come in Italia.
Il partito italiano del Pil è il partito del NO. C’è chi dice (e ormai sono in molti) di ascoltare l’IPCC – il comitato degli scienziati di tutti i paesi del mondo che monitorano i cambiamenti climatici – che ci dà solo pochi anni di tempo per imporre una svolta al sistema prima che il trend del cambiamento climatico in corso diventi irreversibile. Molti, anche nel partito del Pil, si dichiarano d’accordo e Greta Thunberg, a differenza di quello che le è successo in Francia, è stata ascoltata da tutto il Senato italiano. Ma appena si tratta di tradurre in pratica qualcuna delle indicazioni che dovrebbero portare a quel cambio di rotta, il Partito del Pil dice NO: bando ai catastrofismi! Finché c’è gas, petrolio e carbone da estrarre o trasportare, lo consumiamo; anche a costo di imporre la costruzione di nuovi gasdotti come il TAP o nuove perforazioni nell’Adriatico.
Leggi tutto
ilsimplicissimus: Polvere di stelle
Polvere di stelle
di ilsimplicissimus
Basta leggere qualsiasi cosa per rendersi conto di come sia i nemici di Salvini che gli amici dei Cinque Stelle, autori di clamorosi autogol di cui non si comprendono fino in fondo le ragioni, consiglino di “resistere resistere resistere” al governo nonostante il fatto che ormai il leader della Lega fa ciò che vuole prendendosi il merito ci ciò che piace alla sua gente e addossando i demeriti al movimento. Ma rimanere ancorati alle poltrone in queste condizioni, per volontà di un’ennesima piccola casta di eletti che si sta riorganizzando dall’alto per mantenere le proprie posizioni, non sarebbe che l’errore mortale per il Movimento: Salvini sa benissimo che la sua crescita impetuosa, propiziata – e questo rivela molte cose – proprio dal maistream, si svolge sulle spalle e con la copertura dei Cinque stelle, che rimanere da solo al governo con contorno di mummie e di piddini sarebbe un pessimo affare, quindi non ha alcuna fretta di far cadere l’esecutivo a meno che non sia costretto a farlo sotto la pressione degli interessi economici di riferimento e magari di quelli europei. E lo farà comunque solo nel momento in cui potrà mettere il minor tempo possibile tra la caduta dell’esecutivo e le nuove elezioni.
A questo punto i Cinque stelle non hanno altra strada che far cadere loro il governo su un tema significativo che, perse tutte le occasioni possibili e immaginabili, distrutto il bene con il male, non potrebbe essere altro che il tema delle autonomie.
Leggi tutto
I più letti degli ultimi tre mesi
Giorgio Galli - Roberto Sidoli: Una discussione sulla teoria dell’effetto di sdoppiamento
Hits 2678
Hits 1967
Hits 1879
Hits 1720
Hits 1712
Hits 1680
Hits 1667